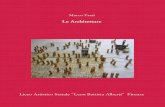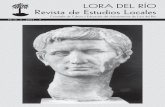PATRONATO ARTISTICO AL PRINCIPIO DEL QUATTROCENTO: IL RUOLO DEI CARDINALI NELLA RINASCITA DELLA ROMA...
Transcript of PATRONATO ARTISTICO AL PRINCIPIO DEL QUATTROCENTO: IL RUOLO DEI CARDINALI NELLA RINASCITA DELLA ROMA...
ii
SISMEL · EDIZIONI DEL GALLUZZOc.p. 90 I-50023 Tavarnuzze - Impruneta (Firenze)tel. +39.055.237.45.37 fax +39.055.237.34.54
[email protected] · [email protected] · www.mirabileweb.it
ISBN 978-88-8450-463-0© 2012 · SISMEL - Edizioni del Galluzzo
DIE KARDINÄLE DES MITTELALTERS
UND DER FRÜHEN RENAISSANCE
herausgegeben vonJÜRGEN DENDORFER und RALF LÜTZELSCHWAB
unter Mitarbeit vonJESSIKA NOWAK
FIRENZESISMEL · EDIZIONI DEL GALLUZZO
2012
iii
Pag. IV bianca
INHALTSVERZEICHNIS
vii Abkürzungsverzeichnis
DIE KARDINÄLE DES MITTELALTERSUND DER FRÜHEN RENAISSANCE
3 Jürgen Dendorfer, Zur Einführung
I. INTEGRATION ÜBER PERSONELLE NETZWERKE
15 Andreas Fischer, Personelle Verflechtung und politisches Handeln: Zur Wahrneh-mung und Funktion kardinalizischer Beziehungen im 13. Jahrhundert
37 Étienne Anheim, Les dynasties cardinalices et l’institution pontificale à la fin duXIIIe et au XIVe siècle. Identité institutionnelle et mémoire collective
55 Andreas Rehberg, Die Kardinäle aus Rom und die Macht der Klientelbeziehungen(1277-1527)
111 Anna Esposito, Tra legami politici e legami clientelari. Il caso esemplare del cardi-nale Guillaume d’Estouteville, camerlengo di S.R.E. nel tardo ’400
II. INTEGRATION DURCH DIE LEGATENTÄTIGKEIT DERKARDINÄLE
127 Claudia Zey, Zum Verhältnis zwischen Päpsten und Kardinallegaten im 11. und12. Jahrhundert
167 Blake Beattie, The Cardinals and Diplomacy in the Fourteenth Century
III. MEDIEN DER KOMMUNIKATION UND HABITUS
187 Matthias Thumser, Kardinal Rainer von Viterbo († 1250) und seine Propagandagegen Friedrich II.
v
201 Pierre Jugie, Les chancelleries des cardinaux légats au XIVe siècle, un outil de com-munication au service de la papauté
229 Werner Maleczek, Kardinalssiegel und andere Abbildungen von Kardinälenwährend des 13. Jahrhunderts
265 Claudia Märtl, Zwischen Habitus und Repräsentation. Der kardinalizische Ornatam Ende des Mittelalters
301 Pio Francesco Pistilli, Patronato artistico al principio del Quattrocento: il ruolo deicardinali nella rinascita della Roma cristiana
321 Marco Pellegrini, Il Sacro Collegio cardinalizio tra Rinascimento e Controriforma.Orientamenti tematici e bibliografici
357 Ralf Lützelschwab, Von Licht und Schatten: Bemerkungen zur aktuellen Kardi-nalsgeschichtsforschung
INDICI
373 Personen- und Ortsregister
vi die kardinäle des mittelalters und der frühen renaissance
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
BF(W) Böhmer – Ficker, Regesta Imperii V
IP Italia Pontifica
JK Jaffé – Kaltenbrunner, Regesta Pontificum Romanorum
JL Jaffé – Loewenfeld, Regesta Pontificum Romanorum
KB Kardinalbischof
KD Kardinaldiakon
KP Kardinalpresbyter
MGH Monumenta Germaniae Historica
Migne PL Migne, Patrologia Latina
RIS Muratori, Rerum Italicarum Scriptores
Potth. Potthast, Regesta Pontificum Romanorum
vii
Pag. VIII bianca
Pio Francesco Pistilli
PATRONATO ARTISTICO AL PRINCIPIO DEL QUATTROCENTO:IL RUOLO DEI CARDINALI NELLA RINASCITA
DELLA ROMA CRISTIANA
Chi si aspetta da questo contributo un’indagine fondata sulla letturaformale delle opere e laddove praticabile, proponendo i consueti giochid’attribuzione, credo che rimarrà alquanto deluso. D’altro canto dissodareun terreno per molti aspetti ancora poco battuto dalla mia disciplina,qual è il patronato cardinalizio dalla fine del Trecento a tutto il pontifi-cato di Martino V, richiede come atto preliminare l’ancorare i fatti arti-stici al momento in cui essi furono concepiti e realizzati. Si tratta di uncompito ingrato perché il periodo fu tra i più tormentati della Chiesa,ma si traduce nell’unica via da percorrere per organizzare un quadrogenerale che da Bonifacio IX al ministero post-scismatico del Colonnavolta decisamente registro, sempre nel solco di una cultura tardogoticanella quale fanno capolino i segni, talvolta inconsapevoli, di un rinnova-mento in chiave rinascimentale.
Per coerenza metodologica, il distinguo finora osservato per i due ter-mini di questa lunga stagione va pure applicato alla fase intermedia. Miriferisco sia al breve periodo della cosiddetta «obbedienza pisana», chepur governando il territorio laziale entro le due invasioni durazzesche del1408-1410 e del 1413-1414 ha lasciato nell’Annunziata di Cori1 (fig. 1)una significativa traccia di un mecenatismo che va ben al di là degli abi-tuali sacelli funerari, sia ai successivi anni del Concilio di Costanza, invece
301
1. P. F. Pistilli, Una committenza castigliana nella Marittima: l’oratorio della SS. Annunziata a Cori,in Architettura: processualità e trasformazione. Atti del convegno internazionale di studi (Roma, CastelSant’Angelo, 24-27 novembre 1999), a cura di M. Caperna – G. Spagnesi, Roma 2002, pp. 233-40; P. F. Pistilli – S. Petrocchi, El oratorio y los frescos de La Anunciación de Cori: un antiguo caso depatrocinio castellano en el agro romano, in «Archivo Español de Arte» 77 (2004), 305, pp. 35-57.
«Millennio Medievale» ?? (2012)
del tutto privi di riscontri. E non poteva essere altrimenti, vista lavacanza della Curia da Roma.
Pertanto è lecito frazionare l’indagine in tre momenti: il primo inter-corre dal pontificato di Bonifacio IX all’aprile del 1408, epoca dellacaduta di Roma nelle mani di Ladislao di Durazzo; il secondo corrispondeal triennio di attività del papato di obbedienza pisana, tra i primi mesi del1410 e il giugno del 1413; l’ultimo, infine, coincide con il ritorno diMartino V nell’Urbe e quindi dall’autunno del 1420 sino alla sua morte.
Di fatto, ciascuna fase ha sue precise peculiarità che si riverberano nel-l’azione o nell’inattività dei cardinali sul fronte dell’evergetismo artistico.Innanzitutto l’evoluzione della crisi interna alla Chiesa, che vede unalenta e progressiva internazionalizzazione del collegio cardinalizio, defi-nitivamente sancita con il ministero martiniano. Al contempo, datol’ampio segmento cronologico considerato, l’avvicendarsi di volta in voltadi nuovi attori, malgrado non manchino qualificate eccezioni, come adesempio il cardinale napoletano Rinaldo Brancaccio, la cui carriera sisovrappone quasi perfettamente al nostro ambito cronologico. Quindi lacaratura culturale, le ambizioni politiche e la libertà di azione dei prota-gonisti che, soprattutto nel terzo decennio del Quattrocento, si dispiegaa Roma, come nello Stato della Chiesa, con la medesima intensità dellecommittenze pontificie in San Giovanni in Laterano e che ne è taloradiretto o indiretto strumento di propaganda.
Entrando nel vivo della questione e analizzando l’età che precede ilConcilio di Pisa, lo scenario che si delinea non offre molti spunti diriflessione. La stessa azione di Bonifacio IX non sembra lasciar spazio almodesto drappello di cardinali che lo fiancheggiano, ridotti all’incirca aduna decina e quasi tutti italiani, né Roma disponeva più di risorse peressere da stimolo a personalità spesso non di alto profilo e, forse, interes-sate ad altro. Anzi, lo stato di rovina delle sue principali basilicherichiama appelli al risanamento che di frequente cadono nel vuoto2,mentre il centralismo pontificio soltanto dal 1398 investe vuoi in opera-zioni architettoniche e urbanistiche tese al controllo della città e dellesue magistrature, vuoi in forme oramai attardate di autocelebrazione, ela-borate in coincidenza con il Giubileo del 1400. Al profondo restauro di
302 pio francesco pistilli
2. M. L. Madonna, Gli interventi nella città tra il 1390 e il 1423, in Roma 1300-1875. La cittàdegli Anni Santi. Atlante, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, marzo-maggio 1985), acura di M. Fagiolo – M. L. Madonna, Milano 1985, pp. 80-2 (pp. 80-1).
Castel Sant’Angelo, ancora riconoscibile sul versante del ponte Elio neidisegni tardoquattrocenteschi3, al potenziamento del Palazzo Senatoriosul Campidoglio a seguito dell’annientamento del Comune romano conl’addizione di due torri sul lato prospiciente i rivitalizzati attracchi flu-viali4, sino alla profonda riformulazione della civitas leonina operata anchea spese della via Francigena5, si affiancano le rappresentazioni del papa incattedra o inginocchiato, consapevolmente attinte o rivitalizzate dall’ico-nografia del potere della Roma del Bonifacio suo predecessore, ovvero dipapa Caetani6.
Queste forme di attardamento, segno peraltro di una città che ancorastentava a rigenerarsi dopo il declassamento trecentesco, connotano purela maggior parte delle committenze cardinalizie, destinate a confezionaresepolcri non sempre altisonanti e comunque distinti tra arche a baldac-chino e semplici lastre terragne. Dunque sono soprattutto i manufattifunerari a testimoniare in senso esclusivamente privato l’attività mecena-tizia dei porporati, relegando per ora a rarità assolute e di ben altro spes-sore artistico imprese in cui viene meno qualsiasi vincolo con la tradi-zione locale. Ciò vale per la produzione dei libri liturgici, avviata altempo di Urbano VI e quindi proseguita dal successore Bonifacio IX, dicui solo di recente si è potuta ricostruire l’attività di una bottega opera-tiva a cavallo del 1400 tanto per papa Tomacelli, quanto per il cardinale
patronato artistico al principio del quattrocento 303
3. M. R. Rinaldi, L’esautorazione del Comune di Roma. Bonifacio IX e la fortificazione del PalazzoSenatorio, in Universitates e Baronie. Arte e architettura in Abruzzo e nel Regno al tempo dei Durazzo.Atti del convegno (Guardiagrele-Chieti, 9-11 novembre 2006), a cura di P. F. Pistilli – F. Manzari– G. Curzi, Pescara 2008, vol. 2, pp. 281-94 (p. 291 fig. 15 e p. 294 n. 57). Per i lavori in CastelSant’Angelo, che stando al Vasari furono affidati all’aretino Nicolò di Pietro Lamberti, si rimandaal datato ma ancora valido C. D’Onofrio, Castel S. Angelo, Roma 1971, p. 170, pp. 190-7.
4. Rinaldi, L’esautorazione (nota 3), pp. 281-94.5. G. Simoncini, Roma. Le trasformazioni urbane nel Quattrocento, vol. 1: Topografia e urbanistica
da Bonifacio IX ad Alessandro VI, Firenze 2004, pp. 62-3.6. La raffigurazione di Bonifacio VIII assiso in trono, nota in più redazioni a Firenze, Orvieto
ed Anagni (S. Maddalo, Bonifacio VIII, in Enciclopedia dell’arte medievale, Roma 1992, vol. 3, pp.626-9 [p. 627]), rimane l’esplicito modello di riferimento del Bonifacio IX in cattedra depositatonel chiostro della basilica ostiense, la cui esecuzione sarebbe successiva al 15 marzo 1400 (A.Tomei – E. Bassan, Le opere d’arte superstiti, in San Paolo fuori le Mura a Roma, a cura di C. Pie-trangeli, Firenze 1988, pp. 151-67 [p. 162]). Più problematico è invece attribuire al tempo diBonifacio IX il rilievo con il pontefice inginocchiato, forse proveniente dalla Loggia delle Bene-dizioni in Laterano. A identificarlo con il Tomacelli concorrono esclusivamente le insegne musive,perché la sua ragionevole «dipendenza stilistica dalla plastica arnolfiana», come proposto da F.Pomarici, Medioevo. Scultura, in San Giovanni in Laterano, a cura di C. Pietrangeli, Firenze 1990,pp. 109-15 (p. 113), ne anticipa la cronologia alla fine del Duecento, così da far ritenere i blasonifrutto di un’interpolazione successiva tesa a rigenerare l’immagine in occasione della ricorrenzagiubilare del 1400.
catalano Pere Serra7 (fig. 2), transfuga nel 1398 dalla Curia avignonese edel quale sopravvive nelle Grotte vaticane parte della cuspide del suo piùconvenzionale baldacchino funerario8.
Ancor più isolato e da intendere come prodotto di importazione risultaessere anche il reliquario con la testa del Battista (fig. 3), custodito inSan Silvestro in capite, chiesa per la quale fu fatto realizzare dal cardinaleAngelo Acciaiuoli nell’ultimo decennio del Trecento9. I documentati rap-porti dell’ecclesiastico fiorentino con la corte durazzesca10, oltre a motivisquisitamente formali, hanno indotto chi lo ha studiato a proporne un’e-ventuale manifattura meridionale, napoletana in un lontano passato, orapiù ragionevolmente ricondotta alla scuola orafa abruzzese11.
304 pio francesco pistilli
7. F. Manzari, Libri liturgici miniati per Bonifacio IX. Il codice Vat. lat. 3747 e la miniatura aRoma e nel Lazio all’epoca dello Scisma, in Il Pontificale di Bonifacio IX. Commentario, a cura di A. M.Piazzoni, Modena-Città del Vaticano 2007, pp. 49-116; Ead., Libri liturgici miniati in Italia cen-tromeridionale all’inizio del Quattrocento, in Universitates e Baronie (nota 3), vol. 1, pp. 109-36 (pp.123-33); Ead., Committenza libraria e legittimità tra Avignone e Roma. I codici liturgici prodotti perBenedetto XIII e per Bonifacio IX durante lo Scisma, in La Papauté et le Grand Schisme. Avignon/Rome.Langages politiques, impacts institutionnels, ripostes sociales et culturelles. Colloque International (Avi-gnon, 13-15 novembre 2008), éd. par A. Jamme, in corso di stampa.
8. Die Mittelalterlichen Grabmäler in Rom und Latium vom 13. bis zum 15. Jahrhundert, vol. 2:Die Monumentalgräber, bearb. und hg. v. J. Garms – A. Sommerlechner – W. Telesko, Wien 1994(«Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom»,II/5,2), pp. 156-7.
9. I. Toesca, Il reliquiario della testa di San Giovanni Battista nella chiesa di San Silvestro in capitea Roma, in «Bolletino d’Arte», 46 (1961), pp. 307-14. Attualmente in restauro presso i labora-tori dell’ISCR, il reliquiario va datato entro il pontificato di Bonifacio IX perché l’arme Toma-celli è caricata nelle insegne del cardinale Acciaiuoli, secondo un uso araldico invalso nella Curiabonifaciana e indagato da Manzari, Committenza (nota 7), in corso di stampa. Per il raro manufattoromano di oreficeria tardogotica, più specificatamente, si è indicata la realizzazione in occasionedelle ricorrenze giubilari del 1390 o del 1400, ma è stato anche vincolato ad una bolla pontificiadel 1391, per cui ibid., pp. 304-14; Tesori d’arte sacra di Roma e del Lazio dal Medioevo all’Ottocento.Catalogo della mostra (Palazzo delle esposizioni, novembre-dicembre 1975), Roma 1975, p. 49.Tuttavia gli stemmi Acciaiuoli sono qui accompagnati dalla mitra e non dal galero, presumibil-mente perché Angelo fu arcivescovo di Firenze sino al 1387, città di cui il Battista è patrono.
10. A. Cutolo, Re Ladislao d’Angiò Durazzo, Napoli 1969, pp. 110-1; A. Esch, Bonifacio IX, inEnciclopedia dei Papi, Roma 2000, vol. 2, pp. 570-81 (p. 571).
11. A favore di un’eventuale produzione abruzzese del reliquiario, che privo di punzone «nellaparte inferiore è composto da sei leoni reggi teca, sui quali poggia la base esagonale, i cui spigolisono caratterizzati da statuine inserite in piccole edicole che intervallano la serie continua diarchetti acuti a traforo, profilati da perlinature e dentature; il tutto è sormontato da un gradinoistoriato a smalto traslucido raffigurante le scene della vita del Battista», si è espressa la dott.ssaIrene Sabatini, che qui ringrazio. A suo avviso «tali tratti ebbero il loro esordio nel reliquiariodella testa di San Savino (Orvieto, Museo del Duomo), firmato dai senesi Ugolino di Vieri e Vivadi Lando nella prima metà del Trecento, per poi diffondersi nel centro Italia. Se queste compo-nenti possono dirsi derivanti da quella manifattura, le stesse non sono comunque distintive diquella produzione specifica. L’evoluzione della struttura del reliquiario romano lo testimonia. Quiil cranio del santo non è celato entro una calotta visibile solo dai pertugi, come nel caso orvie-tano, ma mostrato interamente in una teca di cristallo di rocca, fatto consueto già nei primi
Senza entrare nel merito del primato artistico degli Abruzzi nel pano-rama tardogotico del Regno almeno sino ai primi anni di governo di Gio-vanna II12, appare comunque palese che da lì s’irradiarono verso Romadeterminati elementi di novità, i quali trovarono nella cosiddetta «signo-ria dei napoletani»13 una sponda evidentemente ospitale. Lo attesta lapresenza in città del calligrafo Stephanus Masii de Aquila, la cui mano èstata rintracciata pure nelle decorazioni del Messale di Pere Serra14; altret-tanto vale per la categoria dei monumenti sepolcrali, come testimonia l’a-vello del cardinale partenopeo Marino Bulcano in Santa Maria Nova (l’at-tuale Santa Francesca Romana), datato intorno al 1394 (fig. 7). In questocaso non riguarda l’aspetto meramente esecutivo, per il vero ancora tuttoda sondare, bensì la ripresa di un preciso modello iconografico incentratosulle virtù teologali, il cui precedente va individuato nell’arca scompagi-nata del conte di Manoppello Giovanni Orsini, fatta eseguire dal figlioNapoleone II per la collegiata di Guardiagrele poco dopo il 138515.
È infatti cosa risaputa che il tema delle virtù si rinviene con una certaassiduità nei sepolcri trecenteschi, dove in veste di figure allegoriche essesostengono la cassa a mo’ di cariatidi, così come è noto che il suo avventonella scultura funeraria trova principio in Giovanni Pisano, mentre la
patronato artistico al principio del quattrocento 305
decenni del XIV secolo in ambito romagnolo (Forlì, reliquiario del Beato Salomoni, 1338), anchese con prodotti strutturalmente diversi. A conferma di un gusto di sapore veneto-romagnolo pre-sente nell’opera romana, vi è il caratteristico elemento decorativo della pigna smaltata di blu alcentro della volta a padiglione posta a copertura del manufatto. È possibile dunque ipotizzare chela committenza del cardinale Acciaiuoli fosse indirizzata ad una manifattura orafa abruzzese,allora attivissima, che sapeva fondere componenti toscane con altre tipicamente altoadriatiche.Così tra le due possibili produzioni, napoletana e abruzzese, è preferibile sostenere la seconda, nontanto per le tracce dell’influenza senese riscontrabili in entrambe le culture, quanto per la pre-senza di tratti provenienti dalla tradizione orafa dalle coste nordorientali della penisola, nonriscontrabile negli oggetti di sicura produzione napoletana che peraltro, per il loro esiguonumero, non consentono nemmeno di tracciarne un profilo ben definito».
12. Qui rimando ai recenti contributi in Universitates e Baronie (nota 3).13. A. Esch, Das Papsttum unter der Herrschaft der Neapolitaner: die führende Gruppe Neapolitaner
Familien an der Kurie während des Schismas 1378-1415, in Festschrift für Hermann Heimpel zum 70.Geburtstag am 19. September 1971, hg. v. Max-Planck-Institut für Geschichte, Göttingen 1972,vol. 2, pp. 713-800.
14. Manzari, Committenza (nota 7), in corso di stampa.15. Die Mittelalterlichen Grabmäler, Garms (nota 8), vol. 2, pp. 103-5. Il rimodernamento di
Santa Maria Nova negli anni 1608-1615 ha alterato il monumento Bulcano, oggetto di unrecente studio per i paralleli iconografici con l’arca di Giovanni Orsini – ora in frammenti nel-l’Antiquarium comunale di Guardiagrele – da parte di G. Pellini, Una rinvenuta testimonianza di etàtardo angioina: il sepolcro di Giovanni Orsini, in Santa Maria Maggiore a Guardiagrele. La vicendamedievale, a cura di P. F. Pistilli, Pescara 2005, pp. 120-9; Ead., Il monumento funebre di GiovanniOrsini, conte di Manoppello († 1384), in L’Abruzzo in età angioina. Arte di frontiera tra Medioevo eRinascimento. Atti del convegno internazionale di studi (Chieti, Campus Universitario, 1-2 aprile2004), a cura di D. Benati – A. Tomei, Cinisello Balsamo 2005, pp. 271-85.
successiva fortuna verso Meridione va imputata alle tombe angioinenapoletane del senese Tino di Camaino, per divulgarsi poi nelle provincedel Regno. Quanto detto non sembra verificarsi nella regione romanaprima dell’arca di Marino Bulcano, tuttavia rispetto all’ormai fissatoschema iconografico, qui, al pari del sepolcro guardiese, si registra uncambiamento sostanziale, in quanto le virtù vi compaiono impaginate neirilievi distribuiti sulla fronte del sarcofago. Se il ricorso a un tale espe-diente fu dettato anche dall’adozione della struttura a doppio blocco pog-giante a terra, è la sovrapponibilità delle raffigurazioni a dimostrare unvincolo parentale dell’esemplare romano dal precedente abruzzese (fig. 13),che non va spiegata nel rapporto diretto copia-modello, peraltro difficileda provare considerato l’evidente scarto stilistico dei due manufatti16.Piuttosto è ragionevole ipotizzare che la scelta di Bulcano fosse ricadutasu una soluzione già arrivata nell’Urbe, il che indicherebbe il presuntoantefatto nel perduto sepolcro del cardinale Tommaso Orsini, fratello delconte Giovanni di Manoppello17, deposto nella cappella familiare in SanPietro all’indomani del 1390.
Che per questo periodo le committenze strettamente private, circoscri-vibili all’ambito della produzione funeraria, facciano la parte del leone èun dato di fatto inoppugnabile per l’elevato numero di sopravvivenze,peraltro giunte di rado nella loro iniziale integrità. Questo genere di pro-dotti, già meticolosamente catalogati alcuni anni fa18, rientra pressochéin toto nella tradizione plastica di secondo Trecento. Nel novero dellearche a parete è in particolare il lignaggio del patronato ad incidere sullaqualità, l’articolazione e la ricchezza plastico-iconografica. I due sepolcripiù nobili furono confezionati rispettivamente da maestranze toscane edalla principale bottega operativa a inizi Quattrocento tra Roma e laTuscia, vale a dire quella che faceva capo al magister Paulus, da taluni rite-nuto esponente alla famiglia de Salvati, per altri nativo del borgo umbrodi Gualdo Cattaneo19.
306 pio francesco pistilli
16. Pellini, Una rinvenuta (nota 15), pp. 120-9; Ead., Il monumento funebre (nota 15), pp. 279-80.17. Sul loro rapporto di consanguineità si rimanda a B. Pio, I signori di Poggio Umbricchio e di
Poggio Ramonte (1239-1558), in «Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria», 84(1994), pp. 59-114 (p. 71).
18. Die Mittelalterlichen Grabmäler in Rom und Latium vom 13. bis zum 15. Jahrhundert, vol. 1:Die Grabplatten und Tafeln, bearb. v. T. Blittersdorf – H. Jäger-Sustenan, hg. v. J. Garms – R. Juf-finger – B. Ward-Perkins, Rom-Wien 1981 («Publikationen des Historischen Instituts beimÖsterreichischen Kulturinstitut in Rom», II/5,1) e vol. 2: Die Monumentalgräber (nota 8).
19. Sulla figura di questo marmoraro, vedi S. Cesari, Magister Paulus. Uno scultore tra XIV e
Appare oggi come una strana coincidenza che il monumento di Phi-lippe d’Alençon, risalente al 1397, e l’avello di Pietro Stefaneschi del141720 (fig. 8), si trovino affiancati in un tardo e scomposto rimontaggiosulla testata meridionale del transetto di Santa Maria in Trastevere. Adun’impresa condotta da scultori orcagneschi del tutto marginali al conte-sto romano si contrappone l’esito dell’iter artistico di magister Paulus, quial servizio del mondo cardinalizio21, ma entrambi i casi paiono accomu-nati nella tronfia apoteosi di formule funerarie che cederanno il passo,seppur lentamente e in principio ben al di fuori dei territori pontifici, apiù aggiornati modelli protorinascimentali di matrice fiorentina. Lodocumenta in primis la tomba ad arcosolio del retrocesso cardinale Bal-dassarre Cossa nel battistero di Firenze, quindi l’arca di Rinaldo Bran-caccio scolpita da Donatello e Michelozzo per l’oratorio napoletano diSant’Angelo in Nilo e ultimata nel 1428.
Piuttosto, di maggior interesse è il dato che emerge dall’analisi dellelastre terragne. Qui colpisce l’accentuata standardizzazione dei manufattiattraverso un modello le cui varianti sono consegnate al ritratto deldefunto e, per ovvie ragioni, ai blasoni di appartenenza. Inscritti in unacornice gotica alquanto convenzionale, inquadrata da un’archeggiatura atriplice guglia, questi prodotti sono destinati a Roma alle gerarchieecclesiastiche più elevate (cardinali, ma non mancano alcuni vescovi) e laloro fortuna sembra racchiudersi tra il pontificato di Bonifacio IX e l’av-vio del governo romano di Martino V: dal 1396 con la lastra per il car-dinale bolognese Bartolomeo Mezzavacca in Santa Maria Maggiore, perpoi passare per le tombe di Antonio Palosio in Santa Maria Maggiore(1398), di Antonio Caetani e di Francesco Aguzzoni, entrambe del 1412e rispettivamente in Santa Maria sopra Minerva e Santa Maria Nova(fig. 9), giungendo infine a quella perduta del veneziano Pietro Morosinidi nuovo in Santa Maria Nova e datata al 142422.
patronato artistico al principio del quattrocento 307
XV secolo, Roma 2001; inoltre P. C. Claussen, Magistri Doctissimi Romani. Die römischen Mar-morkünstler des Mittelalters, Stuttgart 1987, p. 234; Die Mittelalterlichen Grabmäler, Garms (nota 8),vol. 2, pp. 126-9.
20. Die Mittelalterlichen Grabmäler, Garms (nota 8), vol. 2, pp. 119-29.21. Riguardo l’attività romana del magister Paulus, questa è autografa per l’arca del cardinale
Stefaneschi e, in precedenza, per il sepolcro di Bartolomeo Carafa in Santa Maria del Priorato,giustiziato nel 1405, opera schedata in Die Mittelalterlichen Grabmäler, Garms (nota 8), vol. 2, pp.112-5.
22. Sulle lastre terragne qui citate, si rimanda a Die Mittelalterlichen Grabmäler, Garms (nota18), vol. 1, pp. 171-3, 180-1, 196-8. Va tuttavia segnalato che nel caso del cardinale Antonio Cae-tani, morto il 12 gennaio 1412, la tomba era in principio ubicata nella cappella di Bonifacio VIIIin Vaticano, da dove fu in seguito trasferita in Santa Maria sopra Minerva per essere finalmentecollocata nell’ambiente antistante la sagrestia (ibid., pp. 180-1).
Se già l’ampio lasso cronologico di quasi tre decenni esclude che essesiano uscite dalla medesima bottega, la ricorrenza seriale indica unascelta giunta dall’alto e di fatto alternativa al tradizionale baldacchino,forse richiesta da un’ala in seno alla Curia tesa a dare di sé un volto piùdimesso, in consonanza con la crisi a vari livelli causata dello Scisma,oltre che dall’effettiva difficoltà di reperire sul posto maestranze atte adimprese più impegnative. Di sicuro si tratta di una linea che la rinascitadi Roma come centro della cristianità farà venire meno, senza tuttaviaimpedire indirizzi simili e per certi versi consapevolmente pauperisti,come testimonia la lastra tombale del cardinale Guillaume Fillastre inSan Crisogono (fig. 10), ridotta in pratica alla sola epigrafe entro unacornice di sapore ancora cosmatesco23.
Ben poco si può invece osservare sul patronato cardinalizio durante idue anni di pontificato di Innocenzo VII e nel successivo e più criticopapato di Gregorio XII. Al di là dell’elevazione al cardinalato nel 1405di personalità che solo in seguito avranno un acclarato ruolo nel patroci-nio artistico, e tra questi tanto Oddone Colonna quanto i romani Gior-dano Orsini e Pietro Stefaneschi, il tutto sembra per ora restringersi altabernacolo Brancaccio, un tempo sulla testata settentrionale di SantaMaria in Trastevere e copiato dall’Eclissi nel Seicento24. Datato tra il1404 e il 1406, epoca in cui il cardinale ricevette la commenda dellabasilica e oggi rovinosamente conservato nella sagrestia, l’affresco dimatrice fiorentina raffigurava nella lunetta la Madonna in trono con ildonatore inginocchiato (fig. 9), mentre i due pannelli del sottarco conte-nevano san Michele Arcangelo e, presumibilmente, il Battista.
A rompere questa situazione di stallo contribuisce in maniera inattesala presa di Roma da parte dei pontefici di obbedienza pisana a discapitodi Gregorio XII. Il lento rientro della Curia nell’Urbe dopo il biennio didominio durazzesco, sancito nell’aprile del 1411 dall’entrata in città del-l’antipapa Giovanni XXIII, la volontà di stabilire nuove relazioni conLadislao dopo la sconfitta delle truppe napoletane a Roccasecca nelmaggio seguente – vittoria che come è noto non fu colta dal pretendenteal trono meridionale Luigi II d’Angiò – è alla base di un primo salto diqualità del patronato cardinalizio, il cui collegio in giugno veniva inner-
308 pio francesco pistilli
23. Ibid., pp. 71-2.24. S. Romano, Eclissi di Roma. Pittura murale a Roma e nel Lazio da Bonifacio VIII a Martino V
(1295-1431), Roma 1992, p. 404.
vato di altre quindici nomine, tra cui quelle di Ludovico Adimari, Guil-laume Fillastre e del lombardo Branda Castiglioni.
Dunque, se per un verso si cercava di riorganizzare su nuove basi la com-pagine curiale e si risanavano le sedi del potere25, dall’altro si faceva pres-sante la volontà di riprendere il controllo dei territori a confine con ilRegno di Napoli che l’aggressione durazzesca aveva messo in discussione eche ancora restavano a rischio. Le attenzioni si rivolgevano soprattutto indirezione dell’agro meridionale di Roma, la cui riacquisizione fu tempora-neamente ratificata dalla pace stipulata sulla spiaggia del Circeo, nelgiugno del 1412, tra Ladislao e il cardinale Brancaccio, ma anche al settoreverso gli Abruzzi attraversato dalla via Tiburtina. Qui l’accorta condotta diBranda Castiglioni, avviata ancor prima della sua elevazione al cardinalato,aveva consentito con l’avallo delle baronie locali la sostituzione dei Bene-dettini a Riofreddo e a Vicovaro con gli Ambrosiani ad nemus, congrega-zione con cui dal 1419 condividerà pure la gestione della basilica romanadi San Clemente di cui era diventato nel frattempo titolare26.
Rimandando per motivi cronologici al ministero di Martino V l’affre-scatura dell’oratorio dell’Annunziata a Riofreddo27, frutto dei tempi siconfigura la fondazione di un’altra cappella dedicata all’Annunziata,quella di Cori, nella Marittima28 (fig. 1). Sorta nel suburbio di un centroinnalzatosi a libero comune già al principio del Duecento e lungo l’assestradale che ancor oggi mette in comunicazione la cittadina dei Lepinialla via Appia, l’istituzione corese costituisce pure la pietra miliare dellaripresa artistica di questo lembo tirrenico del Lazio meridionale, che neidecenni precedenti era stato depredato dall’azione di Onorato I Caetani equindi martoriato dalla breve occupazione durazzesca29.
patronato artistico al principio del quattrocento 309
25. Sugli interventi finalizzati al ripristino del corridoio del «passetto» che collegava il Vati-cano a Castel Sant’Angelo, si veda R. Valentini – G. Zucchetti, Codice topografico della città diRoma, Roma 1953, vol. 4, p. 110; D’Onofrio, Castel S. Angelo (nota 3), p. 178, p. 197, per ilquale l’impresa non risalirebbe all’estate del 1411, ma al 1415.
26. Sul radicamento nel Sublacense degli Ambrosiani, dove nel 1398 subentrarono nel mona-stero di San Giorgio a Riofreddo e dieci anni dopo nel San Cosimato a Vicovaro, si rimanda a L.Di Calisto, «Super hanc columnam reedificabo ecclesiam meam». L’oratorio della SS. Annunziata di Rio-freddo: committenza Colonna tra percorsi devozionali e politica assistenziale, in Universitates e Baronie(nota 3), vol. 2, pp. 237-40.
27. Romano, Eclissi (nota 24), pp. 477-82; e da ultimo Di Calisto, «Super hanc columnam»(nota 26), pp. 226-47.
28. Pistilli, Una committenza (nota 1), pp. 233-40; Pistilli – Petrocchi, El oratorio (nota 1), pp.35-57. Inoltre sull’oratorio corese è in corso di pubblicazione una monografia a cura dello scrivente.
29. Per un quadro storico dell’Agro pontino a cavallo del 1400, si veda G. Pesiri, La Marit-tima nel secolo XV: il contesto ecclesiastico e politico, in La carriera di un uomo di curia nella Roma delQuattrocento. Ambrogio Massari da Cori, agostiniano: cultura umanistica e committenza artistica, a cura
Soltanto il recente riconoscimento del blasone cardinalizio, affrescato alato dell’Annunciazione, nelle armi del castigliano Pedro Fernández deFrías (fig. 16) ha consentito di inquadrare l’operazione nella giusta pro-spettiva storica. Venuta così a cadere la tradizionale datazione tardotre-centesca, costruita su un’errata identificazione dello stemma attribuito aun tal Petrus Hispanus elevato alla porpora cardinalizia nel 137830, l’ora-torio di Cori emerge ora come la testimonianza più concreta di un direttocoinvolgimento della Curia romana teso a risollevare le retrovie dellostrategico confine meridionale. Allo stato attuale delle indagini, è comun-que problematico comprendere perché fu scelta Cori, che già il 5 febbraio1410 aveva ripristinato il suo status di feudo del Senato e Popolo diRoma31, mentre il patrocinio di Fernández de Frías va ragionevolmentericondotto alla carica di rettore della provincia di Campagna e Marit-tima, riconosciutagli nel giugno del 1410 da Giovanni XXIII32. Disicuro tanto il comune locale, rappresentato dallo stemma lapideo in fac-ciata, quanto l’ecclesiastico castigliano collaborarono all’unisono inquesta operazione che, rimasta sospesa nel 1413, sarà portata avanti dopoil 1426 da altri suoi connazionali, ovvero i cardinali Alfonso Carrillo deAlbornoz e Juan Cervantes de Lora, nel rispetto della memoria del fon-datore, come certifica la scritta sopra l’ingresso che nel recitare «DE SPA-GNIA FVIT QVI ME LEGERIT DICAT VNV(M) PATER N(OSTE)R P(RO) A(N)I(M)AMEA», dimostra il decesso del Frías, avvenuto a Firenze nel 1420.
Si diceva che l’iniziativa promossa nell’inoltrato 1410 fu abbandonataprima del giugno del 1413 in coincidenza dell’affrescatura della volta perla precipitosa fuga del committente da Roma, occupata per la secondavolta da Ladislao di Durazzo. Nel frattempo l’impresa aveva interessatol’elevazione del modesto oratorio rettilineo, in linea con l’architetturadelle cappelle gotiche, non solo romane33, così come si era avviato un
310 pio francesco pistilli
di C. Frova – R. Michetti – D. Palombi, Roma 2008, pp. 137-60 (pp. 138-49); per le vicendeartistiche, si rinvia a P. F. Pistilli, Arte e architettura nei domini Caetani della Marittima dal 1297alla fine del XV secolo, in Bonifacio VIII, i Caetani e la storia del Lazio. Atti del convegno di storici(Roma, Palazzo Caetani, 30 novembre 2000; Latina, Palazzo «M», 1 dicembre 2000; Sermoneta,Castello Caetani, 2 dicembre 2000), Roma 2004, pp. 81-116 (pp. 90-2).
30. Così lo identificava F. Hermanin, Le pitture della cappella dell’Annunziata a Cori presso Roma,in «L’Arte», 9 (1906), pp. 45-52, sulla scorta del repertorio di A. Ciaconius – A. Oldoinus, Vitaeet res gestae Pontificum Romanorum et S.R.E. Cardinalium, Romae 1677, vol. 2, coll. 649-50.
31. P. L. De Rossi, Cori all’epoca di Ambrogio: nuovi assetti istituzionali, in La carriera di un uomodi curia, Frova (nota 29), p. 130 e n. 18.
32. Un aggiornato ritratto è proposto da W. Decker, Fernández de Frías, Pedro, in Dizionariobiografico degli Italiani, Roma 1996, vol. 46, pp. 347-50.
33. La radice architettonica ancora cistercense dell’Annunziata trova illustri precedenti fuoridall’ordine dalla metà del Duecento, tanto a Roma quanto in altri contesti dell’Italia centrale.
programma decorativo volutamente esemplato anche nei tituli cheaccompagnano ciascun episodio veterotestamentario sul modello propostodall’antica basilica di San Pietro34, di cui Fernández de Frías ricoprì lacarica di arciprete dal 28 gennaio 1412. Se quest’ultimo termine crono-logico sottintende come di poco successiva l’esecuzione dei murali, ilmonumento nel suo portato architettonico e pittorico si configura ancorafiglio di una tradizione artistica ancorata al passato, così da giustificarechi ne aveva fissato la datazione al secolo precedente35. D’altronde il solocardinale ispanico allora operativo per Giovanni XXIII, che per evidentimotivi politici rimaneva isolato dal contesto culturale di appartenenza, siera dovuto giocoforza piegare a quanto Roma e il suo stretto circondariooffriva a quell’altezza cronologica. E come emerge dai radi frammentisuperstiti in area romana, ciò era davvero ben poca cosa36. L’evergetismodi Fernández de Frías, quindi, si carica indirettamente di un ulteriorevalore, quale testimonianza al più alto livello dell’arte locale prima delradicale rinnovamento dell’età di Martino V. Ciò vale soprattutto per laqualità della costruzione, piuttosto che per i deboli murali della parete difondo e dell’imbotte della volta, spesso alterati da pesanti ridipinture. Difatto, è l’apparecchio murario in blocchi squadrati di calcare e tufo asopravanzare le fabbriche coeve o di poco precedenti37, anticipando, nelsuo forzato isolamento cronologico, gli esiti del grande cantiere pontifi-cio di Genazzano, avviato nel terzo decennio del secolo38.
Risolti a Costanza i problemi interni allo Scisma, si entra di dirittonella fase martiniana, indubbiamente quella in cui si assiste a una vera e
patronato artistico al principio del quattrocento 311
Oltre al caso della cappella di San Silvestro nel palazzo cardinalizio dei SS. Quattro Coronati, con-sacrata nel 1246 (L. Barelli, Il palazzo cardinalizio dei SS. Quattro Coronati a Roma nel bassoMedioevo, in Il Lazio tra Antichità e Medioevo. Studi in memoria di Jean Coste, a cura di Z. Mari – M.T. Petrara – M. Sperandio, Roma 1999, pp. 111-24), finalità anche funzionali di edificio di cultoal servizio dei viandanti accomunano l’Annunziata di Cori all’oratorio benedettino di San Pelle-grino a Bominaco nell’Abruzzo aquilano, eretto dall’abate Teodino nel 1263 (M. Moretti, Archi-tettura medioevale in Abruzzo (dal VI al XVI secolo), Roma s. d. [1971], pp. 414-21).
34. H. L. Kessler, L’antica basilica di San Pietro come fonte e ispirazione per la decorazione delle chiesemedievali, in Fragmenta picta. Affreschi e mosaici staccati del Medioevo romano, catalogo a cura di M.Andaloro et alii, Roma 1989, p. 60.
35. Hermanin, Le pitture (nota 30), pp. 45-62; Romano, Eclissi (nota 24), pp. 448-52.36. Ibid., p. 379.37. Stridente è il confronto con quanto è noto dei cantieri di Bonifacio IX, la cui fattura non
era apprezzata già alla metà del Quattrocento, stando alle affermazioni di Flavio Biondo sui lavorinel Palazzo Senatorio, in Roma ristaurata, et Italia illustrata, Vinegia 1558, lib. I, § 73, p. 16r.
38. P. F. Pistilli, La rifondazione di Genazzano ai tempi di Martino V, in Martino V. Genazzano,il Pontefice, le Idealità. Studi in onore di Walter Brandmüller, a cura di P. Piatti – R. Ronzani, Roma2009, pp. 127-49.
propria escalation della committenza cardinalizia che – com’è noto ai più– contribuirà, al pari degli interventi pontifici successivi al 1425, ad uneffettivo rinnovamento architettonico e soprattutto artistico, sia in sensotardogotico, sia facendo incubare nell’Urbe i germi del Rinascimento. Inogni caso, il tutto appare quasi sempre vincolato al mondo culturale fio-rentino, anche quando si tratta di artisti di origine marchigiana, qualierano Arcangelo di Cola da Camerino o Gentile da Fabriano. Tuttavianon è di questo che voglio parlare, dato che i capisaldi di una siffattarinascita (dagli affreschi gentileschi nel Laterano alla cappella masoli-niana in San Clemente) sono già stati ampiamente indagati39, ma diquando prese il via questa nuova stagione, di come si mossero alcuni por-porati e delle diverse finalità della loro azione.
Appare subito chiaro che l’avvio del patronato cardinalizio non coin-cide né con l’elezione del pontefice nel novembre del 1417 né, tantomeno, con il suo arrivo a Roma, che cade il 30 settembre 1420. Molte-plici sono i motivi di una siffatta inattività: in primo si aspettava chefosse riconosciuto il consolidamento del potere colonnese in seno allaCuria, quindi la sicurezza che Roma fosse rielevata ad unica capitale dellaCristianità e tanto più dopo le aspre discussioni sorte all’indomani del-l’elezione di Martino V circa il luogo in cui egli avrebbe dovuto fissare lasede papale. Alla luce di quanto era accaduto nei due decenni precedentie con un collegio costituito ora anche da personalità che a Roma, comenei territori pontifici, non avevano mai messo fisicamente piede, è ragio-nevole che in molti cardinali vi fosse una certa riluttanza ad investire lapropria immagine (e, perché no, i propri averi) in un progetto piuttostorischioso e in una città da tempo in stato di rovina, priva ancora di unsuo nerbo culturale e artistico.
D’altronde, durante gli anni che corrono dal 1420 al 1424, la riacquisi-zione di Roma, come il controllo di larghi distretti del Lazio e dello Statodella Chiesa (rappresentativo è il caso della collegiata marchigiana di SanGinesio, dove nella lapide commemorativa dei lavori della facciata comparenel 1421 e, in assoluto per la prima volta, il nome di Martino V40), ha
312 pio francesco pistilli
39. Per gli affreschi lateranensi si rimanda alle schede sia in Gentile da Fabriano e l’altro Rina-scimento, catalogo a cura di L. Laureati – L. Mochi Onori, Milano 2006, pp. 306-7 sia in La pit-tura medievale a Roma, 1312-1431. Atlante percorsi visivi, vol. 1: Suburbio, Vaticano, Rione Monti, acura di M. Andaloro, Viterbo-Milano 2006, pp. 193-202, mentre per il ciclo commissionato daBranda Castiglioni in San Clemente, vedi St. Roettgen, Wandmalerei der Frührenaissance in Italien,vol 1: Anfänge und Entfaltung 1400-1470, München 1996, pp. 118-35.
40. C. Marchegiani, Il frontespizio in terracotta della pieve di San Ginesio. Una proposta gotica ale-manna nella marca di Martino V, in I Da Varano e le arti. Atti del convegno internazionale (Came-
quale protagonista il pontefice, coadiuvato quasi esclusivamente dai suoistretti familiari: i fratelli Giordano e Lorenzo. Credo superfluo enumerarequi gli interventi architettonici, urbanistici e, in misura assai minore,artistici di questa fase di acquartieramento41, se non per ricordare comele imprese romane e nel contado riprendano in senso generale, ma conuna maggiore intensità e determinazione, le linee guida tracciate oltrevent’anni prima dal pontificato di Bonifacio IX. Innanzitutto il controllodei luoghi del potere, quindi dei punti strategici della città e del sistemadi accesso viario e fluviale (si pensi all’innalzamento della torre cilindricaad Ostia Antica42), senza mancare di sostenere la nascita di nuovi ospe-dali anche a carattere nazionale43, forse in previsione del fallito Giubileodel 1423. La gran parte di queste iniziative, e nella fattispecie quellefamiliari nella zona dei Santi Apostoli44, non vedono altri attori che iColonna, gli stessi che nel 1420 avevano intrapreso la rifondazione del-l’avito borgo prenestino di Genazzano a partire dall’antica parrocchiale diSan Nicola, consacrata nel dicembre del 1421 dall’allora Patriarca diCostantinopoli Giovanni de Rupescissa ed elevata immediatamente alrango di collegiata45. Un progetto, quest’ultimo, prettamente baronale,nel cui prosieguó furono coinvolte soltanto le famiglie locali arricchitesiall’ombra del pontefice46, ma che comunque ebbe un sicuro riflesso nel-
patronato artistico al principio del quattrocento 313
rino, Palazzo Ducale, 4-6 ottobre 2001), a cura di A. G. De Marchi – P. L. Falaschi, AscoliPiceno 2003, vol. 2, pp. 637-54.
41. L. von Pastor, Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo, nuova versione italiana a cura di A.Mercati – P. Cenci, Roma 1958, vol. 1, pp. 226-31; A. M. Cerioni, Censimento delle operazioniarchitettoniche e artistiche in occasione dei Giubilei del 1390, del 1400 e del 1423, in Roma 1300-1875,Fagiolo – Madonna (nota 2), pp. 84-6; G. Lombardi, La città, libro di pietra. Immagini umanistichedi Roma prima e dopo Costanza, in Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431). Atti delconvegno (Roma, 2-5 marzo 1992), a cura di M. Chiabò – G. d’Alessandro – P. Piacentini – C.Ranieri, Roma 1992 («Nuovi studi storici», 20), pp. 17-46; C. Bianca, Martino V, in Enciclopediadei Papi, Roma 2000, vol. 2, pp. 619-34.
42. S. Pannuzi, Il castello di Ostia Antica: analisi delle fasi costruttive, in Il castello di Giulio II adOstia Antica, a cura di S. Pannuzi, Firenze 2009, pp. 23-60 (pp. 23-9).
43. F. Colonna, Distribuzione urbana e tipologie degli edifici assistenziali, in Roma. Le trasformazioniurbane nel Quattrocento, a cura di G. Simoncini, Firenze 2004, vol. 2, pp. 159-88 (pp. 162-3).
44. L. Finocchi Ghersi, Le residenze dei Colonna ai Santi Apostoli, in Alle origini della nuova Roma(nota 41), pp. 61-75.
45. Pistilli, La rifondazione (nota 38), pp. 134-49; ed anche M. Lucci, Le vicende architettonichedella chiesa di San Nicola di Bari a Genazzano all’epoca di Martino V, in Martino V. Genazzano, Piatti– Ronzani (nota 38), pp. 201-17.
46. A. Rehberg, Etsi prudens paterfamilias... pro pace suorum sapienter providet. Le ripercussioni delnepotismo di Martino V a Roma e nel Lazio, in Alle origini della nuova Roma (nota 41), pp. 225-82(pp. 242-54); Id., Uomini di fiducia e collaboratori di Martino V provenienti da Genazzano e dintorni:le origini socio-culturali del papa Colonna e i loro effetti sul suo pontificato, in Martino V. Genazzano,Piatti – Ronzani (nota 38), pp. 53-85 (pp. 77-85).
l’evergetismo di uno dei maggiori collaboratori del papa, il cardinaleBranda Castiglioni. Fu infatti egli a promuovere la nuova veste ediliziadel suo feudo lombardo di Castiglione Olona47 (anche in questo caso ini-ziando dalla ricostruzione della collegiata, tra il 1422-1425), che già ilvescovo pavese Francesco Pizolpasso definì una sorta di città ideale48, cosìcome avrebbe dovuto essere l’abitato di Genazzano, qualora fosse statoportato a totale compimento.
Appurata oggi l’estraneità della Curia all’operazione genazzanese, cheappare invece di natura squisitamente feudale e in forme architettonichedurazzesche, per evidenti ragioni politico-territoriali vincolate ai rapporticon la corte di Giovanna II che meriterebbero di essere approfondite, perravvisare il risorgere della committenza cardinalizia nell’Urbe e nel cir-condario laziale si deve attendere il biennio 1425-1426. Consolidatosi ilpotere pontificio e il suo dominio sul suburbio, cui aveva certo giovato lamorte di Braccio da Montone nell’assedio dell’Aquila, innescato il risana-mento urbano che proprio in quel torno di anni rilevava una risalita deivalori immobiliari49, le condizioni erano ora mature. Nel caso di Romafu lo stesso Martino V, ormai privo dell’appoggio del defunto fratelloGiordano, a sollecitare i membri del collegio cardinalizio a proporsi comeprotagonisti, restaurando in primis le proprie residenze cittadine50, maanche promovendo il risanamento materiale e spirituale di quei mona-steri che erano stati loro affidati. È il caso di San Paolo fuori le mura, nelquale il cardinale veneto Gabriele Condulmer introdusse nel 1426 iCanonici regolari di San Giorgio in Alga e, attraverso il priore LudovicoBarbo, fece trasformare l’ala duecentesca del cenobio prospiciente la viaOstiense nel dormitorio delle «quaranta celle», poi smantellato per farposto al cinquecentesco Corridoio del Silenzio51.
314 pio francesco pistilli
47. Su questo punto rimando a P. Carol, Early Renaissance Sculpture and Architecture at Casti-glione Olona in Nothern Italy and the Patronage of a Humanist, Cardinal Branda Castiglione, Ph. D.University of Texas at Austin, Ann Arbor-London 1989, testo che purtroppo non ho avuto mododi consultare perché irreperibile.
48. T. Foffano, La costruzione di Castiglione Olona in un opusculo inedito di Francesco Pizolpasso, in«Italia medioevale e umanistica», 3 (1960), pp. 153-87.
49. M. Vaquero Piñeiro, Il mercato immobiliare, in Alle origini della nuova Roma (nota 41), pp.555-69; G. Curcio, «Nisi celeriter repararetur totaliter est ruitura». Notazioni su struttura urbana e rin-novamento edilizio in Roma al tempo di Martino V, ibid., pp. 537-54; Simoncini, Topografia (nota 5),pp. 78-80.
50. R. W. Kennedy, The Contribution of Martin V to the Rebuilding of Rome, 1420-1431, in TheRenaissance Reconsidered. A Symposium, ed. by L. Gabel, Northampton 1964, p. 34.
51. Il compito di rifondare la basilica con il monastero fu affidato dal cardinale al connazio-nale Ludovico Barbo, commendatario di San Giorgio in Alga e suo superiore a Venezia tra il 1404
In definitiva, si trattava di un salto di qualità improcrastinabile, con-comitante sia con la decisione pontificia di ripristinare la pericolantebasilica lateranense sia nell’improntare finalmente a immagine delColonna la Curia, tramite la creazione di nuovi porporati. Purtropposulla loro attività edificatoria romana ben poco conosciamo sotto l’aspettodelle scelte in campo architettonico52. Del tutto perduto è infatti ilfastoso palazzo di San Lorenzo in Lucina, lungo la via Lata e sul fiancoorientale dell’omonima basilica, laddove fu poi ritrovata l’Ara Pacis53. Ilcomplesso fu risanato all’indomani del 15 settembre 1427 dal neo-cardi-nale rotomagense Giovanni de Rupescissa54, il cui patrocinio era traman-dato da una lapide già perduta al tempo di Fioravante Martinelli, chereperì il testo in un codice della Biblioteca Vaticana55. Identico discorso
patronato artistico al principio del quattrocento 315
e il 1408. Fondatore della Congregazione nota come De Unitate, Barbo reggeva allora la comunitàpadovana di Santa Giustina e giunse a Roma al principio del 1426, come riferisce I. A. Schuster,La Basilica e il Monastero di S. Paolo fuori le Mura: note storiche, Torino 1934, pp. 183-9. Al suoarrivo la situazione doveva essere talmente disastrosa «Si aliquae circa claustrum mansiunculaecum tecto supererant. Illae pro porcorum et pecorum stabulo extiterant usurpatae; et talia inmonastero, qualia in ecclesia cohabitabant animalia bruta»; pertanto «Mentis conceptu ad repara-tionem se totum convertit (…) etiam ipsum dormitorium mensuravit et cellas quadragintaibidem costruenda concepit (…) ad suo tempora per ipsum perficiendum effectualiter persevera-vit», stando al Thesaurus anecdotorum novissimus, ed. B. Pez, Augustae Vindelicorum 1721, vol. 2,3, fol. 302; inoltre vedi R. Krautheimer, in Corpus Basilicarum Christianarum Romae. Le basilichecristiane antiche di Roma (Sec. IV-IX), a cura di R. Krautheimer – S. Corbett – W. Frankl, Città delVaticano 1980, vol. 5, p. 106, che invece riporta un testo di identico tenore tratto da F. Marti-nelli, Roma ex ethnica sacra Sanctorum Petri et Pauli apostolica praedicatione profuso sanguine exposita,Romae 1653, pp. 272-3. A questa campagna di lavori va forse ricondotto anche l’affresco con ilCristo crocifisso, ritrovato nel 1906 nell’area del dormitorio quattrocentesco e poi trasferito nellacappella dei Conversi, di recente attribuito a Gentile da Fabriano da G. Polverelli, Problematichegentilesche nella Roma di Martino V, in Universitates e Baronie (nota 3), vol. 2, pp. 269-79.
52. Un quadro riassuntivo sulle dimore cardinalizie, sebbene allargato a tutto il Quattrocento,è offerto da M. G. Aurigemma, Residenze cardinalizie tra inizio e fine del ’400, in Roma. Le trasfor-mazioni urbane nel Quattrocento, Simoncini (nota 43), vol. 2, pp. 117-36; S. Sperandei, Repertoriodelle residenze cardinalizie, ibid., pp. 137-58.
53. Secondo Krautheimer, il complesso (ora palazzo di Fiano) era costituito da «un vastoagglomerato di edifici incongrui con tre torri agli angoli nord-ovest, nord-est e sud-est ed unalunga ala, parallela, ma non contigua a via del Corso (…). Invero ancora nel 1662 una torremedievale o quattrocentesca del vecchio palazzo sorgeva nell’angolo sud-est presso il Corso. E finoa quella data un arco trionfale romano, forse eretto da Adriano [Arco di Portogallo], era contiguoal muro est della torre e sormontava via Lata», in Corpus Basilicarum Christianarum Romae. Le basi-liche cristiane antiche di Roma (Sec. IV-IX), a cura di R. Krautheimer – S. Corbett – W. Frankl,Città del Vaticano 1962, vol. 2, pp. 165-8.
54. A quella data Martino V ordinava ai conservatori di spendere 63 fiorini «de pecuniisCamere alme Urbis (...) pro mundatura palatii Sancti Laurentii in Lucina», in A. M. Corbo, Arti-sti e artigiani in Roma al tempo di Martino V e di Eugenio IV, Roma 1969, p. 63.
55. Il testo dell’epigrafe, trascritto da F. Martinelli, Roma ricercata nel suo sito, e nella scuola ditutti gli antiquarij, Venetia 1677, p. 138, e quindi V. Forcella, Iscrizioni delle chiese e d’altri edificiidi Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri, Roma 1874, vol. 5, p. 120 nr. 345, così recitava: «MILLE
QVADRINGENTIS DOMINI LABENTIBVS ANNIS / VIGINTI SEPTEM ADIVNCTIS QVO TEMPORE PASTOR /
vale per i lavori promossi dall’ambizioso Alfonso Carrillo de Albornozper la sua dimora. Stabilitosi a Roma nel febbraio del 1424, il prelatocastigliano avviava il rimodernamento della magione nei SS. QuattroCoronati, titolo cui associava le cariche di camerlengo del collegio cardi-nalizio e, dal marzo del 1428, di arciprete della basilica lateranense insostituzione dell’ottuagenario Guillaume Fillastre56. Di questa impresasopravvivono modeste reliquie del corredo plastico. Oltre all’iscrizionemetrica murata sopra l’ingresso alla prima corte del monastero, si conser-vano un concio con il blasone familiare appartenente ad una bifora e, pre-sumibilmente, la parte inferiore della parete che chiude lo stesso cortile sullato verso l’ospedale militare del Celio, la cui muratura differisce da quelleimpiegate nella fabbrica altomedievale e moderna. Lo stringato contenutodell’epigrafe (fig. 12) che esprime lo status fisico nel quale versava l’inse-diamento e l’impegno economico profuso nel risanarlo, si conclude con unperentorio «DVM SEDET EXTINCTO MARTINVS SCISMATE QVINTVS», tutti ele-menti (e credo che non si tratti di pura coincidenza) presenti anche nellaprolissa iscrizione già murata nel palazzo di San Lorenzo in Lucina. Aseguire, un ulteriore intervento fu messo in opera dal cardinale GiordanoOrsini per aggiornare la dimora della sua casata a Monte Giordano, nellaquale sappiamo che fu appositamente realizzata una sala theatri – dipinta
316 pio francesco pistilli
MARTINVS QVINTVS PRIVS ODDO A STIRPE COLVMNA / ECCLESIAM AC POPVLOS TRANQVILLA IN PACE
REGEBAT / IVSTITIA AC PIETATE SIMVL QVI FROENA SVPERBIS / IMPOSVIT VIRTVTE SVA DOMVITQ(VE)REBELLES / EXPVLIT INVISOS PATRIA DE SEDE TYRANNOS / RAPTORESQ(VE) TRVCES PEREGRINIS
OMNIBVS VRBEM / FECIT ITER TVTVM NEC TEMPORE TVTIVS VLLO / CASTRA VRBES IVRA ECCLESIAE
DISTRACTA PER ANNOS / AD DOMINVM REDIERE SVVM ET SVBIECTA FVERE / VRBS ETIAM ROMANA SVI
NON PARVA RECEPIT / INCREMENTA NEC VNQVAM IN TANTA PACE QVIEVIT / ROTHOMAGI PATER ET
PRAESVL VENERANDVS AD VRBEM / ROMVLEAM VENIT RVPE DE SCISSA IOANNES / CARDINE APOSTOLICO
DOMINO DECORATVS AB IPSO / HVIVS ET ECCLESIAE TITVLO REMANENTE PRIORI / ROTHOMAGI ECCLE-SIAE MERITO COGNOMINE PATRI / ISTE DOMVM QVASI COLLAPSAM ET PROSTATA RVINAE / FVNDAMENTA
VIDENS NAM VT PRISCA RECENSVIT AETAS / VNVS CARDINEO ANTISTES PRAECLARVS HONORE /ANGLICVS HAEC OLIM FVNDASSE PALATIA FERTVR / VLTRO OPVS AGGREDITVR TEMPLVMQ(VE)DOMVMQ(VE) CADENTEM / CVNCTA NOVANS REPARAT PARTMQ(VE) PALATIA TEMPLI / FVNDITVS INSTAV-RAT SVBLATAQ(VE) IVRA REDEMIT / CVI DECVS ET MERITAE MANENT PER SECVLA LAVDES». Il palazzoquattrocentesco, ancora in uso al principio del XVII secolo, era stato costruito inizialmente dalcardinale inglese Ugo di Evesham tra il 1281 e il 1287. Emblematico è il giudizio che ne dàintorno al 1445 Flavio Biondo in Roma ristaurata, lib. II, § 15, p. 28r: «[il palazzo] che Gio-vanni de Gallijs Piccardo Cardinal Morine(n)se hora habita, e che nel 1300 il cardinale Anglicov’edificò, et hora sono 20 anni, che’l Cardinal Rotomagense [Giovanni de Rupescissa] con moltaspesa l’ampliò, et il detto Cardinal Morinense l’ha hora così magnificato, che dal palazzo di s.Pietro in fuora, non ha Roma cosa più bella». Tuttavia egli dimentica che tra il 1437 e il 1440la dimora era passata al cardinale Giovanni Vitelleschi, sotto il quale sono attestati nuovi lavorinel biennio 1439-1440, come documenta Corbo, Artisti e artigiani (nota 54), pp. 63-5.
56. Per un profilo biografico, v. A. Strnad, Carrillo de Albornoz, Alfonso, in Dizionario biograficodegli Italiani, Roma 1977, vol. 20, pp. 753-8.
da Masolino tra il 1430 e il 1432 con un ciclo di «Uomini illustri» –dove i primi circoli umanistici celebravano le loro riunioni57. D’altronde,che in queste sedi ciascun cardinale tenesse corte cum magno statu, lo affer-ma Enea Silvio Piccolomini nel De viris illustribus proprio per Carrillo deAlbornoz, riferendosi quindi ad un momento precedente al giugno 1431,allorché il prelato castigliano lasciò Roma per non farvi più ritorno58.
A questo punto ritengo opportuno sorvolare sul patronato romano,perché appare scontato parlare delle opere di artisti quali Gentile daFabriano, Masolino o Masaccio, il cui soggiorno rivitalizzò l’asfitticopanorama artistico locale e che tra il 1426 e il 1428 si misero al serviziosia del pontefice sia di alcuni porporati, in quanto storia oltremodo notapure ai non addetti ai lavori. Ben diverso, invece, è il discorso sull’ever-getismo cardinalizio, diretto e talvolta mediato, destinato fuori dall’Urbee per lo più ammantato di finalità propagandistiche. Per questi anni eper il territorio laziale due sono gli esempi acclarati: la decorazione adaffresco dell’oratorio dell’Annunziata a Riofreddo, località al confine conl’Abruzzo montano lungo la direttrice della via Tiburtina e, di nuovo, ilcaso di Cori.
Per il primo, il protagonista va indicato in Branda Castiglioni, quirappresentato dalla congregazione degli Ambrosiani ad nemus, ormai radi-cata nella valle dell’Aniene. Benché gli affreschi siano imperniati sultema escatologico, dato che la cappella serviva dal 1422 il vicino ospe-dale, ed attribuiti alla committenza di Antonio Colonna, cugino del pon-tefice, la mano occulta del cardinale e della congregazione lombarda nel-l’elaborazione del ciclo si palesa nelle raffigurazioni di papa GregorioMagno (fig. 4) e del vescovo Ambrogio (fig. 5), affrontate nel segmento
patronato artistico al principio del quattrocento 317
57. R. W. Scheller, «Uomini famosi», in «The Rijksmuseum bulletin», 10 (1962), pp. 56-67;W. A. Simpson, Cardinal Giordano Orsini († 1438) as a prince of the church and a patron of the arts.A contemporary panegyris and two descriptions of the lost frescoes in Monte Giordano, in «Journal of theWarburg and Courtauld Institutes», 29 (1966), pp. 135-59; R. L. Mode, The Orsini «Sala thea-tri» at Monte Giordano in Rome, in «Renaissance Quarterly» 26 (1973), pp. 167-72; A. Amberger,Giordano Orsinis Uomini Famosi in Rom. Helden der Weltgeschichte im Frühhumanismus, München-Berlin 2003 («Italienische Forschungen des Kunsthistorischen Instituts in Florenz», 3); A. DelleFoglie, Leonardo da Besozzo e Masolino: un dialogo tra Roma, Castiglione Olona e Napoli, in «Artelombarda», n. s. 140, 1 (2004), pp. 56-63.
58. Enee Silvii Piccolomini postea Pii PP. II, De viris illustribus, ed. A. van Heck, Città delVaticano 1991 («Studi e testi», 341), p. 34. Così riferisce la lapide dei lavori: «HEC QVECVMQ(VE)VIDES VETERI PROSTRATA RVINA - / OBRVTA VERBENIS EDERIS DVMISQ(VE) IACEBANT / NON TVLIT
HISPANVS CARRILLO ALFONSVS HONORE / CARDINEO FVLGENS. S(ED) OPVS LICET OCCVPAT INGENS /SIC ANIMVS MAGNA REPARATQ(VE) PALACIA SVMPTV / DVM SEDET EXTINCTO MARTINVS SCISMATE
QVINTVS -», è trascritta anche da Forcella, Iscrizioni (nota 55), Roma 1876, vol. 8, p. 290 nr. 720.
di volta a ridosso dell’ingresso. Rispetto ai riquadri destinati agli altridottori della Chiesa e ai quattro evangelisti, questi mostrano peculiaritàiconografiche in linea con la condotta politica degli ultimi anni dellaCuria martiniana. Nel caso del ritratto di Gregorio Magno evidente è lavolontà di raffigurare l’effigie dello stesso Oddone Colonna59: consuetu-dine, quella del cripto-ritratto (ma si potrebbe affermare del culto dellapersona), sperimentata da Martino V nel polittico della Neve in SantaMaria Maggiore e per di più ripresa per volontà del cardinal Branda, esempre sotto le spoglie di Gregorio Magno, nei più tardi murali masoli-niani di Castiglione Olona60; nel riquadro dedicato al vescovo milaneseci si sofferma, per contro, sulla vicenda di Ario flagellato dal santo esulla personificazione femminile dell’Eresia in atto di schermirsi.Dunque Ambrogio come campione tra i persecutori degli eretici, sicchéi riferimenti alla lotta contro i Wycliffiti e gli Hussiti condotta dalColonna ben prima di essere elevato al soglio pontificio e a BrandaCastiglioni nella veste di braccio armato della Chiesa, non ammettonoulteriori commenti.
D’altronde, che la questione ereticale fosse diventata in quel torno dianni cavallo di battaglia del papa e del suo stretto entourage, ritenendolaminaccia più grave di un ritorno allo Scisma, è confermato dalle inter-pretazioni di ulteriori iniziative artistiche di ben più alto prestigio. Adattestarlo è in particolare il gruppo plastico commissionato dal cardinaleLudovico Aleman a coronamento del portale maggiore della costruendafabbrica di San Petronio. Nella sua organizzazione iconografica, fissatadal contratto stipulato nel 1425 dal legato bolognese con Jacopo dellaQuercia, avrebbero dovuto trovare posto la statua del pontefice accompa-gnata dallo stesso cardinale inginocchiato, ma l’opera fu solo parzial-mente realizzata a causa della rivolta cittadina del 142861. Pertanto un’i-dea di come dovesse essere il progetto prima della forzata riduzione vacercata in un altro gruppo statuario, ovvero quello patrocinato nel 1428da Branda Castiglioni per la collegiata del suo feudo lombardo, destinato
318 pio francesco pistilli
59. L. Di Calisto, Per una ricostruzione dell’iconografia di Martino V, in Martino V. Genazzano,Piatti – Ronzani (nota 38), pp. 109-25.
60. Ibid., pp. 119-23; P. Helas – G. Wolf, «E fece uno granni bene alla città di Roma». Conside-razioni sulle opere di Martino V per la città di Roma, in Martino V. Genazzano, Piatti – Ronzani (nota38), pp. 231-40.
61. J. H. Beck, Jacopo della Quercia e il portale di San Petronio a Bologna. Ricerche storiche, docu-mentarie e iconografiche, Bologna 1970, pp. 19-33, pp. 63-85; C. Gnudi, Per una revisione criticadella documentazione riguardante la «Porta Magna» di San Petronio, in «Römisches Jahrbuch fürKunstgeschichte», 20 (1983), pp. 155-80.
ancora per una lunetta di portale e, sembra, con i medesimi intenti pro-pagandistici antiereticali62 (fig. 14).
Un taglio diverso ha invece l’Annunziata di Cori, anche perché si trat-tava di rigenerare un’impresa bruscamente interrotta nel 1413 e in unmomento storico piuttosto lontano dall’epoca che l’aveva vista sorgere.Qui il filo conduttore va ben oltre la comune identità castigliana del suofondatore e dei cardinali Alfonso Carrillo de Albornoz e Juan Cervantesde Lora63, che ripresero in mano il progetto. Di fatto, il primo avevasostituito Pedro Fernández de Frías nelle sue cariche iberiche orbitantinelle diocesi di Palencia e di Burgo de Osma, quando quest’ultimo avevaabbandonato l’obbedienza avignonese nel 1408, così come dopo la suamorte ne aveva preso il posto nella veste di cardinale di Spagna in senoalla Curia di Martino V e ciò spiegherebbe pure la presenza dello stemmadella corona di Castiglia e Leon nell’oratorio corese (fig. 15). In questocaso, però, il programma condotto a partire dal 1426 – come tramandaanche un’attendibile cronaca seicentesca riconoscendone i promotori64 –non sottintende un preciso fine politico perché si dirige verso il propo-sito di farne soprattutto un’istituzione religiosa a carattere nazionale, ipo-tesi peraltro confermata da un ulteriore stemma ispanico, quello di Juande Tovar, documentato fin dal 1418 come cubiculario di Martino V65.Tuttavia, rispetto all’impresa di Fernández de Frías e in un clima artisticoormai in piena rinascita, i prosecutori elevarono il livello degli affreschitardogotici (fig. 17) in una campagna immediatamente precedente aquella per cui fu chiamato Pietro Coleberti allo scopo di dipingere il
patronato artistico al principio del quattrocento 319
62. Beck, Jacopo della Quercia (nota 61), p. 85 n. 69. Secondo l’autore, identiche finalità poli-tiche dovevano avere sia i perduti affreschi che sempre Ludovico Aleman aveva voluto per la suaresidenza bolognese, raffiguranti nella sala da pranzo il Miracolo di san Pietro che cammina sulleacque (ibid., p. 77), sia il ciclo della cappella Brancacci nella chiesa fiorentina del Carmine, per ilquale Beck avanza l’ipotesi di una committenza diretta del cardinale Rinaldo Brancaccio (ibid., p.85 n. 69).
63. Per una loro biografia si veda, oltre al citato Strnad, Carrillo (nota 56), pp. 753-8, ancheF. Perez, Cervantes de Lora (Juan), in Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, vol. 12,Paris 1953, coll. 179-80 e Foffano, La costruzione (nota 48), pp. 156-8.
64. «... antiquites pictures pictis circa annum D(omi)ni 1426, sicut quaedam Cardinaliuminsignia cognosci potest, ac vetus, novum Testamentum pictum est …» in S. Laurienti, HistoriaCorona, 1637, fol. 38v, Biblioteca Casanatense di Roma, ms. 4057.
65. O. Villarroel González, Las relaciones monarquía-iglesia en época de Juan II de Castilla (1406-1454), Madrid 2006, p. 1375. Devo alle ricerche del dott. Clemente Ciammaruconi, in via dipubblicazione nella monografia dedicata all’oratorio, l’esatta identità dell’effigiato che in prece-denza avevo individuato in un Juan de Tovar, documentato nel 1441 al servizio di Alfonso V d’A-ragona: Pistilli, Una committenza (nota 1), p. 237, p. 240 n. 22.
Giudizio finale in controfacciata66 (fig. 6). Da anni egli era il pittore aservizio dei Caetani e nulla esclude che dietro la sua partecipazione vifosse lo stesso pontefice, visti gli stretti legami parentali che quella gene-razione dei Colonna di Genazzano aveva da tempo stretto con la casatasermonetana.
ABSTRACT
The artistic patronage of the cardinals from the pontificate of Boniface IX to theage of Martin V has been little studied. This is obvious considering two factors: thevicissitude of the Roman Church, torn by the Great Schism until the Council ofConstance (1417), and the cultural heritage of the fourteenth-century Rome,almost outside the climate of the Italian and European late Gothic.
Starting from a disadvantageous position, the primary objective of the contribu-tion is to arrange these products in the most appropriate horizon, responding to thehistorical phases of the papacy, before and after the reunification of the RomanChurch. This period was divided into three major blocks: the Neapolitan pontifi-cate of Boniface IX; the so-called «Pisan obedience»; the post-schismatic age ofMartin V. This kind of periodization wants to guide the understanding of this phe-nomenon, identifying the specific artifacts (for example the tombs of the cardinals)and their cultural and iconographic effects. Besides, already before 1417, certaininitiatives show religious and political purposes, that only after 1426 (during theministry of Martin V) contributed substantially to the physical, spiritual and pro-grammatic renewal of the Roman Church, prelude to the Renaissance for Rome andits surroundings.
Pio Francesco PistilliProfessore di Storia dell’arte medievale – Filesuso
Sapienza, Università di [email protected]
320 pio francesco pistilli
66. Pistilli – Petrocchi, El oratorio (nota 1), pp. 49-56.
pio francesco pistilli
Fig. 1. Cori, oratorio della SS. Annunziata, Pi-stilli, Roma.
Fig. 2. Messale del cardinale Pere Serra, f.143v: Crocifissione, Blackburn, Museum andArt Gallery, Hart 20918.
Fig. 3. Roma, San Silvestro in capite, reli-quiario del Battista, parte superiore della te-ca con gli stemmi del cardinale Angelo Ac-ciaiuoli caricati dell’arme Tomacelli, ISCR,Roma.
Fig. 4. Riofreddo, oratorio della SS. Annun-ziata, Gregorio Magno, Notarnicola, Roma.
Fig. 5. Riofreddo, oratorio della SS. Annun-ziata, Sant’Ambrogio, Notarnicola, Roma.
Fig. 6. Cori, oratorio della SS. Annunziata,Giudizio finale, Pistilli, Roma.
pio francesco pistilli
Fig. 7. Roma, Santa Francesca Romana, se-polcro del cardinale Marino Bulcano, Pi-stilli, Roma.
Fig. 9. Roma, Santa Maria sopra Mi-nerva, lastra tombale del cardinaleAntonio Caetani, Pistilli, Roma.
Fig. 11. Roma, Santa Maria in Trastevere, Ma-donna in trono con il cardinale Rinaldo Bran-caccio in veste di donatore proveniente dalla te-stata settentrionale del transetto, ICCD, Roma.
Fig. 8. Roma, Santa Maria in Trastevere,sepolcro del cardinale Pietro Stefaneschi,Pistilli, Roma.
Fig. 10. Roma, San Crisogono, lastra tombaledel cardinale Guillaume Fillastre, Pistilli, Roma.
Fig. 12. Roma, SS. Quattro Coronati, epigrafedel cardinale Alfonso Carrillo de Albornoz nelprimo cortile del monastero, Pistilli, Roma.
pio francesco pistilli
Fig.
13.
Rili
evi
con
la S
pera
nza
e la
Fed
e ne
i se
polc
ri B
ulca
no e
del
con
teG
iova
nni
Ors
ini
di M
anop
pell
o, g
ià i
n Sa
nta
Mag
gior
e a
Gua
rdia
grel
e,P
isti
lli,
Rom
a.
Fig.
15.
Cor
i, or
ator
io d
ella
SS.
Ann
unzi
ata,
ste
mm
ade
lla
Cor
ona
di C
asti
glia
e L
eon
tra
le a
rmi
dei
card
ina-
li A
lfon
so C
arri
llo
de A
lbor
noz
e Ju
an C
erva
ntes
de
Lo-
ra,
Not
arni
cola
, R
oma.
Fig.
14.
Cas
tigl
ione
Olo
na,
coll
egia
ta d
ei S
S. S
tefa
no e
Lore
nzo,
lun
etta
del
por
tale
, P
isti
lli,
Rom
a.
Fig.
16.
Cor
i, or
ator
io d
ella
SS.
Ann
unzi
ata,
Ann
unci
azio
ne c
on l
’arm
ede
l ca
rdin
ale
Ped
ro F
erná
ndez
de
Fría
s, N
otar
nico
la,
Rom
a.Fi
g. 1
7. C
ori,
orat
orio
del
la S
S. A
nnun
ziat
a, N
oli
me
tan-
gere
, N
otar
nico
la,
Rom
a.