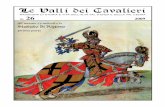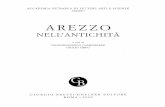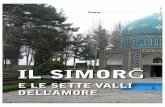Le Sette Valli e le Quattro Valli - Bahá'u'lláh é il Nuovo Millennio
Viabilità antica in Val d'Enza, in "Le Valli dei Cavalieri", 29-32, Parma 2012-2015
Transcript of Viabilità antica in Val d'Enza, in "Le Valli dei Cavalieri", 29-32, Parma 2012-2015
81
VIABILITÀ ANTICA NELLE VALLI DEI CAVALIERI
(Prima parte)
La via Francigena, il più conosciuto itinerario medievale, si compo-ne di un gran numero di sentieri e percorsi tutti situati sull'asse euro-peo del pellegrinaggio Roma-Canterbury. All'interno del fascio via-rio spiccano le tappe conservate nelle memorie del Vescovo Sigericodi Canterbury, che ricorda le stazioni percorse durante il suo viaggioverso l'Urbe. Nel territorio della Provincia di Parma transita attraver-so la Via di Monte Bardone, valicando gli Appennini al Passo dellaCisa. Seguendo il racconto del Vescovo Sigerico non dobbiamo, tut-tavia, pensare ad un'autostrada ante litteram, quanto piuttosto a qual-cosa di estremamente distante da una concezione moderna di stradae dal ricordo delle antiche vie consolari romane. Nelle mutate esigen-ze, e soprattutto nell'assenza di un potere centrale forte, vanno ricer-cate le cause della nuova rete di vie che risponde alle necessità di col-legamento di una diversa civiltà; nel nostro caso una civiltà dellafede, che trova una sua risposta alla vita nel pellegrinaggio versoRoma, S. Giacomo di Compostela e Gerusalemme, ma pure una civil-tà dei commerci, crescenti e floridi su queste direttrici. Il percorso è,quindi, racchiuso in un areale vasto, non limitato ad una sola strada,ma inserito nel territorio e soggetto a cambiamenti. La ViaFrancigena valicava gli appennini anche passando poco più a Sud diMonte Bardone, attraverso il passo del Lagastrello per poi scenderea Lucca, luogo di devozione dell'Effige del Volto Santo, e di lì prose-guire per Roma. A testimoniare la presenza di questo percorso alter-nativo al più noto valico della Valle del Taro, rimangono i segni delpassaggio delle genti di fede e della via commerciale fra Toscana epianura sopra accennata. La fondazione romanica di Zibana spiccain tutto il territorio della Valle dell'Enza mentre la distrutta chiesa diRoncarola si conserva in alcuni bassorilievi che documentano inoltrela presenza di artigiani specializzati. La raffinata tecnica ricorda in
molti casi l'opera degli scalpellini che operarono nelle fondazionireligiose promosse da Matilde di Canossa o dai suoi predecessori;non è un caso che la presenza dei Marchesi di Toscana, soprattutto diMatilde, sia documentata fra i poteri che nel XI e XII secolo control-lavano questo territorio di confine. L'itinerario della fede si serviva,però, anche di punti di ristoro del corpo, oltre che dello spirito; didue xenodochi, uno nel villaggio di Ranzano e un secondo a Vairo,è rimasta memoria nei documenti, e i loro resti restituiscono ladimensione di quell'area di strada così vasta che era la ViaFrancigena, qui ricordata con il nome di “strada dei Francesi”.L'itinerario veicolava la grande mole dei commerci dalla pianura allaTuscia e gestiva l'approvvigionamento del sale che arrivava a Parmadal mare; la sua permanenza è stata assicurata fino a tutto ilQuattrocento dalla particolare situazione del territorio dell'Alta Vald'Enza, al confine fra le Provincie di Parma e Reggio Emilia. Ancoraoggi si chiama Valli dei Cavalieri, dall'antico vallis militum comericordato nei documenti medievali. Nel nome stesso si perpetua lamemoria di una potente consorteria feudale, cioè un insieme di fami-glie di comune origine, che governava questo territorio. A capo diquesto clan era il casato dei Vallisneri mentre sul territorio si sparge-vano le altre famiglie nei loro piccolo feudi, con un proliferare dicastelli e torri di guardia a controllare la zona e, soprattutto, i traffi-ci, sia di persone che di beni. Al momento di valicare gli Appennini,prima che la strada prendesse la via di Lucca, l'Abbazia dei Linariaccoglieva i pellegrini e controllava il passo del Lagastrello. Era sededi un potente ordine Ospedaliero, i Cavalieri di Altopascio, che siprendevano cura di assicurare il passaggio e confortare spiritual-mente i viandanti. L'importanza di questo snodo di crinale si è con-servata ben oltre la vita stessa del centro monastico che perse d'im-portanza a partire dalla metà del XV secolo, in concomitanza, peral-tro, con la fine delle autonomie feudali nelle Valli dei Cavalieri. Ilnome di strada de Linario è tuttavia rimasto ad indicare quel tratto diviabilità prossima al luogo dove sorgeva l'Abbazia.
Da qui la strada proseguiva valicando la Valle del Taverone attra-verso i possedimenti malaspiniani per arrivare a Fivizzano e quindia Lucca, dove si ricongiungeva con il percorso raccontatoci dalVescovo Sigerico, per proseguire alla volta di Roma.
Filippo Fontana
82
(continua)
RASSEGNA DI STORIA E DI VITA
DELL’ALTA VAL D’ENZA E DELLA VAL CEDRA
30
2013
A CURA DELLA COMUNITÀ DELLE VALLI DEI CAVALIERI
Le caratteristiche del problema relativo alla definizione della viabili-tà storica del territorio delle Valli dei Cavalieri sottolineano il gradodi coinvolgimento che i poteri locali vantavano, all’interno del rappor-to con le fondazioni religiose che risultano i punti nodali dell’area distrada.
Una sfaccettatura ulteriore è legata al fatto che gli xenodochi sor-gevano presso le succitate comunità religiose, in modo che al ristorofisico corrispondesse anche quello spirituale. Puntualmente le princi-pali fondazioni signorili della zona rivelano la loro funzione di ospizioltre che fornire il mezzo per legare o ottenere grandi interessi e quin-di controllare il territorio. Molto spesso, infatti, la fondazioni di similiistituti religiosi diveniva il migliore mezzo per legare a sé vasti interes-si (SERGI 2003) allodiali in modo che questi fossero difesi dall’istitu-zione ecclesiastica cui erano destinati. Dopo aver fondato il beneficioera prassi comune tenere per la propria famiglia il diritto di patrona-to e nomina del Rettore, cioè di colui che ne avrebbe percepito le ren-dite. Fornivano inoltre e non da ultimo un modo per mantenere unforte legame con il territorio.
Così l’Abbazia di Linari ha fra le dipendenze Rigoso e Campingia,mentre Roncarola è soggetta al controllo di Ranzano, come si vedràmeglio nel capitolo dedicato a questa fondazione. Il Libro Morello1 ela lista del notaio Gherardo Mastagi forniscono notizia sicura sul-l’ospedale di Vajro documentandolo nel 1436 (Pellegri 1973, pag. 98).Era sicuramente più antico e concordemente gli autori ne situano lafondazione alla metà del duecento, quando la chiesa di Vajro aumen-
135
VIABILITA’ STORICA NELLE VALLI DEI CAVALIERI(Seconda Parte)
1) La lista degli hospitali della Diocesi compilata nel 1436 dal notaio Gherardo Mastagifigura negli atti del Sinodo del vescovo Delfino della Pergola (ARCH. VESC. 1436). IlLibro Morello è un elenco degli Xenodochi all’anno 1492 in ASPr 1492.
ta la sua importanza, nel momento in cui la consorteria feudale dellaVal d’Enza stringe la presa nel feudo (Capacchi 1983, pag. 38). Vajrorappresentava poi l’ultimo posto di sosta prima dei Linari, oltre ilLagastrello. Una menzione particolare spetta al priorato di San Matteosul Cajo; nonostante infatti sia ai limiti dell’area di strada presa inconsiderazione, nelle vicende legate alla sua dotazione e al controllodello xenodochio che ospitava ha un ruolo di spicco la consorteria deimilites. Fra i beneficiati si contano diversi membri di famiglie dellaconsorteria (Schiavi 1925, pag. 56) e addirittura nel 1411 divienepatronato perpetuo della famiglia Lalatta, a mezzo di un provvedimen-to di Giovanni XXII (Schiavi 1940, pag. 463) che lo tenne fino al seco-lo XVI. negli ultimi secoli dipendente dalla piccola chiesa diTrevignano, il cui edificio sacro fu ricostruito nel 1627, era nel secoloXII di proprietà del Capitolo della Cattedrale di Parma.
L’importante e ricchissimo priorato di San Matteo è infatti ricor-dato già nel 1015 in una Bolla papale come dipendente dal Monasterodi San Giovanni di Parma (Torelli-Gatta 1938, pag. 284). Smembratol’antico priorato e ridotto ad una dipendenza della Pieve di Tizzanopassa infine sotto la giurisdizione di Trevignano, villaggio posto nellevicinanze di Isola. Di un ospedale di Santa Maria Maddalena è mezza-dro Pedrezzolo da Isola, nel 1415 (Zanzucchi Castelli-Trenti 1999).Che si tratti di una struttura di Isola è altamente possibile, come haipotizzato il Pellegri (Pellegri 1973, pag. 78), anche in considerazionedel fatto che la chiesa di Isola è posta sotto tale titolo (Schiavi 1940,pag. 87).
Roncarola è una fondazione dell’XI secolo, almeno stando aimanufatti che dovrebbero provenire da quelle stesse murature, riuti-lizzati nelle murature della chiesa di Ranzano alla quale passò il bene-ficio dopo che l’oratorio di Roncarola andò incontro a distruzione nelsecolo XVI (Dall’Aglio 1966, p. 795). Nel XIII secolo risultava dipen-dente dall’antichissima pieve matildica di Sasso, mentre successiva-mente passa sotto la sfera d’influenza della pieve di San Vincenzo(Ghirardini 1988, pp. 20-21). Ugualmente nel territorio di Ranzano sitrovava un altro ospedale nel complesso di edifici della Bastia in loca-lità della Fontana; l’attribuzione è stata fatta sulla base dell’analisidelle murature e della struttura dell’edificio, rovinato negli anniSessanta del secolo scorso, e sulla scorta di una pàtera marmoreadatata al XII secolo inserita nel paramento murario (Capacchi 1983,pag. 36).
Questo sistema di strutture religiose e xenodochi situati nell’area di
136
strada dell’Alta Val d’Enza si compone quindi degli ospizi di Ranzano,Campingia, Isola, San Matteo, Vajro e Linari. A questi, che risultanoparte dell’organizzazione territoriale delle Valli dei Cavalieri, vannoaggiunte le dipendenze che risultano all’interno della città di Parma;quest’ultime, secondo quanto riportato dagli Statuti del 1215 (Ronchini1856, pag. 345), ne ribadiscono il pieno controllo alla consorteria deimilites. Attraverso i loro consoli i quali rappresentavano in merito lamassima magistratura, sovrintendendo anche le Arti che afferivano allacura e all’equipaggiamento delle cavalcature e curando la raccolta delletasse nelle terrae militum nell’Alta Val d’Enza (Ronchini 1856). Lastruttura era il cosiddetto hospitale militum presso la Chiesa di S.Antonio in Parma, dove i milites ricevevano assistenza spirituale e ave-vano garantito l’uso del portico antistante.
Come è precisato nel testo statutario anche il controllo del suddet-to hospitale rientrava fra le regalie che il Comune volle concedere allaconsorteria (Ronchini 1856). Lo stesso poi sembra avere come dipen-denza la cappella di Campingia (Micheli 1915, pag. 205) la quale consicurezza risulta collegata all’Abbazia di Linari nel 1299. Altra docu-mentazione che collega il sistema ospitaliero, parte dell’organizzazio-ne delle fondazioni religiose studiate, a questa stessa consorteriaemerge dalla partecipazione, ancora in pieno Quattrocento, di mem-bri di famiglie consorziate nella gestione dell’ospedale militum.
Nel 1441 infatti il dominus Giovanni da Nirone et est militis e lafiglia di Patrizolo de la Braja percepiscono dallo stesso ospedale unarendita (Pellegri 1973, pag. 73). La località, posta sul versante destrodell’Alta Val d’Enza, risulta fra le cappelle sottoposte alla pieve di SanVincenzo nel 1230 come attestato dal Rotulus Decimarum (Schiavi1925). Del villaggio non è rimasta che la traccia toponomastica inquanto l’edificio religioso è rovinato assieme a tutto il paese in segui-to alla frana che l’ha distrutto nel corso del XV secolo (Pezzana 1842,pag. 455).
Infine il punto culminante del percorso di valico, ovvero l’abbaziadi Linari. Già ricordata per la prima volta nel 1045 rappresenta nelsecolo XI un punto forte di controllo delle vaste corti del districtumalpium e non a caso compare tra i beni confermati nel 1077 a Ugo eFolco, figli del marchese Azzo, da parte dell’imperatore Enrico IV(Tiraboschi 1963 [1821-1825], pag. 135). Il monastero raggiunse ilsuo massimo splendore tra il IX e il XV secolo, con numerose proprie-tà sui due versanti appenninici.
Inizialmente dedicata a San Salvatore e a partire dal XIII secolo a
137
San Bartolomeo. Forse aveva una doppia dedicazione poi perduta, oforse quella precedente a San Bartolomeo sostituì l’altra quando imonaci cominciarono ad occuparsi dei pellegrini e della strada. Sulprincipio del XV secolo l’Abbazia perse la sua importanza e venneeretta in commenda con disposizione del 14 maggio 1477 del ponte-fice Sisto IV che elesse in abate commendatario del monastero il ret-tore della chiesa di S. Giorgio a Comano. Venne soppressa nel 1583,per mezzo di un Breve del pontefice Gregorio XIII che annettendo isuoi beni alla chiesa e monastero degli Agostiniani di Fivizzano(Repetti 1966 [1833-1846], pag. 622); nelle vicinanze delle rovine èstata eretta una cappelletta. Considerate le sue pertinenze nel versa-te emiliano ed il suo ruolo, appunto, forte nel controllo delle corti divalico è ipotizzabile che, nei secoli XII-XIII e cioè all’accentrarsi deipoteri dei militi, la storia dell’abbazia di Linari, come già è stato pro-posto (Bottazzi 2000, pag. 82), sia legata proprio a questo consorziodi milites.
La viabilità della zona in oggetto divenne un problema precipuo siaper i Duchi di Parma sia per gli Estensi che ne affidarono la cura e laricostruzione ai loro ingegneri. Il valico appenninico rappresentava unproblema di primaria importanza in quanto garantiva ai piccoli duca-ti padani una via di sbocco verso il mare.
Tale importanza dal punto di vista militare e commerciale è stataoggetto di attenzione dell’ingegnere Marco Antonio Pasi che ne rilevòi limiti e le possibilità di sviluppo nel corso delle sue ispezioni ai con-fini ed alle fortezze del modenese.
Per lo stesso motivo che nel XIX secolo viene decisa la costruzio-ne della strada statale Massese, una nuova carrozzabile che rivoluzio-na il tracciato viario delle valli. La costruzione di questa grandiosa,per l’epoca, opera comincia, per il tratto da Capoponte a Rigoso, nel1868 e termina con lo scadere del secolo, nel 1900. In effetti le aspe-rità ed i problemi di portata che gli ingegneri incontrarono in tutto iltracciato non favorirono una soluzione dei lavori a breve termine. Perla costruzione dei 50 km di strada si aprì una sottoscrizione fra iComuni interessati: 80,000 Lire da Palanzano e Monchio e 10,000 daTizzano (Scala 1997).
Alla nuova infrastruttura seguì il progetto di realizzazione dellaferrovia. Il podestà Castiglioni Scala, infatti, perorò con insistenza lacausa appoggiando il tracciato Enza-Taverone per collegare Parma aPontremoli in modo che la ferrovia passasse da Palanzano e portassecon sé il progresso. Vennero fatti progetti su progetti, venne studiato
138
un sistema per permettere al convoglio di valicare i Paduli ed il Passodel Lagastrello ma alla fine il dislivello era comunque eccessivo.L’ardito progetto cadde in favore del più agevole tracciato Taro-Magra(Quarantelli 1995).
Filippo Fontana
Bibliografia
BOTTAZZI 2000 – G. Bottazzi, Le dipendenze dell’Abbazia di Linari nel ver-sante emiliano, in Linari tra il Po e il Mar Tirreno. Genti in cammino neiversanti appenninici tosco-emiliani attraverso i secoli, Atti del Convegno diStudi (Ramiseto-Comano 19-20 Agosto 2000), Reggio nell’Emilia, pp. 71-85.CAPACCHI 1983 – G. Capacchi, Vajro. Antica capitale delle Valli deiCavalieri, Parma. DALL’AGLIO 1966 – I. Dall’Aglio, La Diocesi di Parma, II, Parma.GHIRARDINI 1988 – L. L. Ghirardini, La misteriosa chiesa di Roncarola, in“Le Valli dei Cavalieri”, 9, Parma, pp.19-24.MICHELI 1915 – G. Micheli, Le Valli dei Cavalieri. Note e documenti, Parma. PELLEGRI 1973 – M. Pellegri, Ospizi e Xenodochi nel parmense dagli inizial 1471, Parma.PEZZANA 1842 – A. Pezzana, Storia della città di Parma, III, Parma. QUARANTELLI 1995 – B. Quarantelli, Breve storia di una ferrovia manca-ta, in “Le Valli dei Cavalieri”, 14, Parma, pp. 47-49.REPETTI 1966 [1833-1846] – E. REPETTI, Dizionario geografico fisico sto-rico della Toscana contenente la descrizione di tutti i luoghi delGranducato, ducato di Lucca, Garfagnana e Lunigiana, II, Firenze, pag.622.RONCHINI 1856 – A. Ronchini, Statuta Communis Parmae digesta anno1255, Parma, pp. 13-18.SCALA 1997 – F. Scala, La strada da Capoponte a Rigoso, in “Le Valli deiCavalieri”, 15, Parma, pp. 51-62.SCHIAVI 1925 – A. Schiavi, La diocesi di Parma, I, Parma.SCHIAVI 1940 – A. Schiavi, La diocesi di Parma, II, Parma.SERGI 2003 – G. Sergi, Le sedi religiose, in E. Castelnuovo-G. Sergi, Arti estoria nel Medioevo, II, Torino, pp. 107-124.TIRABOSCHI 1963 [1821-1825] – G. Tiraboschi, Dizionario topografico sto-rico degli stati estensi, II, Modena.TORELLI-GATTA 1938 – P. Torelli-F. S. Gatta, Le carte degli archivi reggia-ni, Reggio nell’Emilia. ZANZUCCHI CASTELLI-TRENTI 1999 – M. Zanzucchi Castelli-G. Trenti (acura di), L’Estimo del Sale di Parma del 1415, Modena.
139
RASSEGNA DI STORIA E DI VITA
DELL’ALTA VAL D’ENZA E DELLA VAL CEDRA
31
2014
A CURA DELLA COMUNITÀ DELLE VALLI DEI CAVALIERI
(segue dal numero precedente)
Per definire i percorsi e la gerarchizzazione degli assi viari nel territo-rio in etàà medioevale è stato particolarmente utile il controllo delledocumentazioni riguardanti le dipendenze afferenti ad alcune fonda-zioni religiose del territorio quali il monastero di San Salvatore diLinari, la chiesa di S. Maria Maddalena di Roncarola e, come vedremo,la Badia di S. Basilide di Cavana. Infatti, la fondazione monastica oreligiosa risulta parte integrante dell’architettura stradale; fornisconoanche informazioni riguardo all’importanza e alle interdipendenzedegli assi stradali. Sebbene, infatti, con la tarda antichità e fino alperiodo comunale le strade non siano più costruite su impulso di unapubblica autorità è importante sottolineare che non vi è una soluzio-ne di continuità con la rete viaria di età romana che continua ad esse-re utilizzata. Ciò che cambia, in relazione alle condizioni socio-politi-che e ai mutamenti della geografia fisica nel territorio, è piuttosto l’im-portanza gerarchica di un percorso piuttosto che un altro come ana-lizzeremo nella parte finale di questo lavoro.
L’importanza e quindi l’uso di un percorso risulta definibile attra-verso gli edifici che sono al servizio delle vie stesse e che ne rappre-sentano la più viva traccia archeologica (MANNONI 2000, p. 15). A que-sto proposito è interessante sottolineare come sia in una dimensioneinterna agli assi viari che si veicolano e si sviluppano i modelli cultu-rali sui quali è stato più volte visto il punto di partenza del “policen-trismo” artistico che segna la fioritura del romanico PORTER 1924-QUINTAVALLE 1967). Queste istanze di rinnovamento, spesso viste solonella composizione dialettica del rapporto città-campagna, non sirisolvono esclusivamente nell’assunzione di un ruolo organizzativo edi punto di riferimento culturale della città. I rapporti culturali sonopiuttosto organizzati sugli assi di collegamento trans-appenninici suiquali si snodano le principali committenze individuate nelle aristocra-
149
VIABILITA’ STORICA NELLE VALLI DEI CAVALIERI
PARTE TERZA
FILIPPO FONTANA
zie, Attonidi e Obertenghi in prima linea, che modellano il loro pote-re su queste due dimensioni, quella rurale e quella cittadina.
In questo senso sono state notati da tempo i risvolti, che questirapporti ebbero dal punto di vista stilistico e artistico (PORTER 1918),esplicitati dai collegamenti fra l’ambiente italiano e francese. In parti-colare nelle dipendenze dei monasteri borgognoni in area rurale emi-liana e di come attraverso questi legami si vedano continuità e discon-tinuità del linguaggio artistico (QUINTAVALLE 1969, pp. 11-33). Il lin-guaggio culturale che ne deriva pone il problema del riconoscimentodelle cosiddette ““derivazioni”” borgognone che innervano il tessutoscultoreo e architettonico emiliano, vendendolo come un’operazioneunitaria frutto di un preciso disegno al centro del quale si pone l’ope-ra riformatrice di personaggi come Matilde, Bernardo degli Uberti,Donizone e Gregorio VII.
Da qui deriva anche l’osservazione che invita a vedere non tantol’esportazione di un modello, che può essere quello cluniacense o piùgenerale quello derivato dalle sue filiazioni in borgogna, quanto l’ela-borazione di un linguaggio nell’ambito del sistema europeo delle vie dipellegrinaggio (QUINTAVALLE 1977, p. 42). Il territorio è interessato daalcuni fasci viari la cui persistenza è possibile rilevare fino alla metàdel secolo XIX quando, cioè, vennero progettate le carrozzabili i cuiitinerari sono ancora utilizzati. Innanzitutto i percorsi che formavanoil tracciato permettevano il passaggio delle merci dalle aree della pia-nura attraverso i passi appenninici.
In particolare la zona di Parma si trova in un crocevia che vedecongiungersi gli assi di collegamento con i centri di Cremona,Brescello, Lucca e Luni, rispettivamente verso nord e verso sud(DALL’AGLIO- DI COCCO 2006, p. 269). Una viabilità che permetteva tut-tavia un trasporto, limitatamente alle merci, che si effettuava con l’au-silio di diversi tipi di carri. Il loro utilizzo era possibile almeno finoall’imboccatura della vallata dove al carro, capace di affrontare pen-denze fino al 15% e larghezze e raggi di curvatura non inferiori di quat-tro-cinque metri, veniva sostituito il dorso di mulo, l’unico mezzo chepermettesse di superare le pendenze dei percorsi montani (MANNONI
2000, p. 16). Questi ultimi si sviluppano all’interno delle zone natural-mente individuate dall’andamento vallivo appenninico e risultanocondizionati dall’accessibilità e percorribilità dei valichi.
La dorsale appenninica, nel tratto che interessa questo studio, sicaratterizza per un crinale spartiacque relativamente alto, dal quale,in direzione nord, si dipartono perpendicolarmente le dorsali, tra loro
150
sub-parallele, che delimitano i bacini dei corsi d’acqua rivolti verso lapianura: il torrente Parma, il torrente Cedra e il fiume Enza. In parti-colare il posizionamento delle due vallate parallele del Parma edell’Enza risulta collegato, nel tratto pedemontano, dal solco vallivooriginato da un’affluente del Parma, il torrente Parmossa. Gli assi viaridi maggiore importanza sfruttavano sicuramente la linea tracciatadalle valli sub-parallele mentre il collegamento trans-vallivo è indivi-duato in una serie di percorsi gerarchicamente inferiori, per frequen-tazione, alle vie che immettevano ai passi.
Questa particolarità genera una situazione che si ripercuote sullaformazione dei tracciati viari in quanto la valle del Parmossa, per lasua posizione intermedia sulla dorsale compresa fra le due vallate sub-parallele del Parma e dell’Enza, individua un percorso sulla linea est-ovest aggirando il massiccio del Monte Fuso (mt. 1117). La valle delParmossa funge così da bacino di raccolta delle naturali direttrici ditraffico improntate sul corso dei bassi percorsi fluviali del Parma edell’Enza, incanalando l’asse viario snodato sulla fondazione monasti-ca della Badia di Cavana e direzionandolo verso il passo delLagastrello. Che si tratti di uno snodo topografico di rilievo, a cavallodel X secolo, è corroborato dalla vicina presenza dei luoghi di isola,antesica e sciola; questi risultano fra le dipendenze di adalberto atto,e sono messi in rapporto con gli interessi dei canossani e dei loro vas-salli (BOTTAZZI 1997, p. 180).
La struttura così articolata è stata individuata e definita “a petti-ne” (ALFIERI ET ALII 1988); apre, in questo modo, una naturale viad’accesso al crinale spartiacque al quale permette di salire lungo ilnaturale piano inclinato che i bacini acquiferi originano, dando la pos-sibilità di arrivare a quote anche assai elevate. Viceversa, i “denti delpettine” cioè le dorsali, pur offrendo una variante in quota per rag-giungere il crinale, hanno sempre rappresentato un altrettanto natu-rale ostacolo all’impianto di una viabilità in direzione est-ovest.Quest’ultima va ricercata fra le forme di collegamento secondariofavorite dai passi aperte nelle dorsali e che sono state individuate nelpasso di Zibana e nel passo del lupo (TAGLIAVINI 1988). La strada vei-cola merci, persone e idee, ma soprattutto fornisce un collegamento,in particolare pone in collegamento interessi diversi, come è possibi-le vedere nel caso delle dipendenze monastiche (PELLEGRI 1970).
Diversamente fornisce un collante nell’ambito dell’articolazionedei patrimoni territoriali laici caratterizzati da una forte discontinui-tà; soprattutto nei casi maggiori, dove le pertinenze erano da ambo le
151
parti del crinale, il controllo delle corti appenniniche e il conseguen-temente dei passi gettava le basi di un legame che era basilare innan-zitutto per la gestione delle diverse curtes (NOBILI 1997). Permettendoun sicuro dialogo tra la pianura padana e la toscana il tema del colle-gamento trans-appenninico è di primo piano fin dai secoli centrali delmedioevo (BOTTAZZI 1997).
Sicuramente il punto d’arrivo sul crinale, relativamente alla zonad’interesse di questo studio, è da individuarsi nei passi, da ovest versoest, del Cirone (mt. 1255), del Lagastrello (mt. 1200) e del Cerreto(mt. 1261) attraverso i quali passano le direttrici più frequentate. Laparticolare conformazione stretta dell’alta val Parma rende disagevoleil passaggio attraverso il passo del Cirone che dovette essere interes-sato da un flusso viario di minore entità rispetto a passi più agevoli. E’opportuno tenere presente che, stabilendo una gerarchia fra le vie dicomunicazione, l’asse sicuramente più frequentato ed interessato daforti flussi di pellegrinaggio era rappresentato dal tracciato che condu-ce al passo della Cisa.
Attraverso i valichi del Lagastrello e del cerreto correvano la stra-da detta parmesana (BARONI 2000) e una variante della via francige-na, o romea. La prima percorreva la sponda destra dell’Enza, essen-zialmente in territorio reggiano, e segnava il confine fra i ducati diModena e Parma ancora fino al seicento (RONCAI 2007), giungendofino al passo del cerreto. La seconda, invece, collegava la città diParma al crinale sulla direttrice della Valle dell’Enza giungendo alpasso del Lagastrello. I percorsi sono particolarmente sviluppati inarea appenninica, dove accanto alle strade principali vi erano, e visono tuttora, diversi sentieri il cui utilizzo variava in base alle condi-zioni di percorribilità. Già durante la guerra greco-gotica (535-553) lacrisi economica e demografica arrivata al suo culmine favorisce, oltreche un restringimento delle città, anche uno spopolamento delle cam-pagne.
In ambienti rurali e appenninici questo comporta il progressivoabbandono delle opere di presidio territoriale, come la rete di drenag-gio superficiale e gli argini dei corsi d’acqua, innescando fenomeni didissesto idro-geologico (DALL’AGLIO 2001, p. 14). In questo contesto,già dal momento dell’invasione longobarda, si assiste al cambiamentodella gerarchizzazione degli assi stradali così come era definita dalpotere centrale romano. Per quanto riguarda le strade che collegava-no Parma romana e Brescello con Luni e Lucca (DALL’AGLIO 2001, pp.271-277), individuabili studiando il popolamento romano nell’area
152
appenninica (BOTTAZZI 1994, BOTTAZZI- SCALISE 1994), vennero ridefi-nite sulla base di nuove necessità di collegamento fra la pianura pada-na e la toscana portando allo sviluppo della via di monte Bardone il cuiutilizzo è ampiamente attestato dall’itinerario medievale di Sigerico.
A lato degli assi viari che percorrono le vallate appenniniche sulladirettrice nord-sud esistevano tutta una serie di percorsi trans-vallivisull’asse est-ovest che sfruttavano le aree create dai bacini idrici diaffluenza ai torrenti maggiori. Questi percorsi, estremamente utili for-niscono un collegamento trasversale, sono molto spesso ancora indi-viduabili nel territorio, all’interno dei tracciati delle mulattiere. Moltospesso risultano gli stessi tratturi utilizzati fino alla metà del secoloscorso per i lavori agricoli e per lo spostamento delle persone. In par-ticolare in un caso è stato possibile raffrontare questa persistenza,dovuta soprattutto al fatto che questi percorsi longitudinali non hannorisentito della creazione di nuove vie di comunicazione carrozzabili.Una particolare via che collega le due vallate oggetto del mio studio sidiparte da Ballone, villaggio nei pressi di Corniglio, e dopo aver vali-cato il monte Caio attraverso il passo di Zibana discende fino aCozzanello, nella vallate del Cedra, affluente dell’Enza seguendo ilsentiero ancora oggi chiamato via della braja (TAGLIAVINI 1988). Da quiprosegue fino a valicare il torrente Cedra al villaggio di Lugagnano permezzo di un ponte cinquecentesco a schiena d’asino il quale, essendodi sicura datazione, permette di stabilire un valido limite cronologicodella fase di vita dello snodo viario. Una serie di sentieri si congiungo-no in un quadrivio che immette nella Val d’Enza attraverso un passodetto Passo del Lupo; una corrispondenza Quattrocentesca fra gliAnziani della città di Parma assieme ai comandanti dell’armata chestava assediando la vicina fortezza del castellaro illustrano il percorsofin qui descritto dal villaggio di Lugagnano fino al passo del lupo(MICHELI 1915, p. 56).
Il prosieguo è descritto all’interno dell’Investitura feudale con laquale l’Imperatore Venceslao concede a Nicolò Terzi i feudi di Tizzano(in Val Parma) e Ramiseto (in Val d’Enza) preCisando un tratto di stra-da che univa Cozzanello, in Val d’Enza con il villagio della Braia in ValParma. La via è così descritta: et terras de balono, et montebello ettotum territorium usque ad domos ville de cozanello et ab inde addomos de la braia eundo per viam de la braia inclusive, eundosuper estremitatem confinium territorii et usque ad territoria curtisraguzzi, parmensis diocesis, inclusive castrum, castellatia et terrasde nigono, montemiscosio, ramexeto, gontano et gazolo ac totoam
154
villam ipsius nigoni (MICHELI 1915, p. 47). Andando per la via dellaBraia quindi si arriva a Cozzanello, allora all’interno della giurisdizio-ne vescovile di Rigoso. I territori si spingono poi fino a Ramiseto col-legando quindi il feudo di Tizzano con quello di Nigone e passandoall’interno dei confini sopracitati. La permanenza di dati toponomasti-ci assieme a testimonianze storiche permette quindi illustrare unaconservatività molto forte, dal medioevo all’età moderna, degli assiviari permettendo di contestualizzare le emergenze archeologiche earchitettoniche quali le fondazioni religiose che rappresentavano deiveri e propri punti nodali. Una via di comunicazione, sebbene non laprincipale, che collegava il valico del Lagastrello a Parma è stata iden-tificata come una direttrice viaria di particolare complessità; il fasciodi strade, per il quale è stata proposta la denominazione di “via diBadia Cavana e di Linari” (BOTTAZZI 1997, p. 173) si appoggia alle duefondazioni monastiche come punti principali.
La qualificazione come variante della via francigena, che nel trat-to, descritto dall’itinerario di Sigerico passa per Fornovo, Berceto e ilpasso della Cisa, è resa esplicita da alcune evidenze documentali chesupportano la concezione di una pluralità di passaggi tipica del con-cetto di area di strada (BOTTAZZI 1997, p. 166). Il Rotulus decimarum,nel 1230, segnala la presenza di dipendenze di importanti monasterifrancesi quali S. Maria de Virgiliacensis (Vezelay, in Borgogna) a cuirisulta legata la chiesa di S. Maria Maddalena di Roncarola in Vald’Enza (SCHIAVI 1925, p. 32) mentre il monastero di Vallombrosa intoscana contava fra le dipendenze il monastero di Badia Cavana e lachiesa di Casola di Tizzano in val Parma (PELLEGRI 1970, p 130).
Un interessante contributo documentale per identificare l’itinera-rio che conduce al passo del Lagastrello è rappresentato dal viaggioche una particolare merce, il sale, affrontava per arrivare a Parma dalmare. Il commercio del sale, sempre attentamente controllato daParma, transitava attraverso la direttrice di Badia Cavana e di Linari:attraverso la strata de Linario che arrivava da Parma fino al Passo delLagastrello, dove sorgeva l’Abbazia di Linari, i funzionari comunalipreposti, detti corrieri del sale, accompagnavano le carovane con ade-guata scorta e ne rispondevano ad un Massaro, diretto rappresentan-te del Podestà di Parma. In città i punti di ingresso dei carichi di saled’origine forestiera erano rigorosamente fissati e controllati: quelliprovenienti da Reggio dovevano entrare per la porta san Michele,quelli da Mantova attraverso Brescello erano controllati alla portabenedetta, quelli giunti dalla strada di monte Bardone passando per
155
Collecchio per stratam de colliclo (STATUTA 1590, p. 346) dovevanotransitare per porta san Francesco, l’attuale barriera Bixio, mentre lecarovane provenienti dalle Valli dei Cavalieri erano obbligate a percor-rere la Strada di Olmazzolo, per stratam de Ulmazolo, ed essere con-trollate dal presidio di Porta Nuova all’attuale Barriera Farini.
Il percorso della strata de Linario, almeno da Linari fino a BadiaCavana, coincideva quindi con quella variante della Strada Francigenache conserva ancora il nome locale di strada di Fransèz (strada deiFrancesi) nel tratto antico che da Rigoso, costeggiando il LagoSquincio, si spingeva fino all’Abbazia ed Ospizio dei Linari subito oltreil Lago Paduli. Fra gli storici locali sono state avanzate diverse ipotesiper sciogliere l’etimo della strada proponendo che dovesse la suadenominazione al passaggio delle truppe francesi durante l’invasionenapoleonica. In accordo con gli ultimi studi in materia si è rilevato chela nomenclatura possa essere riferita al fatto che l’asse viario non siaaltro che un fascio della via Francesca o francigena (CAPACCHI 1983, p.39) cioè, appunto, proveniente dalla Francia. Procedendo da sud versonord, le carovane del sale, lasciato il Monastero di Linari, percorreva-no la citata “strada dei Francesi” fino a Rigoso; di qui, rasentandol’abitato di Aneta, procedevano sulla mulattiera, rimasta la principalevia di comunicazione fino a tutto il secolo XIX, che toccava l’odiernalocalità della Perdera fino alla costa del Monte Gròppolo, scendendopoi a Vajro Superiore dove è documentato un Ospizio per Pellegrini(PELLEGRI 1973) per raggiungere Palanzano per la “strada vecchia”, amonte dell’attuale provinciale Vajro-Palanzano. Da quest’ultima loca-lità i carichi proseguivano per l’antica mulattiera che da Mont al Frarscendeva alla Cedra per risalire fin sotto Pratopiano, quindi perRanzano, poi per Celso e Bodria. Una possibile variante più a montepoteva passare da Palanzano a valle di Caneto, quindi di lì a Lalatta,Galgheto e Bodria. Qui intercettava l’altro snodo viario dell’Alta Vald’Enza rappresentato dalla chiesa di S. Maria Maddalena di Roncarolanelle cui immediate vicinanze è stata documentata l’esistenza di unaltro xenodochio (CAPACCHI 1983, p. 38). La strada scendeva al fondodel torrente Bardea a monte di Magreto, per risalire lungo la mulattie-ra per Moragnano dove, annessa alla chiesa romanica di S. Giulianaesisteva un ennesimo ospizio per i pellegrini. Lasciate le Valli deiCavalieri, l’itinerario proseguiva in Val Parmossa, poi a mezza costadalla Val Toccana fino all’Abbazia di San Basilide Cavana, da dove icarichi del sale prendevano – obbligatoriamente, a norma di Statuto –la strata de Ulmazolo. Fino a questo punto, come si è visto, la strada
156
del sale coincide perfettamente con una variante locale della StradaRomea. Questo è quanto è possibile desumere osservando gli statuticinquecenteschi di Parma.
Del toponimo Ulmazolo, dove sembra convergere l’asse viario cheè stato descritto, rimane una traccia a pochi chilometri a nord-est diParma nella località Pilastro, in un gruppetto di edifici che nella dizio-ne locale sono tuttora detti “Gli Olmazzoli”, e che un tempo, è chia-ro, avevano ben maggiore importanza di quanta non ne abbiano algiorno d’oggi. Questo permette di desumere che tragitto affrontato,dopo Badia Cavana, traversasse il Parma per imboccare l’attuale stra-da Langhirano-Parma, scavalcasse di nuovo il torrente sull’attualePonte Dattaro o poco più a monte e finisse col raggiungere il castellodi Porta Nuova. Qui venivano esperiti i controlli d’obbligo prima deldefinitivo trasporto dei preziosi carichi all’edificio della Dogana, dacui il sale doveva venire ridistribuito con l’esercizio di un rigorosissi-mo regime di monopolio.
Questa direttrice si sviluppa come una prosecuzione verso nord
157
Fig. 2 - Antica strada da Ruzzano a Carbognana
della via Parma-Pilastro è rappresenta una persistenza del rettifilosegnato dalla via pubblica romana che coincideva con il cardine mas-simo della centuriazione (BOTTAZZI 1997, p. 171). Inoltre questa con-tinuità è sottolineata dalla notizia documentale dell’ospedale di S.Maria degli olmazzoli, a circa un chilometro da pilastro, citato nellalista decimale del 1354 (BOTTAZZI 1997, p. 170). Sebbene l’ospedalerisulti già in rovina nel corso del Quattrocento la notizia della stratade Ulmazolo fa pensare ad un utilizzo ancora vivo di questo percorsoper tutto il Cinquecento. La strada parmesana, che corre sull’altroversante dell’Enza sopra Vallisnera e Valbona arrivando fino al cerre-to era conosciuta anche con il nome di strada maestra di Fivizzano,nel suo ultimo tratto che, valicato il monte Casarola giungeva al passodell’Ospedalicchio, o delle cento croci (BARICCHI 1990, p. 30).
Chiamata dai reggiani strada ducale di lunigiana o strada reggiana,fu dai parmigiani sempre considerata, almeno nel tratto che percorre-va le valli dei cavalieri come il segno di confine fra i due ducati, inepoca moderna (MICHELI 1915, p. 182). Il suo tracciato, prima delleopere di rifacimento che approdarono alla costruzione della Stataledel Cerreto, era così descritto, nel 1788 dal Ricci «Uscita di quellaterra ritorna nella Giurisdizione di Bismantova, stendesi alle cale delGarfagnolo, entra nei Feudi di Busana, passa per le borgate diCervarezza, e rivolta alla faccia di Meriggio corre sulla pendice diVentasso. Non molto dopo attraversa il paese di Busana, e lasciando laSecchia alla sinistra continua sempre colla stessa direzione per le bor-gate di Nismozza, Aquabona e giunge a Culagna. Esce di Culagna rivol-ta a Ponente, e dopo qualche tratto passa sulla confluenza di dueTorrenti detti Canalazzo e Biola, e li sormonta ambedue in un belponte di cinque archi, poscia entra nel Feudo di Valbona, e taglia peltratto di due miglia la pendice di macigno, che quasi perpendicolaresovrasta ivi alla Secchia sulla sinistra. Quivi piegata al meriggio calanel fiume, indi sale al cerreto, e ne attraversa l’abitato, poscia conti-nuamente montando per due miglia e mezzo giunge alla cima dell’Alpifino ai confini di Sassarbio giurisdizione di Fivizzano, paese della luni-giana, e dominio del granducato di toscana» (RICCI 1788, p. 45).
Dal punto di vista dell’inquadramento storico del territorio è pos-sibile fornire alcune letture recenti riguardo l’interpretazione dellagestione territoriale fra X e XIV secolo al fine di meglio comprendereil discorso itinerario fin qui impostato.
Le terre dell’Alta Val d’Enza sono ampiamente attestate nel pano-rama dei diplomi e delle disposizioni imperiali a partire dal 948 quan-
158
do l’imperatore Lotario concede curtem Neironis in perpetuam pro-prietatem al vescovo di Parma1. La critica diplomatica, già da tempo,propende a ritenere falso il documento in questione in quanto la dizio-ne curtem Neironis vi appare chiaramente interpolata. Tuttavia è del935 la notizia di un placito, convocato a Pavia e presieduto da re Ugo,la cui vertenza è relativa alla disputa che interessa il vescovo di ParmaSigefredo e il marchese Anscario II. La questione si riferisce alla pro-prietà del locellum quendam Luculum, una curticella dalla qualedipendeva l’alta Val d’Enza e con essa il controllo del passo appenni-nico del Lagastrello. Durante l’ostensio chartae viene riportato undiploma precedente con il quale si dimostra come il 13 Marzo dell’881l’imperatore Carlo il Grosso concedesse al vescovo di Parma la pro-prietà della corte appenninica. La notizia documenta una situazionedi particolare attenzione rivolta ad aree strategiche del comitato diParma per il controllo dei passi appenninici. Un’attenzione promossasia dai poteri laici che dai vescovi i quali si dimostrano particolarmen-te consapevoli dell’importanza di mantenere le loro posizioni di pre-minenza nelle aree strategiche del comitato; una caratteristica, que-sta che incide prepotentemente sul contesto di formazione delle fon-dazioni monastiche oggetto di questo studio (ALBERTONI 2010, p. 86).
Dello stesso tenore sono, tuttavia, le deliberazioni del 1029 adopera dell’imperatore Corrado che, con le stesse parole, destina i ter-ritori in oggetto allo stesso vescovo parmense. A maggior favore delletesi che identificano nel diploma di Lotario un falso giunge comeprova ulteriore il documento di Enrico che nel 1015 concede Nironee Vallisnera al conte di Parma Bernardo; in quella sede si fa esplicitoriferimento al fatto che quelle corti fossero già fra le disponibilità e ifeudi dei marchesi di toscana per mezzo di un diploma dell’imperato-re ottone a noi non pervenuto (PIVANO 1916, p.25).
Definire gli aspetti del controllo del territorio implica considerarele interazioni che si generarono fra le casate comitali parmensi, lequali tendevano alla giurisdizione su tutto il comitato, e le grandi ari-stocrazie dell’epoca, in particolare le famiglie dei marchesi canossanie obertenghi (NOBILI 1981). Queste erano beneficiarie di immensesignorie territoriali che comprendevano diverse curtes (NOBILI 1988)e si estendevano dall’alto Lazio fino alla pianura padana; si rivelarono
159
1) I documenti imperiali che dispongono delle corti appenniniche in favore dellacuria parmense sono esaminati in ALBERTONI 2010 e PROVERO 2010. Per un’edizionecritica si rimanda a MGH 1888.
inoltre estremamente attente a mantenere e favorire legami forti coni loro territori, prestando particolare attenzione alle corti di valico(RINALDI 2003, p. 144).
Alla luce di quanto detto risultano maggiormente comprensibili leconsorterie feudali e le situazioni possessorie legate ad una feudalitàminore che proliferano sotto l’ala protettiva dei grandi signori territo-riali. Questi interessi divennero via via decisivi con il calare della pre-senza comitale a Parma (CARBONI 1999); non è un caso che la poten-za dello “stato” canossano sia sotto Bonifacio che sotto Matilde fosseincentrata sulla domus canossana, ovvero sui rappresentati della feu-dalità minore che rappresentavano il vero collante della giurisdizionedei marchesi di toscana (FUMAGALLI 1994). Allo stesso modo, moltospesso, (BORDONE 1987) i rappresentanti della stessa feudalità minoreosservata rientravano all’interno delle clientele vescovili quandodiviene preoccupazione dell’autorità ecclesiastica di mantenere ilcontrollo sul territorio (GRECI 2010b). La situazione possessoriadell’Alta Val d’Enza documentata da parte del vescovo di Parma restaa tutti gli effetti una dominazione più de jure che de facto, nonostan-te i diversi diplomi esaminati. Questa particolare viscosità nellagestione dell’area all’estremo confine con la Toscana non è sfuggitaagli storici emiliani che la esaminarono in diverse riprese. Per primofu Ireneo Affò a lamentare la sottrazione di beni della mensa vescovi-le da parte di “mani laiche et militari” che egli identifica con le clien-tele armate cittadine desiderose di indebolire la presa del vescovo sulterritorio (AFFO 1792). Di quali “mani laiche et militari” si parlasseancora ai tempi del vescovo Ugo (a. 1027) non è del tutto facile appu-rarlo con certezza.
Amadio Ronchini nella sua prefazione all’edizione degli Statutidella città di Parma (a. 1225) esamina alcuni passi delle disposizionistatutarie nei quali vengono descritte le esenzioni accordate dalComune ai domines de Valisneria et domines de Vagire et quos tene-ant equos pro guerra communis Parmae2. Tali esenzioni fiscali,applicate alle vaste regioni dell’Alta Val d’Enza rivendicate dall’autori-tà religiosa, mostrano la presenza di alcune famiglie insediate nel ter-ritorio le quali si pongono come interlocutrici con il comune di Parmatraendo benefici in cambio di aiuto militare e fedeltà. L’area, che gra-
160
2) Gli Statuti del 1255 della città di Parma sono in ASPr, 1255 e sono editi inRONCHINI 1856.
vita attorno ai centri di Vairo e Vallisnera viene definita come terraemilitum, denominazione che queste valli conservano ancora oggi nel-l’appellativo “Valli dei Cavalieri”. Ronchini ipotizza una infeudazionedi questi territori fatta dal comune ai cittadini più abbienti e suggeri-sce che «l’indagine genealogica, seppur così difficile in antico, ne con-fermerebbe l’attacco con il ceppo viscontile di Parma» (RONCHINI
1856). Di tutt’altro avviso il Micheli che nella sua indagine storica esa-mina a fondo i documenti e approfondisce le caratteristiche di giuri-sdizione nelle Valli dei Cavalieri delineando un complesso sistema difamiglie consorziate a controllare il territorio (MICHELI 1915). La tesidel Micheli è stata ripresa di recente nel panorama degli studi sullaformazione delle élites comunali; anche il caso in questione rientraall’interno delle dinamiche di sviluppo dei ceti dirigenti cittadini edelinea il loro rapporto fra il ruolo all’interno della città e la base ter-ritoriale-rurale dalla quale queste clientele traggono la loro forza(VIGUEUR 2004, p. 230).
Le capacità militari, di controllo del territorio ed economiche dellaconsorteria di milites, molto spesso legata al potere vescovile permezzo di donazioni e concessioni di livelli, risultano di primaria impor-tanza nella politica del nascente organismo comunale. Attraverso ilcontrollo di questi poteri di contado crea, infatti, le condizioni per ilgoverno del proprio territorio (GRECI 2005). Ad alcuni milites della con-sorteria erano affidate le entrate delle tasse e la sovrintendenza algoverno delle Artes dei maniscalchi e degli artigiani che lavoravano ifinimenti per le cavalcature. Godevano, inoltre, di un loro hospitale inParma fra la chiesa del santo sepolcro e l’attuale via Saffi ed avevanoassistenza spirituale nella chiesa di san Pietro, il cui portico sulla piaz-za grande era loro riservato (VIGUEUR 2004, p. 248).
La classe militare parmense, nel suo complesso, si compone dialtri elementi di origine feudale; gruppi familiari che ritrovano il lorocomune denominatore nel potere interno alle clientele vassallatichedi ambiente vescovile e configurato su base territoriale. Un caso, inparticolare, è quello dei da Cornazzano e dei Rossi che, partendo daposizioni di controllo giurisdizionale e amministrativo di alcune cur-tes di cui sono investiti dal vescovo, pongono le fondamenta di esteseproprietà e castellanie sparse per tutto il contado (GRECI 2010b). Altrifamiglie, quale quella dei Ruggeri, ritornano nella distribuzione dellecariche comunali all’esordio dell’esperienza di governo come membridella militia di origine aristocratica. I Ruggeri vantano poi il controllodel feudo e castello di Felino del quale vennero investiti da Federico I
161
e di cui, durante la fine del Trecento, i Rossi attraverso un’accortapolitica matrimoniale riescono ad entrare in possesso (GAMBERINI
2005).La posizione di predominanza sancita dagli statuti di Parma del
1255 (RONCHINI 1856, p. 238) permise ai membri della classe militaredi accumulare enormi ricchezze (VIGUEUR 2004, p. 230). Il principaleintroito era ovviamente rappresentato dalla gestione delle tasse nelleterrae militum all’interno delle quali sia i rossi, sia i Ruggeri, conser-vano fra il trecento (MICHELI 1915, p. 165) e il quattrocento vastiappezzamenti di terra, spesso in comproprietà con i membri dellaconsorteria dei milites (ASPR 1216). Nell’Alta Val d’Enza i militesmembri della consorteria dei domines de Valisneria et domines devagire assumono cognomi diversi a seconda della zona di influenza odi origine della famiglia e nel 1207, nella chiesa di Vallisnera promul-gano lo statuto di Vallisnera, volto a regolare gli obblighi dei liberi pro-prietari nei confronti dei signori e a tutelare gli interessi dei comunirurali (FONTANA 2010, p. 47).
(continua)
BIBLIOGRAFIA
ASPR 1216 – Archivio di Stato di Parma, Diplomatico, Atti privati.AFFO 1792 – I. Affò, Storia della città di Parma, I, Parma.ALBERTONI 2010 – M. P. Alberzoni, La chiesa cittadina, i monasteri e gli ordi-ni mendicanti, in Storia di Parma, III, Parma, pp. 261-322.ALFIERI ET ALII 1988 – N. Alfieri- M. Cremaschi- G. Marchetti- P. L. Dall’Aglio-A.Veggiani- G. Uggeri, Direttrici di traffico, in La formazione della città,Bologna, pp. 11-68.BARICCHI 1990 – W. Baricchi, Brevi note sugli itinerari medievalinell’Appennino Reggiano, in Canossa prima di Matilde, Milano, pp. 25-34.BORDONE 1987 – R. Bordone, La società cittadina del regno d’Italia: forma-zione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII, Torino, pp.144-197.BOTTAZZI 1994 – G. Bottazzi, Archeologia territoriale e viabilità, spunti diricerca sulle relazioni tra l’Emilia e il varsante tirrenico dall’Età del Bronzoal pieno Medioevo, in Archeologia nei territori Apuo-versiliese e Modenese-reggiano, Atti del Convegno (Modena 3 Ottobre 1993), Modena, pp. 169-266.BOTTAZZI 1997 – G. Bottazzi, Viabilità medievale nella collina e montagna
162
parmense fra i torrenti Parma ed Enza, in Studi Matildici IV: il territorioparmense da Carlo Magno ai Canossa, Atti del Convegno (Modena 17Settembre 1995), Modena, pp. 153-206.BOTTAZZI- SCALISE 1994 – G. Bottazzi- C. Scalise, Una ricerca campione sulpopolamento romano nell’alto Appennino emiliano: Sasso di NevianoArduini (Parma), in L’archeologia nei territori apuo-versiliese e modenese-reggiano, Atti del Convegno (Massa 3 Ottobre 1993), Modena, pp. 267-297.CAPACCHI 1983 – G. Capacchi, Vajro. Antica capitale delle Valli dei Cavalieri,Parma.CARBONI 1999 – B. Carboni, Alcune osservazioni riguardanti il comitato par-mense in territorio reggiano e modenese nei secoli X e XI, in «BollettinoStorico Reggiano», 71, Reggio nell’Emilia, pp. 1-13.DALL’AGLIO 2001 – P. L. Dall’Aglio, Viabilità romana e altomedievalesull’Appennino parmense: dalla Parma-Luni alla Via Francigena, in R.Greci (a cura di), Studi sull’Emilia occidentale nel Medioevo: società e isti-tuzioni, Bologna, pp. 1-24.DALL’AGLIO- DI COCCO 2006 – P. L. Dall’Aglio- I. Di Cocco, La linea e la rete.Formazione storica del sistema stradale in Emilia-Romagna, Milano 2006.FONTANA 2010 – F. Fontana, Le Valli dei Cavalieri. Storia, territorio, araldi-ca, Parma.FUMAGALLI 1994 – V. Fumagalli, Economia, società, istituzioni nell’Appenninotoscoemiliano occidentale durante l’Alto Medioevo, in Signorie Feudali ecomunità appenniniche, Atti del Convegno di Studi (Capugnano 3-4Settembre 1994), Pistoia, pp. 7- 12.GAMBERINI 2005 – A. Gamberini, La territorialità nel Basso Medioevo, inPoteri Signorili e feudali nelle campagne dell’Italia Settentrionale fra Tre eQuattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio, Atti delConvegno (Milano 11-12 Aprile 2003), Firenze, pp. 47-73.GRECI 2005 – R. Greci (a cura di), Il governo del vescovo, Parma.GRECI 2010 – R. Greci, Origini, sviluppi e crisi del comune, in Storia diParma, III, Parma, pp. 115-167.MANNONI 2000 – T. Mannoni, Gli aspetti archeologici della ricerca sulle stra-de medievali, in R. Greci (a cura di), Un’area di strada: l’Emilia occidenta-le nel Medioevo. Ricerche storiche e riflessioni metodologiche, Atti delConvegno (Parma-Castell’Arquato Novembre 1997), Bologna, pp. 13-18.MICHELI 1915 – G. Micheli, Le Valli dei Cavalieri. Note e documenti, Parma.NOBILI 1981 – M. Nobili, Le famiglie marchionali della Tuscia, in I ceti diri-genti in Toscana nell’età precomunale, Atti del I Convegno (Firenze 2 dicem-bre 1978), Pisa, pp. 71-105.NOBILI 1988 – M. Nobili, Alcune considerazioni circa l’estensione, la distri-buzione territoriale e il significato del patrimonio degli Obertenghi (metàsecolo X-inizio secolo XII), in Formazione e strutture dei ceti dominanti nel
163
Medioevo: marchesi conti e visconti nel Regno Italico (secc. IX-XII), Roma,pp. 71-81.NOBILI 1997 – M. Nobili, Le signorie territoriali degli obertenghi inLunigiana, in La signoria rurale nel medioevo italiano, I, Pisa, pp. 19-37.PELLEGRI 1970 – M. Pellegri, Pievati e strade in pergamene dal 1004 al 1230,in «Parma nell’Arte», II, Parma, pp.121-134.PELLEGRI 1973 – M. Pellegri, Ospizi e Xenodochi nel parmense dagli inizi al1471, Parma.PIVANO 1916 – S. Pivano, Le Valli dei Cavalieri, a proposito di recente pub-blicazione, in «Archivio Storico per le Provincie Parmensi», Parma.PORTER 1918 – A. K. Porter, The Rise of Romanesque Sculpture, «AmericanJournal of Archaeology», pp. 399-427.PORTER 1924 – A. K. Porter, The Tomb of Doñña Sancha and the RomansqueArt of Aragon, in «The Burlington Magasine», pp. 165-179.QUINTAVALLE 1967 – A. C. Quintavalle, Continuità medioevale, Firenze,pp.1-97.QUINTAVALLE 1969 – A. C. Quintavalle, Romanico padano, civiltàd’Occidente, Firenze.QUINTAVALLE 1977 – A. C. Quintavalle, L’immagine e l’eresia, in Romanicopadano Romanico europeo, Atti del Convegno Internazionale di Studi(Modena-Parma, 26 ottobre-1 novembre 1977), Parma, pp. 1-22.RINALDI 2003 – R. Rinaldi, Tra le carte di famiglia. Studi e testi canossani,Bologna.RONCAI 2007 – L. Roncai, Un territorio strada, in L. Briselli, Hanno per scuo-la l’Alpe, Cremona, pp. 69-89.RONCHINI 1856 – A. Ronchini, Statuta Communis Parmae digesta anno 1255,Parma, pp. 13-18.SCHIAVI 1925 – A. Schiavi, La diocesi di Parma, I, Parma.STATUTA 1590 – Statuta Magnificae Ciuitatis Parmae, Parma.TAGLIAVINI 1988 – A. Tagliavini, La penetrazione longobarda nell’appenninotosco-emiliano e le sue direttrici, in “Le Valli dei Cavalieri”, 9, Parma, pp. 3-12.VIGUEUR 2004 – J. C. M. Vigueur, Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti esocietà nell’Italia comunale, Bologna.
164
RASSEGNA DI STORIA E DI VITADELL’ALTA VAL D’ENZA E DELLA VAL CEDRA
32
2015
A CURA DELLA COMUNITÀ DELLE VALLI DEI CAVALIERI
LE VALLI DEI CAVALIERIRASSEGNA DI STORIA E VITADELL'ALTA VAL D'ENZA E VAL CEDRA
Comitato di Redazione
MICHELE BERINICARLOTTA CAPACCHIFILIPPO FONTANARACHELE GRASSIFRANCESCA SCALA
*
Periodico annuale. I volumi possono essereacquistati presso la Libreria Palatina Editriceb.go Tommasini 9/a43123 Parma0521/[email protected]
*
I manoscritti possono essere inviati allaSegreteria della Comunità delle Valli dei Cavalieriall'[email protected]
*
ISBN: 9788894014518Impaginazione: Adriano MilesiStampa: Cartografica Toscana
*
In copertina:Camillo Scaramuzza (1866) Case di Vairo – (par-ticolare), olio su tela 95 x 135 cmGalleria Nazionale di Parma
67
(segue dal numero precedente)
Le caratteristiche che abbiamo fin qui esaminato delineanole principali vie di risalita lungo la val d'Enza Val d'Enza. Le fre-quentazioni preistoriche a più alta quota invece, come quelle situatenella linea di risalita dell’itinerario fluviale dell’Enza, lasciano in-tendere finalità più prettamente di controllo e occupazioni stagio-nali volte alla conduzione di attività economiche quali l’alpeggio(TIRABASSI 1996) o l'approvvigionamento di arenaria, steatite, cornodi cervo, conchiglie fossili e minerali di rame presenti in giacimentinon redditizi ma significativi per le esigenze del tempo. A questoproposito è interessante ricordare che l’impatto economico dell’alle-vamento caprovino è ampiamente documentato con l’alto numerodi capi di bestiame attestati nei resti osteologici rinvenuti nelle ter-ramare di pianura (DE GROSSI MAZZORIN-RIEDEL 1997, pp. 475-480).Su queste basi è plausibile l’esistenza di percorsi di transumanza im-postati anche su insediamenti a carattere stagionale si può citare lapersistenza di consuetudini quali gli spostamenti delle mandrie dicaprovini che, documentate dall’età romana (BOTTAZZI 1994) nella ta-bula alimentaria e in pieno medioevo fino ai giorni nostri si inseri-scono suggestivamente in un contesto culturale ed economico qualequello descritto (DE MARCHI 2003, p. 171).La distribuzione dei siti nella media e alta Valle dell’Enza delineauna tendenza, che ha il suo inizio durante la fase iniziale del BronzoMedio, ad occupare in maniera sistematica e diffusa il territorio inprossimità di paleosuperfici e terminazioni di crinale delineando unadistribuzione prevalente di siti d’altura con le caratteristiche econo-miche tracciate supra (DE MARCHI 2003, pp. 174-179). La tendenza al
VIABILITÀ STORICA
NELLE VALLI DEI CAVALIERI
FILIPPO FONTANA
68
progressivo arrocamento in posizioni di controllo fra Bronzo Medioe Recente generalizzata per l’ambito collinare e montano terramari-colo trova delle corrispondenze in Val d’Enza nelle attestazioni diCecciola e Groppo di Vetto e ha corrispondenze con il coevo incre-mento delle fortificazioni delle terramare in pianura (BERNABÒ BREA-CARDARELLI-CREMASCHI 1997, p. 281). Il modello insediativo c.d.diffuso mostra alcuni cambiamenti nel corso della fase iniziale dellaRecente Età del Bronzo quando si osserva la tendenza di alcuni sitistrategici e di piccole dimensioni a essere sostituiti da abitati estesie posti in ampie paleosuperfici a controllo del paesaggio. La ten-denza a forme di insediamento caratterizzate da un fenomeno diibridismo culturale si fa più evidente nella Recente età del bronzo(monte Verola monte corno). Una variabilità così struttrurata sembraaver favorito, assieme alle condizioni geografiche, in settori partico-larmente chiusi quali vallecole laterali lo sviluppo di tipologie “lo-cali” (DE MARCHI 2003, p. 174). Gli sviluppi culturali terramaricoli eibridi sono ampiamente documentati in Val d’Enza al contrario delleforti presenze occidentali in val parma e val baganza. La viabilità dicrinale sviluppata lungo l’asta fluviale dell’enza, centrale anche nellescelte insediative altomedievali sembrava essere una percorrenzatransappenninica sfruttata eminentemente da comunità terramari-cole. Emergono pertanto siti di cultura terramaricola in Val d’Enzaquali Monticelli di Guardasone, San Polo, Rossena, Groppo, Casterfìmentre presentano caratteristiche di cultura mista le attestazioni diPieve di Sasso e Cecciola.Alcuni autori hanno messo in luce un primo impianto pertinente aduna fase di espansione degli insediamenti e dei traffici durante il VI-V secolo a.C. (DE MARCHI- MACELLARI 2005) mentre sembra acclaratoil potenziamento a partire dal IV secolo d.C. di assi viari già attivi inetà romana (LIPPOLIS 1997). I rinvenimenti di Campo Pianelli e delCasale di Bismantova assieme al centro proto-urbano di Servirola te-stimoniano la vitalità del percorso e la sua posizione di contatto fral'alta toscana e il fiume Pò seguendo una direttrice di traffico che ar-riva fino al grande emporio di Frattesina di Fratta Polesine (DAL-L'AGLIO- DI COCCO 2006). Sulla base di quanto esposto è quindipossibile definire il sistema itinerario della valle attraverso i seguentiassi connotati da una diversa posizione nella gerarchia itineraria equindi da un diverso utilizzo: Via di Val d'Enza, Via di Badia Cavana
Fig. 1 - Particolare cartografico che indica la presenza del Ponte del Pievato– ASPr, Raccolta di mappe e disegni
69
e di Linari, assi di collegamento Est-Ovest.Dal punto di vista della geografia fisica il tratto ovest del-
l’Appennino emiliano è caratterizzato da tutta una serie di vallatetra loro subparallele che vengono a costituire delle naturali direttriciche dalla pianura raggiungono il crinale spartiacque principale,mentre a sud questa struttura “a pettine” lascia il posto ad una seriedi bacini elissoidali con l'asse maggiore all'incirca orientato NO-SE,che altro non sono se non antichissimi invasi lacustri progressiva-mente colmatisi a partire dal Villafranchiano e poi incisi dai corsid'acqua che si sono impostati in essi. L'andamento di questi bacini fasì che ciascuno di essi finisca per essere il collettore di tutta una seriedi quelle direttrici che da nord raggiungono i valichi appenninici.Così, ad esempio, in Lunigiana mettono tutti valichi che si aprono trala Val Taro ad ovest e la testata di valle dell'Enza ad est. La valle delMagra diventa quindi il bacino di raccolta della maggior parte delledirettrici che dalla pianura parmense risalgono l'Appennino alla
volta del crinale spartiacque principale, divenendo perciò il canale dicollegamento tra queste e il mare. Oltre a questo elemento di carat-tere geografico, la nascita di Parma e Luni è accomunata dalla fun-zione di capisaldi della lotta contro i Liguri, funzione che coinvolgeanche Lucca.
Nell’analisi del paesaggio tardoantico in rapporto all’inse-diamento è utile focalizzare l'attenzione sul cambiamento politico-amministrative avvenuto attorno al VI sec. d. C. cui è succeduto ilmodificarsi dell'uso del territorio e quindi della gerarchia itineraria.Già le fonti itinerarie, in particolare l’Itinerarium Antonini, riportanoindicazione riguardo ai percorsi attivi fra III e IV secolo. I dati in let-teratura sembrano quindi convergere verso la definizione di un mo-mento, che trova il suo culmine nell’VIII secolo, in cui laridefinizione degli assetti territoriali nella Regio VIII riflette il cam-biamento delle condizioni politiche dagli avvenimenti della guerragreco-gotica alla conquista longobarda.
Il potenziamento dell'idrovia padana sul fiume Po, docu-mentata nel IV secolo dalla Tabula Peutingeriana con un iter ab Hosti-lia Ravennam per Padum e ancora attiva nell’VIII secolo come si evincedal Capitolare liutprandeao (MONTANARI 1986, p.461), unito allo spo-stamento della capitale da Milano a Ravenna porta ad un indeboli-mento del tradizionale asse nord-sud (via Emilia-via Flaminia) conil conseguente potenziamento degli assi tran-sappenninici. È all'in-terno di tale nuova situazione che si colloca la sostituzione del-l'odonimo Aemilia con Claudia nel tratto ad ovest di Bologna e conFlaminia tra Bologna e Rimini. Sulla scorta di queste osservazioni èstato identificato un cambio della gerarchia itineriaria che si riflettenel mutamento onomastico e si identifica con l’impianto di un nuovopercorso preferenziale via Aemilia o, per quanto riguarda la via Clo-dia, ad essa collegata da tutta una serie di bretelle transappennini-che, tra cui la Perme-Laca dell'Itinerarium Antonini. Diversi Topografiche si sono occupati del tema (DALL'AGLIO 1998; STORCHI 2008) hannosottolinato come lo sviluppo del cammino in età romana dovesseproseguire verso sud, oltre il tracciato Brixellum-Tannetum-Luceria,fino a raggiungere il crinale. Collegamenti diretti fra Parma e Luccasono documentati ancora nel VI secolo in relazione agli avvenimentiche coinvolsero le due città nel 553 d.C. così come raccontato da Aga-zia (Agathia, Historiae I 14-15). In pieno VII sec. La notizia del viag-
70
gio dell'abate di Bobbio Bertulfo, ammalatosi di ritorno da Romapresso Bismantova, denota la persistenza dell'attività del percorso(STORCHI 2008, p. 105).Se i cambiamenti del sistema itinerario sono la conseguenza dellemutate condizioni politico-amministrative rimane da chiarire, perquanto riguarda il territorio in esame, quali siano i rapporti con il si-stema insediativo. Nella vicina Val Taro il tracciato della Parma- Lunisarà utilizzato, a partire dal VII secolo, per garantire il passaggiotrans-appenninico la cui importanza è stata più volte sottolineatanell’ambito dell’affermazione del regno longobardo (DALL'AGLIO
1998, p. 80). In età romana è appurata l’esistenza di un asse stradaleche tagliava obliquamente le maglie centuriali con un andamento ri-preso dall’attuale via Traversetolo e risaliva la valle dell’Enza inprossimità del vicus di Luceria valicando l’Appennino in prossimitàdei passi dell’Ospedalaccio o del Pradarena per raggiungere Lucca.I contributi più recenti concordano nel poter riconoscere in questoasse il percorso Parma- Lucca noto dall’Itinerarium Antonini (DAL-L’AGLIO 2009, p. 586; STORCHI 2008, p.104). La diversa gerarchizza-zione degli assi viari che assicuravano il collegamentotrans-appenninico ha, come documentano diversi casi di studio(DALL'AGLIO - DI COCCO 2006, p. 134), influito nelle scelte insediativee di gestione del territorio fra IV e VIII secolo.
Ancora in epoca moderna, così come si evince dalle infor-mazioni riportate dalla dispute confinarie che hanno interessato leValli dei Cavalieri nel XVII secolo, la via di risalita al passo del Cer-reto seguiva il tracciato antico. L'importanza del percorso è testimo-niata dall'utilizzo quale confine fra i ducati di Parma e Modena conil nome di strada Parmesana. Questo tracciato, in risalita della Vald'Enza sul versante destro, è documentato già nella relaziona, fattanel 1458, dal commissario incaricato da Duca di Parma di dirimerele controversie di confine con gli Stati Estensi (MICHELI 1915, p.82). Lacopiosa documentazione riguardante la questione, protrattasi finoal XVIII secolo, ci informa sull'andamento del percorso che staccan-dosi dalla via Emilia all'altezza di Sant'Ilario proseguiva per Cianod'Enza ricalcando l'itinerario antico. Da qui risalendo per Cereggiolae, attraverso i terrazzi fluviali, Vetto fino alla costa di Cereggio eTemporia per poi passare a lato di Ramiseto e risalire verso PieveSan Vincenzo quindi attraverso il Passo della Scalucchia guadagnare
71
Fig. 2 - La viabilità lungo la Val d'Enza sui due versanti – ASPr, Raccoltadi mappe e disegni
72
il valichi del Cerreto e dell'Ospedalaccio secondo un percorso calco-lato in 140 km (Lerici-Parma) uguagliando il percorso attraverso laCisa (RONCAI 2007).
Secondo indicazioni cartografiche di XVIII sec. (ASPr XVIII)già all'altezza di Ciano d'Enza era presente un attraversamento delfiume dal quale la strada si snodava a mezza costa attorno al monteLugaro, dove si riconoscono diversi tratti di selciato con sistemazionie tagliate nella roccia. Raggiunto Cedogno, con un nuovo passaggiooltre il fiume, si portava fino a Vetto ricongiungendosi all'asse viarioprincipale sul versante destro del fiume. I resti del ponte all'altezzadi Vetto, di cui si dirà più avanti, testimoniano un passaggio attivoin età medievale verso il versante sinistro della Valle. Dopo aver su-perato, a valle, Scurano, prosegue verso Ruzzano e Ranzano arri-vando a Rigoso per Vaestano e Nigone. Un'interessante notazionecartografica, nel medesimo documento, segnala all'altezza di Ran-zano una bivio dal quale si diparte verso sud un'altra strada il cui
73
orientamento riprende quello del percorso che, proseguendo da Ron-carola a Moragnano si affacciava in Val Parma all'altezza di BadiaCavana. Della c.d. “Via di Badia Cavana e di Linari”, che per la cittàdi Parma assunse particolare importanza durante il XVI secolo (es-sendo il percorso principale sul versante destro parzialmente in ter-ritorio estense), abbiamo illustrato caratteristiche problematiche suqueste stesse pagine (FONTANA 2014).
Di estremo interesse, per la definizione degli itinerari inter-vallivi sull'asse est-ovest, appare l'indicazione dell'esistenza sul fi-nire del XVII secolo di un ponte sull'Enza nel tratto più alto dellaValle, fra Nirone e Vairo, indicato con il nome di Ponte del Pievato(ASPr XVI). In merito a questo appare utile indicare come nella fa-scia alta della vallata passasse il percorso detto della Braja che do-veva attraversare il fiume nell'area dove doveva sorgere il manufattosecondo la notazione cartografica. Le indicazioni riguardo alla pre-senza di manufatti per il guado del fiume sono riferibili a due noti-zie riguardanti un ponte in localita ad moras de Encia (XIV sec.) e unosul torrente Cedra in prossimita del villaggio di Isola (XV sec.). Perla parte alta della vallata non si sono trovate indicazioni né docu-mentali né archeologiche che indicassero la certa presenza di guadio ponti stabili. Solo una lettera di supplica al governatore della cittàdi Parma (1847) riporta le richieste degli abitanti che lamentano lamancanza, nella parte alta della vallata, di un ponte stabile che per-metta il passaggio sia in estate che in inverno (GRASSI 2008, p. 53). Aquesto proposito, in luogo dell'attuale ponte della Golara, costruitonel secolo scorso, la memoria popolare ricorda un antico ponte, lacui memoria si perde nella notte dei tempi, proprio dove in anticosorgeva il Ponte del Pievato che, tuttavia, doveva essere distrutto allametà dell'Ottocento.
La disamina del sistema viario dell'Alta Val d'Enza fa emer-gere due assi principali di risalita posti sul versante destro e sinistrodel fiume. Attestazioni di un percorso importante per i traffici suampio raggio segnalano definiscono il tracciato della c.d. Via di Vald'Enza (STORCHI 2008) che si sviluppa sul versante destro fin dall'etàdel Bronzo. Successivamente, secondo delle dinamiche di occupa-zione e controllo territoriale che si sviluppano dal IX al XII secolo siassiste alla definizione di un asse viario, gerarchicamente meno im-portante del primo, che si sviluppa lungo il versante sinistro del-
l'Enza affacciandosi in val Parma all'altezza di Badia Cavana. Su que-sto percorso, battuto da un trasporto e una frequentazione preva-lentemente locale ossia a corto raggio, durante il XV e XVI secoloverrà impostato l'itinerario preferenziale di approvigionamento delsale in arrivo nella città di Parma. Ugualmente di corto raggio, edutili al passaggio trans-vallivo, risultano essere la via della Braja, cheinteressa il tratto alto della vallata nel percorso documentato dal-l'investitura a Niccolò Terzi, e la via posizionata in prossimità delponte della mora. Se sia esso da situarsi fra Ranzano e Temporia ov-vero nell'area antistante Vetto, dove rimangono i resti di due arcate,è ancora questione aperta. Gli statuti che ricordano la volontà di eri-gere un ponte ad moras de Henzia, con il lavoro prestato dagli uominidi Bazzano e Neviano, non ci da notizie certe riguardo la sua effet-tiva costruzione. Il manufatto, sul quale abbiamo operato dei rilievistratigrafici murari, sembra mostrare caratteristiche costruttive as-sieme ad una tecnica edilizia compatibile con il XIV secolo che con-tribuiscono a suggerire un'attribuzione. Le motivazioni che, con ogniprobabilità, spinsero Giacomo della Palude a perorare l'erezione diun ponte in quella posizione sono state già ampiamente espresse(CAPACCHI 1983); quello che è possibile aggiungere in questa sede èuna valutazione sulla natura geomorfologica dell'area dove sorge ilponte di Vetto che, delineando uno stretto morfologico in corri-spondenza di un meandro, è caratteristica dei guadi fluviali impo-stati laddove la corrente e la distanza tra le due sponde sono minori.Dal punto di vista itinerario, inoltre, il percorso che sfrutta ponte perattraversare l'Enza e risalirne il corso, aggirando il monte Fuso e con-nettendosi alla via di Badia Cavana e di Linari, si stacca all'altezza diVetto da un'arteria di cui abbiamo sottolineato l'importanza e chemaggiormente contestualizza un manufatto di tanto rilievo.
Bibliografia:
ASPr XVI = Archivio di Stato di Parma, Raccolta di Mappe e Disegni,vol. I, carta 2ASPr XVIII = Archivio di Stato di Parma, Raccolta di Mappe e Dise-gni, 45/18
74
BERNABÒ BREA-CARDARELLI-CREMASCHI 1997 = M. Bernabò Brea-A.Cardarelli-M. Cremaschi, L’insediamento collinare e montano, in M. Ber-nabò Brea-A. Cardarelli-M. Cremaschi (a cura di), Le Terramare, la piùantica civiltà padana, Catalogo della Mostra (Modena-Foro Boario 15Marzo-1 Giugno 1997), Milano, pp. 275-295BOTTAZZI 1994 = G. Bottazzi, Archeologia territoriale e viabilità: spunti diricerca sulle relazioni tra l’Emilia e il versante tirrenico dall’Età del Bronzoal pieno Medioevo, in Archeologia nei territori apuo-versiliese e modenese-reggiano, Atti del Convegno (Modena 3 Ottobre 1993), Modena pp.169-266CAPACCHI 1983 = G. Capacchi, Alcune note per la storia della Temporia:il castello del Gaso e il ponte della Mora, in «Valli dei Cavalieri», VI,Parma, pp. 21-32DALL'AGLIO 1998 = P. L. Dall'Aglio,Dalla Parma-Luni alla via Franci-gena: storia di una strada, ParmaDALL'AGLIO - DI COCCO 2006 = P. L. Dall’Aglio-I. Di Cocco, La linea ela rete. Formazione storica del sistema stradale in Emilia Romagna, Mi-lanoDALL’AGLIO 2009 = P. L. Dall’Aglio, Il territorio di Parma in età romana,in D. Vera (a cura di), Storia di Parma, II, Parma, pp. 555-602DE GROSSI MAZZORIN-RIEDEL 1997 = J. De Grossi Mazzorin-A. Riedel,La fauna delle terramare, in M. Bernabò Brea-A. Cardarelli-M. Crema-schi (a cura di), Le Terramare, la più antica civiltà padana, Catalogo dellaMostra (Modena-Foro Boario 15 Marzo-1 Giugno 1997), Milano, pp.475-481DE MARCHI 2003 = L. De Marchi, Archeologia della Preistoria fra par-mense e reggiano: l’Età del Bronzo nelle Valli Parma, Enza e Baganza,ParmaDE MARCHI- MACELLARI 2005 = L. de Marchi- R. Macellari, Archeolo-gia globale del territorio fra parmense e reggiano. L’età del Ferro nelle ValliParma, Enza e Baganza tra civilizzazione etrusca e cultura ligure, PratoFONTANA 2014 = F. Fontana, Viabilità storica nelle Valli dei Cavalieri, in«Valli dei Cavalieri», XXXI, Parma, pp. 44-57GRASSI 2008 = R. Grassi, Un ponte per unire le Valli dei Cavalieri, in«Valli dei Cavalieri», XXV, Parma, pp. 45-47LIPPOLIS 1997 = E. Lippolis, Nuceria, in XLIII Corso di cultura sull'arteravennate e bizantina, Ravenna, pp. 401-428MONTANARI 1986 = M. Montanari, Il capitolare di Liutprando: note e sto-
75
ria dell'economia e dell'alimentazione, in La civiltà comacchiese e pompo-siana: dalle origini preistoriche al tardo Medioevo, Atti del Convegno na-zionale di studi storici (Comacchio 17-19 Maggio 1984), Ferrara, pp.461-497RONCAI 2007= L. Roncai, Un'area di strada, in L. Briselli, Hanno perscuola l'Alpe, Succiso (RE), pp. 69-89STORCHI 2008 = P. Storchi, La viabilità nella provincia di Reggio Emilia.Elementi per l'individuazione di un tramite fra l'Italia centrale e setten-trionale, in «Orizzonti», IX, Pisa, pp. 101-105
76