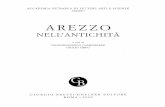Mutilazioni dei genitali femminili e diritti umani nelle comunità migranti
Insediamenti umani pleistocenici e la viabilità di caccia sul Tauro acron e nel suo hinterland
Transcript of Insediamenti umani pleistocenici e la viabilità di caccia sul Tauro acron e nel suo hinterland
Italo Russo
INSEDIAMENTI UMANI PLEISTOCENICI NEL TERRITORIO AUGUSTANO E LA VIABILITÀ PREISTORICA
DI CACCIA SUL TAURO E NEL SUO HINTERLAND
Human pleistocene settlements in the augustan country and the prehistoric hunting paths
on the Tauros acron and on its hinterland
__________________________
A- SCOPI DELLA NOTA.
La nota (che non è da ritenere esaustiva del problema di cui ci occupiamo) esamina, in funzione della identificazione di presunti antichi itinerari, la realtà archeologica preistorica pleistocenica e del primo Olocene, nota ed inedita, del Monte Tauro (1) e del suo hinterland, e considera l’arco di tempo compreso tra le prime manifestazioni del Paleolitico superiore e l’insorgere, nel primo Olocene, delle culture c.d. epipaleolitiche o di tra-dizione paleolitica.
Siamo coscienti che la nostra ipotesi, in quanto basata sulla interpreta-zione di dati culturali purtroppo insufficienti (manufatti litici, per esem-pio, il più delle volte frutto di ricognizioni di superficie o di scavi incon-trollati; in assenza di basi cronologiche assolute (2); nella impossibilità di distinguere con chiarezza le varie fasi del processo evolutivo per l’assenza di ricerche condotte a largo raggio e correlate), da sola non aiuta a risolve-re il problema relativo alla conoscenza della presunta viabilità preistorica nel nostro territorio, se non mettendo a confronto, se esistenti, e con diffi-coltà, tecniche di sussistenza espresse da comunità già accertate paritarie, delle quali è possibile ipotizzare fenomeni di interrelazione ed interazio-
ITINERARI SUL TAURO PLEISTOCENICO ITALO RUSSO
2
ne, e, quindi, presumere per le stesse collegamenti “reali” a mezzo di si-stemi viari preferenziali.
Manca intanto, a nostro parere, a pro della viabilità preistorica, un u-nicum, una sintesi della ricerca finalizzata alla individuazione di definibili direttrici lungo le quali si sono mosse le varie correnti culturali paleoliti-che o di tradizione paleolitica che si sono attestate sul territorio augusta-no. Mancandoci, come abbiamo detto, dei riferimenti soddisfacenti, e nel-la impossibilità di collegare razionalmente gli esisti della ricerca, purtrop-po in Sicilia molto avara di dati, compreso il nostro territorio malgrado diverso parere espresso da autorevoli studiosi (3), la nostra rimane una ipo-tesi interpretativa, che può suggerire il modo di muoversi “nel problema”, ma non può fornire dati assoluti per la sua risoluzione.
B- Paradigma d’indagine del territorio di caccia.
Se un sentiero viene naturalmente ad essere tracciato in quanto è possibile percorrere lo spazio lungo una sue serie indefinita di punti a, b, c, …, una strada viene invece segnata per congiungere il punto A al punto B, e quindi il B al punto C, e così di seguito se un sistema viario è abbastanza sviluppato ed i centri A, B, C, contemporanei e dello stesso status.
Quindi, mentre il sentiero percorre il tòpos, e si esaurisce in esso, la strada, o via, attraversa lo spazio per unire due o più tòpoi politicamente compatibili.
Intanto è da assumere che A e B possono essere congiunti da una stra-da in quanto esistano come punti, ed esistano entrambi nello stesso mo-mento “storico” come entità topografica. Se B non esiste, una strada che si parte da A non ha senso, se non a prendere atto che si è, in effetti, in presenza di un sentiero che si snoda, anche sulla lunga distanza, più o meno regolarmente, secondo una linea retta, curva o spezzata, ma dentro il tòpos, cioè entro limiti territoriali indefiniti, geograficamente non ap-prezzabili.
In una economia di sussistenza basata sulla caccia, sulla pesca e sulla raccolta di prodotti spontanei della terra, sia essa pianificata o non, i punti a, b, c, … , sono altrettanti tòpoi che l’uomo, il più delle volte inciden-talmente, scopre e, se lo ritiene opportuno e conveniente, decide di sfrut-tare; e poiché in un simile modello economico i bisogni sono da ritenersi
ITINERARI SUL TAURO PLEISTOCENICO ITALO RUSSO
3
elementari ed i modi per soddisfarli sono il più delle volte azioni riflesse, estemporanee, si può assumere per certo che il sentiero viene a svilupparsi su 360°, dove i punti a, b, c, …, più che essere raggiunti, vengono scoper-ti, e quindi valorizzati nello stesso momento in cui se ne riconosce l’utilità immediata, ed eventualmente futura. Il tòpos a, può essere un passaggio obbligato di quaglie o tortore, mentre il tòpos b, una estensione di terreno dove abbondano i conigli (la Gisira di Brucoli, per esempio). Per raggiun-gere i tòpoi a, e b, non è escluso che si debba attraversare il tòpos c, (il greto di un torrente), che può fornire nuclei di selce o quarzite.
Trattandosi di una economia di sussistenza basata sullo sfruttamento di animali e piante selvatici, la valorizzazione del tòpos presuppone l’incidenza di una particolare “capacità di sostentamento”(4), non necessa-riamente definibile topograficamente né demograficamente. A voler se-guire la Laviosa Zambotti (5) , “…l’economia di caccia vive nel tempo e si irradia nello spazio”.
È certo in ogni caso che tale modo di procacciasi il cibo costringe l’uomo a muoversi secondo il bisogno immediato, a differenza di una e-conomia agricola alla zappa o all’aratro che può pianificare la produzione, compreso il surplus, e deciderne il trasferimento da A a B e da qui a C, a mezzo di sistemi viari affermati e politicamente riconosciuti, tipici della civiltà urbana o ad essa assimilabile.
In quanto abbiamo detto più sopra che il punto B per essere raggiunto da una via deve almeno esistere, si rende necessario per chi scrive di rag-gruppare le entità archeologiche secondo la cultura, o corrente culturale se possibile, da esse espressa, nella presunzione che le stesse siano coeve anche se non facenti parte di un sistema complesso; in altre parole -assunto per buono che nella preistoria del nostro territorio certamente non si costruivano strade, né si tracciavano sentieri in funzione di “future” necessità politiche, militari od economiche- è necessario tentare di dimo-strare, se possibile, almeno che A sia coevo a B. Altrimenti non avrebbe senso ipotizzare un collegamento viario fra culture distanti nel tempo an-che migliaia di anni; sarebbe, infatti, assurdo più che paradossale, ipotiz-zare contatti tra una stazione paleolitica, che tutto lascia supporre trattarsi di un insediamento dell’Epigravettiano finale siciliano nella sua fase a ge-ometrici triangolari, con altro insediamento del Gravettiano propriamente detto, magari in una sua fase evoluta.
ITINERARI SUL TAURO PLEISTOCENICO ITALO RUSSO
4
Altrettanto difficile sarebbe discutere di contatti fra insediamenti neo-litici di diversa collocazione temporale e culturale. Per esempio, come ab-biamo cercato di dimostrare in un recente lavoro (6), l’insediamento di Punta Bonìco sulla Gisira, nella sua fase a trancianti trasversali della tra-dizione geometrica, al quale altri ha attribuito una economia “agricola” semplicemente perché neolitico, e con esso tutta la mezzaluna brucolana fino a Punta Tonnara, è da ascriversi ad un neolitico di tradizione mesoli-tica –quindi, per il confronto stilistico e tipologico che riteniamo di poter stabilire con la grotta dell’Uzzo a Trapani (7), dove è stato possibile otte-nere delle datazioni al 14C, collocabile alla fine del VII o agli inizi del VI millennio a.C.- mentre Mégara Hyblaea, come precisa il Vallet (1959), e come è stato confermato da un nostro recente studio (8), “…appartient à la phase la plus récente de la civilisation néolithique…”, ed esprime una e-conomia decisamente agricola.
Altri esempi non riteniamo necessari, ma conviene subito sottoporre a disamina i vari siti preistorici di cui ci occupiamo in funzione dei possibili contatti con altri siti, e quindi della definizione eventuale di una “viabilità di contatto” e non di un “flusso culturale isolato di transito”.
C- I SITI DEL PALEOLITICO SUPERIORE DEL TERRITORIOESAMI NATO.
Relativamente al Paleolitico superiore (rappresentato fino ad oggi dalle grotte di Campolato, da un Riparo sotto roccia sempre a Campolato, dal Vallone Amara nord, dal Vallone Amara sud o Acquasanta, dal Cozzo Telegrafo e dal Maccaudo) sembrerebbe confermato che l’uomo paleoliti-co del Cozzo Telegrafo sia stato nel suo tempo il primo e, forse, il solo padrone a percorrere un territorio che, secondo come proposto da Higgs e Vita-Finzi (9), poteva essere raggiunto e “sfruttato” in una giornata di cac-cia. Adattando al territorio da noi esaminato le distanze supposte dagli Autori -10 km di raggio per una attività di sussistenza basata prevalente-mente sulla caccia –il nostro cacciatore paleolitico avrebbe avuto la pos-sibilità di esplorare il bacino di tutti i maggiori corsi d’acqua del territo-rio: il S. Calogero, il Porcaria e quindi il Mulinello, il Marcellino e, forse, il Cantera, nel cui ambito livelli culturali presunti coevi alle varie presen-ze paleolitiche del Tauro non sono noti. Un rapporto di interdipendenza, o
ITINERARI SUL TAURO PLEISTOCENICO ITALO RUSSO
5
un contatto, tra i vari siti paleolitici (visti i dati a disposizione, le modalità di acquisizione dei dati stessi, e la evidente discordanza culturale che lo strumentario recuperato evidenzia), non può essere assolutamente soste-nuto, malgrado quattro siti su sei (Campolato grotte, Campolato riparo, Vallone Amara nord e Acquasanta) si trovino allineati a poca distanza l’uno dall’altro, su un tratto di alta scogliera tirreniana, in non più di 1500 metri di sviluppo costiero.
Comune ai quattro siti sembrerebbe l’assenza di microlitismo geome-trico. Quindi, possiamo solo ipotizzare, ma non provare in alcun modo, allo stato attuale delle nostre conoscenze, la possibilità che più siti siano stati occupati nello stesso tempo da gruppi umani diversi, che a Monte Tauro avevano provvisoriamente stabilito la loro dimora.
Contatti tra Monte Tauro e l’entroterra paleolitico rappresentato dal Cozzo Telegrafo e dal Vallone Maccaudo, sono da escludersi. Il Maccau-do, a differenza del Tauro, gravita nella sfera del microlitismo geometrico –triangoli e segmenti di cerchio, ma anche prototipi di trapezio o trancian-te trasversale; pochi, ancora insufficienti ma significativi, gli indizi di una più antica frequentazione pre geometrica -mentre il Cozzo Telegrafo, che restituisce dorsi arcuati, assenti a Monte Tauro, ed indizi di un Gravettia-no relativamente evoluto, è da porsi, a nostro parere, in un momento più antico della frequentazione paleolitica del territorio augustano.
Emergerebbe, dai pochi indizi a nostra disposizione, che l’uomo, pri-ma di colonizzare la falesia tirreniana del Tauro, si sia fermato nell’immediato entroterra (due chilometri mediamente dalla costa), ed ab-bia sfruttato le risorse dell’ hinterland, i cui depositi antropici contengono Bos ed Equus. L’ipotetica assenza di consistenti indizi di interdipendenza culturale tra i vari siti del Monte Tauro, escluderebbe in ogni caso la pos-sibilità che anche le due località di Campolato e di Acquasanta, pur con industria tipologicamente confrontabile, fossero strategicamente unite da una via ideale di raccordo. Tutto quindi lascia supporre che l’uomo il qua-le si fermò nel territorio augustano, sia che si fosse stanziato sulla costa che nell’immediato entroterra, in effetti era solo: il solo a muoversi su 360° alla ricerca del cibo.
E poiché non sembra che la nostra Isola sia stata interessata da episodi migrazionali dei grandi mammiferi, che si ritiene stanziali per le margina-li modificazioni ecologiche che il variare del clima tardo pleistocenico ha
ITINERARI SUL TAURO PLEISTOCENICO ITALO RUSSO
6
prodotto da noi, è da ritenersi che l’attività di caccia non risentisse dei lunghi spostamenti che un branco in movimento impone.
Dobbiamo tuttavia ammettere una diversa (da oggi) condizione am-bientale nel tempo in cui riteniamo che l’uomo paleolitico si sia aggirato sulle nostre terre alla ricerca di cibo. Il “graben di Palma” (10) nella sua e-stensione areale meridionale, ai confini col sinus megarensis e col golfo Xifonio certamente paludosi, come toponimi tardi ci indicano (11) e come la topografia evidenzia; corsi d’acqua a regime torrentizio e quindi diffici-li da guadare in caso di forti precipitazioni così come la letteratura classi-ca ci ha tramandato, anche se in maniera esasperata, per qualcuno di essi (12); bacini idrici (il Vallone Maccaudo per esempio, che è la Cava Diavo-lodopera –opera del diavolo- dell’Holm) (13), invasi quasi sempre in ma-niera impenetrabile dalla macchia mediterranea, in particolare dal Robus delle more: elementi di disturbo certamente, ma non tali comunque da frenare l’uomo che nel Maccaudo o sul Tauro aveva una riserva alimenta-re che ne assicurava la sussistenza.
Quanto si possa accettare dei dieci chilometri percorribili in una gior-nata di attività venatoria, non è un dato facilmente definibile; si può tutta-via ammettere che, in assenza di vie preferenziali (il greto di un fiume per esempio, se percorribile con relativa facilità), dei sentieri obbligati fossero idealmente tracciati per superare difficoltà che la teoria di Higgs e Vita-Finzi non poteva prevedere per le nostre contrade, e per sfruttare agevol-mente i tòpoi a, b, c, …; gli stessi sentieri, talvolta erratici, che i cacciato-ri oggi involontariamente tracciano.
Un sentiero è allora ipotizzabile, solo ipotizzabile, nel Paleolitico su-periore tra Punta Izzo e Punta Bonìco, in quanto la costa del Monte Tauro, col suo sviluppo di poco più di otto chilometri, ed il suo prolungamento a nord nell’horst di Gisira, era fonte di approvvigionamento anche di pro-dotti del mare (patella ferrugine, attestata nella alimentazione dell’uomo paleolitico di Campolato, e forse anche di muricidi, trochidi, mitilidi: ma-lacofauna bentonica usuale nella alimentazione del successivo uomo neo-litico).
Ma il “reale” sviluppo di tale sentiero non può essere assolutamente visto, e non solo perché non ne esiste traccia alcuna, come probabilmente non ne esisteva nel lontano passato paleolitico, ma principalmente perché preferiamo ipotizzare l’ esistenza di sentieri preferenziali validi sul mo-
ITINERARI SUL TAURO PLEISTOCENICO ITALO RUSSO
7
mento, in quanto utili, che esaurivano la loro funzione utilitaria nello stes-so momento in cui permettevano di rendere accessibile e quindi esplorabi-le 360° di regione.
Migliaia di anni dopo, l’uomo ha riconosciuto sul Tauro tale sentiero preferenziale, e ne ha confermato la validità strategica nella toponomasti-ca, attribuendogli il nome di via Marina del Monte. Nel termine Marina si riconosce l’utilità essenzialmente costiera della strada la quale, oggi fa-gocitata sistematicamente dai moderni moduli di lottizzazione, abusivi od autorizzati, sta per incuria umana perdendo la funzione di pubblica utilità.
È certo che la viabilità che si intuisce da quanto più sopra detto, è una viabilità atipica, al di fuori di ogni canone: viabilità di sussistenza vo-gliamo chiamarla, che ci permette di identificare il tòpos nella porzione di mondo da sfruttare in quanto raggiunto e ritenuto utile alla sopravvivenza. Perché proprio il lebensraum primitivo non poteva proporre soluzioni che non derivassero da problemi immediati, di pura sopravvivenza.
D- L’UOMO E L’ACQUA.
Sopravvivenza; la quale è possibile solo in presenza di acqua potabile. Ora, se i fiumi, i molti fiumi in verità, che bagnano più o meno este-
samente le nostre contrade e per certi aspetti ne delimitano il confine a nord e a sud (il S. Leonardo, e quindi il S. Calogero o Castelluccio nel suo basso corso, il Porcaria, Il Mulinello, il Marcellino, il Cantera, il S. Cu-sumano), i quali hanno saziato la sete delle colonie umane che in ogni tempo si sono accampate lungo le loro rive, confermano la regola che la presenza d’acqua favorisca l’insediamento umano e naturalmente l’ amal-gamarsi di più specie animali nella stessa area, il Tauro sembrerebbe sfuggire a tale regola, perché non è minimamente interessato dalla pre-senza di corsi d’acqua, ed apparentemente è un arido bassopiano, meglio dire un tavolato, un banco calcareo dai lati precipiti e con pendenza verso est intorno a 10°.
Apparentemente. Ma leggiamo quanto sinteticamente ha scritto Rosa Lanteri (14) circa la presenza d’acqua dolce sul Tauro. Il Monte Tauro “…geologicamente si presenta come un banco calcareo di origine mari-na, formatosi nel Mio – Pliocene ed ormai completamente emerso in se-
ITINERARI SUL TAURO PLEISTOCENICO ITALO RUSSO
8
guito a fenomeni geodinamici, nel Quaternario. Stratigraficamente il blocco calcareo è sovrapposto a depositi sedimentari marnosi del Terzia-rio. Questo strato di marna spiega la presenza delle numerose sorgenti che sgorgavano a livello del mare, lungo il versante orientale di Monte Tauro. Infatti l’acqua piovana, filtrando attraverso il calcare, trova uno sbarramento costituito dalla marna, per cui si fa strada fra il calcare fes-surato seguendo la pendenza media verso est del monte”.
Il tempo imperfetto “sgorgavano” usato dalla Lanteri ha un significato ben preciso, e bene descrive una situazione in atto. Infatti, delle numerose sorgenti segnalate dagli storici locali (15) sul versante est del Tauro, ne ri-mangono ben poche. I motivi che ne hanno determinato la scomparsa so-no molteplici: tra questi, le oscillazioni climatiche che interferiscono nella distribuzione e nella intensità delle precipitazioni, ma anche i numerosis-simi pozzi da trivella che attingono alla falda acquifera ed in maggior mi-sura a quella freatica; ma non va trascurato che il nostro territorio si è ab-bassato, per fenomeni geodinamici ed eustatici, da 7 a 10 metri negli ul-timi ottomila anni (16), fenomeno maggiormente avvertibile lungo le coste (17), per cui, e per come è possibile verificare lungo le “frane” sulla spalla est del Tauro, molte sorgenti oggi sgorgano al di sotto del livello medio del mare, comunque dalle fessure d’ interstrato comprese tra le marne e i calcari.
E- FAUNA PLEISTOCENICA NEL TERRITORIO AUGUSTANO.
È da supporre che la viabilità di sussistenza umana e quella animale ab-biano talvolta sviluppato sul Tauro gli stessi percorsi, preferito gli stessi tòpoi; la viabilità di sussistenza animale e quella umana è possibile che si siano incrociate o confuse lungo le vallecole fossili di Acquasanta o di Vallone Amara e, più a sud, del Vetrano, dove l’uomo e l’animale pote-vano trovare rifugio nelle grotte, e acqua negli scoli di cui abbiamo detto.
Oggi noi non conosciamo, se non per fatti incidentali, la fauna plei-stocenica del Tauro; ovvero: l’unico insediamento umano pleistocenico esplorato con intenti di ricerca stratigrafica, il Riparo sotto roccia, rivela la presenza di Bos ed Equus tra i rifiuti di cucina, forse Bos Primigenius ed Equus Hydruntinus secondo come ritiene il Bernabò Brea (18), e come
ITINERARI SUL TAURO PLEISTOCENICO ITALO RUSSO
9
di norma la letteratura specialistica conferma. Altri ingrottamenti hanno restituito Cervus Elaphus e Hyæna Crocuta sp., che non sono associati ad industria umana. Insomma, la fauna pleistocenica del Tauro è ancora tutta da verificare.
L’Elephas Mnaidriensis,scoperto di recente a Monte Amara per gli scavi di Lorenzo Guzzardi,è certo che la sua presenza in zona Monte A-mara abbia preceduto quella umana. Se ne potrebbe dedurre che il Tauro (malgrado geologicamente sia un’isola calcarea delimitata da fiancate ri-pide) abbia ospitato una fauna quaternaria a grandi mammiferi prima della comparsa dell’uomo nel Paleolitico superiore. Quando l’uomo colonizzò il Tauro, l’ Elephas Mnaidriensis ed il Cervus Elaphus si erano già estinti, mentre rimanevano ancora a pascolare nel territorio augustano, forse an-che sul Tauro, il Bos e l’Equus.
Evidentemente la presenza di Elefante sul Monte Tauro suscita per-plessità. Noi oggi non riconosciamo sul nostro Monte un habitat adatto a favorire la vita di un pachiderma, che ha bisogno di una notevole riserva d’acqua. Ma sul Tauro l’Elefante c’è, su questo non vi è alcun dubbio.
Ma, in effetti, cosa sappiamo noi di quello che può essere stato il Tau-ro nel Quaternario pleistocenico? Sulla geologia del territorio sappiamo molto per S. Bordonaro ed Altri (19), ma quali studi paleontologici hanno privilegiato tale territorio? Malgrado i grandi passi in avanti della scienza archeologica nella ricerca e nella interpretazione di dati antichi, il nostro rimane un territorio derelitto, dove l’improvvisazione ad oggi ha regnato sovrana e le istituzioni preposte alla tutela del bene archeologico sono sta-te costrette a correre dietro alla emergenza nel vorticoso variare di legi-slazioni e modelli di vita; incomprensibili tuttavia i motivi che hanno por-tato alla eliminazione totale del deposito a grandi pachidermi di Costa Gi-gia; incomprensibili anche i motivi che hanno impedito alla ricerca uffi-ciale di esplorare con intenti scientifici il deposito a Hyppopotamus di Cozzo Telegrafo, malgrado la presenza di fauna quaternaria vi fosse stata già segnalata dall’ Orsi (20).
Gli anni ’90 hanno finalmente visto il piccone dello scavatore a Monte Amara, che ha dato un volto a certi indizi da noi visti e segnalati alle competenti autorità già dagli anni ’60 (21). Lo scavatore ha potuto portare alla luce l’Elefante Mnaidriensis anche a Monte Amara e tuttavia i dati non sono stati ancora pubblicati se non parzialmente.
ITINERARI SUL TAURO PLEISTOCENICO ITALO RUSSO
10
Noi ci muoviamo, talvolta goffamente, in mezzo a brani di verità. È questo il motivo che, purtroppo, ci costringe a ipotesi e a congetture, tal-volta anche sulla nostra ricerca che non riusciamo a inserire conveniente-mente nel grande mosaico preistorico isolano. Ci aiuta parzialmente l’analisi dell’ industria litica, la quale riesce a personalizzare, all’ occor-renza, gli itinerari lungo i quali si è mosso l’uomo paleolitico, circa allo stesso modo che i caratteri runici indicano le vie lungo le quali si son mossi i Vichinghi. Ma le conclusioni cui si arriva, giuste o sbagliate, dif-ficilmente ci aiutano ad elaborare sistemi viari di sussistenza che non si presentino incompleti o nebulosi, sempre alla mercé di nuove scoperte, che danno ai sistemi viari già presunti l’ apparenza di piste nel deserto in continuo movimento a seconda che si muovano le dune. I flussi migratori si rivelano incerti sul nostro territorio, quindi incerta si rivela anche la ri-cerca quando si vogliano inserire le varie presenze paleolitiche sulla gran-de tela del tempo pleistocenico.
Se più tardi, già dal Neolitico iniziale, la via dell’ossidiana ci mostrerà l’uomo nel suo espandersi sul nostro territorio, altrettanto non possiamo dire della via della selce, i cui itinerari spesso si intuiscono per deboli, e tuttavia preziosi, indizi.
F- LE VIE DELLA PIETRA.
A questo proposito, vogliamo soffermarci su un particolare strumento di selce, il quale può indicarci un itinerario di sussistenza epipaleolitico. Si tratta di un elemento laminare di selce color avana (fig. 1/B), lungo 51 mm., largo 29 e spesso 8; la sezione è trapezoidale. Lo strumento, finito, non è stato rinvenuto in associazione con scarti e schegge dello stesso tipo di selce. È interessante la relazione scientifica che i geologi S. Chilardi e A. Gilotti di Siracusa, ai quali lo strumento è stato sottoposto per analisi, hanno fatto e che in parte trascriviamo.
“…Il campione presenta una tipica associazione faunistica del Ter-ziario inferiore riferibile ad un ambiente di mare basso, caldo e con ele-vato idrodinamismo (condizioni tipiche delle scogliere)… I generi indivi-duati sono: NUMMULITES sp. (si notano le spesse pareti a struttura fi-brosa raggiata con fibre disposte perpendicolarmente alla parete del gu-scio); DISCOCYCLINA sp. (si notano le camere equatoriali con la so-
ITINERARI SUL TAURO PLEISTOCENICO ITALO RUSSO
11
vrapposizione irregolare delle camere secondarie); ASSILINA (frammen-ti?). Questa associazione faunistica ha una collocazione stratigrafica che va dal Paleocene all’Eocene medio.
Il campione, vista la componente faunistica, la collocazione stratigra-fica ed il materiale costituente (macroforaminiferi immersi in un gel sili-ceo) potrebbe appartenere alla parte superiore della Formazione Ameril-lo (Cretaceo – Eocene medio), affiorante a Licodia Eubea (contrada Bo-schetto) e nei pressi di Monterosso Almo”.
Fermiamoci qui. La relazione evidenzia un dato: la pietra silicea, il nucleo da cui è stata
staccata la lama, “potrebbe” provenire dal ragusano, cioè dalla Formazio-ne Amerillo di Licodia Eubea o di Monterosso Almo; la selce, cioè, è sta-ta trasportata, forse quale prodotto finito (visto che in associazione non sono stati rinvenuti frammenti di scarto o schegge dovuti alla lavorazio-ne), da Licodia Eubea o da Monterosso Almo fino al territorio augustano (Vallone Maccaudo), seguendo un itinerario che deve essere coinciso ne-cessariamente con quello di caccia; altrimenti dovremmo ammettere già nell’Epipaleolitico un commercio di prodotti finiti (lame od altri strumen-ti), o di materie prime (nuclei o prodotti semilavorati). Il che, anche se non impossibile, è tuttavia difficile da accettare alla luce delle attuali co-gnizioni.
Naturalmente la selce a macroforaminiferi ci indica un percorso e ci conduce ad un tòpos; ma nulla ci dice della reale provenienza dell’uomo che quella selce ha trasportato fin dentro la fòrra del Maccaudo; non ci di-ce, per esempio, come tale uomo sia arrivato in Sicilia, se dal continente o dal mare africo, o se la sua razza sia discesa dall’uomo del Paleolitico in-feriore che visse nell’agrigentino settecentomila anni prima; non ci dice neanche per quali vie dal ragusano sia pervenuto nel territorio megarese. Come abbiamo già detto, mancano ricerche correlate e studi finalizzati a stabilire la provenienza dei materiali litici utilizzati nella nostra zona nel-la preistoria.
La selce a macroforaminiferi sarebbe dunque un prezioso testimone per la stesura di un itinerarium della selce, come preziosi potrebbero rive-larsi i diaspri e le quarziti, fortemente presenti nell’ economia dell’uomo paleolitico dell’area megarese.
ITINERARI SUL TAURO PLEISTOCENICO ITALO RUSSO
12
Esula però dal nostro compito ricercare l’origine delle varie pietre che rappresentano l’armamentario di sussistenza di tale uomo, compito che spetta di diritto alla Geologia e alla Petrologia; non vorremmo cadere neppure nel luogo comune di considerare in ogni caso iblea la selce utiliz-zata nel nostro territorio. La definizione di selce “iblea” è generica, forse perché l’ attenzione è stata sempre rivolta alle miniere di selce scoperte nel ragusano. Ma i fiumi e le sassose spiagge del nostro territorio abbon-dano di ciottoli silicei, che certamente l’uomo preistorico conosceva e sfruttava, almeno fino al Neolitico iniziale e prima che Mégara neolitica attuasse, con la sua organizzazione urbana, insolita sul nostro territorio, una debole forma di sinecismo.
Mégara neolitica, che ci segnala già una economia produttiva e non più di mera sussistenza, conferma rapporti commerciali non solo con Li-pari, che fornisce ossidiana, ma anche con l’ area iblea, la cui selce è for-temente presente a Mégara (22).
G- L’ECONOMIA DI PREDAZIONE SUL TAURO: CACCIA E RACCOLTA.
Se oggi la predazione può ritenersi fenomeno marginale, spesso comple-mentare alle manifestazioni di attività economica dell’ uomo, altrettanto non possiamo dire del passato paleolitico, ove si consideri che trentamila anni addietro l’ economia dell’ uomo, per quel che si sa, fu essenzialmen-te economia di predazione. Comunque e dovunque, il binomio animale cacciato/strumento di caccia è manifesto. Anche sul Tauro, associati alle ossa degli animali uccisi, si rinvennero strumenti di pietra chiaramente le-gati ad attività di caccia, cioè di predazione (dalla lama tagliente al ra-schiatoio per lavorare le pelli, attraverso lo strumento principe dell’uomo cacciatore, la cuspide di lancia (fig. 4).
Sul tardi, nell’Olocene, col regredire dei freddi, l’uomo, organizzato in villaggi scopre, con l’agricoltura e l’allevamento del bestiame, la se-dentarietà e conseguentemente attua una economia produttiva che non è più di mera sussistenza.
Ma alcune decine di millenni prima, l’uomo è nomane, ed è alla con-tinua ricerca del cibo. Ora, fino a quando uno studio mirato non ci infor-merà compiutamente sulle abitudini alimentari dell’uomo paleolitico di
ITINERARI SUL TAURO PLEISTOCENICO ITALO RUSSO
13
Campolato o dell’Acquasanta, dobbiamo dedurre, anche alla luce dello strumentario di pietra recuperato, che tale uomo consumasse in prevalen-za carne. Ma la “raccolta” è istintiva nelle abitudini umane, come lo è in tutti gli altri animali, per cui, se si eccettua una integrazione alimentare rappresentata dai frutti del mare, in ogni caso dalle risorse del mare, non può essere escluso, anche se ancora non è stato provato, che il Tauro rap-presentasse un bacino alimentare completo, capace cioè di fornire anche prodotti spontanei della terra. Non ci spiegheremmo altrimenti perché l’uomo paleolitico si sia stanziato lungo la costa, e non abbia utilizzato, ad esempio, le grotte dell’ entroterra; tranne ad ammettere che il Tauro con-tenesse, ed in abbondanza, riserve alimentari in carne e prodotti vegetali tali da consentirgli la sopravvivenza.
Tuttavia, una tendenza ad una progressiva accentuazione dell’attività venatoria sul Tauro e nel suo hinterland rispetto ad una attività di raccolta di molluschi marini e terrestri (il confronto non va fatto naturalmente con l’attività di raccolta di piante e frutti spontanei della terra), si avverte, per la poca consistenza nei residui dei pasti di elementi marini quali patella ferruginea e, tra quelli terrestri, di Helix, che tuttavia è presente. Tale ten-denza persiste, a nostro parere, fino a quando il territorio di caccia fornirà animali da abbattere: Bos ed Equus in prevalenza; poi la grande fauna quaternaria si assottiglierà e sparirà quindi del tutto.
L’uomo, anche sul nostro territorio, modifica ora le proprie abitudini alimentari, per soddisfare le quali trasferisce altrove la propria residenza.
Ritroviamo più tardi l’uomo paleolitico all’interno del Vallone Mac-caudo, ma non più sul Tauro; questa località rimarrà disabitata, per come ci risulta, ancora per alcune migliaia di anni, almeno fino all’inizio dell’Olocene, quando l’uomo paleolitico del Maccaudo, con la fine dell’era glaciale, espanderà la propria presenza nuovamente verso la co-sta, installandosi alle due estremità nord e sud del Monte: Punta Tonnara e Punta Izzo.
L’uomo paleolitico del Maccaudo esprime altra identità culturale, per-ché riteniamo di non poter inserire la sua produzione litica tra le facies c.d. “gravettiane”. Avvertiamo invece nei tipi litici influenze nordafrica-ne, influenze che si manterranno fino alla fasi iniziali del Neolitico antico a ceramiche impresse e incise. E ancora, l’ alimentazione non sarebbe più
ITINERARI SUL TAURO PLEISTOCENICO ITALO RUSSO
14
vincolata per intero all’esistenza dei grandi mammiferi, dei quali, forse, rimane solo il bue.
Il Maccaudo rappresenta, con gli altri bacini idrici fluviali, una note-vole riserva di piccoli mammiferi, tra i quali si nota il Cane ed il Cinghia-le; l’avifauna non ci è nota nelle sue varietà, ma la sua presenza tra i rifiu-ti dei pasti è consistente. Purtroppo, uno studio della fauna presente nel tardo Pleistocene nel nostro territorio sembra non sia stato fatto, per cui le nostre ipotesi si interrompono qui.
H- ITINERARI DI PREDAZIONE NEL PRIMO OLOCENE.
Quando l’uomo del Maccaudo rivolgerà la sua attenzione al mare, non fa-rà altro che riproporre un itinerario di sussistenza già sperimentato dall’uomo che abitò il Cozzo Telegrafo. La presenza di elementi marini tra i rifiuti dei pasti conferma che è l’ambiente (che infine fornisce la ma-teria prima della sopravvivenza) a proporre gli itinerari utili all’uomo.
Comunque l’uomo post-glaciale, che si è installato nel territorio augu-stano, abbia preso possesso di un ambiente capace ancora di favorire un tipo di economia definibile di predazione e che attinge essenzialmente alla terraferma, tuttavia lo sfruttamento della scogliera del Tauro, in ogni tem-po ricca di ittiofauna, di crostacei e di molluschi, rimane tra gli obiettivi primari. Oggi useremmo la locuzione: valorizzazione dell’ ambiente, op-pure: fruizione di un bene, di una ricchezza naturale; e ne potremmo in-ventare tant’altre di tali locuzioni, fino a perdere di vista la realtà “reale”, che è ben più semplice e non è soggetta a schemi.
Il nuovo ambiente, uscito dal freddo, fu quello che permise allo uomo di diecimila anni addietro di sopravvivere, L’uomo post glaciale del Mac-caudo, che ha visto modificato l’ambiente naturale e quanto di utile alla predazione era in esso presente, ha dovuto diversificare anche gli itinerari di caccia e lo strumentario litico, che doveva essere adattato al nuovo am-biente. La predazione viene rivolta ancora su 360°, ed è prevalente nell’ economia di sussistenza dell’uomo; e ancora: malgrado la viabilità di sus-sistenza sposti ora il suo baricentro dalla costa all’interno, non si avverte una particolare modificazione nelle abitudini alimentari dell’uomo del Maccaudo, se non nel rapporto, nuovo in verità, che viene a crearsi tra la
ITINERARI SUL TAURO PLEISTOCENICO ITALO RUSSO
15
nuova emergenza (la scomparsa quasi totale dei grandi mammiferi) e l’attitudine dell’uomo a inventare strumenti nuovi, utili ad affrontare tale emergenza.
Il nuovo strumentario dell’uomo, che il Maccaudo ha restituito ab-bondantemente, è essenzialmente microlitico (ved. figg. 2 e 3) ed ha for-me geometriche. Non vi è dubbio che l’uomo sta valorizzando l’uso dell’arco e della freccia, uso peraltro già noto da millenni, come ci mo-strano alcune punte che provengono da Campolato (ved. fig. 1/F). È evi-dente che una piccola punta di freccia, inutile a perforare la pelle di un grosso mammifero, è invece utile per abbattere piccoli animali, i quali possono trovarsi dovunque e volare, se muniti di ali, in ogni direzione. Potremmo congetturare che il sentiero di caccia non abbia più motivo d’essere? È possibile, ma non è stato provato, se è vero che, anche oggi, il cacciatore conserva nella memoria e sfrutta alla occasione, sentieri talvol-ta visibili solo a lui; e che, in ogni caso, l’economia di caccia, come la pa-storizia, impone il nomadismo, che è continua scoperta di tòpoi.
Il microlito, di forma normalmente geometrica - triangoli, segmenti di cerchio, segmenti trapezoidali, trapezi, rombi - traccia anch’esso un itine-rario di caccia, di predazione. La sua presenza, che ormai caratterizza quale fossile-guida la cultura mesolitica o c.d. epipaleolitica, è stata regi-strata un po’ dovunque sul nostro territorio e durante un lungo arco di tempo: da Punta Izzo a Punta Tonnara, a Punta Bonìco, da Campolato a Cozzo Telegrafo, al Petraro, ed abbraccia un tempo che vede svolgersi culture che vanno dal Mesolitico propriamente detto alle culture di tradi-zione mesolitica del primo neolitico locale a ceramiche impresse e incise.
Ora gli itinerari di sussistenza si sviluppano in ogni direzione, favo-rendo l’insorgere di concetti nuovi, primo fra i quali il tentativo di aggre-gare in comunità le sparse tribù del territorio; il che darà vita ai grandi vil-laggi costieri di Punta Bonìco, di Brucoli e di Punta Tonnara, la cui eco-nomia rimane, tuttavia, di sussistenza e la predazione sazierà ancora per alcuni millenni la fame dell’uomo stanziatosi sul nostro territorio.
Quando più tardi, all’incirca nel quarto millennio avanti la venuta di Cristo, le comunità neolitiche del nostro territorio e dei territori vicini si organizzeranno in villaggi recintati, e daranno vita ad un tipo di organiz-zazione che possiamo definire proto urbana (Mégara, Matrensa, Stentinel-lo, Ognina di Siracusa) l’allevamento prima, poi la agricoltura e conse-
ITINERARI SUL TAURO PLEISTOCENICO ITALO RUSSO
16
guentemente il commercio, soppianteranno definitivamente sul territorio megarese l’economia di predazione.
Liberamente tratto da: Insediamenti umani pleistocenici in territorio augustano, e la viabilità preistorica di caccia sul Tauros acron e nel suo hinterland, in Notiziario Storico di Augusta 20, 1998, dell’Autore.
ITINERARI SUL TAURO PLEISTOCENICO ITALO RUSSO
17
Note
1- Tauros è in Diodoro XIV, 58, 2, che lo menziona per la prima volta; in Tolomeo, Geogr. III, 4, 4- Sikelias nèsu tésis è il Tauros acron (il promon-torio Tauro), mentre Idris (in Amari, Biblioteca arabo-sicula, TO 1880) segna-la un Râs ‘as Salîba – Capo della Croce- che pone a 4 miglia da Iksifu (Xifo-nia, l’attuale Augusta?) e a 6 miglia dal Porcaria e, per esso, Brucoli con il suo Canale). Circa la localizzazione di Xifonia, tanto controversa, si rimanda al carteggio Vigo - Holm: Disputa sul vero sito della vetusta Sifonia, PA 1873.
2- Cronologie assolute: derivate da tecniche di datazione che forniscono date calendariche, espresse cioè in anni a partire da oggi (B.P., che è abbrev. di Before the Present).
3- Cfr. I: RUSSO, R. LANTERI in Augusta e territori limitrofi – I – Preistoria, in Arch. Stor. Sirac., supplemento n. 5, 1966.
4- Massimo di individui di una data specie che può essere mantenuto dalle risorse biologiche di un territorio.
5- P. LAVIOSA ZAMBOTTI: L’economia nella Preistoria e nella sto-ria arcaica, in Riv. Sc. Preist., 1963.
6- I. RUSSO, P. GIANINO: Archeologia del basso corso del Porcaria. Preistoria di Gisira di Brucoli, in Arch. Stor. Sirac. s.III, IX (1995).
7- Cfr. M. PIPERNO, S. TUSA, I. VALENTE: Campagne di scavo 1977 e 1978 alla grotta dell’Uzzo (Trapani), in Sicilia Archeologica, 42, 1980.
8- I. RUSSO: L’industria litica del villaggio neolitico di Mégara Hyblæa (scavi Orsi 1917-1920) – Alcuni dati tipologici e tipometrici, in Arch. Stor. Sirac., s.III, X (1996).
9- Cfr. C. VITA-FINZI, H. HIGGS, Prehistoric economy in the Mount Carmel area of Palestine: sitecatchment analysis, in Proc. Prehist. Society, 36 (1970).
10- Il “graben” di Palma è delimitato a nord dagli horst di Gisira e del Tauro, e ad ovest dalla contrada Mendola. A SE si fonde in unica struttura col graben di Mégara, con orientamento NO-SE.
11- La contrada di “Maremorto”, che comprende gli attuali Pantanelli. 12- Servio, nei commenti a Virgilio, afferma che il Pantagia “…implebat
sonitu pæne totam Siciliam, unde Pantagias dictus est, quasi ubique sonans”. Naturalmente non sappiamo se Servio abbia voluto riferirsi all’odierno Porcaria, o ad altro fiume del nostro territorio. Ved. in proposito I. RUSSO, P. GIANINO:
ITINERARI SUL TAURO PLEISTOCENICO ITALO RUSSO
18
Problematica storico-archeologica di Trotilon e del torrente Pantakyas, in Not. Stor. Di Augusta, 18/1995.
13- La tradizione letteraria locale ha recepito il toponimo Diavolodopera (e le sue varianti Diavolopri, Diavolopera, ecc.). Il toponimo peraltro è stato ri-ferito sia al Cozzo Telegrafo (Cfr. G. A. MASSA: Della Sicilia in prospettiva, PA, 1709) che al Vallone Maccaudo ( cfr. A. HOLM: Storia della Sicilia nell’antichità, PA, 1896 – 1901). Holm ritiene che il nome derivi al Vallone dal-la credenza secondo la quale solamente un’opera diabolica avrebbe potuto rea-lizzare le centinaia di grotte presenti nella fòrra del Maccaudo. Noi insistiamo nella nostra ipotesi, derivata da una tradizione locale, che vuole che il toponimo, riferito indifferentemente sia al Cozzo Telegrafo che al Vallone Maccaudo, sia in effetti una corruzione della lezione opera d’Avalos, o d’Avalos opera (contrat-ta in Diavolodopera), proprio per qualche “opera” realizzata in zona dal viceré di Sicilia e marchese di Pescara. Sta alla ricerca archeologica stabilire di quale opera si tratti.
14- R. LANTERI: Insediamenti antichi nel territorio di Augusta – Il Monte Tauro, in AITNA, Quaderni di topografia antica, CT.
15- Cfr. V. AMICO: Dizionario topografico della Sicilia, PA. 1858; G. A. MASSA, cit.
16- Cfr. B. ACCORDI: Rapporti tra il Miliziano della costa iblea (Sicilia sud-orientale) e la comparsa di Elephas mnaidriensis, in Geologia Romana, 1963; cfr. inoltre G. LENA, B. BASILE, G. DI STEFANO: Approdi, porti, inse-diamenti costieri e linee di costa della Sicilia sud-orientale dalla preistoria alla tarda antichità, in Arch. Stor. Sirac., s. III, II (1988).
17- Le variazioni avvenute nel livello del mare si osservano, per esempio, a Punta Castelluzzo e a Punta Bonìco, dove alcune cave di pietra, certamente coltivate al di sopra del livello del mare, oggi risultano semisommerse o total-mente sommerse in fase d’alta marea. Il fenomeno è certamente connesso alla trasgressione Flandriana, che è ancora in atto.
18- L. BERNABO’ BREA: La Sicilia prima dei Greci, 1958. 19- S. BORDINARO, A. DI GRANDE, W. RAIMONDO: Lineamenti
geomorfostratigrafici pleistocenici tra Melilli, Augusta e Lentini, in Boll. Acc. Gioenia di Sci. Nat. – vol. 17, CT 1984.
20- Cfr. P: ORSI: Molinello presso Augusta, III, Periegesi archeologica, in Notizie degli Scavi di Antichità, 1902.
21- Una nostra relazione diretta alla Soprintendenza archeologica di Sira-cusa e relativa ad una nostra ricerca all’interno ed all’esterno della maggiore grotta di Vallone Amara precisa tra l’altro: “…La grotta A è interessata da uno strato di escrementi di ovini misto a terra, il cui spessore varia da 1 a 3 cm. Im-
ITINERARI SUL TAURO PLEISTOCENICO ITALO RUSSO
19
mediatamente sotto, uno strato di humus raggiunge lo spessore medio di cm. 20. Tale strato è misto a ciottoli di varia grandezza, di origine più che altro calca-rea. Immediatamente sotto lo strato di humus si trova un deposito a sabbie, in avanzate condizioni di rassodamento, in cui si nota abbondante la presenza di ossa di animali. Tale strato non è stato preso in esame”. I recenti scavi eseguiti dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici di Siracusa, diretti da Lorenzo Guz-zardi, hanno dimostrato che le ossa di Vallone Amara appartengono allo Elephas mnaidriensis.
22- Cfr. I. RUSSO: L’industria litica del villaggio neolitico di Mégara Hyblæa, cit.