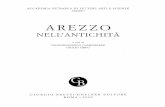S. ZEGGIO, Dall’indagine alla città: un settore del Centro Monumentale e la sua viabilità, in...
-
Upload
sovraintendenzaroma -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of S. ZEGGIO, Dall’indagine alla città: un settore del Centro Monumentale e la sua viabilità, in...
Quando, in occasione della Giornata di studio, Clementina Panella mi attribuì l’onere di «ricucire» in una visione generale le informazioni provenienti da punti e momenti diversi dello scavo condotto dal 2001 al 2004 sulle pendici nord-orientali del Palatino, mi fu subito chiaro quanto riduttivo sarebbe stato leggerle separatamente dalle miriadi di dati ricavati dal prece-dente scavo della Meta Sudans1, che per diverse ragioni dopo un’edizione preliminare sono in
Sabina Zeggio
Dall’inDaGine alla Città: un settore Del Centro MonuMentale
e la sua viabilità Dalle oriGini all’età neroniana
1 Dirette da C. Panella con la collaborazione di chi scrive, le indagini si sono svolte dal 1986 al 1994 in regi-me di collaborazione fra la soprintendenza archeolo-gica di roma (da ora s.a.r.) e la cattedra di Metodolo-gia e tecniche della ricerca archeologica dell’università degli studi di roma «la sapienza», mentre dal 1995 al 2003 in regime di concessione del Ministero per i beni e le attività Culturali al Dipartimento di scienze sto-riche, archeologiche e antropologiche dell’antichità della stessa università. Direttore dei lavori è stata M.l. Conforto, quale ispettore responsabile della s.a.r. si sono invece succeduti C. Pavolini e dal 1999 r. rea; i responsabili dei singoli saggi saranno indicati di volta in volta (per i saggi privi d’indicazione la responsabi-lità è di chi scrive). Come quello delle pendici nord-orientali del Palatino, lo scavo ha svolto la funzione di cantiere didattico con l’impegno di laureati, laureandi e studenti della cattedra, che ringrazio tutti per aver reso possibili questi risultati. i dati delle indagini dal 1986 al 1989 sono riassunti in C. Panella, La Valle del Colosseo nell’Antichità, in Boll. Arch. 1-2, 1990, 34-88, mentre quelli delle campagne dal 1989 al 1992 sono trattati in C. Panella (a cura di), Meta sudans I. Un’area sacra in Palatio e la valle del Colosseo prima e dopo Nerone, roma 1996. informazioni preliminari sulle campagne successive sono in C. Panella - P. Pensabene - M. Mi-lella - M. Wilson Jones, Scavo nell’area della Meta su-dans e ricerche sull’Arco di Costantino, in Arch. Laziale
12, 1 (Quad. Arch. Etr. Ital. 23), roma 1995, 41-61; P. Pensabene - C. Panella, Reimpiego e progettazione ar-chitettonica nei monumenti tardo-antichi di Roma, in Rend. Pont. Acc. 66, 1993-94 (1995), 111-283 (in part. 246-259); s. Zeggio - G. rizzo, I materiali residui come indicatori della storia di un sito: il caso della fossa di fon-dazione dell’Arco di Costantino, in F. Guidobaldi - C. Pavolini - Ph. Pergola (a cura di), I materiali residui nello scavo archeologico, Testi preliminari e Atti della tavola rotonda (Roma, 16 marzo 1996), roma 1998, 125-148; M. Cante - s. Panciera - C. Panella - s. Zeggio, Il tempio restaurato da Claudio e l’organizzazione de-gli spazi tra pendice nord-orientale del Palatino e Valle del Colosseo in età giulio-claudia: nuovi dati, in Rend. Pont. Acc. 67, 1, 1994-95 (1998), 123-151; s. Zeggio, La realizzazione delle fondazioni, in P. Pensabene - C. Pa-nella (a cura di), Arco di Costantino tra archeologia e archeometria, roma 1999, 117-137; s. Zeggio, Tratto di mura arcaiche nello scavo della Meta sudans, in a. Ca-randini - r. Cappelli (a cura di), Roma. Romolo, Remo e la fondazione della città (Cat. mostra, Roma), Milano 2000, 301-302; C. Panella, La valle del Colosseo prima del Colosseo e la Meta sudans, in a. la regina (a cura di), Sangue e Arena (Cat. mostra, Roma), Milano 2001, 49-67; C. Panella - s. Zeggio, Tra Palatino e valle del Colosseo: nuovi dati, in Workshop di Archeologia Clas-sica 1, 2004, 65-87; s. Zeggio, Un santuario alle pendici nord-orientali del Palatino ed i suoi depositi votivi fra
62 s. Zeggio Sc. Ant.
parte ancora inediti. in questa fase di rivalutazione di mappature e carte archeologiche2, anche grazie ai sistemi informatici, utilizzando sia i dati già confluiti nel sit dedicato ad ambedue le nostre aree d’indagine3, sia quel pregresso che per la sua vetustà attende ancora di entrarvi, ho dunque ritenuto di integrare tutti gli elementi da noi acquisiti sulla porzione urbana estesa nell’area occidentale della valle dell’anfiteatro fra le estreme propaggini meridionali dell’op-pio e le pendici nord-orientali del Palatino (fig. 1) e di tentare una lettura generale almeno
età arcaica e medio-repubblicana, in a.M. Comella - s. Mele (a cura di), Depositi votivi e culti dell’Italia an-tica dall’età arcaica a quella tardo-repubblicana, Atti del Convegno di Studi (Perugia, 1-4 giugno 2000), bari 2005, 63-76; s. Zeggio, Roma, Valle del Colosseo. Scavo dell’area della Meta sudans 1996-2002. Spazi urbani e storia, in P. attema - a. nijboer - a. Zifferero (a cura di), Papers in Italian Archaeology, VI. The Groningen Conference. Communities and Settlements from the Neolithic to the Early Medieval Period (Groningen, April 15-17, 2003) (Brit. Arch. Rep., Int. Ser. 1452), 1, oxford 2005, 269-277. le ricerche sono brevemente edite anche on web, ad esempio nel sito dei Fasti online,
iniziativa recentemente sorta dalla tradizione dei Fasti Archaeologici, all’indirizzo http://www.fastionline.org.
2 relativamente a roma ed al suo suburbio vd. da ultimo l’ampio dibattito sorto in questo senso nelle giornate del convegno suburbium II. Il suburbio di Roma dalla fine dell’età monarchica alla nascita del sistema delle ville (V-II sec. a.C.) (roma 17-18 feb-braio 2005), attualmente in corso di stampa a cura di v. Jolivet e r. volpe.
3 Per l’organizzazione e le caratteristiche di que-sto sistema informativo territoriale, basato su piat-taforma Gis, rimando al contributo di e. brienza in questo volume.
Fig. 1. – il Centro Monumentale di roma. Delimitata in rosso l’area in esame.
13, 2006 Dall’indagine alla città 63
delle fasi più antiche della sua evoluzione, dalle prime testimonianze antropiche individuate al grande incendio neroniano. si tratta di una lettura essenzialmente archeologica e topogra-fica, legata il meno possibile, pur considerando che di roma si tratta, alle identificazioni dei singoli monumenti e tesa invece principalmente a cogliere sviluppo, modifiche, sopravvivenze, zonizzazioni funzionali del quartiere4. le piante schematiche che illustrano le fasi evolutive dell’area5 sono in questo senso una sorta di fogli di quegli album per bambini, con una figura sempre uguale ma differente in qualche particolare, che sfogliati velocemente danno l’illusione del movimento. Qui è la città che si muove: nasce, vive, si modifica fino al grande disastro del luglio 64, da cui rinascerà con un volto del tutto diverso.
Dall’età pre-urbana all’età orientaliZZante
in origine l’area compresa fra Palatino-velia, esquilino e Celio doveva presentarsi come una valle a tratti piuttosto stretta, circondata da colline più evidenti di oggi e dalle pendici ove più ove meno acclivi, ma comunque marcate. alla luce dei dati più recenti questa valle, per-corsa da un torrente dotato di affluenti perlopiù stagionali provenienti dalle selle fra le colline, risulta pressoché priva, almeno in età storica, della palude tradizionalmente immaginata al suo centro per assimilazione allo stagnum artificiale di età neroniana6. Ho affermato più volte come l’importanza di quest’area nasca a mio avviso dall’essere zona di passaggio, dato che le sponde dei corsi d’acqua offrivano un reticolo di percorsi relativamente agevoli lungo le selle intercol-linari. Da qui più o meno si doveva passare7, che si fosse diretti ai centri del litorale tirrenico (fig. 2, a), oppure attraverso il tevere alla «riva veiente» e dunque all’etruria meridionale
4 in questo senso alcune affermazioni potranno risultare autoreferenziali o apodittiche ed avranno bisogno di ulteriori approfondimenti, primo fra tut-ti quello del confronto fra dati archeologici e fonti antiche, già ampiamente affrontato per il complesso monumentale dell’angolo orientale del Palatino (vd. da ultimo C. Panella - s. Zeggio, art. cit., 2004 [a n. 1], con bibliografia precedente), ma tuttora in corso per altri elementi di più recente individuazione.
5 ove non altrimenti indicato gli elaborati grafici a corredo di questo contributo sono di chi scrive su base cartografica di e. brienza.
6 Questi dati, brevemente presentati in s. Zeggio, art. cit., 2005 (a n. 1), 71-72, nn. 13-15 e in s. Zeggio, Roma, Valle del Colosseo, cit. (a n. 1), 271 e restituiti in una prima elaborazione grafica 3D in C. Panella - s. Zeggio, art. cit., 2004 (a n. 1), 68, fig. 3, saranno editi a breve nell’ambito di una più approfondita e ge-nerale revisione dei dati geomorfologici e ambientali dell’area, in preparazione da parte di antonia arnol-dus Huyzendveld e di chi scrive.
7 la centralità dell’area in analisi (evidenziata in
rosso) è palese nella carta a fig. 2, elaborata da chi scrive sulla base della Pianta di Roma e del conte-sto circostante alla fine dell’età arcaica presentata da l. Quilici, in M. Cristofani (a cura di), La grande Roma dei Tarquini (Cat. mostra, Roma), roma 1990, 34, fig. 4. Pur datata, questa pianta rimane uno stru-mento prezioso, che varrebbe la pena ripensare alla luce delle più recenti acquisizioni. in questo senso, oltre gli studi in corso per l’area qui in esame (per i quali vd. alla n. precedente), ricordo a mero tito-lo d’esempio: relativamente alle aree del Foro e del velabro le analisi di a.J. ammerman (da ultimo a.J. ammerman - D. Filippi, Dal Tevere all’Argileto: nuove osservazioni, in Bull. Com. 105, 2004, 6-28, con bibliografia precedente), relativamente all’area Carinae-oppio-Fagutal gli studi di a. arnoldus (a. arnoldus Huyzendveld, Geologia del colle Oppio ed ipotesi sulla morfologia pre-traianea, in Mél. Éc. Franç. Rome, Antiquité 112, 2, 2000, 529-537) ed a scala più generale il recentissimo lavoro di r. Funi-ciello - G. Giordano (a cura di), Carta Geologica del Comune di Roma, scala 1:10.000. 1, roma 2005.
64 s. Zeggio Sc. Ant.
(fig. 2, b), o ancora a sud-est in direzione dei Colli albani e dell’italia meridionale (fig. 2, c), o che si tendesse verso est alla via per Gabii (fig. 2, d), o verso nord indirettamente a quelle per la valle dell’aniene e la sabina (fig. 2, e), o più semplicemente si volessero raggiungere l’area forense e l’arce capitolina (fig. 2, f).
non è dunque un caso che questa «vocazione al transito», che certo ha le sue radici nei periodi più remoti, caratterizzi i rinvenimenti più antichi effettuati nell’area in esame. Prossimi all’angolo nord-orientale della bassa pendice del Palatino (l’area è in grigio a fig. 3), questi rin-venimenti si configurano come livelli sovrapposti di preparazioni e battuti stradali, databili con
Fig. 2. – Carta dell’area romana alla fine dell’età arcaica (da l. Quilici, Pianta, cit. [a n. 7]). in rosso l’area in esameed i percorsi che la interessano.
13, 2006 Dall’indagine alla città 65
buona approssimazione a partire dal passaggio fra viii e vii secolo a.C.8 e pertinenti al trac-ciato che collegava la valle a Palatino, velia ed area forense. l’immediata contiguità di questo tracciato col ruscello che scorreva nella sella fra le due colline è evidenziata, in un momento di trapasso fra vii e vi sec. a.C., dalla realizzazione proprio sul limite settentrionale della strada di un irregolare argine in blocchi (fig. 3, 1)9, che rappresenta il primo tentativo di irreggimen-tazione delle acque del ruscello stesso.
Dalla storia più remota l’area mostra però chiaramente anche un’altra connotazione: quel-la sacrale. un luogo di culto occupa l’angolo nord-orientale della pendice del Palatino, finitima
8 un’edizione preliminare di questa stratigrafia, che vede il primo livello di calpestio ad una quota di soli m 9,50 ca. s.l.m., e di alcuni dei reperti da essa provenienti è in s. Zeggio, art. cit., 2005 (a n. 1) e in ead., Roma, Valle del Colosseo, cit. (a n. 1), 271 e 272, fig. 2.
9 Questo manufatto rimane in uso più o meno per un quarto di secolo; composto in una prima fase
da una sola assise di blocchi di cappellaccio e tufo li-toide lionato, squadrati ma di taglia variabile, dopo circa un decennio dalla realizzazione subisce la so-prelevazione di un ulteriore filare, strutturalmente analogo ed oggi pressoché perduto. Per un’analisi più specifica vd. s. Zeggio, art. cit., 2005 (a n. 1), 67. vd. anche oltre, n. 15.
Fig. 3. – valle dell’anfiteatro e pendici nord-orientali del Palatino. in grigio l’area di attestazione dei mantellistradali più antichi, in rosso la localizzazione delle altre testimonianze relative all’età orientalizzante.
66 s. Zeggio Sc. Ant.
al tracciato che sale verso il Foro, e almeno dal tardo vii secolo a.C. accoglie certamente un edificio costruito in pietra e coperto da tegole, come attesta il fatto che per un suo restauro agli inizi dell’età arcaica si rendono necessari sacrifici di animali e deposizione di ex voto (fig. 3, 2)10. Di questa antichità, della collocazione del santuario su uno dei vertici del «pomerio ro-muleo» e degli altri elementi che rendono quantomeno probabile l’identificazione di esso con le Curiae Veteres già si è detto11, ma non è questa l’unica evidenza dell’area in esame connessa alla sfera del sacro: per quanto ancora non altrettanto ben definito esiste un altro elemento cultuale, con attestazioni allo stato addirittura più antiche del santuario delle vecchie curie. si tratta di alcuni dei numerosi reperti ceramici provenienti da un deposito votivo realizzato agli inizi della repubblica (fig. 3, 3), di cui meglio si dirà in seguito, ed in specie di una scodella tronco-conica carenata con ansa angolare a maniglia inclinata applicata all’orlo, che nonostante l’irregolarità della fattura ed il pessimo stato di conservazione parrebbe rifarsi ad una tipologia di transizione fra l’età del ferro e l’età orientalizzante12. al momento non è possibile individua-re con certezza il culto di riferimento di questi reperti, né stabilire localizzazione, tipologia e cronologia originarie del santuario di provenienza; la loro presenza sembra però indiziare che già in un momento di passaggio fra viii e vii secolo a.C., in coincidenza cronologica forse non casuale con la prima infrastrutturazione volontaria del tracciato viario valle-Foro, sia presente nei pressi di esso, apparentemente sul versante veliense, un polo sacrale separato da quello po-stulabile a partire dall’età romulea sull’opposta pendice palatina13.
Dall’età arcaica agl’iniZi Della repubblica
Dopo queste prime attestazioni assai limitate nello spazio (ma è sempre il caso di ricordare quanto sull’assenza di evidenze delle fasi più antiche influiscano i vincoli dello scavo) e nel sus-seguirsi continuo di rifacimenti del battuto stradale del percorso verso l’area forense, una vera e propria maglia urbana della zona comincia a cogliersi più chiaramente in connessione con la stagione della «Grande roma dei tarquini»14. in concordanza con le fonti storiche le prime
10 il deposito votivo con i suoi reperti ed il com-plesso rito di deposizione connesso sono illustrati in s. Zeggio, art. cit., 2005 (a n. 1), 67-70, tavv. iii e iv, a-b; ead., Area della Meta sudans (Municipio I), Deposito votivo alto-arcaico, in M.a. tomei (a cura di), Roma. Memorie dal sottosuolo. Ritrovamenti archeologici 1980/2006 (Cat. mostra, Roma), verona 2006, 90.
11 in proposito vd. s. Zeggio, art. cit., 2005 (a n. 1); s. Zeggio, Roma, Valle del Colosseo, cit. (a n. 1); da ultimo C. Panella - s. Zeggio, art. cit., 2004 (a n. 1), 69-73, con ulteriore bibliografia.
12 la deformazione e l’alterazione del corpo ce-ramico subite per la ripetuta esposizione al fuoco da questo vaso, probabilmente d’impasto rosso e già di per sé irregolare, non hanno permesso sinora l’individua-zione di un confronto tipologico preciso. esso è stato
rinvenuto in frantumi sul fondo del deposito votivo, probabilmente perché ritualmente infranto insieme ad un altro esemplare particolarissimo, di cronologia più recente ma di forme volutamente arcaizzanti. tutto il contesto dei reperti è in corso di studio da parte di chi scrive per l’edizione definitiva; una notizia preliminare è in C. Panella - s. Zeggio, art. cit., 2004 (a n. 1), 78-79.
13 Che il deposito votivo in esame non sia attri-buibile al luogo di culto delle pendici palatine nord-orientali è chiaramente desumibile dalle differenze tipologiche, cronologiche e rituali dei due contesti.
14 suggestivo in questo senso il richiamo alla fonte liviana (liv., 1, 35, 5), pur relativa alle aree cir-costanti il Foro, che attesta l’opera di divisione e di-stribuzione di lotti edificabili ai privati da parte del primo tarquinio.
13, 2006 Dall’indagine alla città 67
evidenze strutturali direttamente riscontrabili in scavo, collocabili in età arcaica nei decenni centrali del vi secolo a.C., sono relative alla canalizzazione ipogea delle acque dei fondovalle attraverso condotti in blocchi di cappellaccio15. Questi condotti sono stati individuati con lo sca vo non lontano dal basamento del Colosso (fig. 4, 1)16, relativamente all’asse esquilino-
15 Come per altre imponenti opere pubbliche, le fonti attribuiscono in realtà l’inizio dei lavori al primo tarquinio, quindi ancora sullo scorcio dell’età orienta-lizzante, e il loro completamento al superbo (liv., 1, 38, 6; 1, 56, 2; 1, 59, 9; Dion., 3, 67, 5 e 4, 44, 1-9; strabo, 5, 3, 8; Plin., Nat. Hist., 36, 104). Questa tradizione, ben-ché ampiamente giustificata dalle incertezze degli sto-rici antichi (non è possibile qui entrare nella complessa questione di composizione e durata reali della «dinastia regnante» etrusca di roma e della verosimile artificiosa reduplicazione della figura di tarquinio, a mero titolo di esempio vd. o. De Cazanove, La chronologie des
Bacchiades et celle des rois étrusques de Rome, in Mél. Éc. Franç. Rome, Antiquité 100, 2, 1988, 615-648), po-trebbe però avere un interessante riscontro nel primo tentativo di irreggimentazione delle acque del ruscello contiguo all’asse valle-Foro con l’irregolare argine de-scritto in precedenza, realizzato appunto al passaggio fra vii e vi secolo a.C. (vd. n. 9) e poi sostituito, come si vedrà, da una vera e propria fognatura.
16 individuata nell’area dell’ambiente 16 del sistema struttivo neroniano della valle, questa fognatura è pre-liminarmente edita in C. Panella, art. cit., 1990 (a n. 1), 41-42, fig. 7; C. Panella (a cura di), Meta sudans I, cit.
Fig. 4. – valle dell’anfiteatro e pendici nord-orientali del Palatino. Planimetria delle evidenze di età arcaica. in rosso le evidenze degli anni centrali del vi secolo a.C., in grigio quelle degli anni 530/520 a.C. ca.
68 s. Zeggio Sc. Ant.
Circo Massimo, e con un sondaggio meccanico nei pressi dello sbocco dell’attuale via sacra sulla Piazza del Colosseo (fig. 4, 2)17, in relazione all’asse valle-Foro18. Quasi contempora-neamente registriamo la traccia diretta del primo edificio in muratura (fig. 4, 3), realizzato in grandi blocchi di cappellaccio e relativo non a caso al santuario delle pendici palatine19, il cui culto comincia in questa fase ad essere attestato anche dagli ex voto di un cospicuo deposito votivo20. nell’ultima fase dell’età monarchica un vasto riassetto dell’area è reso evidente
(a n. 1), 63, fig. 58. visibile per una zona limitata e non ispezionabile a causa della profondità di rinvenimento (cresta al massimo m 14,90 s.l.m.) questo condotto, con direzione n-s e volta a filare almeno duplice di conci di cappellaccio di medie dimensioni (variabili, ma in me-dia di cm 40 x 40 x 23-28 [spess.] ca.) assemblati a secco, presenta una larghezza esterna ricostruibile di m 3,5 ca. accettando l’ipotesi della volta a doppio filare, quindi spessa cm 80-90 ca., lo speco risulterebbe largo m 2,5 ca. ed alto dunque almeno m 3, dimensioni vicine a quel-le della Cloaca Maxima (vd. H. bauer, Cloaca, Cloaca Maxima, in Lex. Topogr. Urbis Romae, 1, roma 1993, 288-290 [in part. 288]). tecnica edilizia e dimensione dei blocchi assimilano in modo stringente la nostra struttura alla cisterna più o meno coeva rinvenuta nello stesso tor-no di tempo nell’area di scavo delle pendici settentrionali del Palatino, per la quale vd. a. Carandini - P. Carafa (a cura di), Palatium e sacra via I. Prima delle mura, l’età delle mura e l’età delle case arcaiche, (Boll. Arch. 31-34), roma 1995 (2000), 228-231, figg. 198-204 (una schema-tica sezione ricostruttiva della fognatura della valle è sta-ta proposta da chi scrive, ibid., 247, fig. 236).
17 Mentre il sondaggio in esame è in corso di edizione (vd. n. 6), un’analisi ricostruttiva delle modi-ficazioni del sistema drenante della sella esistente fra Palatino e velia, e conseguentemente di quello viario dell’asse valle-Foro, è in s. Zeggio, art. cit., 2005 (a n. 1), 66, tav. ii, c; 69.
18 in ragione di queste evidenze e della cronologia delle sovrastanti pavimentazioni stradali, assai ben defini-bile soprattutto per l’asse valle-Foro, risulta ormai del tut-to priva di fondamento la tradizionale convinzione, basa-ta sulla denominazione canalis data alla Cloaca Maxima da Plauto (Plaut., Curc., 4, 475-476) e in modo indiretto anche da Festo (Paul., ex Festo, 40 l.), che questi primi grandi condotti di scarico realizzati in età arcaica fossero canali scoperti e che la loro copertura fosse avvenuta solo nella tarda repubblica, dopo la morte del commediogra-fo nel 184 a.C. (così t. Frank, Roman Buildings of the Republic, roma 1924, 142, n. 9; e. nash, Pictorial Dic-tionary of Ancient Rome, new York-Washington 19682, 258. riguardo specificatamente alla Cloaca Maxima: C. Morselli - e. tortorici [a cura di], Curia. Forum iulium. Forum transitorium [Lavori e Studi di Archeo logia 14],
roma 1989, 1, 47; e. tortorici, argiletum, in Bull. Com., suppl. 1, roma 1991, 22 e 84; per una copertura parziale M. torelli, L’urbanistica di Roma regia e repubblicana, in P. Gros - M. torelli, Storia dell’urbanistica. Il mondo romano, roma-bari 1988, 61-126 [in part. 73]; dubitativo F. Zevi, Il Foro, in M. Cristofani [a cura di], op. cit. [a n. 7], 47-52 [in part. 51]). Per una sostanziale inconsistenza di questa convinzione si era già espresso C. ampolo in occasione del simposio in memoria di F.e. brown, tenu-tosi a roma il 6 giugno 1989. nell’intervento Storiografia antica su Roma arcaica e topografia romana, purtroppo non confluito nella successiva edizione (ma prontamen-te accettato in a. Carandini, Campagne di scavo delle pendici settentrionali, in Boll. Arch. 1-2, 1990, 159-165, in part. 163, n. 9), sulla scorta di numerose fonti (vd. n. 15 ed inoltre: vitr., de Arch., 7, 4, 1-2 e 8, 6, 1; liv., 5, 55, 5, quest’ultima a mio avviso però meno perspicua) ampolo afferma che la parola canalis ha l’accezione generica di «condotto» e che ad una puntuale rilettura risulta anzi in vari casi evidente che anche nelle fasi più antiche questi «condotti» erano sotterranei e dunque a speco chiuso. nell’ambito della stessa Cloaca Maxima, del resto, i tratti più antichi, realizzati in blocchi di cap-pellaccio e coperti a pseudo-volta risulterebbero per via indiretta databili all’età tardo-arcaica (vd. H. bauer, voce cit. [a n. 16], 289). anche l’obiezione dell’assenza di co-perture a volta in strutture idrauliche ipogee così antiche è superata dallo stringente confronto fra il rinvenimento dell’ambiente 16 dell’area della Meta Sudans e la cisterna delle pendici settentrionali del Palatino (in questi termini e per un ulteriore confronto con il canale emissario del lago di albano vd. a. Carandini - P. Carafa [a cura di], op. cit. [a n. 16], 246-247).
19 Per le caratteristiche tecniche e l’interpreta-zione funzionale di questo muro quale recinzione dell’area di culto vd. s. Zeggio, art. cit., 2005 (a n. 1), 69; s. Zeggio, Roma, Valle del Colosseo, cit. (a n. 1), 272-273, figg. 2, c e 3, b.
20 le principali classi di ex voto sono illustrate in s. Zeggio, Il deposito votivo, in C. Panella (a cura di), Meta sudans I, cit. (a n. 1), 95-113; ead., Area della Meta sudans (Municipio I), Contesto votivo arcaico e repubblicano, in M.a. tomei (a cura di), op. cit. (a n. 10), 90-91.
13, 2006 Dall’indagine alla città 69
dai nuovi mantelli stradali, da ora solidamente glareati e dotati di cunette laterali o centrali (fig. 4, 4)21, e dal rifacimento, in blocchi di cappellaccio più piccoli ma più regolari, del muro di cinta del santuario delle pendici palatine (fig. 4, 5)22, il cui culto sempre vivo è documentato dagli ex voto progressivamente più numerosi.
i primi tempi della repubblica vedono la sostanziale sopravvivenza di allineamenti e edifi-ci preesistenti, l’ulteriore ripavimentazione glareata delle vie dirette rispettivamente all’esqui-lino ed al Foro e la realizzazione lungo quest’ultima di una struttura ipogea rettangolare in
Fig. 5. – valle dell’anfiteatro e pendici nord-orientali del Palatino. schema planimetrico ricostruttivo della zoniz-zazione funzionale dell’area agli inizi della repubblica. nei due toni di rosso la viabilità ed i luoghi sacri, in grigio le
probabili aree di edilizia privata.
21 Di questo secondo tipo è il mantello stradale della via che sale al Foro (vd. s. Zeggio, Roma, Valle del Colosseo, cit. [a n. 1], 274, fig. 4), che reca una cu-netta centrale larga quasi un metro e profonda max. cm 25 ca., commisurata all’eccezionale ampiezza del
tracciato, che raggiunge i m 6.22 le caratteristiche tecniche di questo muro, i
cui blocchi recano fra l’altro alcune «marche di cava» incise, sono descritte in s. Zeggio, art. cit., 2005 (a n. 1), 69.
70 s. Zeggio Sc. Ant.
blocchi di cappellaccio. Come recentemente edito23, in questa struttura del tutto particolare va riconosciuto un bothros, gradualmente riempito di ex voto sino almeno al finire del iii secolo a.C. e verosimilmente connesso ad un santuario sito non lontano, sulle pendici meridionali della velia24.
agli inizi dell’età repubblicana25 il quartiere mostra dunque almeno due percorsi princi-pali infrastrutturati e serviti da condotti fognari26, l’asse Circo Massimo-esquilino (fig. 5, a) e l’asse valle-Foro (fig. 5, b), e due poli cultuali, che le caratteristiche dell’offerta dimostrano sicuramente differenziati. se nel santuario delle pendici palatine è possibile riconoscere con ogni probabilità le romulee Curiae Veteres (fig. 5, c), del culto connesso al bothros (fig. 5, d) ci sfugge l’eventuale santuario di riferimento sulla velia (fig. 5, e). Ma le case private? a differenza di quanto accade ad esempio lungo la Sacra via27, lo scavo non ha sinora rivelato alcun indizio di edilizia privata di età arcaica, né nell’area della Meta Sudans, né lungo la pendice collinare28, ma case sono forse ipotizzabili almeno sul lato della strada di fronte al santuario palatino (fig. 5, f), se ad esse appartenevano in origine i frantumi di craticeo combusto rinvenuti proprio sulla pavimentazione proto-repubblicana della via diretta all’area forense29.
23 C. Panella - s. Zeggio, art. cit., 2004 (a n. 1), 77-80.
24 almeno a partire da questa fase questo edificio di culto è fortemente indiziato dalla presenza, fra gli oggetti deposti nel bothros in età medio-repubblicana (vd. oltre, n. 34), di almeno due frammenti di decora-zione architettonica fittile policroma, relativi rispetti-vamente ad una lastra di coronamento e ad un’antefis-sa con menade, quest’ultima databile appunto agl’inizi del v secolo a.C., per i quali vd. C. Panella - s. Zeggio, art. cit., 2004 (a n. 1), 79. un’attenta revisione dei culti veliensi è in D. Palombi, Tra Palatino ed Esquilino: velia, Carinae, Fagutal. Storia urbana di tre quartie-ri di Roma antica (Riv. Ist. Arch. St. Arte, suppl. 1), roma 1997, 67-133.
25 lo schema planimetrico presentato a corredo della ricostruzione topografica di questa fase (fig. 5), come quelli che seguiranno, è ovviamente ipotetico e provvisorio. in questo senso le dimensioni delle singole aree sono le minime ricostruibili in base ai rinvenimen-ti reali, e dunque da considerarsi indicative, mentre un punto interrogativo indica l’incertezza riguardo alla localizzazione o all’interpretazione di un elemento; ugualmente i percorsi stradali sono tracciati integrando i dati delle fasi più antiche con quelli più estesi relativi all’età giulio-claudia. in questi schemi planimetrici gli areali ricostruibili sono indicati da lettere, mentre nelle planimetrie composite di periodo ogni singola eviden-za archeologica è identificata da un numero.
26 alcuni rinvenimenti effettuati nel 1939 in oc-casione della conduzione della metropolitana (vd. ol-tre, n. 207 e cfr. fig. 16, 12 e 18-20) potrebbero però
indiziare la presenza di un’altra strada servita da fo-gnatura e di due setti murari nella zona ad est della via per l’esquilino.
27 le ricche quanto articolate case ad atrio rinve-nute alle pendici settentrionali del Palatino, peraltro da-tabili al medesimo torno di tempo (530/520 a.C.) del su citato riassetto del santuario e delle vie adiacenti, sono analizzate e ricostruite in a. Carandini - P. Carafa (a cura di), Palatium e sacra via, cit. (a n. 16), 215-282. Per la casa rinvenuta sul lato opposto della strada, nei pressi del tempio di antonino e Faustina, e per le sue discus-se ipotesi ricostruttive vd. invece F. Melis - a. rathje, Considerazioni sullo studio dell’architettura domestica arcaica, in Arch. Laziale 6 (Quad. Arch. Etr. Ital. 8), roma 1984, 382-395 (in part. 387-389); a. rathje - i. van Kampen, The Distribution of Space and Mate-rials in Domestic Architecture in Early Rome. A Case Study of the pre-Republican Habitation Levels on the Sepolcreto Arcaico Site at the Roman Forum, in From Huts to Houses. Transformations of Ancient Societies. Proceedings of an International Seminar Organized by the Norwegian and Swedish Institutes in Rome (21-24 September 1997), stockholm 2001, 383-388.
28 Per questa zona, in cui lo scavo non ha ancora raggiunto livelli così antichi, vd. però oltre, n. 38.
29 l’accumulo di frammenti di argilla con evidenti tracce della trama vegetale, arsi e crollati in seguito ad un incendio e quindi sparsi sulla via per livellarla in funzio-ne di un’ennesima ripavimentazione, era intercalato fra due mantelli glareati, databili grazie ai contesti ceramici rispettivamente ad una fase iniziale del v e intorno alla metà del iv secolo a.C. (li reperti sono stati studiati da
13, 2006 Dall’indagine alla città 71
l’età meDio-repubblicana
Con la media età repubblicana le evidenze strutturali s’infittiscono, anche se risultano per lo più scarsamente leggibili, perché molto frazionate dai ben più imponenti interventi delle fasi successive; se in funzione di ciò il iv secolo a.C. è sinora attestato solo da rifacimenti dei mantelli glareati delle due vie principali (fig. 6, 1)30, il iii secolo a.C. risulta più variamente
Fig. 6. – valle dell’anfiteatro e pendici nord-orientali del Palatino. Planimetria delle evidenze di età medio-repub-blicana. in verde le evidenze di iv secolo a.C., in rosso quelle di iii secolo a.C., in grigio quelle riutilizzate.
a. santelli, che ringrazio per le informazioni, nell’am-bito della tesi di laurea «Storia ed economia sulla strada per il Foro. Contesti ceramici dalla media repubblica al primo impero dallo scavo della Meta sudans», per la cat-tedra di Metodologia e tecniche della ricerca archeolo-gica della Facoltà di scienze umanistiche dell’università di roma «la sapienza», aa. 2004-2005). la presenza sul lato palatino della strada del muro in blocchi di recin-zione del santuario, alto e continuo, rende quasi certo
che il crollo delle pareti sia avvenuto dal lato opposto e la tecnica edilizia più economica fa ritenere preferibile la loro appartenenza ad edifici di minore rilevanza, quali appunto case private di medio livello.
30 in questo senso si noterà come l’unico inter-vento visibile in pianta sia quello effettuato sulla via esquilino-Circo Massimo, apparentemente non sosti-tuito nel secolo successivo come accade invece sull’al-tro tracciato.
72 s. Zeggio Sc. Ant.
caratterizzato. si rilevano innanzi tutto due ulteriori glareazioni della strada che sale verso il Foro, collocabili rispettivamente agli inizi e negli anni centrali del secolo; nell’area delle pendici nord-orientali del Palatino la pavimentazione più tarda conserva in parte i marciapiedi (fig. 6, 2), perduti invece nei due tratti di strada individuati nell’area della Meta Sudans (fig. 6, 3)31. Continua il culto delle pendici palatine, attestato da una gran quantità di ex voto seriali tipici della media età repubblicana32, e il santuario riceve apparentemente solo un’intonacatura del muro di cinta. in connessione con il secondo rifacimento stradale il bothros della pendice ve-
Fig. 7. – valle dell’anfiteatro e pendici nord-orientali del Palatino. schema planimetrico ricostruttivo della zoniz-zazione funzionale dell’area alla fine della media età repubblicana. nei due toni di rosso la viabilità ed i luoghi sacri,
in grigio le probabili aree di edilizia privata.
31 sono stati rinvenuti due tratti del marciapiede settentrionale, per complessivi m 4 circa di lunghezza, realizzato in lastroni di tufo giallo semilitoide spes-si cm 25 ca. la larghezza del marciapiede non è però ricostruibile (max. cm 40 visibili), in quanto verso nord esso è inglobato in una fondazione cementizia posteriore. sinora non si sono invece trovate tracce del marciapiede meridionale, sul lato palatino della
strada, pur chiaramente indiziato da appositi strati preparatori individuati nell’area della Meta.
32 alcuni di questi reperti, appartenenti alle clas-si di ex voto più diffuse fra iv e iii secolo a.C. in area etrusco-laziale, fra cui soprattutto coppe in vernice nera e statuette fittili a matrice, sono illustrati in s. Zeggio, art. cit., 1996 (a n. 20), rispettivamente 99-101 e 102-107.
13, 2006 Dall’indagine alla città 73
liense (fig. 6, 4) vede la modifica dei suoi filari superiori33 ed una nuova deposizione di ex voto, mentre un’altra doveva esser stata effettuata nel secolo precedente34. in entrambe le aree d’in-dagine si può poi osservare la conduzione di piccoli condotti fognanti a sezione quasi quadrata (fig. 6, 5-6), realizzati con lastre di cappellaccio35, che sembrano sottintendere un’edificazione più fitta degli spazi e la conseguente necessità di un più capillare smaltimento idrico. Questa ipotesi sembra rafforzata, infine, dal rinvenimento nell’area i dello scavo palatino di alcune lastre di tufi semilitoidi in situ (fig. 6, 7-8) e nell’area della Meta Sudans, subito a nord dell’asse valle-Foro, di un lacerto molto limitato di battuto (fig. 6, 9), evidenze entrambe riferibili a pa-vimentazioni, rispettivamente da esterno e da interno.
sul finire della media età repubblicana il quartiere conserva dunque sostanzialmente l’or-ganizzazione impostata per esso in età arcaica, con la sopravvivenza tanto dei tracciati prin-cipali (fig. 7, a-b), sotto ai quali continuano a funzionare i condotti dell’epoca regia, quanto dei due poli cultuali preesistenti (fig. 7, c-d), anche se per quello veliense persiste l’incertezza sulla localizzazione del santuario di pertinenza (fig. 7, e). le aree di probabile edilizia privata, indiziate dal rinvenimento di condotti di limitata dimensione e di lacerti di pavimentazioni dalla funzione differente ma comunque di semplice fattura, sembrano però in questa fase salire a due. nel primo caso (fig. 7, f) parrebbe peraltro confermata la destinazione ad edilizia priva-ta dell’area prospiciente il santuario delle pendici palatine, ipotizzata per l’epoca precedente, mentre nel secondo (fig. 7, g) possiamo riconoscere i primi indizi di una destinazione d’uso che verrà ampiamente confermata per le epoche successive, sino all’incendio neroniano.
l’età tarDo-repubblicana
Con il ii secolo a.C., mentre entrambi i poli cultuali, benché non più attestati da deposi-zioni di ex voto per la modifica degli usi rituali, continuano a «vivere» con le forme architetto-niche acquisite in precedenza, ha inizio nell’intera area un periodo di estesi e profondi rinnova-menti, riflesso indiretto del «salto di scala» compiuto da roma nel Mediterraneo e delle nuove conquiste tecnologiche nell’edilizia. Già all’inizio del secolo si assiste alla costruzione di nuovi edifici, sia sulle pendici settentrionali del Palatino36 che su quelle orientali della velia, in questo
33 l’alterazione della struttura originale, con gli ultimi tre filari attualmente conservati ricollocati fuori allineamento a creare un vano più ampio, è chiaramen-te leggibile nella pianta e nella sezione della struttura presentate in C. Panella - s. Zeggio, art. cit., 2004 (a n. 1), 77, fig. 5, a-b.
34 il riempimento della struttura sembra avvenire in tre riprese (vd. C. Panella - s. Zeggio, art. cit., 2004 [a n. 1], 78): la prima collocabile come su detto agli ini-zi del v secolo in connessione con la realizzazione del bothros, la seconda nell’ambito del iv e la terza, non necessariamente l’ultima (ma per le alterazioni succes-sive il dato non è più verificabile), appunto nel iii se-colo a.C. in connessione con la modifica strutturale.
35 Questi piccoli condotti, con speco rettangola-re o quasi quadrato che non supera i cm 30 di lato, ri-sultano dall’accostamento a secco di lastre che paiono per lo più di riutilizzo, ricavate «affettando» in due i blocchi di età arcaica e proto-repubblicana dello spes-sore di un piede osco; esse appaiono infatti quasi sem-pre irregolari e dagli spigoli usurati o sbrecciati, spesse cm 12-13 (ossia appunto poco meno della metà di un piede osco di cm 27,5).
36 in quest’area non si sono ancora rinvenuti set-ti murari riferibili alla fase in esame, ma alcuni sono forse intuibili al disotto dei livelli attualmente in sca-vo. la presenza di edifici è comunque attestata, come si vedrà, da altri elementi strutturali.
74 s. Zeggio Sc. Ant.
caso con un complesso di almeno tre ambienti non ortogonali (fig. 8, 1)37; qui un piccolo dolio interrato all’angolo di uno dei vani, lì un impluvium in lastre e blocchi modanati di tufo litoide lionato (fig. 8, 2)38 sembrano attestare il carattere privato di ambedue i fabbricati.
37 in un saggio prossimo al tratto centrale del-la fronte del tempio di venere e roma, condotto nel periodo 1986-88 da M. Ceci, lo scavo ha rivelato una coppia di fondazioni fra loro legate, non ortogonali e che delimitano tre vani, realizzate in cavo libero in una particolare opera cementizia. Composta quasi esclusi-vamente di blocchetti e scaglie di cappellaccio fittamen-te allettati per piani orizzontali e con poca malta mar-rone friabile, questa tecnica edilizia si pone con tutta evidenza fra i primi tentativi di utilizzo del concreto: ancora legata ad una disposizione per assise orizzon-tali, senza differenziazione fra nucleo e paramenti, si presenta in facciavista come un’opera incerta di bloc-
chetti rettangolari, di taglia relativamente regolare e molto ravvicinati, ed è infatti utilizzata senza soluzione di continuità, a parte una sottile risega, anche per gli elevati, conservati però solo in minima parte.
38 assai alterato da interventi posteriori, questo impluvium, per una più accurata analisi del quale ri-mando al contributo di v. Carbonara in questo volume, parrebbe connesso ad una cisterna preesistente, non ancora individuata ma fortemente indiziata da tratti di condotti e da alcuni elementi in cappellaccio in parte emersi durante le ultime indagini. in questo senso, an-che in considerazione del materiale impiegato, è forse da supporre l’esistenza nei livelli direttamente sottostanti,
Fig. 8. – valle dell’anfiteatro e pendici nord-orientali del Palatino. Planimetria delle evidenze di ii secolo a.C. in verde le evidenze degli inizi del ii secolo a.C., in rosso quelle del secondo quarto, in blu quelle della seconda metà,
in grigio quelle riutilizzate.
13, 2006 Dall’indagine alla città 75
intorno al 180/170 a.C. altre due strutture (fig. 8, 3-4) vengono aggiunte all’edificio delle pendici veliensi, dando luogo ad un articolato complesso affacciato sulla via esquilino-Circo Massimo39. Contemporaneamente si dà l’avvio al radicale restauro in cementizio dei grandi con-dotti arcaici di fondovalle (fig. 8, 5)40, o alla loro sostituzione con nuove fognature in opera incerta (fig. 8, 6)41, mentre continua l’inserzione di scarichi di portata limitata, come quello in-dividuato sul limite settentrionale della strada valle-Foro (fig. 8, 7)42. Queste operazioni hanno ovviamente un pesante impatto sui due assi viari principali, che contestualmente vengono infatti entrambi integralmente riallestiti; in perfetta consonanza con la fonte liviana43 le vie sono per la prima volta silice stratae, con basoli irregolari di piccola taglia44 allettati su preparazioni argillose a fitte scaglie di basalto (fig. 8, 8-9) e con marciapiedi in lastroni di tufo (fig. 8, 10-11)45.
o comunque a poca distanza dall’impluvium, di una ci-sterna ipogea in blocchi di cappellaccio, rettangolare, come quella già vista a servizio della «domus 3» delle pendici settentrionali del Palatino sulla Sacra via (vd. a. Carandini - P. Carafa [a cura di], Palatium e sacra via, cit. [a n. 16], 229-231, 244-246, 268-274) o «a fia-sco», del tipo diffuso in domus e ville di area romana fra vi ed inizi v secolo a.C., come ad esempio nella «villa di Grottarossa» (su posizioni cronologicamente diver-se vd. da ultimo J.a. becker, Investigating Early Villas: the Case of Grottarossa, in P. attema - a. nijboer - a. Zifferero [a cura di], Papers in Italian Archaeology, cit. [a n. 1], 3, 2 e M. De Franceschini, Ville dell’Agro Romano [Mon. Carta Agro 2], roma 2005, 86-88, figg. 28.2-3; 307; 500, tav. 6.5); in tal caso si avrebbe una te-stimonianza, per ora indiretta, dell’esistenza anche in quest’area di un complesso di edilizia privata di età ar-caica o proto-repubblicana.
39 appunto ad una data prossima al 180/170 a.C. possiamo riferire due setti, attualmente separati ma fra loro ortogonali, individuati subito ad est dei preceden-ti. l’appoggio del più occidentale di essi al sistema pre-esistente, la diretta connessione dell’altro al rifacimento stradale lastricato della via per l’esquilino di cui fra breve si dirà e infine l’uso di un cementizio del tutto si-mile a quello impiegato nei sistemi fognari connessi alle strade stesse (vd. nn. 40-41) confermano questa crono-logia leggermente posteriore al primo impianto.
40 un restauro di questo genere, che interessa la copertura del condotto che scendeva nella sella fra Pa-latino e velia, è attestato dal carotaggio effettuato nei pressi dello sbocco dell’attuale via sacra sulla piazza del Colosseo (vd. n. 17). trattandosi appunto di un sondaggio, la datazione al secondo ventennio del ii secolo a.C. è ovviamente ipotetica e basata essenzial-mente sulla forte somiglianza del cementizio utilizza-to con quello della fognatura dell’asse esquilino-Cir-co Massimo, di seguito descritta, e di altre strutture, con funzione diversa, collocabili in questa fase. in
tutti questi casi il calcestruzzo utilizzato risulta com-posto di malta grigio-scura molto consistente, di calce e pozzolana grigia, mista ad una gran quantità di inerti di medie e piccole dimensioni, di cappellaccio ed altri tufi semilitoidi e granulari di evidente reimpiego, per-lopiù allettati con cura.
41 Questa fogna, che reca uno speco a volta lie-vemente ribassata alto m 1,60 e largo m 1,00 ca. (ma le dimensioni originarie potrebbero essere maggiori), sembra sostituire il grande condotto di età regia cor-rendo subito ad est di esso e forse in parte obliteran-dolo. Con infiniti restauri e rifoderature esso rimarrà in uso per tutta l’età antica e sarà colmato con un vero e proprio «immondezzaio» solo verso la metà del vi secolo.
42 si tratta di un piccolo condotto fognario in lastre di cappellaccio di riutilizzo, individuato per un tratto as-sai breve e dalla struttura molto simile, se non per le di-mensioni leggermente maggiori e per le lastre più sottili, a quelli di età medio-repubblicana (vd. n. 35).
43 liv., 41, 27, 5-7, riferito ai censori del 174 a.C.44 anche se i mantelli lastricati di questa fase
sono perduti per ambedue i tracciati, le caratteristi-che delle pietre impiegate sono certe, sia perché nel caso della via diretta al Foro le stesse sono riutilizzate, come si vedrà, nella pavimentazione successiva, sia per il limitato dislivello fra i piani di vita di questa fase e della successiva, sia infine per le impronte lasciate sulle preparazioni.
45 Del marciapiede meridionale della via che sale al Foro, ampio m 2 ca., rimane, addossato al muro di recinzione delle presunte Curiae Veteres, un lastrone di tufo litoide lionato (fig. 8, 10) di cm 130 x 66 x 16 (spess.) (vd. anche s. Zeggio, Roma, Valle del Colos-seo, cit. [a n. 1], 273, n. 20). Di quello settentrionale rimane invece traccia più ad ovest, in una serie di la-stroni del medesimo tufo (fig. 8, 11) conservati per una lunghezza di m 3,40 e per una larghezza di max. cm 60.
76 s. Zeggio Sc. Ant.
in un momento avanzato del secolo un altro intervento edilizio fornisce testimonianza dei primi setti murari relativi all’impianto della domus che si sviluppa sulla pendice palatina, a sud della via che sale al Foro. se per questa fase ci sfuggono i limiti e dunque le dimensioni dell’impianto e se i brevissimi tratti di fondazioni cementizie rinvenuti in prossimità di essa (fig. 8, 12) non permettono ancora di capire l’organizzazione dei vani sul fronte-strada, nella zona retrostante, più prossima al colle, una serie di tre fondazioni fra loro ortogonali (fig. 8, 13-14), recanti in un caso parte dell’eleva-to in opera incerta, danno ragione di un piccolo vano di servizio probabilmente scoperto, una sorta di chiostrina o pozzo di luce, che riutilizza lo scarico dell’impluvium precedente46.
nei primi decenni del i secolo a.C. l’edilizia vive un altro momento di grande fervore. sul tratto sud-orientale delle pendici della velia viene impiantato un sistema di almeno due corridoi voltati seminterrati paralleli (fig. 9, 1), evidentemente atto alla sostruzione di un nuovo edificio, o
46 Per un’analisi di questi rinvenimenti rimando al contributo di v. Carbonara in questo volume.
Fig. 9. – valle dell’anfiteatro e pendici nord-orientali del Palatino. Planimetria delle evidenze della prima metà del i secolo a.C. in verde le evidenze del primo quarto del secolo, in rosso quelle del secondo quarto, in grigio quelle
riutilizzate.
13, 2006 Dall’indagine alla città 77
forse all’espansione e soprelevazione di quello già attestato subito a nord. Questi corridoi, costruiti in cementizio e fra loro comunicanti, dovevano anche svolgere la funzione di ambienti di servizio47, come del resto il vano subito ad est di essi, forse una corte scoperta, di cui restano solo scarse tracce del pavimento in cocciopesto (fig. 9, 2). Più o meno nel medesimo torno di tempo il santuario pa-latino vede il radicale e accurato restauro dell’arcaico muro di recinzione con grandi blocchi di tufo lionato (fig. 9, 3-4)48 e forse anche l’allestimento di una nuova pavimentazione dell’area interna in lastroni di tufo (fig. 9, 5); una canaletta con spallette in opera incerta e quasi-reticolata (fig. 9, 6-7) at-traversa il tratto più occidentale del nuovo muro, convogliando verso nord anche le acque di un suo discendente49 e testimoniando l’ininterrotta inserzione di adduzioni nei condotti di fondovalle.
Più ad ovest, fra la pendice palatina e la via che sale al Foro, con tecnica e materiali del tutto analoghi a quelli utilizzati per la recinzione delle probabili Curiae Veteres è edificato un setto in opera quadrata con orientamento grosso modo n-s (fig. 9, 8)50, che a partire da questo momento e sino all’incendio neroniano segnerà il limite orientale dell’isolato che dal secolo precedente ospitava la domus con impluvium e maglia interna in opera incerta. in origine que-sto limite, non ancora individuato dallo scavo, doveva trovarsi più a valle (verso est), dato che, come si ricorderà, proprio sotto l’attuale allineamento del muro in blocchi correva invece un fognolo in lastre di cappellaccio51. l’isolato subisce dunque uno slittamento verso ovest o una contrazione, che sarebbe suggestivo supporre a favore di un ampliamento del luogo di culto dell’angolo nord-orientale del Palatino, che abbiamo visto appunto radicalmente restaurato. Per effetto di questa modifica la corte coi resti dell’impluvium viene trasformata in una piccola stanza (fig. 9, 9), attraversata da un fognolo in opera incerta e pavimentata in mosaico bicromo; un lacerto di mosaico del tutto analogo, probabilmente pertinente al vano contiguo, è stato rinvenuto poco più ad ovest (fig. 9, 10)52. Queste vaste ristrutturazioni hanno ovviamente un
47 Parzialmente obliterati da possenti fondazioni di età neroniana, questi ambienti, individuati in un limita-to saggio di scavo condotto nel periodo 1986-87 da r. Graziani e l. suaria, si presentavano colmati di terra, scaricatavi all’indomani dell’incendio del 64 d.C., e dif-ficilmente accessibili. alti m 2,30 e larghi poco più di m 4, all’atto della scoperta recavano ancora alle pareti par-te dell’intonaco bianco, mentre i pavimenti erano stati asportati, mettendo in luce nel vano meridionale un fo-gnolo con spallette in opera quasi-reticolata, atto a con-vogliare in un condotto evidentemente esistente lungo la pendice veliense le acque del piano superiore, incanalate attraverso la volta cementizia e poi lungo la parete da un discendente oggi perduto. Per una prima analisi di que-ste strutture vd. C. Panella, art. cit., 1990 (a n. 1), 47.
48 Dopo un breve accenno in C. Panella, art. cit., 1990 (a n. 1), 44-45, questo muro, in un primo momen-to erroneamente datato al ii secolo a.C., è descritto per la prima volta in C. Panella, Un’area sacra sulle pendici nord-orientali del Palatino, in C. Panella (a cura di), Meta sudans I, cit. (a n. 1), 27-91 (in part. 32-33). Per lo spostamento della sua datazione e per il complesso
sistema d’installazione, che permette la precisa conser-vazione del filo originario della struttura tardo-arcaica vd. s. Zeggio, art. cit., 2000 (a n. 1), 301-302; C. Panella, art. cit., 2001 (a n. 1), 54; s. Zeggio, art. cit., 2005 (a n. 1), 66, tav. ii, a-b; 69; s. Zeggio, Roma, Valle del Colosseo, cit. (a n. 1), 273, n. 21 e fig. 3, c.
49 un’immagine del tratto meridionale della ca-naletta (fig. 9, 6), ripavimentato in età claudia, è in C. Panella, art. cit., 1990 (a n. 1), 43, fig. 9, mentre un pro-spetto del discendente è in C. Panella, Un’area sacra, cit. (a n. 48), 33, fig. 18.
50 Prescindendo dal tratto sovrapposto al muro arcaico, ambedue le strutture mostrano fondazione a cavo libero di solida malta rossastra ed inerti di tufi (soprattutto tufo litoide lionato) ed elevato in blocchi di tufo litoide lionato, alti e spessi due piedi romani (cm 58 x 58 ca.) e di lunghezza variabile, connessi a secco per testa in un unico filare.
51 vd. n. 35 e fig. 6, 6.52 Per una più specifica analisi di queste eviden-
ze rimando al contributo di v. Carbonara in questo volume.
78 s. Zeggio Sc. Ant.
forte impatto sulla via per il Foro, che viene infatti contestualmente ancora una volta pavimen-tata, come attestano i rinvenimenti effettuati, sia nell’area della Meta Sudans (fig. 9, 11)53 che in quella palatina (fig. 9, 12-13).
solo nell’isolato occupato dalla domus alle pendici del Palatino è riconoscibile una fase co-struttiva leggermente più recente, collocabile nell’ambito del secondo quarto del i secolo a.C. ed essenzialmente legata ad un riassetto degli spazi interni. se ancora non è chiara la disposizio-ne dei vani fronte-strada, che da questo momento parrebbero serviti da un condotto in opera incerta parallelo al limite meridionale della via valle-Foro (fig. 9, 14)54, nel settore retrostante è
53 in questa zona dell’allestimento stradale non rimane che la preparazione, conservata per un’am-piezza di soli m 5 ca.
54 la collocazione del condotto fognario in questa fase e non piuttosto, come parrebbe logico, in quella di poco precedente, al momento del vero e proprio reimpianto della domus e della contestuale ri-
pavimentazione della strada prospiciente (in ogni caso necessaria, visto il passaggio della fognatura proprio al disotto del marciapiede; vd. anche n. 57), è legata essenzialmente all’analisi tuttora in corso della stra-tigrafia tagliata dal condotto stesso e come tale è da considerarsi ipotetica e provvisoria.
Fig. 10. – valle dell’anfiteatro e pendici nord-orientali del Palatino. schema planimetrico ricostruttivo della zoniz-zazione funzionale dell’area intorno al 60 a.C. nei due toni di rosso la viabilità, nei due toni di verde i luoghi sacri
sicuri o ipotetici, in grigio le aree di edilizia privata.
13, 2006 Dall’indagine alla città 79
attestata la trasformazione in corridoio della piccola stanza un tempo occupata dall’impluvium e di quella contigua ad ovest, grazie all’abbattimento del muro di separazione nord-sud in ope-ra incerta. un interessante mosaico rinvenuto poco più ad ovest (fig. 9, 15-16), che pavimenta il corridoio stesso, aiuta a comprendere per la prima volta, grazie alla diversificata decorazione geometrica tricroma, la distribuzione degli ambienti che su di esso si affacciano, appartenenti alla zona residenziale della casa55.
alla fine di queste trasformazioni, prima della metà del i secolo a.C., l’area in esame pre-senta dunque un panorama assai più articolato che nel passato. Delle vie principali, ambedue ormai lastricate, quella nord-sud (fig. 10, a) ha raggiunto un’ampiezza di più o meno m 5, con marciapiedi di circa un metro. Per la seconda mancano dati dimensionali del tratto orientale, pressoché pianeggiante e forse già irregolarmente più ampio a formare una sorta di slargo (fig. 10, b) a discapito degli edifici privati qui esistenti durante le fasi precedenti56, mentre il tratto occidentale, che in più ripida salita si dirige al Foro, è ora largo globalmente m 8/9 ca., di cui almeno m 3 occupati dai marciapiedi (fig. 10, c)57. un dato interessante riguarda in questo senso il bothros delle pendici veliensi (fig. 10, d). a causa dell’interruzione delle deposizioni votive dal ii secolo a.C., non siamo più in grado di capire se esso sia ancora in uso, e tantomeno se continui a vivere l’eventuale santuario di riferimento58; è certo però che almeno da questa fase, ma forse già appunto dal ii secolo a.C., esso sporge dal filo del marciapiede settentrionale, creando un’area di rispetto e dunque una strozzatura della sede stradale difficilmente giusti-ficabili se non con un’intangibilità sacrale della struttura, evidentemente ancora quanto meno rispettata, se non frequentata. È l’anticipazione di un fenomeno che vedremo reduplicarsi negli anni successivi.
senz’altro attivo e frequentato è invece il santuario delle pendici palatine (fig. 10, e), pur se ormai privo anch’esso di attestazioni votive, e di grande interesse sarebbe la definizione della sua reale estensione in questa fase, con un eventuale e ragguardevole incremento dimensionale rispetto al passato (fig. 10, f), ai danni del confinante isolato59. Quest’ultimo (fig. 10, g) reca ormai tracce certe ed articolate dell’esistenza di una domus di alto livello, che occupa tutta la bassa pendice collinare e si sviluppa longitudinalmente lungo la via per il Foro, superando am-piamente ad ovest i limiti dell’area indagata, al disotto delle «terme di eliogabalo».
55 le partizioni e gli schemi decorativi del mo-saico, così come un’analisi della domus sono illustrati nel contributo di v. Carbonara in questo volume.
56 Questa ipotesi, non direttamente verificabile, na-sce dall’osservazione degli allineamenti divergenti delle pur esigue porzioni conservate dei due marciapiedi e da quanto riscontrabile con certezza per le fasi successive.
57 sia i basoli di piccola taglia che i lastroni di tufo dei marciapiedi (questi talvolta conservati in posto) sono a tratti riutilizzati dal mantello stradale preceden-te. ad un’ampiezza di m 1,5 per ciascun marciapiede, ridotta rispetto alla fase anteriore, sembrano ricon-durre sia le impronte conservate nell’area della Meta Sudans che alcune evidenze strutturali ancora non del tutto indagate sulle pendici palatine nord-orientali. vd.
anche il contributo di v. Carbonara in questo volume. Per la differenza dimensionale fra i due tracciati in rap-porto al percorso delle pompe civiche ed in particolare di quella trionfale, già intuibile per le fasi precedenti ma ora chiaramente documentata, vd. s. Zeggio, art. cit., 2000 (a n. 1), 301; s. Zeggio, art. cit., 2005 (a n. 1), 65.
58 in questo senso ogni indicazione dell’ipoteti-co luogo di culto veliense è stata omessa nella pianta ricostruttiva di questa fase (fig. 10).
59 È questo in effetti uno dei motivi che ci ha spin-to ad estendere l’area d’indagine dalla valle dell’anfi-teatro verso il Palatino e, in specifico, ad aprire nella campagna 2005 un nuovo saggio di scavo (area iii) proprio a ridosso dell’angolo nord-orientale della pendice (nella zona circostante la lettera f di fig. 10).
80 s. Zeggio Sc. Ant.
Più incerti i dati relativi alle pendici orientali della velia. Qui ad occidente della via diretta all’esquilino si sviluppano due nuclei edilizi; il meridionale (fig. 10, h) ha uno sviluppo vertica-le di almeno due piani, mentre il settentrionale (fig. 10, i) reca una complessa disposizione degli ambienti, differenziata tra fronte-strada, allineato alla via, e settore retrostante. in questa fase non è chiaro se si tratti di due edifici diversi ed eventualmente separati, o piuttosto, come ac-cadrà in seguito, di due porzioni di un medesimo e movimentato complesso in cui riconoscere ancora una volta una domus del ceto elevato, né è possibile dire se e come il plesso meridionale si estenda sino all’incrocio fra la via diretta al Foro e quella per l’esquilino60.
nei decenni centrali del secolo, più o meno fra il 60 ed il 30 a.C., tutta l’area è interessata da un gran fermento edilizio, una prima evidenza del quale è rappresentata dal notevole riassetto della rete fognante. nella zona delle pendici veliensi, in momenti diversi ma molto ravvicinati, questo riassetto prevede l’inserzione nel grande condotto di fondovalle n-s di due fognature trasversali, a servizio di altrettanti ambienti del blocco edilizio più settentrionale delle pendici veliensi (fig. 11, 1-2)61, e conseguentemente il restauro in opera reticolata di parte del condotto stesso (fig. 11, 3). Poco prima della fine del periodo la più settentrionale di queste due adduzio-ni, condotta per prima, verrà anche modificata in funzione dell’installazione nel vano sovra-stante di una probabile vasca (fig. 11, 4), ma questo intervento risulta quasi incomprensibile a causa della successiva ristrutturazione augustea; nel medesimo torno di tempo un fognolo (fig. 11, 5) è condotto anche nel vano retrostante, forando uno dei muri in opera incerta62.
nella zona più vicina al Palatino un nuovo fognolo (fig. 11, 6-7) serve la parte più occi-dentale della domus affacciata sulla via per il Foro, ora come si vedrà radicalmente ristrutturata, scaricando le sue acque nella fognatura limitanea al fronte-strada, realizzata nella fase prece-dente. un altro fognolo (fig. 11, 8) serve il displuvio settentrionale del recinto del santuario pa-latino, sostituendo in parte o modificando nel tracciato quello condotto al momento della sua edificazione63. nell’area poi occupata dalla Meta Sudans viene infine condotto un canale (fig. 11, 9-10) più o meno parallelo a nord del collettore principale di fondovalle fra velia e Palatino, ma di quota più superficiale, che doveva convogliarvi le acque tramite pozzetti di caduta64.
60 relativamente alla planimetria ricostruttiva van-no a questo proposito notati due elementi. innanzitut-to in questa fase, a differenza di quanto accadrà per le successive, non è ancora strutturalmente definibile la situazione della zona orientale di questo incrocio, da cui si dovrebbe dipartire la strada, prosecuzione intramu-ranea della via Tusculana, oggi ricalcata dalla via dei ss. Quattro (sull’antichità di questo percorso vd. C. Panel-la, Un’area sacra, cit. [a n. 48], 65, n. 75); inoltre l’ecce-zionale dimensione complessiva di m 14 attribuita alla strada che dall’incrocio medesimo scende a sud verso il Circo Massimo è del tutto ipotetica e desunta da quanto noto per un momento genericamente precedente l’in-cendio del 64 dai rinvenimenti effettuati sul finire del XiX secolo per lo scavo del «fognone dell’esquilino» (vd. in proposito C. Panella, Un’area sacra, cit. [a n. 48], 34, n. 5, con bibliografia precedente; 65, n. 74).
61 ambedue i condotti furono ampiamente re-
staurati in età augustea, cosicché non è possibile sta-bilirne l’originario sistema di copertura. essi hanno spallette in opera reticolata e piano di scorrimento in semplice malta; in parte non svuotati ed in parte nascosti da altre strutture, sono perciò rappresentati nella planimetria (fig. 11) solo schematicamente.
62 si tratta di un piccolo condotto con speco qua-si quadrato (cm 40 x 35 ca.), spallette (spess. cm 25 ca.) e piano di scorrimento in friabile cementizio marrone e copertura piana di lastre di cappellaccio riutilizzate (spess. cm 14 ca.); ne rimane un breve tratto, danneg-giato dagli interventi di età claudia.
63 Cfr. fig. 9, 6-7. va notato che il tratto sud-occi-dentale del fognolo originario (fig. 9, 6) resta invece in uso; sia quest’ultimo che il condotto ora edificato ver-ranno poi eliminati dal grande restauro di età augustea.
64 Di questa fognatura, larga all’estradosso pia-no m 1,50 ca., sono stati individuati due tratti per una
13, 2006 Dall’indagine alla città 81
Fig. 11. – valle dell’anfiteatro e pendici nord-orientali del Palatino. Planimetria delle evidenze dei decenni centrali del i secolo a.C. in verde le fognature in fase, in rosso le altre strutture in fase, in grigio le evidenze riutilizzate.
lunghezza complessiva di m 12,60 ca.; lo speco, lar-go cm 60 ca., mostra copertura cementizia a volticel-la lievemente ribassata e spallette in opera reticolata, mentre rimangono ignoti tanto la struttura del piano di scorrimento che l’altezza (stimata in m 1,60 ca.), dato che non si è potuto svuotare nessuno dei due tratti. nonostante non si siano individuati pozzi o bracci di raccordo con il più antico e profondo canale di fondovalle, almeno due diversi elementi inducono a ritenere che esso continui a funzionare sino all’età claudia (quando, come si vedrà, è in effetti attestata la conduzione di una grande fogna sotto l’asse strada-le valle-Foro), e che questa nuova fognatura non ne rappresenti che un potenziamento. il primo elemento è costituito dalle dimensioni dello speco, troppo li-mitate per un condotto principale, mentre il secondo riguarda un insieme di dati provenienti dal sondag-gio effettuato nel 1996, che ha individuato il condotto
stesso; come già accennato (vd. n. 17) i dati relativi a questo sondaggio sono in corso di edizione e ringrazio i singoli autori di seguito citati per avermi dato la pos-sibilità di queste brevi anticipazioni. se la situazione stratigrafica individuata nel tratto di carotaggio subito soprastante il condotto rende sicuri che dopo l’incen-dio del 64 d.C. esso viene almeno in parte smantellato, la presenza al disotto del livello di distruzione di oltre m 2 di stratigrafia naturale di abbandono all’interno di esso paiono testimoniarne un disuso alquanto pre-cedente. in realtà questi sedimenti, per lo più sterili, non forniscono elementi di cultura materiale per una datazione, ma un sostegno cronologico sembra veni-re dai reperti archeobotanici, analizzati da a. Celant, fra i quali si distingue un seme di melone (Cucumis melo l.), rinvenuto quasi sul fondo del condotto: la presenza di questo frutto fornisce alla formazione del sedimento un terminus ante quem non collocabile più
82 s. Zeggio Sc. Ant.
la domus delle pendici settentrionali del Palatino subisce ora una ristrutturazione totale, che, a fronte di un riutilizzo circoscritto al muro in blocchi di tufo delimitante ad est l’isolato e ad alcuni setti in opera incerta, vede la comparsa di una maglia di murature a fondazione cementizia ed elevato in opera reticolata e pilastri in blocchi di travertino (fig. 11, 11-13); anche il muro in blocchi di tufo riceve verso la via una testata in travertino e da essa si diparte ad est un setto (fig. 11, 14), di cui rimane solo la fondazione cementizia e che rappresenta il primo limite settentrio-nale a noi noto dell’isolato contiguo ad est alla domus. allineata alla via che sale al Foro è ora ben definibile una serie di almeno tre botteghe, aperte su strada con grandi porte dalle soglie in travertino (fig. 11, 15-16) in parte rimaneggiate in seguito, pavimentate in cocciopesto (fig. 11, 17) o in laterizi posti di piatto (fig. 11, 18) e dotate di allestimenti idraulici (fig. 11, 19). Più sfuggente è la sistemazione del settore abitativo retrostante, dove, ad esclusione di alcune nuove pavimen-tazioni (fig. 11, 20), sembrano sopravvivere gli allestimenti preesistenti65.
in conseguenza di tutti i lavori su descritti si rende necessario il rifacimento dei mantelli stradali, che alterazioni successive hanno però conservato solo in parte, sia per il tracciato diretto all’esquilino (fig. 11, 21), che per quello valle-Foro (fig. 11, 22-24). È questo anche il momento in cui proprio lungo il limite settentrionale della stessa via compare la testimonianza archeologica di due strutture di grande interesse, ambedue in realtà forse precedenti ma la cui maggior antichità per motivi diversi non è attualmente accertabile. la prima è una fondazione dalla forma approssimativamente rotondeggiante (fig. 11, 25) sita al disotto della vasca della futura Meta Sudans augustea, che per essere ovunque circondata da strutture non risulta da-tabile se non per cronologia relativa e comunque con qualche incertezza. il rapporto con la fogna in reticolato appena descritta (cfr. fig. 11, 10), cui la fondazione parrebbe direttamente sovrapporsi, è infatti poco visibile e quindi non del tutto chiaro, non permettendo di escludere invece una preesistenza della struttura ed una sua parziale intaccatura proprio per il transito del collettore66. Pur nell’incertezza cronologica questa evidenza non è irrilevante, dato che la sua forma apparentemente circolare fa supporre il sostegno di un monumento a pianta centrale del tutto simile per dimensioni al saliente della successiva fontana augustea67, ponendo così il pro-
o meno fra la tarda età augustea e l’età tiberiana. non è questa la sede per affrontare la complessa proble-matica dell’inizio della conoscenza e della coltivazio-ne del melone in italia (per la quale rimando al mio contributo in appendice all’edizione del sondaggio), qui basti ricordare che questa pianta risulta ignota ai più antichi scrittori latini di agraria, quali Columella e Catone, mentre ad una sua introduzione in Campania fra i regni di augusto e tiberio allude Plinio (Plin., NH, 19, 65-67), e che una delle prime rappresentazio-ni di essa compare sulla phiale detta «di alessandria» del tesoro di boscoreale (vd. in proposito e. bonnet, Plantes représentées sur les vases de Boscoreale (Musée du Louvre); étude historique et critique, in Comptes Rendus de l’Association Française pour l’Avancement des Sciences 28, 2, 1900, 419-427). ai primi decenni del i secolo d.C. sembrano del resto rimandare anche le datazioni del sedimento ottenute col metodo del ra-
diocarbonio, eseguite da G. Calderoni, M. lombardo e a. spoto.
65 Per un’analisi di questa fase della domus e per le ipotesi interpretative dei singoli ambienti si rimanda al contributo di v. Carbonara in questo vo-lume.
66 i cementizi ad inerti tufacei utilizzati nelle due strutture sono in effetti diversi, grigio friabile per la fondazione, solido e rosaceo per la fogna, ma il dato non pare determinante.
67 in base all’unico settore curvilineo conservato la fondazione mostrerebbe un diametro di m 4,40 ca. (= 15 piedi romani; l’impatto globale è riproposto dal cerchio blu a fig. 12, m). Considerata la risega di fon-dazione, di solito abbastanza consistente per strutture particolarmente sviluppate in altezza, si otterrebbe per l’elevato un diametro inferiore ai m 4, del tutto analogo a quello del tamburo basale in blocchi di tufo
13, 2006 Dall’indagine alla città 83
blema dell’esistenza nel medesimo punto68 di un’ulteriore Meta «prima della Meta», in questo caso verosimilmente non dotata di apprestamenti idrici. Questa eventualità porterebbe neces-sariamente a leggere il monumento, non più solo come segno topografico del punto di contatto delle Regiones amministrative augustee, architettonica commistione del terminus territoriale col betilo apollineo (e quindi indirettamente augusteo) propagandisticamente riproposta ed ingigantita dai Flavi dopo la parentesi neroniana, ma anche riconnettendolo ad ulteriori e più antiche simbologie, ancora una volta in apparenza legate al circuito pomeriale originario ed al suo vertice nord-orientale69.
la seconda struttura «particolare» è un pozzo in cubi forati di peperino (fig. 11, 26)70, posto una decina di metri ad est dell’antico bothros e anch’esso in qualche modo collegato alla sfera cultuale, almeno in secondo uso. anche in questo caso la presenza tutt’intorno di altre strutture non ha permesso sinora un significativo approfondimento dello scavo, per de-terminare da un lato l’eventuale presenza di una fase più antica della costruzione, dall’altro il rapporto fra la funzione sacrale, di cui meglio si dirà per le fasi successive, e quella utilitaria. va rilevato che l’esiguità del foro e l’assenza di pedarole per la manutenzione sembrerebbero ostare ad un reale utilizzo del pozzo, indiziato però per converso sia dal rivestimento interno in intonaco idraulico, che dalla presenza intorno all’imboccatura dei resti di una vaschetta in cocciopesto71.
nei decenni centrali del i secolo a.C. il quartiere mostra dunque una sistemazione gene-rale sostanzialmente analoga a quella della fase precedente, ma che è possibile ricostruire nelle sue specifiche componenti in modo assai più particolareggiato che per il passato. Per le aumen-tate necessità la rete fognaria è rinnovata e più articolata e corre al disotto di vie lastricate ed ampie (fig. 12, a-c); nonostante che per le mutate usanze dell’offerta nei depositi votivi non si depongano più ex voto, il santuario di antica fondazione nel quale riconosciamo le Curiae Ve-teres (fig. 12, d) è vitale e funzionante, anche se persistono i dubbi sulla sua reale estensione (fig. 12, e), mentre il bothros (fig. 12, f) è ancora quantomeno rispettato; isolati di edilizia privata a più piani si estendono sia sulle pendici settentrionali palatine (fig. 12, g) che su quelle veliensi orientali (fig. 12, h-i) e recano in facciata serie di botteghe. in questo quadro si collocano anche
del saliente della fontana augustea (m 3,55 in assen-za del rivestimento marmoreo), ricostruibile dai resti marmorei recuperati come una sorta di betilo tripar-tito e mistilineo alto m 16 ca. (mentre un’accurata ri-proposizione architettonica è in preparazione da parte di M. Cante e G. Pardini, una prima ricostruzione è in C. Panella - s. Zeggio, art. cit., 2004 [a n. 1], 74-75).
68 la distanza lineare fra i centri delle due strut-ture non raggiunge i m 5.
69 Per questa ipotesi e per la volontà di augusto di riconnettersi e confrontarsi con «il fondatore» romo-lo, volontà evidente nelle realizzazioni monumentali sia del Germalo che di quest’area, vd. s. Zeggio, Roma, Valle del Colosseo, cit. (a n. 1), 274-276. se l’ipotesi di una Meta precedente all’augustea coglie nel vero, il va-lore di questa presenza resta inalterato, pur nella diffe-
rente temperie storica oggi purtroppo non definibile, sia che la fondazione si collochi alla metà del i secolo a.C., sia che, in funzione dell’uso della tecnica cementi-zia, essa possa retrodatarsi al massimo al ii secolo a.C.
70 il pozzo è realizzato sovrapponendo a secco blocchi di peperino cubici (lato cm 60 ca.), forati al centro (Ø foro cm 52 ca.) e rivestiti all’interno di un sottile strato di fine cocciopesto bianco, ora conserva-to solo a tratti.
71 tagliata dalla ristrutturazione di età augustea, questa vaschetta doveva essere in origine anch’essa quadrata e connessa ad una vera oggi perduta tramite un grosso bordo in cocciopesto a corona circolare e sezione convessa, un frammento del quale è stato rin-venuto sulla superficie della sigillatura del pozzo (vd. oltre, n. 83).
84 s. Zeggio Sc. Ant.
il pozzo (fig. 12, l) e l’ipotetica Meta «originaria» (fig. 12, m), due strutture la cui realizzazione solo in questa fase ed il cui reale significato non sono ancora del tutto chiari, ma che colpiscono anche per un altro particolare: come già si era evidenziato nella fase precedente per il venerando bothros, l’ampiezza degli assi stradali fa sì che anch’essi ricadano all’interno della carreggiata, obbligandola ad una serie di irregolarità e restringimenti che certo non sono casuali e che da un lato fanno propendere per l’antichità dei singoli elementi, dall’altro sottolineano con l’inamo-vibilità la loro importanza «dalle origini», quali che esse fossero o venissero ritenute.
Colpisce la fittezza delle evidenze a vario titolo monumentali, e in senso lato sacrali, che costellano una zona tutto sommato molto limitata dell’area in esame. in questa fase tale den-sità risalta immediatamente e rende chiari almeno alcuni dei motivi della scelta augustea, che farà di questo breve tratto di 60 metri scarsi di strada e dei suoi lati uno dei fulcri della nuova organizzazione cittadina ed uno dei punti della memoria storica di roma e della propaganda personale del rifondatore della città e dello stato. Ma questo ruolo di punto di addensamento di memorie ha inizio in una fase ben precedente e tutto induce a credere che già nella prima metà
Fig. 12. – valle dell’anfiteatro e pendici nord-orientali del Palatino. schema planimetrico ricostruttivo della zoniz-zazione funzionale dell’area intorno al 30 a.C. nei due toni di rosso la viabilità, nei due toni di verde i luoghi sacri
sicuri o ipotetici, in blu i monumenti di incerta funzione, in grigio le aree di edilizia privata.
13, 2006 Dall’indagine alla città 85
del ii secolo a.C., in connessione col riassetto che prevede l’ampliamento e la lastricatura degli assi viari, esso assuma il volto «definitivo», che attualmente siamo in grado di leggere solo alla metà del i secolo a.C. e che augusto riallestirà in forme più monumentali e coerenti. in questo senso anche l’ultimo elemento della ristrutturazione augustea non ancora considerato, ossia il sacello verosimilmente compitale che si addossa alla fontana, è forse già esistente in età tardo-repubblicana (fig. 12, n)72.
il quartiere assume il carattere definitivo della sua prima grande fase di vita, una vita dura-ta almeno 7 secoli, fra i principati di augusto e Claudio; poi, con l’incendio del 64 d.C., tutto sarà distrutto ed il volto dell’area muterà radicalmente. Ma paradossalmente proprio l’incendio è stata la nostra grande fortuna. il progetto neroniano prevedendo l’innalzamento del piano di calpestio delle aree più depresse, onde permettere lo sviluppo di plessi edilizi ampi e regolari, ha consentito una conservazione eccezionale delle strutture sottostanti, tanto che buona parte del quartiere giulio-claudio, pur danneggiata e situata fra i quattro ed i sei metri di profondità rispetto all’odierna piazza del Colosseo, risulterebbe ancora frequentabile, con i diversi edifici chiaramente riconoscibili. il racconto sintetico di quanto accade in una zona tanto estesa ed in un panorama tanto complesso e ben conservato non è facile, tanto che, a differenza di quanto fatto sinora, per queste ultime fasi la descrizione procederà più per settori che per classi di evidenze73.
l’età auguStea
l’età augustea è una fase di profondo rinnovamento, che a diversi livelli coinvolge infra-strutture, edilizia privata, monumenti ed edifici pubblici dell’area in esame, dando loro l’im-pianto generale che conserveranno sino alla repentina distruzione del 64 d.C. l’area antistante le pendici veliensi orientali è interessata da notevoli ristrutturazioni in ambedue i blocchi edilizi siti ad ovest della via diretta all’esquilino; contemporaneità, conformità tecnica e complemen-tarietà funzionale delle evidenze ci assicurano che essi sono ora parte di un unico complesso edilizio, articolato su almeno due piani e con diversi orientamenti, in parte ancora vincolati
72 una preesistenza del compitum era già stata ipotizzata da C. Panella (C. Panella - s. Zeggio, art. cit., 2004 [a n. 1], 84) a parziale giustificazione del-la collocazione del basamento, topograficamente del tutto incongrua: come vedremo nella ristrutturazione augustea dell’area esso si addossa alla fontana a sud-est, creando un’ulteriore strozzatura proprio nel luo-go dove l’incrocio dovrebbe aprirsi per agevolare il transito. anche considerando le soluzioni adottate in concomitanza delle altre preesistenze è molto difficile credere che questo punto sia stato scelto per un’edifi-cazione ex novo.
73 relativamente a queste fasi l’esposizione qui presentata è necessariamente sintetica e non esaustiva. se per i recenti rinvenimenti sulle pendici nord-orien-
tali si rimanda ancora una volta al contributo di v. Carbonara in questo stesso volume, per l’area del san-tuario un’analisi puntuale è in C. Panella (a cura di), Meta sudans I, cit. (a n. 1) e nel successivo M. Cante - s. Panciera - C. Panella - s. Zeggio, art. cit., 1994-95 (a n. 1). Per l’antistante complesso monumentale Meta Sudans-compitum un’analisi preliminare è in C. Pa-nella - s. Zeggio, art. cit., 2004 (a n. 1) ed in s. Zeggio, Roma, Valle del Colosseo, cit. (a n. 1), mentre per le altre aree dello scavo della Meta Sudans l’edizione de-finitiva è in preparazione. si ricorda che per analoghi motivi di complessità i numeri riportati sulle plani-metrie composite potranno d’ora in poi rappresentare non solo la singola presenza, ma anche un gruppo di evidenze strettamente collegate fra loro.
86 s. Zeggio Sc. Ant.
dalle preesistenze. nella porzione settentrionale del complesso i due vani del fronte-strada vengono delimitati da un nuovo muro, di cui rimane solo la fondazione cementizia (fig. 13, 1). il vano settentrionale ospita probabilmente una piccola fullonica; tre piccole vasche rettangola-ri contigue (fig. 13, 2)74 si appoggiano al setto in opera incerta che ancora divide i due ambienti e scaricano direttamente nel condotto sottostante (fig. 13, 3), preesistente ma la cui copertura è ora totalmente rifatta appunto per accogliere i fori di deflusso75. nel vano meridionale è
Fig. 13. – valle dell’anfiteatro e pendici nord-orientali del Palatino. Planimetria delle evidenze al passaggio fra i secolo a.C. e i d.C. in verde le fognature in fase, in rosso le altre strutture in fase, in grigio le evidenze riutilizzate.
74 Questo allestimento è radicalmente asportato dalle modifiche di età claudia e ne rimane solo il mas-setto fondale delle vasche, larghe grosso modo cm 90 e lunghe m 1,50 ca., separate da muretti spessi cm 20 ca., e dalla profondità non ricostruibile.
75 Dei tre fori (Ø cm 20 ca.), tangenti al muro di fondo, due erano realizzati con un’unica lastra di tra-vertino preformata, mentre nel terzo si conservava, pur collassato sul fondo del collettore, il tubo di scarico, formato da due colli di anfore adriatiche del tipo Dres-
sel 6a incastrati l’uno nell’altro, uno dei quali reca un bollo (già rinvenuto a roma: CIL, 15, 3358) relativo al produttore P. Quinctius Scapula, che in età augustea smercia vino (appunto in anfore Dressel 6a) e olio (in anfore Dressel 6b) soprattutto in Cisalpina e in veneto (vd. in proposito: s. Pesavento Mattioli, Anfore: pro-blemi e prospettive di ricerca, in G.P. brogiolo - G. ol-cese [a cura di], Produzione ceramica in area padana tra il II secolo a.C. e il VII secolo d.C.: nuovi dati e prospet-tive di ricerca, Atti del Convegno internazionale di De-
13, 2006 Dall’indagine alla città 87
invece installata una vasca bassa ed ampia di forma non ricostruibile (fig. 13, 4), delimitata da un muretto in laterizio rinforzato all’esterno da una massicciata cementizia, che fungeva da gradino per facilitare l’accesso76; anche in questo caso la copertura della sottostante fognatura (fig. 13, 5) è rifatta per accogliere lo scarico della vasca. la disposizione delle diverse vasche sembra ostare all’apertura dei due vani verso la strada, facendo di essi piuttosto degli ambienti di servizio di un’ampia domus, la cui parte padronale doveva svilupparsi al piano superiore.
restauri e ricostruzioni di edifici e fognature in tutto questo tratto devono aver neces-sariamente provocato un rifacimento almeno parziale della sede stradale del tracciato diretto all’esquilino, di cui però non rimane traccia, a causa del massiccio reintervento di età claudia. senza modifiche sembra invece continuare a funzionare il collettore principale di fondovalle diretto a sud verso l’area del Circo Massimo.
nella zona retrostante agli ambienti appena descritti il carattere di settore di servizio di una ricca domus si fa più evidente77. sulla radicale rasatura delle antiche strutture repubblica-ne s’impianta ora un sistema di vani, incentrato su un corridoio, che perpetua l’orientamento obliquo delle murature preesistenti e le sfrutta in parte quali fondazioni, e del cui pavimento rimane solo un battuto di terra (fig. 13, 6). l’individuazione di un pilastro laterizio, dei resti di una soglia e di un terminale di setto anch’esso laterizio (fig. 13, 7) fa solo intuire che il corridoio stesso si apre a sud-ovest su una stanza, mentre a sud-est sbocca in un’area ancor più bassa, forse una corte scoperta, cui tende anche il fognolo con copertura in cappellaccio del periodo precedente, ora fortemente restaurato (fig. 13, 8). sul lato opposto, invece, la situazione è più chiara: un nuovo muro laterizio (fig. 13, 9) limita ad ovest i vani del fronte-strada su descritti e nell’ambiente angolare che si forma fra esso ed il corridoio è installata con tutta probabilità una cucina. lo spesso massetto pavimentale cementizio (fig. 13, 10), realizzato a quota maggiore rispetto al piano del corridoio ed accessibile da questo tramite pochi e piccoli gradini oggi pres-soché perduti, permette di ricavare al disotto dell’ipotetica cucina un basso magazzino-cantina interrato, anch’esso praticabile dal corridoio. al nuovo muro laterizio si addossa un muretto (fig. 13, 11) costruito nella medesima tecnica, alto poco più di un metro e che verso la porta d’ingresso si amplia a triangolo, nascondendo al suo interno un contenitore metallico, di cui rimangono l’incasso circolare del fondo ed una grappa d’ancoraggio alla parete della stanza. sembra di poter riconoscere in questo muretto, radicalmente rasato nella fase seguente, quel che resta di un bancone di cucina, mentre nel suo terminale triangolare l’alloggiamento per un serbatoio d’acqua78.
senzano del Garda [8-10 aprile 1999], Mantova 2000, 107-120 [in part. 111]; C. Panella - v. Morizio [a cura di], Corpus dei bolli sulle anfore romane, I. I bolli sulle anfore italiche, roma c.d.s., nrr. 1834, 2020-2025); nei colli era ancora inserito un puntale del medesimo tipo d’anfora, funzionante in origine da tappo dello scarico. il condotto è anche rialzato ed in parte ampliato, evi-dentemente per far fronte all’aumentato flusso idrico.
76 una soluzione simile, che farebbe di questa vasca l’elemento di un balneum, è documentata più volte nelle terme private dell’area campana (e. Fab-
bricotti, I bagni nelle prime ville romane, in Cron. Pompeiane 2, 1976, 41, 60-61).
77 Questa zona mostra livello di calpestio più basso di circa un metro rispetto ai vani del fronte-strada e per effetto della risalita della pendice veliense doveva risultare in origine seminterrata.
78 il vano qui sommariamente descritto è raffigu-rato in C. Panella, art. cit., 1990 (a n. 1), 45, figg. 12-13. la piccola rampa di scale d’accesso al vano è in primo piano in fig. 13, mentre l’alloggiamento murario con incasso circolare da cui dovrebbe essere stato asportato
88 s. Zeggio Sc. Ant.
Poco più a sud anche la zona dei corridoi voltati seminterrati della tarda età repubblicana subisce modifiche e tutto fa credere che appartenga ora al medesimo complesso privato. Pur non essendosi individuati ulteriori muri di limite, lo spazio antistante ai due anditi, prima pa-vimentato in cocciopesto grossolano e forse scoperto, dev’essere ora trasformato in ambiente chiuso, probabilmente una latrina. il nuovo pavimento in opera spicata (fig. 13, 12) nasconde il passaggio di una fistula, poi spoliata ma in origine alloggiata in un’apposita canaletta ricavata nel massetto; il percorso di essa conduce nei pressi di un pozzetto a pianta quadrata con cana-letta di scolo, in cui dovrebbe identificarsi la latrina vera e propria (fig. 13, 13)79.
sulle pendici palatine nord-orientali la domus radicalmente ricostruita nella fase prece-dente sembra continuare a vivere senza restauri o modifiche apprezzabili, mentre sul lato op-posto della via che sale al Foro viene costruito un nuovo fabbricato, il cui allineamento coinci-de però precisamente con il limite settentrionale dell’area di scavo, cosicché le fondazioni della sua fronte risultano visibili solo in sezione (fig. 13, 14). Ciononostante alcuni indizi, come la lunga estensione lineare80 e la profondità delle fondazioni cementizie a cavo libero, fanno sup-porre che si tratti di un edificio di notevoli dimensioni, forse dotato, data la presenza in esse di rinforzi in blocchi riadoperati di tufo e cappellaccio, di un ampio ingresso o di un portico in facciata. il nuovo corpo edilizio è anche fornito di due condotti fognari quasi paralleli, diretti a sud-est verso il collettore di fondovalle e totalmente restaurati nelle fasi successive81, e se verso ovest pare proseguire senza soluzione di continuità, verso est sembra arrestarsi proprio nei pressi del luogo occupato dal pozzo in blocchi di peperino. su quello che verrebbe dunque ad essere l’angolo sud-orientale dell’edificio, subito alle spalle del pozzo, è ora documentata una fondazione cementizia di spessore limitato, una sorta di massetto (fig. 13, 15) rifinito da una lastra di marmo bianco verosimilmente lunense, che farebbe pensare alla presenza di un piccolo monumento, del quale nulla si può dire e che assume però ulteriore interesse alla luce di quanto accade in questa fase proprio al pozzo (fig. 13, 16). Quest’ultimo è ora sigillato con un complesso rito, che prevede dapprima lo scarico in esso di terreno argilloso, di un angolo di blocco e di altri frammenti più piccoli di tufo litoide, e poi di altro terreno argilloso; quindi la deposizione di un piccolo coperchio in ceramica comune con presa a pomello, circondato da tre astragali ovini e da due assi bronzei tardo-repubblicani con prora e testa bifronte di Giano; seguono poi alcuni strati di ceneri e carboni ed infine uno spesso strato di scorie82. la
il recipiente metallico è ben visibile in fig. 12, fra i due muri indicati con la lettera b; i resti radicalmente rasati del bancone addossato al muro di fondo sono infine leggibili sul lato sinistro della fig. 12. Pur in assenza del forno d’alimentazione, l’impronta del serbatoio, il co-spicuo numero di fognoli e le tracce di fistulae, oltre alla vasca già descritta, fanno ritenere che già in questa fase, come accadrà in scala maggiore nella fase successiva, la casa accolga una piccola terma ad uso privato.
79 il pozzetto (speco di lato cm 40 ca., prof. cm 65 ca.) risulta realizzato in cementizio foderato su tre lati e sul fondo in grosse tegole; il quarto lato è aperto e da esso si diparte obliquamente il canalicolo di scolo, conservato per brevissimo tratto. tracce di un incasso
sul bordo superiore del pozzetto dovrebbero essere pertinenti alla seduta, evidentemente lignea.
80 il tratto di fondazioni individuato è lungo m 17 ca.
81 Dati gli scarsi resti di età augustea, queste due fognature non risultano visibili nella pianta composita di questa fase a fig. 13 (per una loro localizzazione cfr. figg. 15, 14 e 18, 16).
82 Come già accennato non si è potuto ancora svuotare il pozzo e ciò fa sì che anche su questo parti-colare rituale vi siano notevoli incertezze. non è sicuro che gli strati attualmente raggiunti, praticamente sterili di reperti, siano altra cosa da quelli di sigillatura; non è ancora possibile definire con precisione il tipo sia del
13, 2006 Dall’indagine alla città 89
vera è asportata e tutto è coperto da uno strato di macerie83, la vasca circostante è tagliata per l’installazione di lastroni di peperino che circondano l’imboccatura del pozzo e dovevano in origine anche coprirla84. la presenza su uno di questi lastroni di due incassi quadrati uniti da una sottile guida a canaletto indiziano l’esistenza di una recinzione quadrangolare a pilastrini e transenne, che delimita l’area del pozzo obliterato. non è chiaro se alla medesima sistemazione appartenga anche una fistula plumbea che, allettata sotto ai lastroni parallelamente all’ipotetico monumentino, fra questo ed il pozzo, sembra seguirne l’angolo curvando verso nord-est.
È evidente che una tale mole di lavori obbliga, come del resto vedremo più ad est, al rifa-cimento della sede stradale, tracce del quale rimangono lungo tutta l’area di scavo delle pendici palatine, relativamente alle preparazioni sia del basolato (fig. 13, 17), che dei marciapiedi (fig. 13, 18-19)85. in questa operazione l’antico bothros viene scoperchiato e coperto dalla prepara-zione del marciapiede settentrionale (cfr. fig. 13, 18), ma asportazioni posteriori impediscono di capire se, com’è verosimile e come accade per il pozzo, esso venga recinto o comunque se-gnalato e preservato86. ugualmente si rende necessario in questo tratto un adeguamento della rete fognante, sia attraverso il restauro del preesistente condotto che serve il fronte della domus tardo-repubblicana (fig. 13, 20), sia attraverso la costruzione di una nuova fognatura (fig. 13, 21-22), che probabilmente si aggiunge a quella di fondovalle ancora funzionante, operando sempre sotto la sede viaria, ma a quota superiore87. l’importanza di questo condotto per le aumentate necessità di smaltimento idrico della zona è attestata dalle dimensioni notevoli del suo speco88 e dall’accuratezza della sua eccezionale fattura, realizzata interamente di blocchi e lastroni di travertino accostati a secco ed impermeabilizzati all’esterno da una «scatola» ce-mentizia a sezione rettangolare. Questa tecnica particolare sembra indiziare anche un maggior carico sopportato dalla via sovrastante, che ben si concilia con l’aumentato traffico cittadino e con le contemporanee realizzazioni monumentali augustee in tutta l’area centrale dell’urbe, con la necessità di movimentazione di carichi eccezionali89.
Di quanto accade in questa fase al santuario delle ipotetiche Curiae Veteres ed alla zona ad esso antistante a nord si è detto varie volte e i dati verranno qui solo riepilogati90. il luogo di culto palatino riceve una nuova pavimentazione in lastre di travertino (fig. 13, 23) che, articola-ta in una platea inferiore, quattro bassi gradini ed una platea superiore, risale da est verso ovest adeguando l’area interna all’altimetria della pendice. nel punto di contatto fra platea inferiore e primo gradino, nel 7 a.C. i suonatori di fiati erigono una statua a tiberio Cesare (fig. 13, 24),
coperchio che dei due reperti numismatici, ugualmente avviati al restauro; non è chiaro se i livelli di ceneri e carboni siano il residuo di una pira accesa direttamente nel pozzo, come potrebbero far pensare alcune macchie sulle pareti di esso; non è chiara infine la natura delle scorie, forse ceramiche, attualmente in corso di analisi.
83 in questo strato si è rinvenuto un frammen-to di bordo in cocciopesto di connessione fra vasca e vera.
84 le lastre di copertura risultano asportate dalla ristrutturazione di età claudia.
85 i lastricati dell’uno e degli altri sono invece
quasi totalmente asportati dalle ripavimentazioni suc-cessive.
86 Per questa attenzione augustea alle preesisten-ze a vario titolo sacrali vd. anche oltre, n. 93.
87 ruolo analogo ha già dalla fase precedente il condotto sottostante la Meta Sudans, di cui fra breve si dirà (vd. in proposito n. 64).
88 lo speco, a sezione rettangolare, si mostra alto cm 160 e largo cm 60.
89 vd. in tal senso il contributo di v. Carbonara in questo volume.
90 Per la bibliografia specifica vd. n. 73.
90 s. Zeggio Sc. Ant.
mentre già nel 12 a.C. ne era stata eretta una ad augusto, ora ricollocata in un punto non di-stante ma non più definibile91. nella parete settentrionale del recinto santuariale sono aperte due porte, connesse da ballatoi alla via prospiciente, e questo intervento manda in disuso il piccolo fognolo del displuvio del recinto stesso92, evidentemente connesso ad un discendente ora non più esistente. sul pavimento del ballatoio occidentale (fig. 13, 25) un disegno bicromo «marca» ora probabilmente il sito dell’antico deposito votivo, accidentalmente rinvenuto du-rante i lavori di apertura della porta93. il recinto è soprelevato in laterizio (fig. 13, 26-28) e nel tratto più occidentale (cfr. fig. 13, 28) una scala lignea addossata ad esso e le tracce di uno stipite nella soprelevazione fanno supporre un piccolo edificio a due piani, probabilmente di servizio, appoggiato al lato interno del recinto stesso94.
sul lato opposto della via che sale al Foro è ora costruito il significativo complesso monu-mentale, comprensivo della fontana detta Meta Sudans (fig. 13, 29) e del piccolo sacello proba-bilmente compitale ad essa addossato a sud-est (fig. 13, 30). nonostante i radicali restauri, della
91 le date sono chiaramente deducibili dalle ri-spettive epigrafi dedicatorie, l’una incisa sulla base bronzea della statua di tiberio e l’altra riscritta ed ap-plicata in età claudia all’angolo occidentale del lungo bancone edificato a sostenere molteplici statue della gens Augusta. Per queste epigrafi e per le complesse vicende ad esse collegate vd. v. Morizio, La base in bronzo con dedica a Tiberio, in C. Panella (a cura di), Meta sudans I, cit. (a n. 1), 115-131; ead., Le dediche ad Augusto e ai Giulio-Claudi, ibid., 201-216.
92 vd. n. 63.93 vari elementi mi hanno sempre indotto a cre-
dere che il deposito, indiziato esclusivamente da grandi quantità di reperti di età tardo-arcaica e medio-repub-blicana ributtati soprattutto nella stratigrafia neronia-na di obliterazione del santuario stesso, si trovasse (ed in parte tuttora si trovi) proprio a ridosso della recin-zione: i materiali votivi si sono rinvenuti unicamente nell’area settentrionale del santuario e particolarmente nei pressi della fondazione neroniana che attraversa la porta occidentale; erano ancora inglobati nell’origina-rio terreno di deposizione, in pile e gruppi di pezzi, così da non far ritenere possibile una loro sensibile traslazione; la soglia della porta occidentale aperta con augusto nella recinzione dell’area sacra è l’unica por-zione di pavimentazione del santuario realizzata in pe-perino e non in travertino e reca appunto questa sorta di «marca» (quadrato nero di peperino, cornice bianca di travertino, ben visibile in C. Panella, Un’area sacra, cit. [a n. 48], 49, fig. 42); al disotto della soglia è stato possibile intravedere resti di murature in cappellaccio, apparentemente indipendenti dalla recinzione tardo-arcaica. a tutto ciò vanno aggiunte altre due particola-rità: proprio nei pressi della porta viene ora aperta una strana fossa quadrangolare, subito colmata da terreno
sterile, a meno di un canalicolo verticale posto quasi al centro (sul fondo del quale erano pochi frammenti di ceramica a pareti sottili), e sigillata con i resti della malta di un tetto in coppi evidentemente smantellato; nelle coeve preparazioni stradali sono stati recuperati alcuni oggetti di età medio-repubblicana, fra cui un vasetto miniaturistico imitante un cratere, alcuni fram-menti di statuette fittili, un triens della serie librale con prora e testa elmata di Minerva ed una semuncia del-la serie semilibrale con prora e testa di Mercurio con petaso. appare dunque assai probabile che nell’aprire l’ingresso occidentale le maestranze augustee siano incappate negli strati superficiali del deposito votivo, disperdendone nelle immediate vicinanze qualche og-getto. Proprio in espiazione del sacrilegio si sarebbe subito realizzata la fossetta, che il canalicolo centrale fa ritenere una sorta di bothros, e nel completare il re-stauro si sarebbe inserito nella pavimentazione il sema bicromo, ad evitare ulteriori involontarie violazioni del deposito. tutta la problematica è più specificata-mente analizzata nell’ambito della tesi di specializ-zazione di chi scrive, «Monete di età repubblicana e proto-imperiale dai recenti scavi nell’area della Meta sudans in Roma» (università «la sapienza», i scuola di specializzazione in archeologia, Cattedra di nu-mismatica Greca e romana, a.a. 2004/2005), in prepa-razione per l’edizione.
94 la parete in blocchi, soprelevata in laterizio e rivestita da uno spesso intonaco bianco che reca chia-re tracce dell’asportazione della scala lignea (e su cui restano fra l’altro numerosi graffiti inneggianti e raf-figuranti il gladiatore Marcus, eseguiti tra la fine del i secolo a.C. ed il 64 d.C.), è raffigurata in C. Panella, art. cit., 1990 (a n. 1), 43, fig. 8, e nel prospetto in C. Panella, Un’area sacra, cit. (a n. 48), 33, fig. 18.
13, 2006 Dall’indagine alla città 91
struttura originale rimangono vari elementi: il lato orientale e forse parte del settentrionale del podio del sacello95; il tamburo basale del saliente centrale della fontana con la relativa fonda-zione; parte della fondazione della vasca, che riutilizza fra l’altro la fondazione del preesistente monumento circolare; parte del fondo in cocciopesto della vasca stessa; infine tre dei grandi blocchi in travertino che componevano l’alto bordo della fontana. Due di essi sono ancora in situ sull’angolo nord-ovest, mentre il terzo è stato rinvenuto riadoperato come sigillo del tom-bino (fig. 13, 31) che augusto aggiunge ora alla preesistente fogna, onde assicurare lo scarico della fontana, e che Claudio invece oblitererà. Di grande interesse è il bassorilievo di questo blocco, pur danneggiato, coronato in alto da un leggero kyma ionico96. Come già indiziato dal tratto più a monte, la via diretta al Foro è ora contestualmente rifatta; di essa restano ampi tratti delle preparazioni (fig. 13, 32-34) ed alcuni resti del basolato (fig. 13, 35)97 e dei marciapiedi in peperino (fig. 13, 36).
le attività edilizie sin qui analizzate appaiono in linea di massima tutte collegate. esse risultano quindi coeve e si dimostrano parte di un disegno più generale98 che tende a «riassorbi-re» le preesistenze e le eventuali anomalie topografico-monumentali, integrandole con le nuo-ve realizzazioni in un insieme più coerente. È evidente l’aderenza di questo progetto alle linee guida di radicale rinnovamento nella formale salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni che improntano la politica augustea. in specifico non può sfuggire, e più volte è stata ricordata99, la stretta connessione fra ristrutturazione delle vie e dell’incrocio100, edificazione o riedificazione della Meta Sudans e del probabile compitum ad essa legato e riorganizzazione dello spatium urbis. Quest’ultima, come ricordato dalle fonti101 e come ricavabile dal calcolo delle ere vicani-
95 vd. però oltre, nn. 97 e 121.96 nel soggetto raffigurato nel rilievo, attual-
mente in corso di studio, sembrerebbe potersi rico-noscere un occhio raffigurato di profilo, volto alla sinistra di chi guarda, con iride circolare ed orbita irregolarmente triangolare. sarebbe forse precipi-toso, ma suggestivo per la collocazione proprio su un monumento come la Meta Sudans già così carico di simboli, identificare questo soggetto con l’occhio apotropaico, che già a partire dall’età arcaica è spesso raffigurato sulle prue di navi da guerra subito sotto all’acrostolio e dietro al rostro. la prora rostrata è infatti uno degli elementi simbolico/decorativi più cari al repertorio figurativo della propaganda au-gustea, spesso commisto a simboli religiosi al fine di sottolineare il nesso fra religio e legittimità della vittoria (vd. in questo senso P. Zanker, Augusto e il Potere delle Immagini [trad. it. di augustus und die Macht der Bilder, München 1987], torino 1989, 88-91 e 135) e raffigurato con frequenza anche in emissioni monetali, a partire dalla vittoria su sesto Pompeo e poi più diffusamente dopo azio. risulta assai interessante in questo senso un tipo di denario (29-27 a.C. ca., da zecca incerta, romana o brindisina;
vd.: C.H.v. sutherland - r.a.G. Carson, The Roman Imperial Coinage, i, london 19842, 265a; H. Mattin-gly, Coins of the Roman Empire in the British Mu-seum, i, oxford 19762, 625; H. Cohen, Description historique des monnaies frappées sous l’Empire Ro-main, communément appelées Médailles Impériales, Paris 1880-18922, 119) con prua rostrata sostenente timone ed ancora incrociati alla base di un trofeo, al-cuni esemplari del quale (ringrazio G. Pardini per la segnalazione) recano sulla prora un occhio di forma assai simile al nostro.
97 un ampio tratto di basolato è anche conser-vato al disotto del sacello compitale, che su di esso si appoggia, apparentemente senza fondazioni pro-prie.
98 sfuggono ovviamente a questa logica i rialle-stimenti interni delle case private, conseguenza diretta degli interessi specifici dei proprietari.
99 vd. da ultimo C. Panella, in C. Panella - s. Zeggio, art. cit., 2004 (a n. 1), 83, con bibliografia pre-cedente.
100 o meglio forse degli incroci, come si vedrà fra breve.
101 Cass. Dio., 55, 8, 5-7; suet., Aug., 30, 1.
92 s. Zeggio Sc. Ant.
che102, prende corpo fra 12 e 7 a.C.103 con la suddivisione della città in 14 circoscrizioni ammi-nistrative e con la rivitalizzazione all’interno di esse del sistema vicanico e del connesso culto compitale, profondamente riformato ed integrato a quello del Genius Augusti104.
È dunque al lasso di tempo fra il 12 a.C. e la fine del secolo che dobbiamo attribuire la trasformazione del quartiere, che vede nella Meta Sudans il suo punto generatore topografico e simbolico105 e che assume ora una fisionomia molto simile a quella definitiva. Gli assi viari già noti mantengono in linea di massima gli allineamenti della fase precedente. tranne che nel tratto settentrionale della via per l’esquilino (fig. 14, a) aumenta però lo spazio riservato ai marciapiedi106, a scapito della sede stradale: sul tratto meridionale dello stesso asse (fig. 14, b) essi dovrebbero ora raggiungere i m 4 ciascuno107, mentre lungo il tracciato che sale verso l’area forense sono larghi m 2 (fig. 14, c). Come sempre più complessa è la situazione nei pressi dell’incrocio fra i due assi (fig. 14, d): il marciapiede meridionale continua regolarmente, men-tre quello opposto manca in corrispondenza del complesso monumentale di nuova realizza-zione ed i basoli costeggiano i bordi della Meta Sudans (fig. 14, e) e dell’ipotetico compitum (fig. 14, f), che sporgono nella sede stradale. un’area pedonale di dimensioni non definibili è però necessariamente ipotizzabile subito a nord del monumento (fig. 14, g), al fine di colli-mare i diversi allineamenti che su di esso vengono ad incontrarsi. Più ad ovest lungo lo stesso lato della strada il pozzo è monumentalizzato da un recinto (fig. 14, h), che forse sporge an-cora leggermente nella carreggiata, ma che per effetto dell’avanzamento del marciapiede crea un’anomalia assai minore che nel passato108. Dietro al pozzo è ora probabilmente realizzato un piccolo monumento con pavimento marmoreo (fig. 14, i), del quale nulla è possibile dire, se non che prevede forse un allestimento idraulico, che in qualche modo lo collegherebbe dunque alla medesima sfera ideale. non lontano una soluzione analoga a quella vista per il pozzo è supponibile, pur in assenza di evidenze, per l’antico bothros (fig. 14, l).
102 sulle «ere anomale» di alcuni vici, che per-mettono di arretrare al 12 a.C., anno in cui augusto assume il pontificato massimo, l’inizio della riforma tradizionalmente datata al 7 a.C., vd. a. Fraschetti, Roma e il principe, bari 1990, 265-268.
103 e non sarà un caso che proprio a queste due date si riferiscono le prime statue della famiglia im-periale che troviamo ospitate nell’area del santuario (vd. n. 91).
104 un’approfondita analisi di questa complessa riforma e delle sue cause è in a. Fraschetti, op. cit. (a n. 102), 204-273. sul fondamentale ruolo svolto dal culto compitale per la diffusione dei temi figu-rativi della propaganda augustea anche presso i ceti inferiori della popolazione urbana vd. t. Hölscher, Monumenti statali e pubblico, roma 1994, 161-164. si pensi in questo senso alle visibilità e leggibilità dell’insieme monumentale Meta-compitum (vd. an-che n. 96).
105 non è possibile qui riprendere il tema delle molteplici valenze sottese al monumento, contem-
poraneamente punto d’incontro di almeno quattro regiones, betilo apollineo a guardia della vicina casa natale d’augusto e forse anche segnacolo di ben più antiche memorie dell’urbe (vd. n. 69); in proposito si rimanda a C. Panella - s. Zeggio, art. cit., 2004 (a n. 1), 75, 80-85 ed a s. Zeggio, Roma, Valle del Colosseo, cit. (a n. 1), 276.
106 Dalle evidenze residue essi sembrano ora rea-lizzati quasi esclusivamente in lastroni di peperino, tranne forse qualche breve tratto in travertino.
107 Come già accennato la datazione della strada pre-incendio del 64 d.C., rinvenuta in più punti sul finire del XiX secolo sull’asse dell’attuale via di s. Gregorio, è generica. vd. n. 60, cui si rimanda an-che per la soluzione ancora incerta dell’area orientale dell’incrocio.
108 l’impatto proposto in blu in fig. 14, h è rico-struito supponendo per il recinto una forma quadrata, con l’angolo nord-ovest in corrispondenza dell’ango-lo del lastrone superstite ed incentrato sul centro del pozzo.
13, 2006 Dall’indagine alla città 93
sul lato opposto della via per il Foro il santuario all’angolo della pendice palatina (fig. 14, m) continua la sua esistenza; permangono i dubbi circa la sua reale estensione (fig. 14, n), ma è certo che è ora radicalmente restaurato ed inizia a mostrare quel legame speciale con la gens Augusta che tanto lo caratterizzerà in seguito109. relativamente invece alle aree di edilizia privata, la domus tardo-repubblicana delle pendici palatine (fig. 14, o) non mostra grandi alte-razioni, mentre i due nuclei sviluppatisi sulle pendici veliensi orientali sono ora pesantemente modificati e con tutta probabilità fanno parte di un’unica ricca casa (fig. 14, p), dotata di servizi al piano terreno e settore residenziale al piano nobile. È stato ipoteticamente attribuito a questa classe di evidenze anche il fabbricato che nasce ora sulla pendice meridionale della velia, subito alle spalle del bothros e del pozzo (fig. 14, q), ma in realtà non vi sono indicazioni riguardo alla sua funzione e la sua collocazione sul limite di scavo ci impedirà di saperne di più. relativa-mente a questa zona va infine notato un altro elemento interessante per la topografia generale
109 a questo proposito vd. oltre, n. 159.
Fig. 14. – valle dell’anfiteatro e pendici nord-orientali del Palatino. schema planimetrico ricostruttivo della zoniz-zazione funzionale dell’area intorno al 7 a.C. nei due toni di rosso la viabilità, nei due toni di verde i luoghi sacri
sicuri o ipotetici, in blu i monumenti, in grigio le aree di edilizia privata.
94 s. Zeggio Sc. Ant.
del quartiere. vari indizi110 rendono ora ipotizzabile in questo punto lo sbocco di una traversa (fig. 14, r) alla strada che sale al Foro, che per la morfologia della pendice collinare doveva correre più in alto rispetto alla via esquilino-Circo Massimo, ad una quota compatibile con gli ingressi al piano residenziale della casa su descritta111.
Dall’età tiberiana al principato Di clauDio
successivamente a questa fase augustea di globale riorganizzazione degli spazi urbani, una serie di modifiche e rifacimenti interessa l’area in un periodo che va dal principato di tiberio ai primi anni di quello di Claudio. Durante questo lasso di tempo gli interventi si distribuiscono in modo alquanto articolato e senza che per alcuni di essi sia possibile raggiungere una data-zione precisa.
un primo momento di attività, collocabile forse ancora negli ultimi anni del principato d’augusto, è limitato e tutto interno alla domus delle pendici palatine112. in primo luogo il set-tore prospiciente la via che sale verso il Foro vede un generale riassetto. Mentre la bottega più occidentale sembra l’unica non interessata dalle attività, viene restaurata la copertura del tratto di fogna che serve quella centrale, davanti alla porta della quale è aggiunto anche un pozzetto (fig. 15, 1) nel punto di raccordo fra la fogna stessa ed il collettore che serve il fronte-strada del-la domus113. la taberna è quindi pavimentata in spicato verso la via (fig. 15, 2) ed in cocciopesto sul retro (fig. 15, 3), sottintendendo una divisione fra la zona destinata alla clientela e quella del personale, forse in origine marcata da un sottile bancone con cresta rifinita da lastre di ar-desia decorate da alcune crustae geometriche in marmi policromi114. Contestualmente cambia l’attività intrapresa nel locale, come attesta la drastica riduzione di apprestamenti idraulici, ora limitati ad un’unica vasca nel retrobottega, presso la parete orientale del vano. anche la taber-na orientale è notevolmente modificata. nel retro viene inserito un breve setto in reticolato con testata in blocchi di travertino (fig. 15, 4), ortogonale al lungo muro che delimita la parte residenziale della casa e poco distante dalla parete occidentale. si viene così a creare uno stretto
110 i principali indizi sono rappresentati dalla già notata interruzione delle fondazioni del fronte dell’edi-ficio appena citato, dalla compresenza del recinto del pozzo e del retrostante «monumentino» non identifi-cabile, che certo avranno necessitato di una pur limitata area di rispetto, e da una particolarità della spoliazione di età post-antica. infatti il cunicolo di ruberia est-ovest, che procede lungo l’allineamento stradale asportando quasi completamente il marciapiede, impedito dal pro-seguire ad est dalla presenza di una fondazione nero-niana, anziché arrestarsi o riaffiorare in superficie, con-serva la medesima quota di fondo e curva bruscamente verso nord proprio in corrispondenza del pozzo.
111 Considerando le quote conservate del piano sovrastante le due gallerie voltate parallele, confinanti con l’ambiente ora allestito a latrina, per il tratto più
prossimo all’incrocio è ricostruibile per questa strada (certo forse più antica, ma solo ora ipotizzabile) una quota di m 19,00/19,30 s.l.m., in effetti compatibile con quella di m 19,70 rilevabile sul pavimento mar-moreo del «monumentino».
112 Per un’analisi di queste modifiche vd. il contri-buto di v. Carbonara in questo volume.
113 l’inserzione di questo pozzetto è certamen-te connessa alla ristrutturazione che interessa il piano superiore della casa, come vedremo, e dovrebbe aver comportato una riduzione del vano-porta della taber-na al solo tratto ad ovest di esso, oggi però non più documentabile.
114 Due frammenti di una lastra sono stati rin-venuti nello strato di macerie bruciate che oblitera il pavimento in età claudia.
13, 2006 Dall’indagine alla città 95
pozzo di luce scoperto, pavimentato in opera spicata e dotato al centro di pozzetto (fig. 15, 5), che ha anche lo scopo di smaltire le acque del compluvio dei tetti circostanti; un nuovo tratto di fognatura scavato nelle murature preesistenti lo collega infatti al condotto della bottega confinante, servendo contemporaneamente una vasca rettangolare ora allestita all’angolo sud-occidentale della taberna (fig. 15, 6)115. anche in questo caso si nota una differenza fra l’area riservata ai clienti, pavimentata in opera spicata (fig. 15, 7), e quella per il personale, dove la fitta compresenza di toppe pavimentali di tecnica diversa (fig. 15, 8) fa fede di una notevole usura, probabilmente connessa al tipo di attività artigianale svolta. Come nella bottega contigua le due parti erano forse separate da un piccolo bancone116. anche nel settore residenziale della casa assistiamo a diverse modifiche. la parte orientale del corridoio posto lungo il limite setten-
115 Di questa vasca rimangono il fondo in coc-ciopesto, assai rovinato, e la tubatura di scarico in colli d’anfora, che sbocca nel fognolo su descritto.
116 Questa ipotesi è basata sulla presenza di una piccola trincea di asportazione, larga cm 25 ca., proprio al limite meridionale della parte pavimentata in spicato.
Fig. 15. – valle dell’anfiteatro e pendici nord-orientali del Palatino. Planimetria delle evidenze di età tiberiano-gaiana. in verde le evidenze databili 10-20 d.C., in rosso quelle riferibili al 30 d.C. ca., in blu quelle riferibili al 40
d.C. ca., in grigio quelle riutilizzate.
96 s. Zeggio Sc. Ant.
trionale di esso è ristretta da uno spesso muro (fig. 15, 9), atto a sostenere una scala d’accesso al piano superiore117, mentre il lato meridionale del corridoio stesso è totalmente ridisegnato da una lunga fondazione cementizia, su cui dovevano insistere le testate in travertino di una serie di setti in opera reticolata, uno solo dei quali (fig. 15, 10) individuato in scavo. tutti gli ambienti venutisi a creare con questa ristrutturazione sono riccamente pavimentati: in minuto mosaico bianco bordato di nero il vano a sud-est del corridoio (fig. 15, 11), in sectilia marmorei la stanza a sud-ovest (fig. 15, 12) ed il corridoio stesso (fig. 15, 13)118.
un secondo momento di più estese ristrutturazioni può essere collocato intorno al 30 d.C. lungo l’asse valle-Foro esso vede il restauro della più occidentale delle fognature del fab-bricato posto alle pendici meridionali della velia (fig. 15, 14) e, probabilmente, il rifacimento della copertura di un tratto del collettore tardo-repubblicano che, più a valle, serve la Meta Sudans (fig. 15, 15)119. Contestualmente tutto il tracciato è ripavimentato, come attestano vari lembi di preparazione (fig. 15, 16-21) ed alcuni basoli (fig. 15, 22) rimasti in situ davanti alla do-mus delle pendici palatine, mentre perduti risultano i marciapiedi, che a tratti riutilizzano però quelli di età augustea. a questo stesso momento costruttivo è con tutta probabilità attribuibile il rifacimento del sacello compitale addossato all’angolo sud-orientale della fontana detta Meta Sudans. Questa operazione prevede dapprima lo smantellamento pressoché totale del podio augusteo, quindi la deposizione di un dolio (fig. 15, 23) al disotto del punto di tangenza fra bordo meridionale della fontana e lato occidentale del probabile compitum120. segue il riposi-zionamento dei blocchi di tufo dei lati sud ed ovest121 e la colmatura del basamento con terra
117 addossandosi al setto preesistente, questo muro è privo della facciavista settentrionale, mentre quella meridionale, in opera reticolata, è dotata di una nicchia a scarsella, forse per l’installazione di un arma-dio a muro o di una scaffalatura. all’aggiunta di questa scala ed alla conseguente ristrutturazione del primo pia-no della domus dev’essere connessa anche l’edificazione del breve setto con pilastro in travertino visto in prece-denza, quale rinforzo di un punto di particolare carico.
118 Di ambedue le pavimentazioni mancano le crustae litiche, ma rimangono le preparazioni cemen-tizie con alcune impronte.
119 il breve tratto di struttura cementizia, indi-viduato proprio sul limite di saggio, non si è potuto indagare e non si è quindi sicuri che si tratti di un re-stauro fognario di età tiberiana. Quest’ipotesi è però supportata dalla posizione della struttura e dalla stra-tigrafia da essa tagliata.
120 la sacralità del piccolo monumento potreb-be riceve un’ulteriore conferma dalla posa in opera di questo dolio, privato della parte superiore (dall’orlo alla spalla), interrato ed incastrato al disotto dell’angolo nord-occidentale del podio; è infatti ampiamente docu-mentato come sostituzioni o ristrutturazioni di monu-menti a vario titolo considerati sacri necessitassero di cerimonie e di conseguenti offerte di ridedicazione o rei-naugurazione. in questo caso il dolio, sfortunatamente
interessato dal passaggio di un cunicolo di spoliazione che ci ha privato dell’eventuale contenuto, era stato al-loggiato in una buca rivestita di poca terra argillosa, che forse non a caso conservava fra gli scarsissimi materiali anche una moneta bronzea, purtroppo illeggibile.
121 Come accennato in precedenza è anche pos-sibile che tutto il podio sia stato smontato e riposi-zionato, ma vari indizi fanno propendere per la prima ipotesi. se è vero che anche i lati nord ed est sono privi di fondazione propria e poggiano sul basolato augu-steo, le commessure fra i blocchi del lato orientale (l’altro è oggi quasi perduto) sono assai più regolari e l’adesione ai basoli è assicurata da un sottile strato di malta, che manca nei due lati certamente riposizionati; il lato occidentale poggia addirittura senza alcuna pre-parazione sulla terra della trincea d’asportazione della sua redazione originale. i blocchi degli stessi due lati sud ed ovest, infine, mostrano con chiarezza tracce di rilavorazione e di esser stati rivoltati, recando all’in-terno del basamento la faccia in origine posta all’ester-no. Questo dato è dimostrato, ad es., dalla presenza su uno dei blocchi meridionali di un incasso rettangolare lungo e stretto, recante in origine una tabula o una decorazione più spessa inserita nel più sottile rivesti-mento marmoreo del podio (indiziato a sua volta dai fori da grappa, ora anch’essi posti sul lato interno), ma anche da tracce sparse di bruciatura.
13, 2006 Dall’indagine alla città 97
argillosa mista a fitte scaglie di travertino e ben compattata (fig. 15, 24)122; al lato occidentale è quindi addossata una scala in travertino di tre gradini (fig. 15, 25) e con il medesimo materiale è verosimilmente lastricato il pavimento del podio123.
negli stessi anni anche l’area gravitante sul tratto più settentrionale della via diretta all’esquilino subisce notevoli modifiche. sul lato della strada volto verso la valle labicana, opposto rispetto alla vasta casa che abbiamo visto svilupparsi dalla tarda età repubblicana124, è per la prima volta documentabile una situazione di certo ben più antica, ma di cui si ha solo ora testimonianza archeologica: dall’asse esquilino-Circo Massimo si diparte ortogonalmente ver-so est una via, della quale risultano visibili all’interno del saggio di scavo solo alcuni basoli (fig. 15, 26), ma che almeno sino alla conduzione della ferrovia metropolitana termini-e42 (oggi eur) doveva essere in realtà ben più conservato (fig. 16, 10)125. Poco a sud di essi, nell’isolato che fronteggia la grande domus, si trovano i resti di un piancito in lastroni di travertino disposti
122 la scarsità quantitativa di questo strato ed in generale di tutta la stratigrafia in connessione, e ancor più quella dei reperti all’interno di essa, non rendono possibile affinare aldilà di una generica «epoca giulio-claudia» la cronologia di questo rifacimento (ringrazio per l’informazione a. santelli, che sta affrontando lo studio di questi reperti nell’ambito della sua tesi di laurea, Storia ed economia, cit. [a n. 29]), avvenuto co-munque non oltre l’età gaiana. la presenza di bruciatu-re sul lato originariamente esterno dei blocchi del basa-mento, appena ricordata, potrebbe però indirettamente rappresentare un elemento a favore per la datazione dell’intervento al 30 d.C. ca. nel 27, infatti, un incendio «più violento del solito» devasta tutta l’area del Celio (tac., Ann., 64; suet., Tib., 48), obbligando tiberio ad intervenire pesantemente con le sue casse private (tanto da voler rinominare augusto il monte stesso) e dando verosimilmente adito ad un esteso riassetto topografico della collina (in questi termini C. Pavolini [a cura di], Caput africae I. Indagini archeologiche a Piazza Ce-limontana [1984-1988]. La storia, lo scavo, l’ambiente, roma 1993, 33; vd. anche a.M. Colini, Storia e topo-grafia del Celio nell’antichità [Mem. Pont. Acc. 7], Cit-tà del vaticano 1944, 411-412). in quest’ambito è ben possibile che, seguendo i tracciati viari che provengono dal colle (cfr. figg. 16, 24 e 29; 17, g-h), il rogo abbia raggiunto l’incrocio, arrivando a lambire da sud-est il compitum e la fontana ed obbligando conseguentemen-te ad un ripristino quantomeno del sacello.
123 l’unica lastra superstite, rinvenuta all’angolo sud-occidentale del podio, sarà però piuttosto da at-tribuire, come vedremo, al restauro di età claudia po-steriore all’incendio del 50 d.C. ca.
124 il saggio qui localizzato è stato condotto nel periodo 1986-89 da D. Cirone.
125 Questo tracciato sembra anche più ampio del-
la strada nord-sud da cui prende avvio; un tratto largo m 5,10 e più prossimo al Colosseo ne fu infatti con tutta probabilità rinvenuto nel 1939, durante gli sterri per la realizzazione appunto della metropolitana (G. schingo, Gli sterri del 1939 per la costruzione della me-tropolitana, dati archeologici inediti dalla valle del Co-losseo, in Bull. Com. 102, 2001, 129-146 [in part. 133, fig. 5 e 143, fig. 11, nr. 10]; per un refuso la descrizione di questo rinvenimento è riportata al nr. 24 [ibid., 139] e viceversa). Come per gli altri rinvenimenti dell’area in esame non frutto di scavo stratigrafico, la cronologia di questo tratto stradale risulta generica e nonostante le approssimative concordanze di collocazione e di quota non si può esser del tutto certi che risalga all’età tibe-riana. in questo senso tutti i ritrovamenti degli sterri del 1939 sicuramente riconoscibili come precedenti all’incendio neroniano, insieme con le strutture coe-sistenti portate alla luce in varie occasioni e con quelle individuate nei nostri scavi, sono evidenziati (rispetti-vamente in rosso, in blu ed in nero) nella planimetria complessiva di fig. 16. Questa è stata elaborata da chi scrive, integrando la cartografia di base (dis. e. brien-za) con la pianta di fase ante 64 d.C. delle aree di scavo (dis. s. Zeggio), con la mappatura generale della valle presentata alla fig. 147 di G. schingo, Indice topografi-co delle strutture anteriori all’incendio del 64 d.C. rin-venute nella valle del Colosseo e nelle sue adiacenze, in C. Panella (a cura di), Meta sudans I, cit. (a n. 1), 145-158 e con la Carta archeologica dei rinvenimenti nel cantiere della metropolitana (G. schingo, art. cit., 2001, 133, fig. 5); di quest’ultima si conserva per chia-rezza la numerazione. Proprio per le suddette incer-tezze di cronologia, tutte le evidenze non attribui bili almeno in ipotesi all’età tiberiano-gaiana saranno trat-tate successivamente, in connessione con l’ultima fase edilizia precedente l’incendio del 64 d.C.
98 s. Zeggio Sc. Ant.
parallelamente alla via est-ovest (fig. 15, 27). le condizioni di scavo non hanno purtroppo per-messo di stabilire con assoluta certezza l’appartenenza di questa struttura alla fase tiberiana126, né di ricostruirne le dimensioni complessive, che in origine dovevano essere comunque note-voli, ed anche la sua primitiva funzione non è definibile con sicurezza. in età claudia questo lastricato rappresenterà infatti il pavimento di un cortile colonnato interno ad un caseggiato, ma in questo momento, se ad esso appartiene un piccolo tratto di preparazione cementizia individuato poco più a nord (fig. 15, 28), come tutto fa credere, mostra di raggiungere senza soluzioni di continuità la via est-ovest e fors’anche di estendersi verso est (fig. 16, 11); che si
126 Come vedremo questo pavimento subisce un approssimativo restauro in età gaiana e su di esso si fondano alcune strutture di età claudia; in assenza di interventi intermedi è stato dunque attribuito alla diffusa attività edilizia tiberiana della zona. la pez-
zatura delle lastre risulta tuttavia del tutto simile (cm 110 x 75 x 15 ca. in media) a quella dei travertini uti-lizzati nella platea del santuario palatino, adombran-do anche per questa pavimentazione una cronologia augustea.
Fig. 16. – valle dell’anfiteatro e pendici nord-orientali del Palatino. Planimetria complessiva delle evidenze in uso al momento dell’incendio del 64 d.C. in nero i rinvenimenti dei cantieri di scavo della Meta Sudans e delle pendici
nord-orientali del Palatino, in rosso quelli del cantiere della metropolitana, in blu quelli occasionali.
13, 2006 Dall’indagine alla città 99
tratti di un circoscritto slargo quadrangolare posto all’incrocio della via esquilino-Circo Mas-simo con l’asse diretto ad est è ipotesi all’atto non comprovabile127.
sempre negli anni intorno al 30 d.C. anche l’isolato sul lato opposto della via è interessato da una notevole ristrutturazione. È abbattuto il muro che, con infinite alterazioni, divideva dalla tarda età repubblicana i due vani del fronte-strada, tutte le infrastrutture idrauliche sono rase al suolo, il livello di calpestio è innalzato e la più settentrionale delle due fognature dirette al collettore di fondovalle è eliminata, mentre quest’ultimo continua regolarmente a funziona-re. al posto dei due ambienti se ne ricostruisce uno solo, che riutilizza il muro augusteo di li-mite verso la strada ed ospita al centro, appoggiata al muro stesso, una bassa vasca pavimentata in spicato (fig. 15, 29)128; in funzione dello scarico di quest’ultima viene modificata la copertura della più meridionale delle due fognature su ricordate. la zona a sud della vasca (fig. 15, 30), ma forse in origine tutto il resto della stanza, è pavimentata in laterizi posti di piatto ed un’area limitata doveva sostenere un braciere o un fornello mobile129. all’esterno, intanto, come gli
127 la porzione di lastricato rinvenuta in scavo (raffigurata in C. Panella, art. cit., 1990 [a n. 1], 51, fig. 18) misura m 3,30 x 1,70 ca., ma in senso nord-sud raggiunge m 9,50 considerando i diversi rattoppi ce-mentizi ed il suddetto tratto di preparazione (cfr. fig. 15, 28). È inoltre probabile che un lacerto di questa stessa pavimentazione sia stato individuato più a sud-est (cfr. fig. 16, 11) da G. Gatti durante gli sterri della metropolitana, profondamente dimidiato dal passag-gio di una fondazione neroniana (G. schingo, art. cit., 2001 [a n. 125], 137, nr. 11; nonostante la chiara in-dicazione cronologica il rinvenimento compare nella pianta generale [ibid., 133, fig. 5] subito a sud della fondazione neroniana nr. 8, ma non in quella selettiva della fase ante 64 d.C. [ibid., 143, fig. 11]). se questa ipotesi risponde al vero (sarà in questo senso da verifi-care l’uguaglianza proposta da schingo fra gli appunti del Gatti datati 7 e 11 luglio, che censiscono rispetti-vamente «lastre di marmo» e «blocchi di travertino», ma vd. anche oltre, n. 144) e se, come sembra, il pavi-mento raggiunge in questa prima fase i basolati delle due strade, si potrebbe ipotizzare in corrispondenza dell’incrocio un’area lastricata quasi quadrata (m 12 n-s x 15 e-W ca., ossia 40 x 50 piedi romani), ripro-posta in fig. 17, f. non sfuggirà in proposito l’anoma-la collocazione del tratto orientale della via est-ovest, apparentemente troppo spostata verso sud e forse do-vuta ad un inesatto posizionamento del rinvenimen-to nella planimetria di G. Gatti (sulle imprecisioni di questa pianta, ricomposta a posteriori, vd. del resto G. schingo, art. cit., 2001 [a n. 125], 131).
128 Questa vasca, larga 2 metri (in senso nord-sud) e lunga almeno altrettanto, risulta limitata sui tre lati su-perstiti da un bordo basso e largo (h. cm 20 ca.) in terra e malta compresse e rivestite di cocciopesto, in origine
addossato ad est alla parete della stanza e sugli altri lati forse ad un più alto bordo in muratura oggi perduto.
129 Della pavimentazione, assai mal conservata, rimangono bessali e tegole. Due di queste ultime, non distanti dalla vasca, risultano crepate dal fuoco, anneri-te secondo una traccia a settore circolare e separate dal resto da una fila di mattoncini da spicato posti longi-tudinalmente, facendo supporre la realizzazione di un riquadro nel pavimento, dedicato appunto all’alloggia-mento di un braciere o fornello. la presenza su una del-le due tegole, quindi su un laterizio in apparente primo uso ed in un contesto strutturale databile attorno al 30 d.C. (cronologia cui riportano come accennato gli strati preparatori delle vie e dell’ambiente stesso), di un bollo rettangolare (CIL, 15, 2234) riferibile alle figlinae tu-scolane di C. Asinius Pollio potrebbe riaprire la contro-versa questione della cronologia di questa produzione laterizia. all’originaria identificazione di H. Dressel di questo personaggio col console del 23 d.C., F. Coarelli preferì infatti quella col console del 40 a.C., anticipan-do così la produzione alla prima età augustea. su tutta la questione vd. M. steinby, I senatori e l’industria late-rizia, in aa.vv., Epigrafia e ordine senatorio, Atti del Colloquio internazionale (Roma, 14-20 maggio 1981) (Tituli 4-5), 1, roma 1982, 227-237 (in part. 236-237); b.M. Malquori, Bolli laterizi dall’area della Meta su-dans in Roma, in aa.vv., Epigrafia della produzione e della distribuzione, Actes de la VIIe Rencontre franco-italienne sur l’épigraphie du monde romain (Rome, 5-6 juin 1992), roma 1994, 335-360 (in part. 342, 352-353 e 359, fig. 18). in questa fase la funzione della stanza non è immediatamente comprensibile; per continuità rispetto al passato ed in connessione con quanto vedre-mo accadere nella zona retrostante si potrebbe suppor-re per essa un uso termale o forse come cucina.
100 s. Zeggio Sc. Ant.
altri dell’area in esame, anche l’asse stradale esquilino-Circo Massimo è nuovamente basolato, riceve marciapiedi di travertino (fig. 15, 31) e in questa fase risulta largo m 4,50 ca.130.
le modifiche apportate alla zona retrostante sono altrettanto radicali di quelle appena descritte per il settore prospiciente la via, ma a causa di alcune difficoltà logistiche dell’indagine risultano più difficilmente databili o, per meglio dire la loro situazione si presta a due inter-pretazioni cronologiche, fra le quali non è possibile scegliere. in questo senso, e per marcare la differenza, tutte le operazioni di questa zona sono state riferite ad un momento più tardo, databile attorno al 40 d.C.131, ma in realtà esse iniziano forse contestualmente a quelle del fronte-strada, in un generale riassetto della porzione settentrionale della domus. la prima atti-vità riscontrabile è anche qui un’eliminazione quasi totale delle strutture augustee: l’ambiente soprelevato in cui si è riconosciuta una cucina è privato di bancone e pavimento, lo scantinato sottostante è quasi totalmente colmato di terreno132, l’ambiente a sud del corridoio è privato della parete orientale, delle soglie e del pilastro angolare di nord-est, divenendo un tutt’uno con gli spazi contigui133. Dopo queste operazioni è realizzata una piccola struttura laterizia «multifunzionale» (fig. 15, 32) che, sfruttando ed ampliando quel che rimaneva della scaletta di collegamento con la cucina, serve contemporaneamente: a sigillare (ad ovest) il passaggio per lo scantinato ormai obliterato, ad aggiungere (a sud) un pozzetto di scarico e di conseguenza un breve tratto di copertura in tegole al fognolo tardo-repubblicano diretto a sud-est, a so-stenere (a nord) e a rendere raggiungibile con una scaletta (ad est) l’imboccatura di un forno (fig. 15, 33) di seguito realizzato nell’ambiente soprelevato usato in precedenza come cucina. la struttura di questo forno è composita: tratti di cerchio, formati da blocchi riutilizzati di cappellaccio affiancati per testa, sono congiunti fra loro e connessi alle pareti dell’ambiente da cunei di argilla cotta dall’uso134; su questo anello, aperto a sud in corrispondenza della bocca del forno, è montata la volta, anch’essa in argilla sostenuta da nervature di bessali135; la camera
130 alcuni resti di questa via, rinvenuti nel sag-gio perimetrato dall’ambiente 16 del sistema strutti-vo neroniano, sono raffigurati in C. Panella, art. cit., 1990 (a n. 1), 58, fig. 22; 62, fig. 25 (in questa imma-gine giace su di essi un residuo di stratigrafia dell’in-cendio del 64 d.C.). Dei 15 piedi romani (appunto m 4,50 ca.) della sua totale larghezza, 9 (m 2,70 ca.) sono occupati dalla sede viaria basolata e 3 per parte dai marciapiedi. secondo Chevallier (r. Chevallier, Les voies romaines, Paris 1972, 96) è questa la dimen-sione di una strada urbana di media importanza; va tuttavia notato che, confrontando i diversi rinveni-menti e le ampiezze della rete stradale da essi rico-struibili (cfr. fig. 17), questo segmento sembrerebbe il più angusto dell’area in esame, dato in apparente contrasto con l’importanza del percorso esquilino-Circo Massimo.
131 vd. oltre, n. 137.132 la colmatura avviene con terra argillosa
dal notevole tasso di cenere e carboni, che in par-te caratterizza anche i livelli di obliterazione degli
ambienti del fronte-strada e che potrebbe provenire da un incendio. Considerato lo stato dei resti strut-turali della fase augustea, questo non sembra però aver colpito direttamente la casa; è dunque possibile che si tratti di terre di risulta portate forse dal vicino Celio, colpito nel 27 d.C. da un terribile rogo (vd. n. 122). anche questo dato mi spinge a credere che la ristrutturazione di tutta la parte nord della casa quanto meno inizi contemporaneamente, negli anni prossimi al 30 d.C.
133 Con l’unificazione della piccola stanza origi-naria, della parte terminale del corridoio e di una parte almeno dell’area probabilmente scoperta ad est di essi, si dev’essere creato un unico grande ambiente, chiuso evidentemente ad est da un nuovo muro oggi perduto.
134 o forse da mattoni crudi, che lo stato di con-servazione non ha permesso di riconoscere.
135 la volta risulta leggermente ribassata e assai più spessa alle reni ed almeno una delle nervature si aggancia alla parete dell’ambiente tramite un incasso in quest’ultima.
13, 2006 Dall’indagine alla città 101
di cottura così ottenuta136 è infine pavimentata in sesquipedali137, mentre l’area circostante il forno è ammattonata in modo approssimativo138. Come vediamo accadere a Pompei139 questo forno è anch’esso polifunzionale: non serve infatti ai soli usi di cucina, ma soprattutto a pro-durre aria ed acqua calde per gli ambienti termali ospitati al piano superiore della casa. Di essi rimane indiretta testimonianza nel crollo che a breve coinvolgerà anche il forno e l’area anti-stante, causato come vedremo da un incendio databile fra 50 e 53 d.C., che ci restituisce i resti di un ambiente dotato di intercapedini ed ipocausto, nonché di vasca nella zona settentrionale direttamente soprastante il forno140.
Grazie ad una testimonianza epigrafica si data invece con precisione al 42141 la ristruttura-zione attestata nell’area sacra delle pendici palatine: appena salito al trono Claudio «riordina» le statue via via dedicate alla gens Augusta dal collegium degli aenatores romani, che trovano ora accoglienza in un’edicola (fig. 15, 34) delimitata da due muri laterizi a forbice desinenti in altrettante colonne di travertino stuccato e coperta da tetto in coppi ad unico spiovente142, sorrette da un’unica base a bancone appoggiata al recinto del santuario143.
136 il risultato è un vano a calotta sferica di m 2,60 ca. di diametro e di m 1,65 ca. di altezza, mentre le dimensioni globali esterne sono di m 3,10 di diame-tro e di m 2 ca. di altezza.
137 Dei 15 mattoni rinvenuti (quelli perimetrali sono ritagliati a curva per essere inseriti in un apposito incasso del cerchio di blocchi e argilla) ben 13 risul-tano bollati: 12 recano stessa bollatura di Saturninus, servus di Domitius Afer, mentre uno è marcato da Sabinus, vicarius di Nereius. Mentre la cronologia dei primi (Novum, CIL, 15 s., 266/985) si colloca grosso modo fra 25 e 59 d.C., anni in cui rispettivamente Cn. Domitius Afer Nemausensis ricoprì la pretura e morì, quella del secondo (CIL, 15 s., 370) si situerebbe nel periodo 37-42, avendo H. bloch riconosciuto in Nere-ius un servus di Caligola (su tutta la questione vd. b.M. Malquori, art. cit., 1994 [a n. 129], 341; 346-348; 352-353; 355, fig. 7; 357, fig. 12, con ulteriore bibliografia). È proprio la datazione fornita da tali bolli a collocare dunque l’intervento costruttivo in questa zona nella domus intorno al 40 d.C., ma rimane il dubbio che la pavimentazione, ed in particolare la parte di essa dove si trova il marchio di Sabinus, rappresenti un restauro reso necessario dall’uso continuato del forno.
138 se ne è individuato solo un limitato spazio a sud-est, irregolarmente pavimentato con pezzame di laterizi su un sottile letto di malta.
139 non è possibile in questa sede analizzare pun-tualmente confronti e corrispondenze con le analoghe installazioni della città vesuviana, riferite di solito ad un momento leggermente posteriore (età claudia o neroniana) rispetto a questa in esame. a mero titolo di esempio si ricordano quelle della Casa del Cente-nario (e. salza Prina ricotti, Cucine e quartieri servili
in epoca romana, in Rend. Pont. Acc. 51-52, 1978-80, 237-294 [in part. 265, fig. 28]) e della Casa del Menan-dro (a. de vos - M. de vos, Pompei. Ercolano. Stabia, roma-bari 1982, 92-93, con ulteriore bibliografia).
140 Dovrebbe trattarsi in realtà di due vani, rispet-tivamente sovrastanti la stanza con forno e l’ambien-te contiguo a sud, ambedue dotati di solaio di grosse travature lignee, di doppio pavimento di sesquipedali su pilae di bessali (evidenti nella foto in C. Panella, art. cit., 1990 [a n. 1], 60, fig. 24), di rivestimento pa-vimentale in mosaico bianco e di intonaco parietale pure bianco; solo per la stanza sovrastante il forno sono anche attestate tracce dell’intercapedine (tegulae mammatae con resti dell’inchiodatura alla parete) e di una vasca (frammenti di bordo in cocciopesto). l’aria doveva raggiungere l’ipocausto tramite sfiatatoi verti-cali aperti nella cupola d’argilla, mentre più complessa risulta la risalita dell’acqua calda, che forse sfruttava un sistema a vaso d’espansione e la cui produzione pare attestata dal mantenimento in uso del bancone augusteo con inglobato il recipiente metallico.
141 Questa è la data ricavabile dalla titolatura di una statua di Claudio ora posta in opera nel santuario (vd. anche n. 143).
142 le macerie di questa tettoia, ristrutturata come vedremo agli inizi del principato di nerone e distrutta nel 64 d.C., sono state ritrovate ai piedi dell’edicola stessa e testimoniano un’intelaiatura lignea coperta da uno strato di malta in cui sono allettati i coppi, alcuni dei quali sono per maggior tenuta anche inchiodati al legno da chiodi passanti.
143 Questa prima fase dell’edicola è raffigurata in C. Panella, Un’area sacra, cit. (a n. 48), fig. 62; M. Can-te - s. Panciera - C. Panella - s. Zeggio, art. cit, 1994-95
102 s. Zeggio Sc. Ant.
le ultime evidenze attribuibili a questa fase nell’area in esame attestano l’uso continuato delle strutture sin qui analizzate. in una data non precisabile il lastricato in travertino posto di fronte alla casa delle pendici veliensi orientali necessita di un restauro (fig. 15, 35), del quale rimane però solo la preparazione144. ugualmente di restauri abbisogna il locale antistante al forno della casa stessa attorno al 50 d.C., tanto che l’incendio coglie i lavori in atto, come at-testano l’assenza di pavimento ed il fognolo tardo-repubblicano parzialmente scoperchiato e con le lastre appoggiate a fianco.
Pur nel sostanziale rispetto della maglia urbanistica riordinata da augusto i dati in nostro possesso permettono dunque di individuare nel quartiere, alla vigilia dell’incendio che di lì a breve lo danneggerà seriamente, alcuni elementi di novità. riguardo alla viabilità non vi sono dati nuovi relativamente all’ampia arteria proveniente dal Circo Massino (fig. 17, a), né alla stra-da che abbiamo ipotizzato percorrere a mezza costa la pendice orientale della velia (fig. 17, b)145 ed anche l’asse valle-Foro (fig. 17, c), benché ripavimentato, non sembra subire alterazioni di sorta; leggermente ristretto risulta invece il tracciato diretto all’esquilino (fig. 17, d)146, dal quale si dipartono ora verso est tre vie. Proprio sull’incrocio la strada più settentrionale (fig. 17, e), servita peraltro da una fognatura che sarà certo sboccata nell’antico collettore di fondovalle ancora perfettamente funzionante, è forse costeggiata a sud da un limitato piazzale quadrango-lare (fig. 17, f), oltre il quale piega leggermente a sud147. la strada mediana (fig. 17, g), anch’essa servita da un condotto fognario, si diparte invece dalla via per l’esquilino poco oltre la Meta Sudans e segue un tracciato antico lungo le pendici settentrionali del Celio, oggi in parte rical-cato dalla via dei ss. Quattro, terminale intramuraneo della via Tusculana148. la terza arteria
(a n. 1), figg. 13-14. le statue ora presenti sono relative ad augusto (con titolatura del 12 a.C.), Claudio (con ti-tolatura del 42) e ad un terzo personaggio ignoto, men-tre sarà stata contestualmente eliminata quella certo a suo tempo dedicata a Caligola (vd. in proposito v. Mo-rizio, Le dediche ad Augusto, cit. [a n. 91], 202-204).
144 l’intervento, sicuramente relativo ad un ri-pristino di alcune lastre di cui rimane solo l’impron-ta sul massetto preparatorio, non è databile che per via stratigrafica, risultando ovviamente posteriore al lastricato originario, ma precedente al muro laterizio di età claudia contiguo a sud. un dato interessante è però la presenza nella preparazione, insieme alle con-suete scaglie di travertino, di frequenti scaglie di mar-mo bianco; questo fatto potrebbe far pensare all’uso appunto di marmo per la nuova lastricatura, rendendo più certa la corrispondenza coi su citati rinvenimenti del 7 luglio del 1939 (vd. n. 127).
145 va comunque notato che le quote ricostruibi-li (m 20,00/20,20 s.l.m.) per gli ambienti con ipocau-sto del primo piano della domus, che su questa via si affaccia da est, risultano ancora una volta compatibili con un tracciato che, in lieve pendenza da nord verso sud, s’immette nella strada valle-Foro ad una quota di m 19,00/19,30 s.l.m. (vd. anche n. 111).
146 l’anomalo restringimento, chiaramente do-cumentato dal fatto che il marciapiede copre il basola-to precedente (cfr. C. Panella, art. cit., 1990 [a n. 1], 62, fig. 25), avviene a scapito della fascia orientale, mentre il limite verso la velia resta inalterato.
147 ampiezza ed inclinazione della via sono state riprese dal rilievo ricostruito del breve tratto rinvenuto negli sterri per la metropolitana (vd. n. 125). il cambio di rotta del tracciato è necessario per conciliare i diversi orientamenti dei due segmenti, l’uno certo perché indivi-duato in scavo, l’altro del tutto credibile perché coerente alle murature individuate più a sud (cfr. fig. 16). Come già dubitato dall’autore (G. schingo, art. cit., 2001 [a nn. 125 e 127], 139, nr. 24 - riferito in realtà come detto al nr. 10) e come con maggior evidenza si vedrà per la fase claudia, non vi è invece modo di ritenere valido il posizionamen-to dell’evidenza, che non lascerebbe spazio all’edificio che prenderà il posto dell’ipotizzato piazzale.
148 Già individuata da r. lanciani e P. narducci sullo scorcio del XiX secolo, in occasione della con-duzione del «fognone di s. Gregorio», questa strada, servita da una fogna laterizia coperta a cappuccina, fu di nuovo intercettata e distrutta nel 1939 dal cantiere della metropolitana (vd. in proposito e con bibliografia precedente: G. schingo, art. cit., 1996 [a n. 125], 156 e
13, 2006 Dall’indagine alla città 103
(fig. 17, h) infine, dotata di marciapiedi eccezionalmente larghi e come le altre fornita di col-lettore sottostante, scende dal Celio con orientamento obliquo, puntando dritta sul complesso monumentale Meta-compitum149. anche se solo di alcune delle strade che convergono su questo
fig. 147, r; id., art. cit., 2001 [a n. 125], 137, nr. 10 - ri-ferito in realtà come detto al nr. 24). la sua ampiezza totale è ignota e solo per l’analogia delle dimensioni del marciapiede è stata ipotizzata uguale a quella della via settentrionale. Come sempre la datazione del mantello colpito dall’incendio del 64 non è sicura, ma la tecnica edilizia del condotto e soprattutto la presenza subito sotto alla redazione in travertino e basolato di un’assise di peperino, che come abbiamo visto caratterizza i mar-ciapiedi di età augustea (più che la strada in sé, come in-vece ritenuto da Gatti), farebbe supporre che si tratti di un rifacimento appunto di età tiberiana, probabilmente
connesso ai restauri posteriori all’incendio del 27 d.C. 149 Come la precedente, anche questa stra-
da fu dapprima individuata subito ad est dell’arco di Costantino durante la conduzione della cloaca dell’esquilino e poi di nuovo intercettata dal cavo del-la metropolitana (vd. in proposito e con bibliografia precedente: G. schingo, art. cit., 1996 [a n. 125], 157 e fig. 147, t; id., art. cit., 2001 [a n. 125], 140-141, nr. 29). Delle due redazioni sovrapposte che la contraddistin-guono, ambedue dotate di marciapiedi in travertino, la più bassa è verosimilmente databile nel periodo in esame: abbiamo notato infatti che le pavimentazioni
Fig. 17. – valle dell’anfiteatro e pendici nord-orientali del Palatino. schema planimetrico ricostruttivo della zoniz-zazione funzionale dell’area intorno al 50 d.C. nei due toni di rosso la viabilità, nei due toni di verde i luoghi sacri
sicuri o ipotetici, in blu i monumenti, in grigio le aree di edilizia privata.
104 s. Zeggio Sc. Ant.
incrocio possediamo testimonianze più antiche dell’epoca giulio-claudia, sembra evidente che la strutturazione di esso ora leggibile debba risalire al piano augusteo, che solo parzialmente riesce del resto a regolarizzare le incongruenze di orientamento di tracciati certo già consolidati150.
volgendoci ora ai monumenti pubblici di vario tenore, vediamo come la fontana (fig. 17, i), vero perno del sistema, rimanga in uso nelle forme precedenti, in apparenza non toccata dal rifacimento che investe invece il sacello appoggiato ad essa (fig. 17, l). Più ad ovest, lungo la via che sale verso l’area forense, non sembra mutata neppure la situazione del pozzo ormai sigillato e recinto (fig. 17, m), del retrostante monumentino ignoto (fig. 17, n) e fors’anche del vecchissimo bothros (fig. 17, o), ma per questa fase i dati risultano evanescenti. sempre vivo ed attivo è poi il santuario delle pendici palatine (fig. 17, p), nella permanente incertezza dei suoi confini reali (fig. 17, q) e nel legame sempre più stretto con la famiglia augusta.
sensibili modifiche subiscono invece le case private: sia per quella delle pendici palatine settentrionali (fig. 17, r) che per quella delle pendici veliensi orientali (fig. 17, s) abbiamo ora estese attestazioni dei piani superiori, e nel caso della seconda anche di allestimenti di lussuoso comfort, finanche in lieve anticipo, trattandosi della capitale, sulle città campane. nulla è pos-sibile dire infine dell’indefinibile edificio delle pendici veliensi meridionali (fig. 17, t), se non che il restauro delle fognature ne attesta l’uso continuato.
sulla fine del principato di Claudio un incendio colpisce tutta l’area in esame con conse-guenze seconde solo a quelle del rogo del luglio 64 d.C. l’antico santuario posto all’angolo delle pendici nord-orientali del Palatino è colpito in pieno e necessita di restauri radicali, come testi-moniano lastre fittili151, laterizi bollati152, elementi architettonici in travertino e peperino arsi e frantumati, buoni solo per far da inerte nei cementizi della ricostruzione. le statue della gens Augusta dedicate dagli aenatores romani devono essere ricostruite: quella di tiberio torna alla sua base sulla scalinata (fig. 18, 1)153, mentre le altre, aumentate di numero, trovano posto sul basamento multiplo precedente, allungato ad est154. tutta l’edicola (fig. 18, 2) è del resto modifi-cata in funzione delle aumentate necessità: raggiunge la scala dell’ingresso orientale al santuario
dei marciapiedi di età augustea dell’area sono per soli-to realizzate in peperino, mentre per converso quelle della fase claudia di poco precedente l’incendio del 64 d.C. si caratterizzano per lastroni di travertino di di-mensioni e spessore notevolmente superiore rispetto al passato, come appunto quelli (spess. cm 40 ca.) rile-vati nel rifacimento più alto di questo tracciato.
150 È appena il caso di ricordare ancora una volta, pur senza entrare nella complessa questione, quanto l’incrocio così ricostruibile risponda all’ipotesi formu-lata da Colini (a.M. Colini, op. cit., 1944 [a n. 122], 440) relativamente alla posizione del Compitum Fabricium in relazione con Curiae Veteres e Curiae Novae.
151 i numerosi frammenti, per lo più pertinen-ti a lastre di rivestimento del tipo «Campana», sono analizzati in a. Caravale, Le terrecotte architettoniche riutilizzate nel restauro di Claudio, in C. Panella (a
cura di), Meta sudans I, cit. (a n. 1), 139-144.152 vd. in proposito b.M. Malquori, art. cit.,
1994 (a n. 129).153 non è possibile dar per certo, dato che la
base bronzea della statua riporta l’originaria data-zione al 7 a.C., che questa sia stata rifatta, va notato comunque che il plinto di sostegno in travertino è rivestito di malta rossastra e marmo lunense, elemen-ti caratterizzanti di tutti gli altri interventi di questa fase.
154 le statue presenti in questa fase sono quel-le precedenti di augusto e Claudio (vd. n. 143), con l’aggiunta di quelle di nerone, come vedremo appena salito al trono (con titolatura del 55/56 d.C.) ed in-terposto fra i due, e di sua madre agrippina Minore, moglie di Claudio (vd. in proposito v. Morizio, Le dediche ad Augusto, cit. [a n. 91], 202-204).
13, 2006 Dall’indagine alla città 105
(fig. 18, 3), contestualmente rifatta155, e come la base multipla è rivestita in marmo156. abbiamo ora anche la prima testimonianza archeologica di un edificio templare tetrastilo corinzio, ospitato in cima alla scalinata nell’area sud-occidentale del santuario157. Di questo tempio e della possibi-
155 il rifacimento interessa anche l’accesso oc-cidentale, ma dopo l’incendio del 64 d.C. la scala fu totalmente asportata e sostituita con una rampa di ter-ra battuta, per permettere l’evacuazione dal santuario di tutti gli elementi riutilizzabili (vd. in proposito s. Zeggio, in M. Cante - s. Panciera - C. Panella - s. Zeg-gio, art. cit, 1994-95 [a n. 1], 142-144).
156 in questa seconda fase l’edicola è raffigurata in C. Panella, Un’area sacra, cit. (a n. 48), figg. 61 e 63. il rivestimento pavimentale e quello parietale, che giungeva al livello superiore del basamento delle statue (mentre la parte alta delle pareti conservava l’intonaco bianco delle fasi precedenti) sono in marmo lunense
bianco e raramente grigio, utilizzato anche per le parti non epigrafiche del basamento stesso, tranne che per il piano d’appoggio in bardiglio grigio-azzurrino, forse in accordo col bronzo delle statue.
157 la parte anteriore del tempio è stata rinvenu-ta in stato di crollo a causa del rogo del 64 d.C. (l’area è indicata dal riquadro in fig. 18), fornendo elementi architettonici preziosi per la ricostruzione, per la qua-le vd. M. Cante, Note sulla ricostruzione grafica della facciata dell’edificio restaurato da Claudio, in C. Pa-nella (a cura di), Meta sudans I, cit. (a n. 1), 92-93; M. Cante - s. Panciera - C. Panella - s. Zeggio, art. cit, 1994-95 (a n. 1), 127-135; C. Panella - M. Cante, Area
Fig. 18. – valle dell’anfiteatro e pendici nord-orientali del Palatino. Planimetria delle evidenze di età claudia. in verde le fognature ed in rosso le altre strutture databili 51-56 d.C., in blu le evidenze databili 59-64 d.C., in grigio
quelle riutilizzate. nel riquadro l’area di rinvenimento della fronte del tempio restaurato da Claudio.
106 s. Zeggio Sc. Ant.
lità di riconoscervi il naos delle Curiae Veteres o piuttosto, vista anche la stretta connessione del santuario con la gens Augusta, il sacrarium Augusti voluto da livia sul luogo della casa natale del marito appunto «in curiis veteribus»158, si è più volte parlato, né vi sono novità che permettano di ritornarvi159; piuttosto preme ricordarne l’epigrafe frontonale160, che con ottima approssima-zione autorizza a datare l’incendio, ignoto alle fonti storiche, in un anno compreso fra il 50 ed il 53 d.C.161 ed al massimo al quinquennio successivo162 le attività di ricostruzione nei vari punti dell’area, in accordo con la cronologia dei contesti ceramici rinvenuti.
Di fronte al santuario anche la Meta Sudans ed il compitum devono essere pesantemente restau-rati. la prima è rifatta quasi completamente (fig. 18, 4), dal canale di adduzio ne proveniente da nord163
della Meta sudans (Municipio I). Il tempio restaurato da Claudio, in M.a. tomei (a cura di), op. cit. (a n. 10), 92-95 (schede di G. Pardini).
158 serv., Aen., 8, 361.159 la questione è trattata dapprima in C. Panel-
la, Un’area sacra, cit. (a n. 48), 83-91, quindi in M. Cante - s. Panciera - C. Panella - s. Zeggio, art. cit, 1994-95 (a n. 1), 126 e da ultimo in C. Panella - s. Zeggio, art. cit., 2004 (a n. 1), 81-83, cui si rimanda per la vasta bibliografia connessa. l’ipotesi di riconoscere nel piccolo edificio il sacrarium Augusti trasformato in tempio dopo la divinizzazione di livia, nel 42 d.C., prospettata anche da M. torelli (M. torelli, Curiae Veteres, in Lex. Top. Urbis Romae, 1, 1993, 337) e da s. Panciera (s. Panciera, in M. Cante - s. Panciera - C. Panella - s. Zeggio, art. cit, 1994-95 [a n. 1], 136-137), è stata da ultimo negata da C. Cecamore (C. Cecamore, Palatium. Topografia storica del Palatino tra III sec. a.C. e I sec. d.C. [Bull. Com., suppl. 9], roma 2002, 159-207 [in part. 167-171], che ritiene più probabile possa trattarsi invece delle antiche Curie (ibid., 34, n. 109). Curiosamente però nel contempo (C. Cecamo-re, Le Curiae veteres sulla Forma urbis Marmorea e il pomerio romuleo secondo Tacito, in Röm. Mitt. 109, 2002, 43-58) la medesima studiosa propone per esse una collocazione ben più a sud, non lontano dal sep-tizodio (vd. oltre, n. 241).
160 Di questa epigrafe si sono rinvenuti tre fram-menti, ancora rubricati, analizzati da s. Panciera in s. Panciera, L’iscrizione di Claudio, in C. Panella (a cura di), Meta sudans I, cit. (a n. 1), 133-137; M. Cante - s. Panciera - C. Panella - s. Zeggio, art. cit, 1994-95 (a n. 1), 135-140; s. Panciera, Claudio costruttore de sua pecunia. A proposito di una nuova iscrizione templa-re romana, in Y. burnand et alii (a cura di), Claude de Lyon empereur romain, Actes du Colloque (Paris, Nancy, Lyon 1992), Paris 1998, 137-160.
161 le parti superstiti dell’iscrizione ci permetto-no di sapere che l’edificio, distrutto de incendio, viene riedificato da Claudio mentre questi ricopre il v con-
solato ed una potestà tribunizia superiore alla X, quin-di fra il 25 gennaio 51 (data d’acquisizione della trib. pot. Xi) ed il 13 ottobre 54 (data della sua morte [suet., Claud., 45]). anche supponendo che la costruzione dell’edificio templare sia l’unico intervento portato a termine da Claudio e che il resto dell’area santuariale sia stato restaurato da nerone, non è credibile che l’in-cendio sia avvenuto più tardi del 53. Come accennato questo evento non sembra coincidere con nessuna del-le notizie d’incendio ricordate dalle fonti relativamente a Claudio (analizzate in s. Panciera, art. cit., 1996 [a n. 160], 135-136). recentemente s. Panciera ha proposto di vedervi la conseguenza di un terremoto ricordato fra i prodigi dell’anno 51 (s. Panciera, Un nuovo fram-mento dell’iscrizione di Claudio dallo scavo della Meta sudans e Nota complementare, in id., Epigrafi, Epigra-fia, Epigrafisti, roma 2006, 473-477 [in part. 476-477]; va ammesso però che nelle strutture dell’area non si ri-scontrano danneggiamenti di origine tettonica, mentre assai evidenti sono quelli dovuti alle fiamme.
162 Come si è visto la data fornita dalla titolatura della statua di nerone riporta al 55/56 d.C. ed i re-stauri dovevano essere comunque terminati prima del 59, data la presenza sulla base della statua di agrip-pina, che appunto in quell’anno è uccisa e subisce la damnatio memoriae. Come vedremo, peraltro, in conseguenza di questa la sua effigie nell’edicola sarà epurata (vd. in proposito v. Morizio, Le dediche ad Augusto, cit. [a n. 91], 204-206).
163 secondo un’analisi recentemente effettuata da r. volpe (comunicazione orale in occasione di Proget-to Meta sudans. Indagini e valorizzazione, Giornata di Studio [Roma, 21 giugno 2004]), considerate la capacità della vasca (con un livello idrico attestato di cm 30 ca., doveva contenere 12/13 m3) e la pressione necessaria all’acqua per raggiungere la cima del saliente alto m 16 ca. (parte veniva inoltre deviata alla base, per alimentare zampilli sul margine della vasca, vd. n. 165), la fontana doveva necessariamente essere servita da un ramo di ac-quedotto che, in assenza di un sistema di pompaggio, per
13, 2006 Dall’indagine alla città 107
allo scarico164: sostituito in gran parte e soprelevato il bordo della vasca, ricostruita buona parte del saliente per la sostituzione del sistema idraulico interno, ridisteso il rivestimento interno e ricondotte le fistulae165, mentre vengono riutilizzati gli elementi marmorei non danneggiati166. il restauro del sacello comporta invece la ripavimentazione del podio (fig. 18, 5) ed ovviamente il ripristino degli elementi architettonici ospitati sul basamento, per i quali però la distruzione quasi totale del piccolo monumento operata in età post-antica rende assai complesso ogni ten-tativo di ricostruzione167.
Poco più ad ovest, sul lato opposto della via diretta al Foro, anche la domus tardo-re-pubblicana subisce danneggiamenti. nel settore residenziale questi comportano il rifacimento delle pavimentazioni (fig. 18, 6) e la tamponatura della nicchia a scarsella presente nel muro di sostegno della scala (fig. 18, 7), mentre il contestuale rifacimento di quest’ultima (fig. 18, 8) fa supporre estesi guasti, non più documentabili, anche al piano superiore. nell’antistante settore d’affitto parte degli apprestamenti idraulici va in disuso ed il livello di calpestio è innalzato grazie alle macerie dell’incendio. la taberna centrale perde il muretto divisorio, conserva la piccola vasca sul fondo (fig. 18, 9)168 ed il pavimento è completamente rifatto in cocciopesto (fig. 18, 10); la divisione di quella orientale parrebbe invece rimanere in uso, dato che lo spicato della zona fronte-strada è restaurato (fig. 18, 11) ed il cocciopesto del retrobottega è sostituito (fig. 18, 12). anche le soglie in travertino di tutte le tabernae sono ora elevate di livello e sosti-tuite (fig. 18, 13-15), in conseguenza di quanto accade all’esterno.
le attività fervono infatti anche sull’asse stradale valle-Foro. il piccolo condotto che fuo-riesce dall’isolato edificato sulla pendice veliense è radicalmente ricostruito (fig. 18, 16) e que-sto intervento, oltre a rappresentare l’unico indizio della continuità di vita dell’isolato stesso, è certo connesso ad un più vasto riordino del sistema fognario. nella zona della Meta vari tratti di cementizio (fig. 18, 17-18)169 indicano la presenza di un grande collettore, che come si è detto
la risalita doveva sfruttare un sistema di sifone rovescio e quindi, per un tubo di adduzione posto a m 15,37, do-veva trovarsi oltre m 31-32 s.l.m. Questo fatto fornisce a suo avviso, ad una prima analisi, due ipotesi più plausibi-li: che l’acqua provenisse dal Celio oppure dalla pendice sud-orientale del Colle oppio, da condotte comunque entrambe diramazioni dell’aqua Marcia.
164 in conseguenza dell’eliminazione, come vedre-mo, di un tratto almeno della fognatura tardo-repubbli-cana sottostante la fontana, lo scarico realizzato in età augustea è obliterato ed il tombino è sigillato dal lastro-ne decorato pertinente al bordo originario (vd. n. 96).
165 Mentre le pareti sono rivestite di sottile in-tonaco idraulico bianco, il fondo della vasca è ripavi-mentato in cocciopesto. su di esso rimangono tracce delle grappe in ferro di ancoraggio di una rete di sottili fistulae ed un tratto di tubatura (Ø cm 5 ca.), forse con resti di una diramazione.
166 Fra questi, attualmente in studio da parte di M. Cante e G. Pardini, un elemento di fregio dorico con metope decorate al centro da un fiore di foggia variabi-
le ed una bocca di fontana zoomorfa frammentaria.167 Dai pochi elementi conservati è stato comun-
que possibile proporre una ricostruzione, attualmente in corso di edizione da parte di M. Cante e G. Pardini che ringrazio per le anticipazioni, comprensiva di una transenna perimetrale marmorea e di un’ara centra-le. sui sacelli compitali noti e sulle loro articolazioni architettoniche vd. da ultimo C. Panella - s. Zeggio, art. cit., 2004 (a n. 1), 75-76 e 83-84, con bibliografia precedente.
168 al momento dell’incendio del 64 d.C. questa vasca doveva essere foderata di piombo o contenere un recipiente di quel metallo, rinvenuto in situ fuso dal calore del fuoco.
169 benché lo speco sia del tutto perduto ed i tratti siano fra loro separati, l’appartenenza ad un’unica fognatura è certa; tutti sono infatti del me-desimo cementizio rossastro con frequenti inerti di travertino arso e mostrano superficie superiore piana, posta ad una quota adatta solo all’estradosso di una fognatura.
108 s. Zeggio Sc. Ant.
sostituisce il condotto tardo-repubblicano che serve la fontana170, ma che sembrerebbe iniziare ben più ad ovest, forse appunto non lontano dal fognolo proveniente dalla velia171. all’indomani dell’incendo del 64 d.C. il percorso di questo condotto sarà ricalcato con precisione dalla grande fognatura neroniana che, con restauri ed inserzioni della media età imperiale, continuerà a funzio-nare sino al XiX secolo172. al disopra delle fognature tutto il tracciato stradale è rifatto e nell’area della Meta Sudans rimangono ampie zone delle preparazioni e cospicui tratti di basolato e del marciapiede meridionale (fig. 18, 19-22)173. nell’area delle pendici palatine rimangono invece al-cune tracce del marciapiede settentrionale (fig. 18, 23-25) e del meridionale (fig. 18, 26-27), ambe-due gradonati per risolvere alla pendenza del tracciato174, pochi basoli e lacerti delle preparazioni (fig. 18, 28-29); il lastricato del marciapiede settentrionale copre ora, in apparenza senza alcun segnale riconoscibile, tanto il pozzo quanto il bothros. in questa redazione la sede stradale subisce un innalzamento di oltre cm 50 in media, fatto che comporta le modifiche cui già si è accennato: le soglie e di conseguenza i pavimenti interni dei vani della domus tardo-repubblicana vengono innalzati e le scale degli accessi al santuario prolungate; il livello del complesso monumentale fontana-compitum rimane invece inalterato, il podio del sacello sporge ora di soli cm 40 dal suolo ed anche la vasca della Meta risulta incassata, tanto che è necessario soprelevarne il bordo175.
l’incendio provoca notevoli danni anche nella vasta domus situata sulle pendici orientali della velia, lungo la via per l’esquilino: gli ambienti termali del piano superiore crollano, il
170 Dai dati del carotaggio eseguito sulla piazza del Colosseo nei pressi dello sbocco dell’attuale via sacra (vd. n. 64) sembrerebbe potersi dedurre che questa fognatura sostituisca in realtà l’antico colletto-re di fondovalle realizzato in età arcaica, dato questo che parrebbe confermato dalle dimensioni dell’estra-dosso (largh. m 3 ca.).
171 una struttura cementizia con caratteristiche ed orientamento del tutto analoghi al tratto più pros-simo alla Meta sta infatti iniziando ad emergere sul limite orientale dello scavo delle pendici palatine (la zona è indicata dal punto interrogativo con cerchio verde in fig. 18).
172 a questo collettore sembra far riferimento almeno il tratto centrale del percorso tracciato in G. schingo, art. cit., 1996 (a n. 125), fig. 147 e id., art. cit., 2001 (a n. 125), 143, fig. 11, che perciò non è stato riportato nella planimetria complessiva di fig. 16. Da un lato infatti le testimonianze di tecniche edilizie co-munque precedenti all’uso del laterizio si concentrano nei segmenti a sud, oltre l’arco di Costantino sotto l’asse dell’attuale via di s. Gregorio (vd. G. schingo, art. cit., 1996 [a n. 125], 156-157 e fig. 147, s), dall’al-tro tutto il tratto individuato in scavo presso la Meta augustea, in parte già ispezionato nel XiX secolo, è certamente neroniano con modifiche ed aggiunte po-steriori. Permane il dubbio sulla cronologia originaria del tratto nord-occidentale della fognatura, più pros-simo all’angolo sud-est del tempio di venere e roma,
già raffigurato nel 1828 in una splendida planimetria di a. De romanis (ora edita in P. Pensabene - C. Pa-nella, art. cit., 1993-94 [a n. 1], 267, fig. 102). su questo tratto potrà forse fornire nuovi dati lo scavo in cor-so alle pendici del Palatino, anche perché nella pianta suddetta esso parrebbe dotato di un’adduzione prove-niente proprio da sud-est, ossia dall’area ora indagata (le fogne individuate nel settore, per una prima analisi delle quali si rimanda al contributo di a.F. Ferrandes in questo volume, sembrano sinora però tutte poste-riori).
173 il marciapiede, realizzato in grandi lastroni di travertino, si presenta ora largo m 2 e alto cm 45, caratteristiche assai simili a quelle riscontrate nella seconda redazione della strada proveniente dal Celio (cfr. fig. 16, 29) individuata dal lanciani e poi negli sterri per la metropolitana (vd. n. 149), che dovrebbe infatti essere coeva.
174 se il marciapiede meridionale risulta anche qui largo m 2, il settentrionale sembrerebbe un po’ più stretto (cm 170 ca.), ma il dato non è certo a causa delle radicali asportazioni di età neroniana. su questo lato si può anche notare il limitato riuso di lastre di peperino preesistenti, mentre non è ovviamente de-finibile lo spessore dei marciapiedi, dato che la sede carrabile procede inclinata e questi invece a gradoni.
175 l’interramento è evidente nel basolo super-stite della via, che copre il più basso dei gradini della preesistente scaletta in travertino d’accesso al sacello.
13, 2006 Dall’indagine alla città 109
forno è distrutto, le stanze del seminterrato sono impraticabili per le macerie. si preferisce quindi radere al suolo i resti e rialzare notevolmente il livello di calpestio di quella parte della casa176, ma a causa di un’estesa spoliazione di età rinascimentale il suo nuovo allestimento non è comprensibile. ne rimangono solo due segmenti di fondazioni cementizie (fig. 18, 30-31)177 ed un breve tratto di canaletta (fig. 18, 32)178; l’unico dato certo è che un muro laterizio (fig. 18, 33) è rialzato sui resti di quello augusteo di limite orientale del vano con forno e continua dunque a rappresentare il confine fra gli ambienti dismessi e la zona del fronte-strada. anche quest’ultima viene del resto notevolmente ristrutturata, ma i piani di vita subiscono qui solo un lieve rialzo, dato che all’esterno del caseggiato la via esquilino-Circo Massimo conserva la pavimentazione, e dunque la quota, precedenti. viene così obliterata l’adduzione meridionale al grande collettore repubblicano, che pur modificata aveva continuato a funzionare; con i materiali edilizi combusti, misti a terra sabbiosa e cenere, si rilivella la zona e viene realizza-ta la nuova maglia muraria laterizia, di cui rimangono i due setti est-ovest (fig. 18, 34-35)179, mentre il muro orientale di limite verso la strada è quasi del tutto asportato dalle spoliazioni post-antiche e quello opposto, come vedremo, è probabilmente il muro ora rialzato su quello augusteo (cfr. fig. 18, 33). al posto dell’ambiente con vasca sorgono due vani contigui, fra loro comunicanti180: quello a sud, pavimentato in cocciopesto (fig. 18, 36), sembrerebbe una cuci-na181, l’altro è invece un ambiente di servizio non meglio definibile, anch’esso pavimentato in cocciopesto e dotato di un’area rettangolare in opera spicata, probabilmente pertinente ad una vasca addossata al muro settentrionale. ambedue sono semplicemente intonacati di bianco e dovettero essere intensamente usati, dato che il pavimento della cucina risulta consunto e dissestato, mentre vedremo che l’altro dovrà essere addirittura rifatto. subito a sud di questi due vani, in una porzione del medesimo edificio prima non documentata182, alla stessa quota
176 il piano di vita di questo settore passa da m 17,10 ca. ad una quota certo superiore a m 18,60 s.l.m.
177 i dati su queste due strutture sono alquanto incerti. la più settentrionale (fig. 18, 31) va a colmare gli spazi fra i resti del bancone augusteo dell’ipotizza-ta cucina e quelli del massetto pavimentale del forno di età gaiana, ma non vedendosene gli altri due limiti non se ne possono comprendere orientamento e fun-zione. la meridionale (fig. 18, 30) ha invece direzione ne-sW, ma se ne ignorano larghezza ed estensione.
178 Questo piccolo condotto cementizio a sezio-ne rettangolare (speco di lato cm 20 ca.) corre paral-lelo al muro laterizio augusteo ora rialzato ed a sud piega ad angolo retto, raggiungendo evidentemente i vani del fronte-strada; una spessa crosta di calcare sul fondo mostra che esso fu notevolmente usato (forse con acqua calda che facilita il precipitato carbonatico, visto l’esiguo lasso di tempo del suo utilizzo), dato il suo pessimo stato di conservazione non s’individuano però, né il senso del flusso, né la specifica funzione.
179 le due fondazioni di questi setti, gettate a sac-co, sono costituite dalla consueta malta rossastra fria-
bile con inerti quasi esclusivamente di grossi pezzi di lastre e blocchi di travertino allettati più o meno oriz-zontalmente, probabilmente riutilizzati dal contiguo marciapiede della strada, che ora sembrerebbe venire un po’ ristretto (ma di questo intervento di restauro la spoliazione post-antica non ha lasciato tracce).
180 resti del vano di una porta, quasi del tutto asportata dall’inserzione di una grande fondazione neroniana, si notano infatti sul limite ovest del setto laterizio meridionale.
181 la superficie del cocciopesto presenta all’an-golo sud-occidentale, non distante dalla suddetta por-ta, un settore di macchia di bruciato in origine circo-lare (raggio cm 50 ca.) certo lasciata da un focolare. Cucine pavimentate in cocciopesto e dotate esclusiva-mente di fornelli mobili sono del resto diffuse sia ad ostia che nelle città dell’area campana ed appartengo-no generalmente a case modeste, quartieri d’affitto, o settori servili (vd. in proposito e. salza Prina ricotti, art. cit., 1978-80 [a n. 139], 239-241 e 278).
182 Questo saggio di scavo, delimitato dalle fon-dazioni dell’ambiente 15 del sistema costruttivo della
110 s. Zeggio Sc. Ant.
sono stati rinvenuti due tratti di pavimentazione in opera spicata (fig. 18, 37), forse in origine separati da un muro parallelo ai setti laterizi già considerati183. il fronte-strada della domus è dunque rappresentato, almeno in questo tratto, da un sistema di vani a pettine di taglia più o meno standard184, occupati da ambienti di servizio e forse da tabernae. ad ovest il sistema è delimitato dal muro ricostruito sul limite del forno ormai distrutto, come attestano l’analogo intonaco bianco ed i lacerti di cocciopesto rinvenuti sulla parete orientale (fig. 18, 38)185, ma non è possibile capire se esso chiudesse ad ovest i setti che separavano gli ambienti, o piuttosto se questi terminassero prima, lasciando lo spazio per un corridoio186.
anche nel settore sud-occidentale della casa l’incendio crea guasti ingenti, obbligando ad una ricostruzione radicale: il muro in opera incerta che chiudeva ad est le due gallerie voltate è profondamente rasato e così anche la parte terminale del divisorio fra i due anditi paralleli187; ad est di essi il pavimento in opera spicata è combusto e viene quindi quasi totalmente divelto, insieme agli allestimenti idraulici previsti nel massetto preparatorio; stessa sorte subisce infine il fondo in spicato della vasca del piano superiore. il restauro comporta la ricostruzione in la-terizio dei due muri suddetti: quello di chiusura delle gallerie (fig. 18, 39), più spesso del prece-dente, è rifatto in laterizio rinforzato da un pilastro in blocchi di travertino, il divisorio invece in semplice laterizio (fig. 18, 40). al piano superiore, l’angolo del vano riacquista la sua vasca con un nuovo pavimento in opera spicata188. Dal muro con pilastro si stacca ora a sud un altro setto laterizio diretto ad est (fig. 18, 41), che deve rappresentare la ricostruzione di quello cui si addossava la latrina della fase precedente. Quest’ultima pare continuare a funzionare, anche se forse solo come scarico189, e l’ambiente che la ospita riceve ora un rivestimento in intonaco
cedenti, non sembrano aperti sulla strada. i pavimenti risultano infatti tagliati praticamente a filo del muro di limite verso la via, asportato come si è detto da un cunicolo post-antico, eppure non vi si nota alcun ap-prestamento per soglie o pilastri, elementi necessari all’apertura di un varco, come peraltro si riscontra anche in altre zone dell’area; anche considerato che le quote di calpestio interne superano di soli cm 15 quelle del marciapiede. È verosimile che il lungo fron-te-strada fosse ripartito fra locali d’affitto, accessibili dunque dalla via, e locali di servizio della domus, rag-giungibili dall’interno.
187 non è possibile sapere per quanta lunghezza questo muro è stato rasato e ricostruito, dato che pro-segue oltre il limite di scavo, ma è evidente che esso non sia stato sostituito completamente, dal momen-to che le volte continuano ad essere quelle originarie, raccordate al tratto di elevato riedificato.
188 nella galleria seminterrata rimane in funzione il condotto originale di scarico, mentre è ovviamente rifatto il discendente, che sfrutta come appoggio l’an-golo fra i due muri, ed i muri stessi sono rivestiti d’in-tonaco bianco. vd. anche oltre, n. 201.
189 il nuovo muro laterizio, evidentemente più spesso del preesistente, o più spostato a nord, e non
Domus Aurea, è stato condotto nel periodo 1986-87 da D. Maestripieri.
183 Questo setto parrebbe indiziato da alcune chiazze di cementizio rimaste sul fondo di un cuni-colo di spoliazione con direzione est-ovest che, gi-rando poi a nord, è responsabile anche della già vista asportazione del muro di limite orientale del caseg-giato.
184 ne risulterebbero 4 ambienti (un tramezzo va infatti ipotizzato anche fra la cucina ed il primo dei due lacerti di spicato, sia per la differente tecnica di pavimentazione dei due vani che per il loro dislivello di oltre cm 10), la cui dimensione è sempre più o meno di m 3 di larghezza per m 6 di lunghezza (considera-to anche l’eventuale spazio del corridoio di cui ora si dirà), ossia di 10 x 20 piedi romani.
185 Come le pareti della cucina e della stanza con vasca anche questa è rivestita di intonaco bianco spes-so cm 3, che in tutti i casi scende di poco sui pavimenti terminando con un sottile cordolo; il modesto lacerto di cocciopesto, inoltre, si trova alla quota precisa degli altri due (m 17,87 s.l.m.).
186 nella ricostruzione presentata in fig. 19, n1 si è preferita questa seconda ipotesi, dato che i due vani più conservati, come del resto avveniva nelle fasi pre-
13, 2006 Dall’indagine alla città 111
bianco ed un nuovo pavimento (fig. 18, 42) in un particolare tipo di battuto190; al centro di esso è posto un braciere, rappresentato da un grande labrum di terracotta privato del fondo. ancora una volta siamo dunque di fronte ad un vano connesso alla funzione termale, probabilmente una sorta di sudatio191.
sul lato opposto della via che sale verso l’esquilino, infine, il rogo degli anni 50/53 sem-bra invece l’occasione per una modifica della situazione topografica antecedente. un nuovo isolato prende forma in corrispondenza dell’incrocio con la più settentrionale delle strade che si dipartono verso est, o più probabilmente un fabbricato preesistente si amplia sino a questa zona, prima forse occupata da una piccola piazza, rendendo necessaria la realizzazione ex novo del marciapiede meridionale della strada est-ovest (fig. 18, 43)192. l’edificio, che come vedremo sembra ancora una volta riconoscibile come una domus su due livelli, mostra al piano terreno due vani nei quali, come attestano le soglie in travertino, è possibile identificare altrettante ta-bernae aperte a nord sulla via e separate fra loro da un setto in laterizio con pilastro di testata, anch’esso in travertino (fig. 18, 44). un muro laterizio le chiude sul retro (fig. 18, 45), sepa-randole da un cortile che risulta a sua volta delimitato a sud da un setto analogo e parallelo al precedente (fig. 18, 46). se la bottega orientale è stata individuata per una superficie minima, insufficiente a farne comprendere dimensioni e funzione, quella occidentale doveva estendersi sino all’angolo nord-occidentale dell’edifico ed aprirsi probabilmente anche sull’asse esqui-lino-Circo Massimo193. l’ambiente ha pareti semplicemente intonacate di bianco, pavimento probabilmente in opera spicata194 ed all’angolo nord-est, in fila lungo la parete orientale, sono
perfettamente ortogonale al muro di limite delle gal-lerie voltate, copre in parte il pozzetto della latrina, ma non ne occlude il sistema idraulico. non è chia-ro quindi se questa continui a funzionare come tale, magari con un apprestamento ligneo per la seduta, o venga sfruttata solo come fognolo.
190 Questo pavimento è realizzato con terra mol-to compattata mista a noduli d’argilla e di malta, car-boncini, piccoli ciottoli e scaglie di tufo. la superficie è regolare e la tecnica di realizzazione ricorda, anche se molto semplificata, quella descritta da vitruvio (vitr., de Arch., 7, 4, 4-5) per ottenere un pavimento assorbente e percorribile a piedi nudi senza provare freddo.
191 il bacile in opera doliare, recuperato solo per metà a causa dei limiti del saggio, presenta un diametro all’orlo di cm 140 ca.; per la trasformazione in braciere il fondo ne era stato segato ed il taglio ac-curatamente lisciato. Deve aver subito un uso conti-nuo, che ne ha annerito la parte inferiore e crepato le pareti, ed in uso era anche all’atto dell’incendio del 64 d.C., come rivela lo spesso strato di ceneri e carboni rimasto al suo interno. Considerato che l’incendio accadde alla metà di luglio, va ovviamente escluso un utilizzo del braciere per il riscaldamento domestico,
così come la mancanza di residui di cibo, griglie o pentolame al suo interno fa escludere un utilizzo per la preparazione di cibi. Per converso l’uso come su-datoio giustificherebbe anche la realizzazione di un pavimento caldo e assorbente.
192 anche in questo caso il marciapiede è realiz-zato con lastroni di travertino alti cm 45 ca.
193 le due tabernae risultano ampie in senso nord-sud m 4 (compresa la soglia); supponendo che quella occidentale giunga all’angolo del fabbricato ne risulterebbe una larghezza in senso est-ovest di m 5,60 ca. Questa soluzione (cfr. fig. 19, o1) sem-brerebbe preferibile rispetto a quella di due vani da poco più di due metri l’uno, alquanto angusti per ospitare un esercizio commerciale. anche a Pompei, del resto, le botteghe d’angolo sono spesso più am-pie e vantano un’apertura su ambedue le strade (è il caso, solo per fare un esempio, del laboratorio di cal-zoleria di M. Nonius Campanus, posto sull’angolo della domus di M. Caesius Blandus, per il quale vd. J. overbeck, Pompeji in seine Gebäuden, Alterthü-mern und Kunst werken, leipzig 1884, 282, fig. 158; 381; 675, nr. 89a).
194 Quasi nulla dell’intonaco rimane in situ sul-le pareti, a parte poche chiazze d’arriccio, ma molti
112 s. Zeggio Sc. Ant.
incassati nel piancito quattro vasi per derrate con ancora parte del loro contenuto195: doveva dunque trattarsi di una rivendita di generi alimentari, o forse di una sorta di popina.
le stanze sovrastanti, abbattute dopo l’incendio del luglio 64 d.C., erano invece rifinite con maggior cura: pavimenti in mosaico bianco/nero e intonaci dipinti dimostrano che, anche in questo caso, il piano superiore è destinato alla residenza. l’accesso ad esse doveva probabil-mente avvenire attraverso la corte retrostante le botteghe, con tutta probabilità praticabile dalla via per l’esquilino, che svolge quindi la funzione di atrio196. la cura delle rifiniture vista per le stanze del piano superiore interessa anche questo accesso alla casa: l’atrio riutilizza come pavi-mento il lastrico augusteo in travertino, acconciandolo ai nuovi limiti con riprese di cementizio lisciato (fig. 18, 47), in origine anch’esse rivestite di lastre. esso era inoltre in origine affresca-to, dato che sia la parete settentrionale che la meridionale, pur mal conservata, recano tracce d’intonaco dipinto su uno spesso arriccio di cocciopesto irto di chiodi197, e probabilmente era porticato con sottili colonne di cipollino198.
le ultime attività edilizie precedenti l’incendio del luglio 64 d.C. sono limitate. l’unica data-bile con una certa precisione è relativa al 59 d.C., quando Agrippina Minor viene uccisa e subisce la damnatio memoriae: in conseguenza di ciò la sua statua è eliminata dal basamento multiplo ospitato nell’edicola del santuario palatino e l’epigrafe è cancellata (fig. 18, 48)199. in un momento probabilmente non lontano si collocano invece gli altri due interventi, entrambi conseguenza
frammenti erano nello strato che ricopriva il suolo della stanza; resti d’intonacatura bianca sono del re-sto anche sulle pareti del vano contiguo. ugualmente buona parte del pavimento risulta asportata, rivelan-do il massetto preparatorio nella consueta malta rossa, ma grandi quantità di mattoncini da spicato giacevano divelti su di essa. anche qui, come in vari altri punti dell’area in esame (vd. ad es. s. Zeggio, in M. Cante - s. Panciera - C. Panella - s. Zeggio, art. cit, 1994-95 [a n. 1], 142-144), le operazioni successive all’incendio neroniano sembrano aver inizialmente previsto una spoliazione degli elementi ancora utili, quasi subito abbandonata in favore di un abbattimento generaliz-zato delle strutture pericolanti o troppo alte rispetto ai nuovi livelli di progetto, i cui crolli, come vedremo, anche in questo caso si sono infatti rinvenuti in posto a sigillare i piani inferiori.
195 si tratta di quattro vasi di grossolana opera doliare, forse già in origine privi della parte superiore, con corpo leggermente tronco-conico (Ø cm 25 ca.) e fondo piano inglobato nella malta del massetto pavi-mentale, che conservano resti del contenuto origina-rio (almeno in un caso forse cereali).
196 nella ricostruzione in fig. 19, o1 si è scelto di tracciare un varco in un muro semplice di recinzione, ma più probabilmente si sarà trattato di un ingresso «canonico», con fauces ed alae: nei quasi sei metri di ampiezza della corte vi è infatti spazio sufficiente per ipotizzare due piccoli vani ai lati di un andito.
197 la tecnica di fissare l’arriccio al muro con chiodi a testa larga e piatta (claves muscarii) si rende-va necessaria quando le pareti erano craticee (vitr., de Arch., 7, 3, 11), oppure nei luoghi umidi, quando que-sto non avrebbe fatto ben presa sul laterizio; in questo caso, inoltre, la trullissatio doveva essere di cocciope-sto, anziché di sabbia e calce (vitr., de Arch., 7, 4, 3). Dati questi che assai bene si adattano all’intonaco di un ambiente aperto.
198 un frammento lungo quasi m 2 di un fusto monolitico di marmo caristio è stato rinvenuto in sta-to di crollo sul lastricato. Quale che fosse l’interco-lumnio, non individuabile, dato il diametro contenuto (cm 25 ca.), va esclusa la possibilità che sorreggesse un architrave con solaio per il piano sovrastante. È dunque possibile che sostenesse il compluvio ligneo dell’atrio o che provenisse da un ballatoio del piano superiore.
199 stranamente fino al luglio del 64 d.C., forse in attesa di un’ulteriore dedica da parte dei suonatori di ottoni, il posto della statua dell’imperatrice madre non era stato ancora occupato. le lettere dell’iscri-zione erano state semplicemente riempite di mastice a base di calce (che reagendo con la rubricatura aveva dato loro un alone violaceo e che si era poi staccato per effetto del calore) e la parola Romani, relativa ai dedi-canti, era stata riscritta in calce all’epigrafe di Claudio (le tracce di cancellazione sono evidenti nella foto in C. Panella, Un’area sacra, cit. [a n. 48], 47, fig. 40c).
13, 2006 Dall’indagine alla città 113
dell’uso continuato delle strutture su analizzate. Da un lato l’ambiente con vasca in spicato e pavimento in cocciopesto, situato nella zona nord-orientale della domus delle pendici veliensi, viene ripavimentato (fig. 18, 49), conservando la bipartizione e quindi evidentemente la funzione precedente200. D’altro canto il fondo in opera spicata della vasca sita poco più a sud-ovest, al pia-no superiore delle gallerie voltate seminterrate, viene rivestito di cocciopesto (fig. 18, 49)201.
sebbene il piano urbanistico generale rimanga quello di età augustea, questo periodo si presenta dunque molto ricco di testimonianze per l’area in esame, permettendone una rico-struzione ben più accurata che nel passato. Mentre le altre vie continuano a funzionare con le infrastrutture precedenti, la strada valle-Foro (fig. 19, a) è dotata almeno per un tratto di un nuovo grande collettore e ripavimentata. È nuovamente lastricato anche il tracciato prove-niente dalla sommità del Celio (fig. 19, b), certo in connessione con la prima realizzazione del Claudium, e vengono infine rifatti o restaurati i marciapiedi della via per l’esquilino (fig. 19, c) e quelli della sua traversa settentrionale (fig. 19, d); la caratteristica dei marciapiedi molto alti, comune a tutti questi casi202, denota la volontà di separare più decisamente il traffico pedonale da quello veicolare.
sul fronte degli edifici pubblici la ricostruzione è generalizzata. il santuario palatino è drasticamente restaurato, con l’edicola ampliata (fig. 19, e1) ed il tempietto tetrastilo (fig. 19, e2) in posizione dominante sulla scalinata. in questo senso abbiamo per la prima volta la certezza che il luogo di culto occupi un’area più vasta di quella direttamente indiziata dalla lunghez-za dei setti murari individuati (fig. 19, f) ed è assai probabile che confini direttamente con la domus delle pendici palatine settentrionali203. Di fronte ad esso il piccolo sacello dell’incro-cio (fig. 19, g) è ricostruito sul podio preesistente e così anche la Meta sudans augustea (fig. 19, h), benché la vasca risulti ora alquanto incassata rispetto all’innalzato piano di calpestio.
200 la stanza così ripavimentata è raffigurata in C. Panella, art. cit., 1990 (a n. 1), 59, fig. 23. i resti conser-vati non permettono di determinare lunghezza e pro-fondità della vasca appoggiata alla parete, ma che di una vasca si tratti parrebbero attestarlo sia i resti di bordo sul limite meridionale, sia l’intonaco idraulico e più spesso rimasto sulla parete settentrionale. Come acca-deva per il primo, anche un lacerto di questo secondo cocciopesto è conservato attaccato alla parete orienta-le del muro ricostruito sul limite del forno distrutto, all’identica quota di quello dell’ambiente con vasca.
201 i due pavimenti sovrapposti sono evidenti nella foto in C. Panella, art. cit., 1990 (a n. 1), 46, fig. 14. relativamente a questa evidenza va notato che, an-che se sicuramente siamo in presenza di un allestimen-to idraulico, non è del tutto certo che in esso debba riconoscersi una vasca; nella parte individuata, oltre-tutto mal conservata, non è infatti rimasta traccia degli eventuali bordi del bacino. si potrebbe dunque trat-tare anche dell’angolo nord-orientale del pavimento di una terrazza, con discendente per il deflusso delle acque meteoriche. in questo senso, come spesso acca-
de, i due strati di pavimentazione potrebbero essere coevi e necessari ad assicurare una miglior tenuta alle infiltrazioni (vd. la cura richiesta da vitruvio in questi casi, vitr., de Arch., 7, 1, 5-7).
202 Cfr. nn. 149, 173 e 192.203 in attesa delle nuove indagini non è ovvia-
mente possibile essere certi di questa contiguità e soprattutto definire da quando essa si verifichi. Di questa possibilità però, anche considerato l’elevato livello sociale testimoniato dalle rifiniture della casa (interessante in questo senso un piccolo frammento di decorazione egittizzante impressa su gesso, rinvenuto sul pilastro in blocchi di travertino del corridoio), an-drà tenuto conto relativamente alla problematica della vicinanza fra Curiae Veteres e casa natale di augusto, poi trasformata in archivio personale di livia e quindi in sacrarium; anche, e direi soprattutto, se si dovesse ritenere valida l’argomentazione di Cecamore (C. Ce-camore, Palatium, cit. [a n. 159], 167-169, con ulterio-re bibliografia) contro l’ipotizzata trasformazione del sacrarium stesso in aedes in conseguenza della divi-nizzazione di livia (su tutta la questione vd. n. 159).
114 s. Zeggio Sc. Ant.
Continuando lungo il lato settentrionale della strada per il Foro, non abbiamo dati certi per il piccolo monumento (fig. 19, i), situato ai margini del fabbricato delle pendici veliensi meridio-nali, mentre è sicuro che tanto il pozzo quanto il bothros spariscono definitivamente sotto al lastricato del marciapiede.
ancora una volta nulla può dirsi riguardo a struttura e funzione del fabbricato veliense testé citato (fig. 19, l), se non che il rifacimento del suo canale di scarico ne assicura la conti-nuazione d’uso. Per converso numerosi dati si aggiungono alla nostra conoscenza degli edifici sicuramente privati dell’area. la domus delle pendici palatine settentrionali è restaurata dopo l’incendio, sia nella zona dei vani prospicienti la via (fig. 19, m1), sia nel quartiere residenziale retrostante (fig. 19, m2), articolato su due piani e lussuosamente rifinito. anche per quanto riguarda la vasta domus sita sulle pendici veliensi orientali le ristrutturazioni sono ingenti e se praticamente nulla conosciamo del piano superiore, che per continuità col passato dovrebbe ospitare la parte residenziale, l’utilizzo del piano terreno appare abbastanza articolato. il tratto settentrionale del fronte verso la via per l’esquilino (fig. 19, n1) ospita una sequenza regolare di vani a pettine, probabilmente divisi fra botteghe e locali di servizio della casa; il settore inter-no meridionale (fig. 19, n2), invece, ospita semplici vani termali, ignoriamo se a servizio della casa stessa o se aperti ad un pubblico di livello comunque non elevato. a queste testimonianze dell’edificio si possono forse aggiungere due evidenze, individuate in momenti diversi sotto la fronte del tempio di venere e roma (fig. 19, n3). la prima è un setto laterizio con testata in travertino (fig. 16, a) del tutto simile a quelli presenti nella casa e nell’isolato antistante ad est204; il secondo (fig. 16, b) è un lacerto di pavimento in opera spicata posto a quota compatibile con quelli del piano interrato205.
indicazioni del tutto nuove abbiamo infine per l’isolato che fronteggia la domus appena descritta. nella sua porzione settentrionale esso ci appare ora occupato ancora una volta da una casa a due piani (fig. 19, o1), con botteghe sulle fronti e probabile accesso ad atrio dalla via per l’esquilino, mentre alla residenza sono di sicuro riservate le stanze del primo piano. anche in questo caso il panorama documentale, pur nell’incertezza delle cronologie specifiche, può essere arricchito da alcuni dei rinvenimenti effettuati durante gli sterri per la conduzione della ferrovia metropolitana. nella zona a sud-est delle tabernae (fig. 19, o2) furono individuati un setto laterizio con direzione est-ovest (fig. 16, 12)206, un tratto di pavimento in opera spicata
204 Questo setto, individuato nel 1982-83 duran-te un’indagine della s.a.r., è sommariamente edito e raffigurato in una planimetria d’insieme in s. Panella, Scavo nella platea del Tempio di Venere e Roma, in aa.vv., Roma. Archeologia nel Centro, I. L’area ar-cheologica centrale (Lavori e Studi di Archeologia 6, 1), roma 1985, 106-112 (in part. 111-112, fig. 8, v) e come tale è ripreso negli studi sull’area di G. schingo (G. schingo, art. cit., 1996 [a n. 125], 156 e fig. 147, P2; id., art. cit., 2001 [a n. 125], 143, fig. 11). il suo allineamento è compatibile con l’orientamento obliquo, retaggio del-le prime strutture tardo-repubblicane, conservato dagli ambienti circostanti la cucina di età augustea.
205 G. schingo (art. cit., 1996 [a n. 125], 156 e fig. 147, P1; id., art. cit., 2001 [a n. 125], 143, fig. 11) ri-costruisce in m 18,00 ca. s.l.m. la quota di questo pa-vimento, citato in un appunto del 1938 da G. Gatti insieme ad un muro in blocchi di tufo, vagamente rap-presentato in uno schizzo e forse anch’esso in qualche modo conservato in uso.
206 Questo setto risulta spiccare a m 16,50 ca. s.l.m. da una fondazione in cavo armato, ma altrove dubitativamente definita «in cappellaccio» (vd. G. schingo, art. cit., 2001 [a n. 125], 137 e 143, fig. 11, nr. 12). in ogni caso quota ed allineamento risultano abbastanza compatibili con quelli dell’edificio ora in
13, 2006 Dall’indagine alla città 115
(fig. 16, 13), e ancor più a sud (fig. 19, o3) altri due lacerti pavimentali, uno in cocciopesto (fig. 16, 20) e l’altro ancora in spicato (fig. 16, 21), tutti posti a quote compatibili col piano terreno dell’isolato207.
esame (sui problemi planimetrici dei rinvenimenti degli sterri della metropolitana, il cui disegno risente forse troppo dell’orientamento dei numerosi setti ne-roniani presenti nell’area, vd. n. 127).
207 le quote ricostruibili per questi pavimenti (da m 17,00 a 16,70 ca. s.l.m.; vd. G. schingo, art. cit., 2001 [a n. 125], 137-138 e 143, fig. 11, nrr. 13 e 20-21) risultano un po’ più basse di quelle delle tabernae e di-gradanti da nord verso sud in modo analogo a quanto riscontrato sul lato opposto della strada per l’esquili-no. sotto questi pavimenti gli scavi individuarono in realtà anche una serie di strutture in blocchi (due setti
murari ed una fognatura a volta), che per l’estrema genericità di descrizione, orientamento e rappresen-tazione non è stato possibile collocare in una fase sto-rica sufficientemente determinata e che non sono stati quindi considerati. solo una fognatura in blocchi di cappellaccio sita a quota molto profonda (cresta a m 14,80 ca. s.l.m., cfr. fig. 16, 20) ed un muro anch’esso in blocchi di cappellaccio (cresta a m 16,20 ca. s.l.m., cfr. fig. 16, 18) del quale G. Gatti specifica orientamento (est-ovest ca.) e spessore dei blocchi (cm 28 = 1 piede osco ca.) si possono verosimilmente ritenere pertinen-ti alla sistemazione di età arcaica o tardo-arcaica della
Fig. 19. – valle dell’anfiteatro e pendici nord-orientali del Palatino. schema planimetrico ricostruttivo della zoniz-zazione funzionale dell’area al 64 d.C. nei due toni di rosso la viabilità, nei due toni di verde i luoghi sacri sicuri o ipotetici, in blu i monumenti, in grigio le aree di edilizia privata. in linea blu le ipotesi ricostruttive dei plessi edilizi.
116 s. Zeggio Sc. Ant.
Per completare l’analisi topografica di questa fase è necessario tornare brevemente alla viabilità, per dar conto di un dato tanto incerto quanto potenzialmente interessante. Durante le indagini effettuate nell’area agli inizi dell’800 fu individuata ed ispezionata una fognatura (fig. 16, 6) che si dirigeva dall’area della base del Colosso neroniano verso quella della Meta Sudans flavia. Questo condotto fu in parte nuovamente rilevato durante la conduzione della metro-politana208 e di recente è stato messo in rapporto con un lastricato in travertino rinvenuto nei pressi del Colosso stesso209. Considerato che la quota ricostruibile per il lastricato è del tutto compatibile, in questa parte più elevata della valle, con quella dei marciapiedi di età claudia e visto anche che l’andamento obliquo del collettore non pare molto dissimile da quello dei muri della parte nord-occidentale della domus delle pendici veliensi orientali210, è forse possibile ipotizzare che oltre l’incrocio con la strada diretta ad est l’asse Circo Massimo-esquilino pie-ghi verso ovest (fig. 19, p), o in alternativa che una via si distacchi da esso in questa direzione, facendo quindi dell’incrocio un trivio211.
un’ultima riflessione, forse più una suggestione, riguarda un ipotetico confronto fra il quartiere così delineato dai resti archeologici e quello rapidamente tratteggiato da seneca in una sua lettera all’amico lucilio212; o meglio l’aggiornamento del confronto già tentato dopo i primi risultati delle nostre indagini nella valle213. in questa lettera, redatta poco tempo prima della sua tragica fine214, l’ex precettore di nerone afferma com’è noto di vivere controvoglia presso una Meta Sudans, enumera la quantità di rumori che continuamente lo infastidiscono e ne descrive puntigliosamente la causa; è altrettanto noto come la maggioranza degli studiosi sia stata propensa a credere che seneca scriva la sua missiva da baia, dove si è ritirato, e parli dun-que di quella città215. vediamo dunque gli elementi che, coincidenti fra descrizione del filosofo
zona (vd. per ambedue G. schingo, art. cit., 2001 [a n. 125], 138 e 143, fig. 11, nrr. 18 e 20).
208 la fognatura compare per la prima volta col nr. 6 nella già citata planimetria di a. De romanis (vd. P. Pensabene - C. Panella, art. cit., 1993-94 [a n. 1], 267, fig. 102) e successivamente è riportata in tratteg-giato (= fognatura antica) nella planimetria di percor-so della ferrovia metropolitana (vd. C. Mocchegiani Carpano [a cura di], Roma: la Valle dell’Anfiteatro, roma 1983, fig. 42).
209 vd. G. schingo, art. cit., 2001 (a n. 124), 136-137 e 143, fig. 11, nr. 6, dove per il pavimento è rico-struita una quota di m 19,25 ca. s.l.m.
210 Cfr. n. 204. in ogni caso va rilevata un’impre-cisione nel tracciato fognario. nessuna adduzione è stata infatti individuata nel grande collettore nord-sud in corrispondenza del punto in cui esso dovrebbe, se ben collocato, immettervisi. È probabile che la con-fluenza avvenga poco più a nord, anche perché questa fognatura, dotata di due pozzetti di piena età imperia-le, doveva necessariamente funzionare come tributa-ria del grande collettore.
211 in questo senso il lastricato farebbe parte del marciapiede nord-orientale della strada. Per la totale
assenza di dati, ad es. sulla tecnica costruttiva della fo-gnatura, non è ovviamente possibile definire la sua da-tazione originaria e quindi un eventuale terminus ante quem per la creazione di questo percorso. Data però la quota relativamente elevata del piano di scorrimento (m 16,40 s.l.m. secondo la pianta della metropolitana cit. a n. 208), il condotto non sembrerebbe precedere la tarda età repubblicana, in sostanziale accordo con i due più antichi setti murari dall’orientamento com-patibile.
212 sen., Epist. ad Luc., 56.213 vd. in proposito C. Panella, art. cit., 1990 (a
n. 1), 60-62.214 l’epistola dovrebbe esser stata scritta fa il 63
ed il 65 d.C., anno del suicidio del filosofo, suicidio indotto a causa del suo presunto coinvolgimento nella congiura pisoniana.
215 la lettera successiva informa infatti l’amico che il poeta è tornano da baia a napoli e secondo la maggioranza dei filologi (vd. ad es. e. Paratore, Storia della Letteratura latina, Firenze 1950, 554-557) le epi-stole furono scritte l’una di seguito all’altra, nel me-desimo ordine poi seguito dalla pubblicazione. una prova del fatto che il testo sia stato scritto in una città
13, 2006 Dall’indagine alla città 117
ed evidenza archeologica, potrebbero contraddire questa interpretazione. innanzi tutto la frase d’apertura, ove questi si lamenta di vivere al piano soprastante una rumorosa terma216: se è vero che il lussuoso impianto termale individuato nella parte nord della domus delle pendici veliensi orientali (cfr. fig. 15, 32-33) mal si accorda con questa dichiarazione, visto che si trova già ad un piano rialzato, parrebbe d’uso squisitamente privato ed è certamente distrutto nell’incendio del 50/53 d.C.217, la più modesta sudatio della fase 51/53-64 d.C. (cfr. fig. 19, n2) indizia invece un impianto assai più rispondente ai lai del filosofo218 e che si trova oltretutto praticamente sull’incrocio, nel punto quindi di traffico più caotico219. a seguire, l’ira dell’intellettuale di-sturbato dai suoi pensieri ricade sui bercianti venditori di ogni tipo di derrata alimentare e sugli osti220; come abbiamo visto i fronte-strada di tutti gli isolati deputati all’edilizia privata sono in effetti occupati da negozi, ed almeno uno di questi (cfr. fig. 19, o1) è probabilmente una popina. ed ancora la concentrazione è disturbata dagli artigiani intenti al loro lavoro, dei quali proprio nell’isolato con ambiente termale paiono esservi labili tracce221, e persino da qualcuno che presso la Meta Sudans, guarda caso nel luogo in cui i suonatori di ottoni dedicano statue alla gens imperiale, si esercita a suonare tube e flauti222. tutti questi elementi possono essere
di mare è fra l’altro ritenuta la frase «Sed iam me sic ad omnia ista duravi, ut audire vel pausarium passim voce acerbissima remigibus modos dantem» (sen., Epi-st. ad Luc., 56, 8), ma è evidente che qui seneca voglia fare l’esempio del rumore intermittente ripetitivo più fastidioso che esista secondo lui («…etiamnunc mo-lestior est mihi sonus qui intermittitur subinde quam qui continuatur»), a prescindere dal fatto che lo senta o meno in quel momento (difficilmente poi avrebbe potuto udirlo da una casa). Per la teoria di una Meta Sudans Baiensis vd. ad es. H. Jordan, Topographie der Stadt Rom im Alterthum, berlin 1907, i, 3, 24, n. 54.
216 sen., Epist. ad Luc., 56, 1: «Ecce undique me varius clamor circumsonat: supra ipsum balneum ha-bito».
217 la mancanza di questi dati, ancora ignoti al momento dell’edizione, porta alla dichiarazione op-posta di C. Panella, art. cit., 1990 (a n. 1), 61-62.
218 Come già accennato il livello pare troppo basso per un impianto privato aristocratico quale il precedente; potrebbe dunque forse trattarsi di un modesto impianto pubblico. un problema potrebbe essere rappresentato dalla citazione di una «piscina» (sen., Epist. ad Luc., 56, 2: «…adice nunc eos qui in piscinam cum ingenti inpulsae aquae sono saliunt»), anche se va tenuto comunque presente che la notevole portata d’acqua necessaria a rifornire la Meta (vd. n. 163) avrà necessariamente comportato la presenza in quel punto di una derivazione di acquedotto.
219 Ibid., 56, 4: «In his quae me sine avocatione circumstrepunt essedas transcurrentes pono…».
220 Ibid., 56, 2: «…iam biberari varias exclama-
tiones et botularium et crustularium et omnes popina-rum institores…».
221 Ibid., 56, 4: «…et fabrum inquilinum et ser-rarium vicinum…». non vi sono dati certi in relazio-ne alla presenza rispettivamente di un falegname (nel senso più che altro di intagliatore, visto l’uso del ter-mine serrarius) e di un fabbro nel medesimo stabile dove seneca vive, ma non si può fare a meno di citare due suggestive coincidenze. la prima è rappresen-tata da uno strato riferibile in realtà all’incendio del 50/53 d.C., che oblitera parte dell’ambiente antistante il forno; questo strato, relativo al rogo dell’ambiente stesso o del vano contiguo a sud (i vani a nord sono infatti sigillati dal crollo della terma sovrastante, vd. n. 140), conservava al suo interno grandi quantità di le-gno arso, frammenti di oggetti ed elementi decorativi d’osso a vario stadio di lavorazione (vd. J. De Grossi Mazzorin - C. Minniti, Gli scavi nell’area della Meta sudans (I sec. d.C.): l’industria su osso, in aa.vv., Atti del primo Convegno nazionale di Archeozoologia (Rovigo, 5-7 marzo 1993) [Padusa. Quaderni 1], Pa-dova 1995, 371-374) ed un gruzzolo di monete per lo più di piccolo taglio, forse l’incasso dell’artigiano (vd. M.C. Molinari, Le monete della Meta sudans [Roma], in Ann. Ist. It. Num. 42, 1996, 109-161 e tavv. 24-25). la seconda coincidenza, meno perspicua ma certo cu-riosa, è che proprio da un locale prossimo alla terma crolli sulla via diretta al Foro, a causa dell’incendio del 64 d.C., un cancello in ferro di dimensioni eccezionali (vd. oltre, n. 226), serramento certo non comune.
222 sen., Epist. ad Luc., 56, 4: «…aut hunc qui ad Metam Sudantem tubulas experitur et tibias».
118 s. Zeggio Sc. Ant.
certo coincidenze, situazioni ricorrenti nel «viver quotidiano di roma antica» e non danno certezza alcuna sul fatto che seneca sia realmente vissuto nella casa alle pendici della velia at-torno al 63 d.C. Certo bisognerà analizzare più approfonditamente il brano ed i suoi eventuali riscontri, ma raramente, credo, una fonte antica trova così suggestivo riverbero nelle tracce dell’archeologia.
l’incenDio Del 64 D.c. e l’impianto Della Domus AureA
a metà di luglio del 64 d.C. tutto quanto sinora abbiamo visto cessa improvvisamente di vivere. se non nella stessa notte del 18, già certo il 19 le fiamme, partite dal Circo Massimo, devono aver raggiunto la valle e le pendici circostanti223. la statua bronzea di tiberio esplo-de insieme alla sua base sui gradini del santuario, anneriti dal crollo dei tizzoni, e la tettoia dell’edicola precipita. la domus delle pendici palatine settentrionali è distrutta proprio mentre è in corso di restauro: accumulati in un angolo i sectilia per i pavimenti di alcune stanze, in fase di pittura le pareti, con i fondi di anfore colmi di colori pronti all’uso224, in ristrutturazione forse alcuni vani225. Dal lato opposto, nei pressi della Meta un pesante cancello di ferro226 s’in-frange rovente sul selciato della via per il Foro, restandovi attaccato, come le miriadi di chiodi fusi che punteggiano tutte le vie. su di esso e su un lungo tratto di strada crolla una facciata in laterizio con grande cornice marcapiano di travertino, un grande blocco della quale cade nella vasca della fontana227. il fuoco non lascia tempo per ripulire il braciere nella domus delle pendici veliensi orientali, né per porre in salvo le derrate dalla bottega all’angolo della via per l’esquilino. Quando alla fine l’incendio si estingue, si tenta di recuperare il recuperabile, ma dopo poco anche questi tentativi vengono interrotti in favore di una «regolarizzazione», che nei luoghi elevati tende a radere al suolo gli edifici, portandone via le macerie, e le sfrutta invece per la colmatura della depressione valliva, dopo l’abbattimento in posto delle strutture perico-lanti o troppo elevate228. Così ad esempio le tabernae della domus palatina sono riempite dai
223 tac., Ann., 15, 38-41; suet., Nero, 38.224 nel vano prossimo all’angolo sud-orientale
dell’area di scavo e nel corridoio antistante si sono in effetti rinvenuti tre fondi di anfore globulari del tipo Dressel 20, con resti rispettivamente di grassello di calce, ocra gialla e ocra rossa, ed anche alcuni fram-menti di piccole coppe di ceramica a pareti sottili con residui di altri colori sono forse connessi al medesimo intervento.
225 l’ipotesi nasce dal rinvenimento nell’area del-la scala diretta al piano superiore di un gruppo di gros-si pesi parallelepipedi in pasta laterizia, attualmente in studio e verosimilmente pertinenti ad uno strumento edile per spiombatura ed allineamento delle pareti.
226 Questa cancellata risulta mancante dei termi-nali di fissaggio e/o di chiavistelli o cerniere e doveva essere dunque in origine ancora più ampia. il tratto
rinvenuto misura cm 180x110 ca. ed è composto di verghe piatte larghe cm 4/4,5 e spesse 1,5 ca., interse-cate ortogonalmente; restaurato e ricomposto, è tut-tora inedito. Data la posizione di crollo sulla strada è certa l’appartenenza del cancello all’edificio del lato veliense, di cui ora si dirà.
227 Questo blocco, rinvenuto nella parte orientale della vasca ed attualmente in studio da parte di M. Can-te, presenta dimensioni analoghe ad altri più malridotti, individuati più ad ovest fin sopra il cancello già descrit-to. Questa situazione suggerisce il crollo da nord di una lunga parete continua di un caseggiato a due piani, in questo senso riconoscibile col lato meridionale della vasta domus delle pendici veliensi orientali.
228 il livello delle strutture abbattute in situ (si pen-si ad es. alla fronte del tempio) e quello dei detriti edilizi scaricati, ma allogeni, è di solito assai ben distinguibile
13, 2006 Dall’indagine alla città 119
resti di un grande edificio in blocchi di tufo e travertino229, mentre la vasca della Meta Sudans è accuratamente colmata da un vespaio di migliaia di frammenti ceramici230.
in conseguenza del terribile rogo tutto in questo settore urbano sarà dunque sommerso231 o spazzato via; muteranno altimetrie ed orientamenti, viabilità e zonizzazioni ed inizierà una stagione del tutto diversa, che sino alla fine dell’evo antico sarà caratterizzata esclusivamente e stabilmente, pur nel mutare delle scelte architettoniche ed urbanistiche, dai grandi impianti imperiali di funzione pubblica. non è possibile in questa sede procedere oltre. Della gigantesca e rivoluzionaria trasformazione neroniana, che sola ha reso possibile ogni successiva modifica al panorama urbano di questa zona232, si tratta in certa misura in altra parte di questo volume233 e così delle successive modificazioni di età flavia, adrianea e severiana234. in chiusura occorre però ricordare un unico elemento. Più volte in questi anni d’indagini chi scrive ha avuto modo di notare che la pianificazione neroniana, pur «dirompente» nel suo generale stravolgimento dello statu quo ante topografico ed urbanistico, rivela a tratti un rispetto inatteso per le preesi-stenze, non tanto in quanto monumenti, ma in quanto spazi, ossìa: il monumento preesistente
per diversi fattori. la notizia tacitiana del trasporto in nave ad ostia delle macerie dell’incendio (tac., Ann., 15, 43, 3) andrà in questo senso circoscritta ai soli resi-dui edilizi che eccedevano da questi livellamenti.
229 le macerie, abbattute (o forse scaricate) da ovest dopo la rasatura dei muri della domus, appar-tenevano ad un grande edificio, dotato di almeno un ampio passaggio arcuato in conci di tufo bugnati e di una vasta terrazza pavimentata in lastre di travertino su spesso solaio cementizio con inerti di travertino e basalto (un tentativo di ricostruzione è attualmente in corso da parte di M. Cante).
230 Questo eccezionale contesto, che ha restituito in massima parte anfore, ma anche diverse altre classi ceramiche, vetri e persino un gruzzolo di ben 35 mo-nete (studiato da chi scrive ed attualmente in prepara-zione per l’edizione), è stato oggetto delle tesi di lau-rea di C. De santis e e. Fresi nell’aa. 2004-2005, e di C. Gualtieri nell’a.a. 2006-2007 (presso l’università degli studi di roma «la sapienza», Facoltà di scien-ze umanistiche, Cattedra di Metodologia e tecniche della ricerca archeologica).
231 sul sistema d’interramento dell’area in fun-zione del cantiere della Domus Aurea vd. s. Zeggio, La stratigrafia relativa alla trasformazione neroniana dell’Area Sacra, in C. Panella (a cura di), Meta sudans I, cit. (a n. 1), 159-163.
232 la vastità e la coerenza topografica del pro-getto neroniano risultano palesi dalle evidenze arche-ologiche raccolte ed analizzate in M. Medri, suet., nero, 31.1: elementi e proposte per la ricostruzione del progetto della Domus aurea, in C. Panella (a cura di), Meta sudans I, cit. (a n. 1), 165-188 ed in C. Panella, art. cit., 2001 (a n. 1), 57-62.
233 un’accurata ipotesi ricostruttiva tridimensio-nale del sistema di plessi edilizi coperti a terrazze di-gradanti e vie, in parte coperte, che nell’area della valle fungeva da connessione fra lo stagnum ed i vari nuclei della Domus Aurea (padiglione «privato» dell’oppio, ninfeo del Celio, atrio/vestibolo veliense e palazzo del Palatino), ed in particolare della via porticata che dalla valle stessa saliva all’atrio/vestibolo, è stata sviluppata da e. brienza nell’ambito della sua tesi di dottorato di ricerca in archeologia Classica (Xvi ciclo, università di roma «la sapienza», a.a. 2003-2004), Valle del Co-losseo: ricostruzione dello sviluppo urbano e monumen-tale di un settore centrale della città antica, ed è breve-mente riproposta nell’ambito del suo contributo, cui si rimanda. un altro progetto di ricostruzione in 3D della reggia neroniana (s. borghini - r. Carlani, Domus Au-rea Neronis), più estensivo ma meno particolareggiato ed a tratti ancora solo delineato, è in corso a cura della Prima Facoltà di architettura dell’università «la sa-pienza» ed è stato presentato preliminarmente in a. vi-scogliosi, L’uso delle ricostruzioni tridimensionali nella storia dell’architettura: immaginare la Domus aurea, in l. Haselberger - J. Humphrey (a cura di), Imaging Ancient Rome. Documentation, Visualization, Imagi-nation (Journ. Rom. Arch., Suppl. 61), 2006, 207-219. la frequente adozione del sistema di copertura terrazzato, oltre a fornire belvedere e percorsi fra loro comunican-ti, era conseguenza di una precisa scelta ingegneristica degli architetti di nerone, tesa a domare più facilmente eventuali incendi (suet., Nero, 16).
234 Per un’analisi delle evidenze sin qui raccolte e per le ipotesi ricostruttive di queste fasi nell’ambito dello scavo delle pendici palatine nord-orientali si ri-manda al contributo di a.F. Ferrandes.
120 s. Zeggio Sc. Ant.
è spoliato, ma lo spazio che occupava è preservato nell’ambito del nuovo progetto. È questo il caso della Meta Sudans augustea (fig. 20, a), solo perimetrata dalle fondazioni della Domus Aurea235, e del santuario nel quale è verosimile riconoscere le Curiae Veteres (fig. 20, b-c), la cui area è attraversata da un numero limitato di setti, rispetto alla densità presente nel resto della valle. Già in passato avevamo supposto in queste apparenti anomalie e smagliature di un progetto altrimenti massivo la volontà di conservare sotto altre forme il venerando luogo di culto236, ma quest’ipotesi sembra tanto più credibile oggi, alla luce dei rinvenimenti della pen-dice palatina nord-orientale237. Questi permettono di ricostruire una vasta terrazza (fig. 20, d) verosimilmente libera da costruzioni se non lungo il perimetro e sostenuta da corridoi semin-terrati, paralleli e frequentabili238. Delimitata a nord dal monumentale portico pilastrato della via che sale all’atrio/vestibolo (fig. 20, e), la terrazza si affaccia ad est su un ampio spazio aperto (fig. 20, f), a quota più bassa, bipartito ed attualmente non meglio definibile239, confinante con una grande aula rettangolare (fig. 20, g) contigua all’avancorpo d’accesso alla Domus Aurea dall’asse dell’attuale via di s. Gregorio (fig. 20, h)240.
non sembra inverosimile leggere nella terrazza e nell’area più bassa ad essa antistante gli spazi destinati alla ricostruzione del santuario, che tuttora viene a trovarsi sull’angolo nord-orientale della pendice, così com’essa è ridisegnata nel progetto neroniano. se cogliesse nel vero, questa ipotesi risolverebbe l’apparente discrasia tra la distruzione del santuario nel 64 d.C. e la citazione delle Curiae Veteres nei Cataloghi regionari241. nella loro ben nota politica
individuati subito a sud-ovest dell’arco di Costanti-no (D. Cirone, I risultati delle indagini stratigrafiche all’Arco di Costantino, in Rend. Pont. Acc. 66, 1993-94 [1995], 61-76), è stato poi riconsiderato da e. brienza nell’ambito della sua ricostruzione (vd. n. 233).
241 non è possibile ripercorrere qui la comples-sa problematica inerente il periodo di reale esistenza e le possibilità di localizzazione delle antiche Curie. Per la sopravvivenza del toponimo anche successiva-mente ad un’eventuale distruzione del monumento si è espresso fra gli altri M. torelli (s. Zeggio, art. cit., 2005 [a n. 1], 65), mentre la questione della localiz-zazione, già ampiamente analizzata da C. Panella (C. Panella, Un’area sacra, cit. [a n. 48], 70-91) è stata in ultimo da lei stessa ripresa (C. Panella - s. Zeggio, art. cit., 2004 [a n. 1], 72) in risposta al riconoscimento, effettuato da C. Cecamore (C. Cecamore, art. cit., 2002 [a n. 159], 43-58) proprio delle Curiae Veteres nel discusso gruppo 452 di frammenti della Forma Ur-bis Marmorea e della conseguente ipotesi di una loro collocazione nell’ambito della lastra 8, comprensiva anche di parte del Circo Massimo, e quindi sul versan-te orientale del Palatino, presso gli archi dell’acque-dotto neroniano non lontano dal septizodio. a questi contributi si rimanda per la cospicua bibliografia sul tema. risulta indubbiamente suggestivo che il gruppo ritragga per l’appunto un’ampia area quadrangolare
235 vd. in tal senso s. Zeggio, Roma, Valle del Colosseo, cit. (a n. 1), 274, n. 26.
236 vd. in tal senso s. Zeggio, art. cit., 2005 (a n. 1), 65.
237 Questa possibilità è già accennata in C. Pa-nella - s. Zeggio, art. cit., 2004 (a n. 1), 72-73. Per un’analisi dettagliata delle evidenze neroniane delle pendici palatine nord-orientali si rimanda al contribu-to di a.F. Ferrandes in questo volume.
238 Questa ipotesi nasce dall’assenza di elementi strutturali sul piano di calpestio della terrazza e dal limitato spessore dei setti che la sostengono, inadatti a reggere il peso di un secondo piano massivamente edificato. Gli unici tre brevi tratti di sottili muri la-terizi paralleli (uno peraltro crollato), individuati sul limite occidentale, risultano posteriori e sovrapposti ai setti del livello seminterrato; essi fanno ipotizzare la sistemazione della terrazza, o la sua ristrutturazione, come un’area quadrangolare scoperta circondata da una serie di vani a pettine disposti lungo il perimetro, ad eccezione probabilmente del lato orientale.
239 l’assenza di una maglia fondale sufficiente-mente fitta non permette al momento di ipotizzare la copertura per quest’area, ampia m 35 x 15 ca.
240 Questo avancorpo, ipotizzato inizialmente da chi scrive (s. Zeggio, art. cit., 1999 [a n. 1], 137 e fig. 117) in conseguenza dei tratti di fondazioni neroniane
13, 2006 Dall’indagine alla città 121
Fig. 20. – valle dell’anfiteatro e pendici nord-orientali del Palatino. Planimetria ricostruttiva del sistema edilizio neroniano. in rosso pieno le strutture individuate, in linea rossa quelle ricostruibili. le lettere nere in corpo minore
indicano le preesistenze.
di riconnessione alla gens giulio-claudia, ad augusto in particolare, ed alle sue realizzazioni monumentali242, in programmatica rottura col predecessore i Flavi modificheranno ed adegue-ranno le linee di progetto neroniane, riproponendo un’altra Meta nella piazza da essi creata nella valle e un piccolo tempio all’interno del probabile santuario curiale243, ma la base proget-
circondata su tre lati da ambienti a pettine, aperti su un triportico che inquadra un piccolo tempio, ma allo stato attuale i frammenti non sembrano trovar posto in alcun modo nell’area da noi indagata e la topografia da essi rappresentata non pare corrispondere a quella indiziata dallo scavo.
242 in quest’ambito vd. da ultimo P. Pensabe-ne, Elementi architettonici dalla Casa di Augusto sul Palatino, in Röm. Mitt. 104, 1997, 149-192 (in part. 163-168); id., Vent’anni di studi e scavi dell’Univer-sità di Roma «La Sapienza» nell’area Sud-Ovest del
Palatino (1977-1997), in C. Giavarini (a cura di), Il Palatino. Area sacra sud-ovest e Domus tiberiana, roma 1998, 5-154 (in part. 75-84); C. Panella - s. Zeg-gio, art. cit., 2004 (a n. 1), 81.
243 la monumentale fontana flavia, edificata in-torno all’85 d.C. e definitivamente demolita nel 1936, è studiata in C. Panella, art. cit., 1990 (a n. 1), 77-82. Per l’analisi delle evidenze della fase flavia e per un’ipotesi ricostruttiva preliminare del piccolo tempio e dell’area circostante si rimanda invece al contributo di a.F. Ferrandes in questo volume.
122 s. Zeggio Sc. Ant.
tuale era a mio avviso già esistente nell’onnicomprensivo piano di nerone, teso alla creazione di un vero e proprio Centro del Potere multifunzionale ed organico244.
244 Questo contributo inevitabilmente rappresen-ta una summa delle mie più che ventennali esperienze nell’area della valle dell’anfiteatro a fianco di Clemen-tina Panella. spero che serva a noi, ma anche ai più
giovani che in questo progetto ci hanno seguito, per portare avanti insieme in tempi rapidi l’edizione defini-tiva di un’enorme messe di dati, di grande interesse per quest’area del Centro Monumentale di roma.