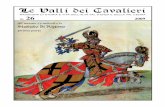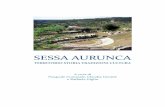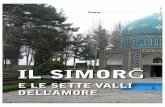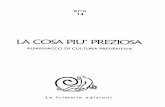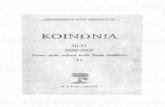Scolpire le pietre, fissare la memoria, in “Le Valli dei Cavalieri”, 26, Parma 2009
Case in legno nelle valli Egua e Sermenza
-
Upload
caivarallo -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Case in legno nelle valli Egua e Sermenza
17
ROBERTO FANTONI
CASE IN LEGNONELLE VALLI EGUA E SERMENZA
PRESENTAZIONE
La trattazione sistematica della casa tradizionale valsesiana è stata affron-tata, in tempi e con modalità diverse, da Ciribini (1943), Comoli Mandracci(1967) e Dematteis (1984). Negli ultimi anni la letteratura si è concentrata sul-l’architettura delle comunità che usavano il legno come principale materialeda costruzione. Pregevoli censimenti delle case in legno sono stati eseguiti daDaverio (1985) per Alagna e da Bellosta e Bellosta (1988) per la Valle Vogna.Per l’area rimellese si segnalano i recenti lavori di Remogna (1993) e Pizzetta(1993, 1996, 1999).
Obiettivo di questo lavoro è un altro “censimento delle case in legno”, aven-te questa volta come oggetto le valli Sermenza ed Egua, portando un modestocontributo a quel “censimento sistematico” delle case walser (o probabilmentewalser) auspicato da Zanzi (1986, pp. 42-45) e Gambi (1986, pp. 109-110).1
Nel 1991 è crollata sotto il peso della neve la torba di Piè di Rosso, che peretà di costruzione, appartenenza familiare e rilevanza storica del probabile co-struttore, poteva essere assunta come emblema della colonizzazione dell’altaVal d’Egua (cfr. Fantoni e Ragozzi, 1997). Il lavoro si propone anche lo scopodi lasciare una documentazione di questi edifici, destinati a massicce ristruttu-razioni o ad un inevitabile degrado, nella speranza che una di queste costru-zioni sia adibita a museo di cultura materiale, preservandone la destinazioned’uso dei locali, analogamente a quanto fatto da istituzioni pubbliche ad Ala-gna (frazione Pedemonte) e da privati a Riva Valdobbia (frazione Rabernar-do in Val Vogna).
COLONIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE VALLI EGUA E SERMENZAFRA TRECENTO E CINQUECENTO
A inizio Duecento risultava già parzialmente abitata la parte inferiore del-la Val Sermenza (Boccioleto e Rossa); nel giuramento di cittadinanza vercel-
edifici conservati è legata all’abbandono di questa tipologia costruttiva inun’età antecedente a quella alagnese. Il rinnovamento edilizio si manifestò conaltre forme e la retrocessione di queste costruzioni ad edifici rurali favorì il lo-ro progressivo degrado.3
L’ubicazione in insediamenti d’alta quota favorì anche la loro degradazio-ne per cause naturali. Alcune case in legno furono distrutte dal peso della ne-ve. In un atto del 1563 (ASVa, FNV, b. 8931) è citato a Rima il corpo di una stu-va diruta per nivem. Un’ulteriore riduzione del numero d’edifici in legno è do-vuto agli incendi. Nell’area esaminata il più dannoso, tra quelli noti, investì Car-coforo nel 1863. Stessa sorte subirono numerosi edifici in legno in molte fra-zioni dell’alta valle4 (cfr.Appendice A).Altri insediamenti persero molte del-le loro antiche case per alluvioni5 o valanghe.A Tetto Minocco furono distrut-te numerose case dall’alluvione del 1755; a Rima nel 1803 tredici case furonotravolte, e mai più ricostruite, in località Breithanorth, in una zona a valle delpaese ove rimangono residui di mura perimetrali con orti.
Attestazioni documentarie
Attestazioni di case in legno compaiono anche nei documenti del Cinque-cento. In un atto del 1531 è descritto un tecto buschis seu lignamibus consertoseu constructo, ossia un tetto, termine con cui in valle si chiamano gli edifici ru-rali, costruito in bosco, ossia in legno (Fantoni e Fantoni, 1995, d. 67).
Nei documenti del Quattrocento e Cinquecento compare inoltre frequen-temente la voce torba, che attualmente nell’uso locale designa le costruzioniin legno. La prima attestazione del termine “torba” risale ad un documento del1302, quando Pietro di Stafenwald (Fondovalle,Val Formazza) vendette ad uncolono di Bosco Gurin un podere e una casa con torba (Rizzi, 1991, d. 153, pp.103-104; Rizzi, 1996, p. 57). Nell’area valsesiana il termine compare per la pri-ma volta in un atto del 1334, quando Giovanni fu Pietro Zamponali de Graxe-neto habitator Pecie vende a Nicolino fu Gualcio de Aput Verdobi habitator Pe-cie, a suo figlio Giovanni e suoi fratelli Giovanni e Giacomo fu Gualcio la ter-za parte dei beni da lui posseduti alla Peccia e la terza parte di una torba con gliedifici pertinenti (torba cum omnibus hedificiis sibi pertinentibus) (Mor 1933,c. LXXXIV; Rizzi, 1983, d. 16;ASVa, SID, FCa, p. 12).
Nel corso del Quattrocento la voce compare poi in numerosi documentirelativi a diverse località di tutte le valli del Sesia. In alta Val Grande numero-si atti sono stipulati ante, super o retro torbam: a Pedelegno nel 1403 (SID, FCa,p. 36), in Val Vogna nel 1420 (p. 50), sulla Riva nel 1443 (p. 84), nel 1450 (p. 93).Nel 1500 è citata una torba al Gabbio (p. 189), nel 1505 ad Praxentino (p. 205),nel 1537 alla Riva (p. 313), nel 1542 alla Rusa (p. 328), nel 1547 alla Montata inVal Vogna (p. 336). In Val Mastallone compare a Fobello in un documento del1483 (Tonetti, 1891, s. IV, p. 143). Le voci torbe e torbetto compaiono frequen-
19
lese prestato dai capifamiglia valsesiani nel 1217 sono documentati rappresen-tanti di Rossa e, forse, di Boccioleto (cfr. Mor, 1933, d. XXIX-XXX, pp. 68-71).Nel secolo successivo la distribuzione degli insediamenti nel territorio di que-ste due comunità raggiunse una configurazione simile a quella attuale (Fanto-ni e Cucciola, 1998).
Fra Trecento e Quattrocento è documentata la colonizzazione della Vald’Egua e dell’alta Val Sermenza, con la fondazione di insediamenti permanen-ti sopra un territorio precedentemente sfruttato come alpeggio dalla mensa ve-scovile novarese e dalla famiglia varallese Bertaglia-Scarognini. Il territorio diRimasco, alla confluenza tra la Val d’Egua e l’alta Val Sermenza, fu popolatoquasi esclusivamente da coloni provenienti dagli insediamenti della bassa val-le. Carcoforo, l’alta Val d’Egua e alcune località dell’alta Val Sermenza furonopopolate in tempi diversi da coloni provenienti da località diverse (frazioni ala-gnesi e rivesi di Pietre Gemelle, Rimella, località della bassa valle), che diede-ro origine ad insediamenti multietnici. Rima, alla testata della Val Sermenza,fu invece fondata collettivamente ad opera di coloni provenienti dalle frazionialagnesi di Pietre Gemelle (Fantoni e Fantoni, 1995).
Le nuove colonie furono fondate nelle posizioni maggiormente soleggia-te e morfologicamente meno acclivi, lontane dai percorsi di valanga o di eson-dazione, su ripiani alluvionali e glaciali, o nel cuneo a monte di confluenze flu-viali. Rima e Carcoforo, ubicati alle testate di valle, sono le uniche comunità incui il centro parrocchiale costituisce l’unico villaggio accentrato. Le altre co-munità sono composte da insediamenti sparsi di dimensioni ridotte o ridottis-sime, in cui il centro parrocchiale è costituito dalla frazione (o semplicementedalla località) ubicata al centro geografico del territorio.
All’inizio del Cinquecento il territorio di tutte le comunità delle valli Eguae Sermenza aveva raggiunto la struttura ancor oggi osservabile. A partire dal-la seconda metà del secolo si realizzò una inversione del processo di coloniz-zazione, coincidente con l’inizio di un periodo caratterizzato da una forte emi-grazione stagionale.2
LE CASE IN LEGNO IN VAL SERMENZA E VAL D’EGUA
Gli insediamenti dell’alta Val Sermenza e della Val d’Egua conservano unastruttura urbanistica quasi invariata rispetto a quella di un secolo fa, come di-mostra il confronto tra la Mappa Rabbini (redatta a metà Ottocento) e le at-tuali mappe catastali; questa struttura è probabilmente simile a quella rag-giunta durante la fase di massima espansione cinquecentesca di questi inse-diamenti.
In alcuni villaggi sono ancora presenti alcune costruzioni in legno; di altrerimane traccia nella memoria storica o in fonti bibliografiche. La scarsità degli
18
rato et partim a torba (b. 8931). In un documento del 1567 di divisione tra Za-ninus et Albertinus et Jacobus frates filii quondam Johannis de Pironzollo deCampo Regucii Vallis Eigue sono indicate domus et capsine cum torba solariset partim lapideo muro murata et plodis coperta cum lobiis, porticu et curte (b.8931). In un documento del 1657 (b. 9884) compare a Pietre Marce un edifi-cio rurale parte murato et parte torbato … ubi dicitur il techiallo de torbis. Lastessa forma compare nel 1635 e nel 1660 alla Munca (b. 9884).
Talora il termine sembra sinonimo di alcune sezioni rurali: in due atti del1579 relativo a Priami compaiono domos cassinas seu torbas; altre volte, nel-lo stesso documento, la voce sembra essere attribuita a sezioni diverse: domoet cassina sive tecto a feno et torba (ASVA, FNV, b. 8935).
Caratteristiche generali
La datazione degli edifici presenti nelle valli Egua e Sermenza, ed una lo-ro probabile attribuzione ad un periodo prossimo a quello della fondazione de-gli insediamenti che li ospitano, è solo indiretta. Sono infatti completamenteassenti, in tutte le case censite, le date che compaiono, con sigle e/o segni di ca-sato, in molte costruzioni alagnesi. Ma anche quest’assenza potrebbe essereconsiderata, indirettamente, un elemento di datazione: anche nell’area di Pie-tre Gemelle le costruzioni ritenute più antiche risultano prive di incisioni, chesi diffondono solo a partire dalla metà del Cinquecento. In realtà in queste val-li l’uso di siglare e datare le costruzioni si diffuse solo parzialmente e tardiva-mente. L’incisione più antica è presente su una casa in pietra, sviluppata su trepiani con loggiati avvolgenti, della Dorca; la data 1577 (o 1511 con diversa gra-fia della cifra iniziale rispetto a quelle finali?) è incisa, a fianco di un segno per-sonalizzante, sull’architrave ligneo a piano terra dell’edificio censito con il nu-mero catastale 192 (fig. 1).
Quasi tutte le costruzioni in legno furono precocemente adibite ad uso ru-rale; recentemente sono state in gran parte ristrutturate a fini residenziali. Ledue variazioni hanno obliterato completamente l’originale destinazione d’usodei vari locali.
Le case censite hanno caratteristiche parzialmente diverse per dimensioniareali, numero di piani, sviluppo del loggiato e probabili destinazioni d’uso. Gliedifici hanno sempre una pianta semplice, quadrata o rettangolare, con asse
21
temente anche in atti cinquecenteschi relativi al territorio di Rimella (Pizzet-ta, 1995, p. 276).
In atti riguardanti le valli Egua e Sermenza la voce compare altrettantofrequentemente. Nel 1451 è documentata a Boccioleto la torba del notaio Za-nolus filius quondam Petri de Battico (SID, FCa, p. 101); nel 1496 un casseto plo-dis coperto et torba superius al Reale della Dorca (ASPF, b. XXVII, f. 212); nel1535 una torba Nicholini Bastuchi a Rimasco e una torba cum stuva … cum suislobiis a Rima ubi dicitur ad torbam illorum de Vyoto (ASVA, FNV, b. 10366);nel 1558 e nel 1563 una torba de Gallino a Priami (b. 10448); nel 1558 una ca-psina murata straigata plodis copertam a Piaggiogna ubi dicitur ad capsine detorbis e unius setii capsine a Piaggiogna ubi dicitur ad setius de torbis (b. 8931);nel 1566 una torba heredum Petri de Jacho a Carcoforo (b. 10448); nel 1574 lanona parte unius tecti torbe ai Casoni ubi dicitur ad tectum veteri (b. 10449) euna domus et torbe in loco de Casettis (b. 8937).
Rizzi (1996, p. 54) ritiene che nel Trecento e Quattrocento in Valsesia conil termine torba s’identificava presumibilmente la casa in legno. Lo stesso Au-tore in un lavoro precedente (1992, p. 207) scriveva però che “per torba, inValsesia, si intende il granaio-fienile in legno”. Dematteis (1984, p. 101) attri-buisce al termine solo il significato di fienile. Le citazioni nei documenti tar-domedievali non forniscono contributi per una soluzione univoca del pro-blema. In alcuni atti relativi a Rimella della fine del Cinquecento con questotermine s’identificano sicuramente gli edifici rurali o le porzioni in legno del-le case polifunzionali adibite ad uso rurale (cfr. dd. 1-5 in Pizzetta, 1996); inuna convenzione del 1590 per la costruzione di una nuova casa a Rimella sicita esplicitamente la torba per riporre i fieni e la ramaglia (Pizzetta, 1996, d.2, pp. 14-15). In un atto del Seicento, relativo a una casa di Selveglio (Val Vo-gna) è indicato come torba un locale sopra la stufa. In un atto del 1776 di Ra-bernardo si cita una torba dove tritolar il grano, ossia battere la paglia (Papa-le, 1988, p. 12). Ma in un documento nel 1547 alla Montata in Val Vogna(ASVa, SID, FCa, p. 336) sono citate una torba ed un tectum, implicando unadiversa funzione dei due edifici.
Nei documenti del Cinquecento relativi all’area esaminata la voce sem-bra designare sia la funzione sia la tipologia, ed in questo caso anche la cor-rispondenza tra le due cose: gli edifici in legno, o la parte in legno degli edi-fici, già adibita ad uso rurale. A favore di una correlazione tra le torbe e lecostruzioni lignee è la contrapposizione in alcuni documenti tra sezioni di ca-sa partim torbate e sezioni partim murate. In un documento del 1567 compa-re un edificio capsine et torbe partim lapideo muro murate et partim ligneiisconstructe nel territorio di Rima dove si dice ad tectum della gravina (ASVA,FNV, b. 8933). La separazione tra la parte lignea e la parte murata è forse lastessa esplicitata in altro modo in un documento del 1560 in cui si cita un edi-ficio seu corpus unius domus et torbe alla Dorca, descritto come partim mu-
20
Fig. 1 - Data e segno personalizzante (Dorca)
23
maggiore comunque prossimo a quello minore. Le costruzioni esaminate pre-sentano la linea di colmo parallela alla linea di massima pendenza, per con-sentire un’esposizione dei fronti all’asse vallivo (generalmente coincidente conesposizioni a meridione). L’ortogonalità del colmo rispetto alle curve di livelloconsentiva inoltre di sfruttare la pendenza del terreno, sviluppando sul frontea valle un piano seminterrato in più rispetto al lato a monte. L’unica eccezionea questa disposizione è costituita dalle case del nucleo centrale di Rima, ove icolmi sono paralleli alle curve di livello.
Tutti gli edifici hanno in comune un basamento in pietra, generalmente li-mitato al piano basale, che risulta generalmente seminterrato per sfruttare l’in-clinazione del pendio. Solo in una costruzione all’alpe Tetto la porzione in mu-ratura non si limita allo zoccolo basale dell’edificio, ma si estende anche allaparte superiore nella sua porzione seminterrata a monte. Il volume ricavato al-l’interno di questo basamento in pietra a piano terreno, che grazie al parzialeinterramento e alla quasi completa assenza di finestre manteneva una tempe-ratura costante, ospitava le stalle e i locali in cui si faceva fuoco.
La parte superiore, sviluppata su uno o due piani, è quasi sempre com-pletamente lignea. Negli edifici originariamente adibiti ad uso esclusivamen-te rurale la separazione tra basamento in pietra e parte superiore lignea av-viene con l’inserimento di un’intercapedine di circa 60 cm d’altezza, che pre-servava dall’umidità del terreno i locali destinati all’essiccazione e alla con-servazione delle risorse agricole. L’intercapedine è invece assente negli edifi-ci polifunzionali, per consentire al primo piano ligneo, destinato alle camere,di sfruttare il calore proveniente dal fuoco e dagli animali presenti al piano in-feriore. La separazione tra i due piani era realizzata mediante tre serie di trepilastrini svasati verso l’alto, a base e tetto rettangolari, che sostenevano trefile di travi longitudinali (Dorca, Carcoforo; fig. 2). Queste intercapedini era-no presenti anche in quelle costruzioni alagnesi che già Giordani (1891, p. 10)definiva antichissime e ormai quasi tutte scomparse; l’Autore segnalava chequeste erano sostenute da 10 o 12 “colonnette di legno sormontate da lastrerotonde e lisce di pietra”. Alcune di queste sono tuttora conservate nel terri-torio di Alagna e in quello di Riva (Val Vogna).Al Ronco superiore sono pre-senti in una costruzione attribuita al Cinquecento, sviluppata su due soli pia-ni, con basamento in pietra e legno, con loggiato su tre lati e fronte 1+2+1.An-che in questa costruzione l’intercapedine, di 70 cm d’altezza, è realizzata tra-mite tre file di tre elementi svasati verso l’alto, con base rettangolare (40x50cm), appoggiati su travi longitudinali e incastrati in una cornice di altre travilongitudinali (Ciribini, 1943, p. 96; Daverio, 1985, AA.VV., 1996, tavole di D.Magugliani, pp. 34-35, 159; Dematteis, 1996, p. 21, f. 57). Un’intercapedine èpresente anche in una costruzione a grossi tronchi con trave di colmo datata1646 ai Merletti, sviluppata su due piani, con loggiato su tre lati e con fronte aquattro moduli (1+2+1) (Daverio, 1985) e a Goreto, in una costruzione a due
22
Fig. 2 - Pilastri di sostegno al piano superiore in legno (Dorca, edificio 186)
Fig. 3 - Incastro di tronchi nelpiano superiore in legno (TettoMinocco, edificio 400-401-402)
ti ascensionali di aria calda che compromettono l’accumulo termico nei localidestinati al soggiorno diurno e al pernottamento situati nei piani inferiori. Lescale, generalmente ubicate in corrispondenza di portici e loggiati, sono quasisempre in pietra per l’accesso al primo piano e in legno per l’accesso ai pianisuperiori. Mentre le scale lignee sono generalmente lineari, quelle in pietra, peradattarsi alla morfologia del terreno sono spesso articolate e modulate da ri-piani litici; presentano alzate in muratura e pedate in lastre monolitiche (superschistus lapideus domu habitationis Nicholini Bastuchi in un documento del1533 a Rimasco;ASVa, FNV, b. 10366; figg. 4-5).
Le finestre sono generalmente di luci ridotte e interrompono, talora senzastipiti, solo uno o due tronchi del block-bau.Alcune sono di forma rettangola-re con l’asse maggiore orizzontale; talvolta sono chiuse da tavolette in legnoscorrevoli (Oro di Boccioleto, ove sono note come vaciarole; fig. 6).7 Le portesono generalmente basse. L’apertura è bloccata ai due lati con montanti con-tro i quali si attestano e si incastrano i tronchi del block-bau (fig. 7).
I loggiati, generalmente limitati al piano superiore in legno, presentano svi-luppi estremamente diversificati. In alcuni edifici si limitano al lato frontale, inaltri circondano perimetralmente l’intera costruzione. Analogamente diversi-ficata è la loro profondità, che talora risulta variabile anche nei diversi lati del-lo stesso edificio. In una costruzione alla Dorca lo spazio in posizione frontalerisulta ridotto rispetto a quello presente in posizione laterale, ove avveniva ilcarico del locale interno adibito a fienile-granaio.A Rima sono presenti edifi-ci con loggiati distribuiti su due fronti, di cui uno estremamente profondo. Illoggiato era adibito prevalentemente all’essiccazione del fieno; non mancanoperò indicazioni di un suo uso non esclusivamente rurale, come tavoli a parte epanche presenti in posizione frontale (Rima, Dorca; figg. 8-9). L’orditura delloggiato è costituita da piedritti e pertiche. In origine le pertiche dovevano es-sere incastonate sul lato interno dei piedritti. In numerosi edifici sui piedrittisono ancora presenti gli incavi a sezione quadrata per l’inserzione delle perti-che; nel modulo centrale gli incavi di alcuni edifici (Dorca, Rima) presentanouna guida che giunge sino al limite del piedritto in modo da agevolarne la mo-bilità garantendo la facilità di carico (fig. 10).
Il tetto è sempre a capanna, con due falde contrapposte che sporgono a co-prire il loggiato. Le coperture erano ordinariamente in piode, in accordo conquanto indicano le fonti documentarie, che citano sempre edifici plodis coper-ti. L’unica eccezione nota è costituita da un piccolo edificio rurale disposto sudue piani ad un solo vano presente ad Oro superiore di Ferrate che, sino allasostituzione della copertura avvenuta nel 1997, presentava una copertura inscandole,8 tavolette di larice spaccate lungo la fibra, note localmente con il ter-mine di inselle.9 Nella prima metà del Novecento erano ancora presenti co-perture in legno in altre case di Oro (edificio censito con il numero catastale225 e la torba smontata negli anni ’60 in posizione 156; parte dell’edificio 129).
25
piani con fronte a tre moduli (2+1) (Daverio, 1985). In Val Vogna una solu-zione uguale a quelle precedentemente descritte è adottata ad Oro, in una ca-sa su due piani, con loggiato su tre lati e fronte a quattro moduli (1+2+1), e aVogna Sotto, in una costruzione a due piani con loggiato su tre lati e con fron-te a sei moduli (1+4+1) (Bellosta e Bellosta, 1998, pp. 58, 78). Al Selletto in-vece i pilastrini di legno sono disposti con asse maggiore trasversale a soste-nere travi trasversali (Bellosta e Bellosta, 1988, p. 30).
In altri insediamenti walser i pilastrini sostengono dei piatti disposti a for-mare strutture note come funghi, che possono essere anche interamente in pie-tra o con piatto in pietra. L’utilizzo di funghi è diffuso nelle valli sul versantesettentrionale della Val d’Aosta, in costruzioni ad uso prevalentemente rurale;funghi interamente in pietra sono presenti a Issime e a Gaby (Dematteis, 1984,p. 48, f. 61); pilastri con diversa sezione sono documentati nel territorio di SaintVincent (p. 70, ff. 116-117); colonnine sostenenti travi longitudinali e trasversa-li sono presenti in un edificio in Valtournanche (pp. 72-73-ff. 122-124). La se-parazione dei piani attraverso intercapedini aerate è presente anche in case li-gnee delle valli ossolane (Macugnaga, Salecchio, Premia e Val Formazza) e nel-la contigua Val Maggia (Canton Ticino). Una funzione simile a quella svoltadai funghi è assolta in alcuni edifici lignei della val Malvaglia (Valle di Blenio,Canton Ticino) da un’incastellatura costituita da tre o quattro anelli di travi(Buzzi, 1996, p. 266).
Se l’intercapedine è assente la parte lignea poggia sullo zoccolo tramite unanello di travi massicce. I piani superiori sono realizzati con elementi lignei co-stituiti da tronchi, semitronchi o da travi diversamente squadrate, disposte oriz-zontalmente gli uni sugli altri con giunzione ad incastro secondo la tecnica no-ta come block-bau6 (fig. 3). La transizione dal tronco rotondo ad una sua sem-pre maggior squadratura ha progressivamente favorito l’aumento della super-ficie di contatto tra gli elementi e la conseguente riduzione della penetrazioned’aria. Il materiale ligneo impiegato è costituito esclusivamente da larici e abe-ti. Tutte le costruzioni di Carcoforo, Tetto Minocco e in Cima al Rivetto sono,od erano, costituiti da block-bau in abete con travatura in larice.
La parte superiore era talvolta parzialmente in legno e parzialmente in pie-tra. Un edificio di questo tipo, recentemente ristrutturato e parzialmente rico-struito in completa uniformità all’originale, è presente a Piè di Rosso. Non èescluso che a questo tipo di case possa riferirsi la citazione negli atti cinquecen-teschi e seicenteschi degli edifici descritti in precedenza come partim murati etpartim torbati.
Gli ambienti ai piani superiori non sono collegati tra loro ma sono disim-pegnati attraverso il portico e il loggiato. In tutti gli edifici gli ambienti ai di-versi piani sono infatti accessibili esclusivamente tramite scale esterne o, quan-do il dislivello lo consente, da accessi diretti a diverse quote del piano campa-gna. L’uso di scale interne, oltre a ridurre la volumetria dei locali, crea corren-
24
2726
Fig. 4 - Scale in pietra (Tetto Minocco, edi-ficio 400-401-402)
Fig. 5 - Scale di accesso al piano superiore(Rima, edificio 45)
Fig. 7 - Ingresso al piano superiore in legno(Oro di Boccioleto)
Fig. 6 - Vaciarola (Oro di Boccioleto)
Fig. 8 - Panca nel loggiato fronta-le (Dorca, edificio 186)
Fig. 9 - Tavolo in legno ribaltabi-le nel loggiato al piano inferiore(Rima, edificio 45)
Fig. 10 - Sistema di incastro dellepertiche all’interno dei piedritti(successivamente abbandonato)(Dorca)
riunite nel comune di Rima S. Giuseppe). Nelle successive citazione nel testodi altri insediamenti verrà mantenuta questa scansione territoriale, più idoneaalla trattazione di quella corrispondente all’attuale suddivisione comunale.
Di ogni villaggio in cui sono presenti costruzioni in legno viene fornita unadescrizione sintetica delle condizioni morfologiche, una breve rassegna delleattestazioni documentarie relative alle origini e un regesto delle eventuali ci-tazioni, in documenti del Quattrocento e Cinquecento, di edifici in legno. Ladescrizione di ogni edificio è preceduta da eventuali segnalazioni già presentiin letteratura e dall’indicazione della sua collocazione nell’insediamento; diogni costruzione viene fornito il numero assegnatole nelle mappe degli attua-li catasti comunali e nelle mappe del catasto ottocentesco, di seguito identifi-cate come mappa Rabbini.
Oro di Boccioleto
L’insediamento è posto alla base del versante meridionale del P.zo Trac-ciora (757 m), tra i centri comunali di Boccioleto (a cui appartiene attualmen-te il territorio) e di Rossa (a cui l’insediamento era legato in età tardomedie-vale) (cfr. Fantoni e Cucciola, 1998).
La prima attestazione documentaria dell’insediamento risale al 1424, quan-do Bertolo di Ca de Secchi di Rossa acquistò da Antonio di Oro di Rossa al-cuni stabili gravati da un legato di una staria di biada per la Confraternita di S.Spirito di Boccioleto (Ferri, ds. inedito s.d.;ASDN, fondo Boccioleto). Succes-sivamente la frazione è citata in un documento del 1476, quando Zaninus filiusquondam Alberti de Burro de Oro Rosse permutava un suo obbligo su due ap-pezzamenti di terra a campo ad pontem Ori Rosse con un altro legato alla Ca-ritatis Confrarie Sancti Spiriti de Bozoleto, istituito nel 1340 da Elena filia quon-dam Albertoni de Oro Rosse su un appezzamento di terra a campo nel territo-rio di Oro ad quarum (ASPB, b. XLIV, f. 266). In questi atti la presenza di nu-merosi appezzamenti di terreno destinati a campi e colture specializzate, asso-ciata ad una ben definita microtoponomastica, suggerisce una strutturazionedel territorio più che secolare.
Al centro della frazione è presente un antico edificio realizzato in pietra aipiani inferiori ed in legno al piano superiore, contiguo alla cappella di S. Pan-taleone, contenente affreschi datati 1476.11 La costruzione potrebbe essereidentificabile con il tectus scitus in cantono Ori Rosse penes capellam SanctiPantaleonis, venduto nel 1587 da Antonius filus quondam Manfredi OtoliniMayoli di Oro a Laurentius filius quondam Antonii Mayoli (ASVa, FNV, b.10367).
La torba (n. 70 nella mappa catastale del Comune di Boccioleto) è de-scritta in Fantoni e Cucciola (1998).
L’edificio è posto su tre livelli. Il piano basale, seminterrato e posto a livel-
29
Inoltre presentavano questo tipo di copertura anche altri edifici rurali a mon-te (Tetto di sopra; le Pesse) e a valle della frazione (la Pasquà, distrutta da unavalanga nel 1986).
L’unica segnalazione documentaria di coperture in legno in Valsesia è pre-sente tra gli edifici citati negli atti di fine Cinquecento del notaio Emiliano Cal-cino di Rimella (ASVa, FNV, b. 1790) ove compare una rassega ad aqua mura-ta et coperta assis (Pizzetta, 1995, p. 276); in una convenzione per alcune varia-zioni da apportare ad una casa alla Sella di Rimella è citato un trunetto “mu-rato coperto d’assi e piode” da costruire davanti alla “casa da focho” (Pizzet-ta, 1996, d. 5, p. 16-17). L’introduzione e la diffusione nel territorio di Oro po-trebbe essere proprio collegata al legame tra questo insediamento e Rimella:nel 1531 è documentata nella frazione la presenza di Zanina filia quondam Ja-cobi de Alberto de Glicho de Rimella, moglie di Albertinus filius quondam An-tonii Balmelli de Oro superiori de Caxivere (Fantoni e Fantoni, 1995, d. 63).
Ma nell’area delle costruzioni in legno è documentato anche un esempiodi copertura in paglia alla Dorca. Le fonti documentarie non chiariscono sequesto tipo di copertura fosse presente anche in edifici in legno o solo in edifi-ci in pietra, in edifici civili o polifunzionali o solo in edifici rurali, ma fornisco-no un areale ben più ampio di quanto sinora presentato in letteratura. Le co-perture in paglia erano infatti diffuse in bassa valle e in buona parte della ValMastallone (cfr.Appendice 2) ma vi sono tracce documentarie di una loro dif-fusione anche in Val Grande e nelle Valli Egua e Sermenza. A Scopa nel 1537è documentata una cassina paleis coperta in villa Scoete ubi dicitur intus curtemde Zento (ASVa, FNV, b. 10367, f. 80). In un atto del 1571 sono citate due ca-scine, una paleiis coperta et altera discoperta ... iacens in loco Scope (b. 10620).10
In un atto del 1574 viene citato un caseto cum solarolo murato et paleis coper-to nel territorio Techialli Rosse (b. 3937). Nella stessa valle, nella frazione Ca-setti di Boccioleto, è documentata la vendita nel 1537 di una domus plodis co-perta con la sua cassina paleis coperta; tra gli altri beni citati compare un tor-beto paleis coperto in loco de Cassetis ubi dicitur super planam de Cassetis (b.10367). In un atto di vendita di beni alla Dorca, ubi dicitur ad cassinam novam,nel 1531 è citata una capsina coperta partim paleis et partim plodis (b. 10366).Nel 1538 viene nuovamente citato un tecto coperto partim plodis et partim pa-leis (b. 10367).
CENSIMENTO DELLE CASE IN LEGNO
Il censimento delle case in legno è stato eseguito per tutti gli insediamen-ti delle valli Egua e Sermenza. Di ogni insediamento viene indicata la comu-nità di villaggio di appartenenza: Rossa, Boccioleto, Rimasco, Vallis Eygue (at-tualmente comune di Rimasco), Carcoforo, Vallis Rime e Rima (attualmente
28
quentazione del territorio di Oro, probabilmente a partire dal Trecento, di abi-tanti di Rima. In un documento del 1538 compaiono ancora, tra i confinanti adun campo superius domos cantoni Ori de Rossa, gli heredes Johannis de la Vi-dua de Rima (ASVa, FNV, b. 10367). La tradizione vuole che la torba, nota co-me Cà ad Zaveriu, dal nome di uno degli ultimi residenti, sia stata un tempocasa parrocchiale ed abitazione del curato Zali.12 Le fonti documentarie forni-scono una conferma a questa tradizione. A metà Cinquecento, tra 1530 e1571,13 è documentato il Venerabilis vir dominus presbiter Johannes filius quon-dam Jacobi de Zalis de Oro Rosse, rector et beneficialis meditate ecclesie SanctiPetri de Bozoleto. Pochi anni dopo il Verbale di Visita di Mons. Speciano del1590 citava, presso la cappella di San Pantaleone, la casa parrocchiale del pre-te Gio.Antonio (ASDN,AVi, v. 8, 387v), che in un altro foglio degli stessi Atti divisita veniva qualificato dominus presbiter Johannis Antonius Zalus filius legit-timus quondam dominus Gasparis et Alaxina de Butioleto14 (ASDN, AVi, v. 8,375v). Di questo secondo prete documentato della famiglia Zali si conosce ladata di battesimo: il Libro della Parrocchia di Boccioleto si apre infatti, ca-sualmente, proprio con la registrazione del battesimo, il giorno di dominica 19feb 1553 di Antonius filius Gasparri de Zalis (ASPB, b. I,Anagrafe parrocchia-le, Libro dei battesimi 1553-1611). Un atto del 1575 precisa che Antonio eral’unico figlio di Gaspare, ancora vivente e fregiantesi del titolo di dominus, ecitava alcuni beni di sua proprietà ad Oro di Rossa e ai Casetti (ASVa, FNV,b. 8937). In tempi successivi il piano superiore, che sino ad inizio secolo ospita-va scaffali con numerosi libri, fu adibito a sala consiliare della comunità di Oro(Fantoni e Cucciola, 1998).
In una relazione redatta nel 1906 per valutare l’importanza degli affreschialla cappella di S. Pantaleone, Cesare Bertea ribadiva non solo il valore dellepitture ma dell’intero complesso, costituito da una struttura che rispecchia il mo-do di costruzione delle case rurali del XV secolo, ritenendolo degno dell’inseri-mento nell’elenco dei monumenti d’arte nazionali. Con attento spirito di con-servazione proibì alla Congregazione di Carità, proprietaria dell’edificio, di con-tinuarne l’uso improprio per il rischio di incendi, ne vietò l’alienazione e l’ese-cuzione di restauri senza autorizzazione, comunicando l’intenzione di redigereun progetto di restauro da parte del suo ufficio. Il finanziamento statale per ilrestauro della cappella previde inoltre la destinazione di parte del fondo all’ac-quisto dell’edificio rurale attiguo, che in tal modo si salvò dal degrado. In questianni, eseguito il necessario intervento di manutenzione straordinaria alla volta,dovrebbe finalmente giungere a termine il restauro degli affreschi della cappel-la di S. Pantaleone. La torba, dopo l’attenzione prestatale ad inizio secolo dalBertea, non ha più destato l’interesse di enti pubblici o associazioni locali.
Nella bassa Val Sermenza rimane un vago ricordo della presenza di torbe aPomarolo, Genestreto e Ca Perdomo. Sopra la frazione Solivo, un insediamen-
31
lo della cappella di S. Pantaleone, è in muratura; presenta un unico accesso dallato ovest e in origine doveva essere adibito a stalla. Sul muro del piano basa-le della torba si estendono dalla limitrofa cappella di S. Pantaleone gli affreschidella Madonna con Bambino tra S. Caterina e S. Sebastiano. La costruzione, sequesti affreschi appartenessero allo stesso ciclo pittorico di quelli interni, risul-terebbe antecedente al 1476, data riportata in posizione interna. In muratura èanche il primo piano, originariamente adibito ad abitazione, che presenta unsolo accesso dal lato est ed una finestra sul lato nord, esposta a monte. Il se-condo piano è in legno, con grosse travi d’abete disposte ad incastro ai lati (fig.11). Internamente è presente un unico locale indiviso a cui si accede dall’in-gresso posto sul lato orientale (cfr. fig. 7); presenta una sola finestra quadrata dipiccole dimensioni (20 cm di lato) sul lato nord, un tempo probabilmente chiu-sa da una membrana di animale e ora sbarrata da una inferriata a croce. Sottoalla finestra è presente una fessura alta circa 5 cm chiusa dall’interno da un’as-se scorrevole (vaciarola, cfr. fig. 6). Le pareti non proseguono sino a chiudere iltimpano, lasciando aperto il locale, che aveva probabilmente funzione rurale.
Un loggiato, attualmente chiuso da listelli inchiodati esternamente ai pie-dritti, si estende sui lati sud ed est. Il tetto è sostenuto da tre sole travi, con legrondane direttamente appoggiate sulle pareti laterali del block-bau.
La torba di Oro è quella ubicata più a valle tra quelle attualmente conser-vate. La sua presenza nel territorio di Oro potrebbe essere correlata alla fre-
30
Fig. 11 - Oro di Boccioleto. Edificio 70 (piano superiore in legno, lato N)
33
to della bassa Val Cavaione, è presente un gruppo d’edifici rurali abbandonatiancora identificato con il toponimo “le Torbe”. L’agglomerato sembra esserestato un tempo un insediamento permanente; in un documento del 1513 com-pare ad esempio un Laurentius Marchisonus de torbis Bozoleti (Fantoni e Fan-toni, 1995, d. 50). Sinora non sono emerse testimonianze documentarie di even-tuali costruzioni in legno successivamente scomparse in questi insediamenti.
Seccio
Il Seccio è l’insediamento più elevato della Val Cavaione (1388 m). La pri-ma attestazione documentaria risale al 1420, quando il comune Seciis comparetra le coerenze dell’Alpe Castello (Fantoni e Fantoni, 1995, d. 13).
Soprattutto a causa della sua elevata distanza dal centro parrocchiale e dal-le altre frazioni della bassa Val Cavaione (Ronchi, Ormezzano e Solivo) l’abi-tato è stato retrocesso negli ultimi anni ad insediamento stagionale. Al centrodella frazione è collocato l’oratorio dedicato a S. Lorenzo, contenente un ciclodi affreschi quattrocenteschi.
All’inizio di questo secolo era ancora presente una torba al margine set-tentrionale dell’abitato, in corrispondenza dell’edificio censito con il numero38 nella mappa Rabbini e 2394 nella mappa catastale del Comune di Boccio-leto; rimane inoltre nella memoria storica, tramandata dalla generazione piùanziana, il ricordo di un’altra torba, posta vicino alla chiesa di S. Lorenzo. Inmolte parti dell’insediamento si trovano inoltre resti carbonizzati di tronchi,che lasciano ipotizzare lo scoppio di uno o più incendi che abbiano distrutto leantiche case in legno.
Tetto
Il Tetto è un piccolissimo insediamento, attualmente costituito da due edi-fici, ubicato su un ripido versante incolto degradante verso il T. Cavaione(1291 m), poco distante dalla frazione Seccio e a valle della mulattiera dellaVal Cavaione.
Originariamente l’insediamento era costituito da quattro edifici, ancoracensiti a metà Ottocento nella Mappa Rabbini. I due edifici sono affiancaticon medesima orientazione della linea di colmo, parallela alla linea di massi-ma pendenza del versante, con fronte esposto ad Est; entrambi sono costitui-ti da un basamento in pietra e da un solo piano superiore ligneo a grossi tron-chi uniti ad incastro.
L’edificio a nord è una costruzione a pianta quadrata con un piano infe-riore in pietra e un piano superiore in legno a grossi tronchi non lavorati, conloggiato su due lati (figg. 12-13). L’accesso al piano basale, probabilmente adi-bito a stalla, avviene dal lato sud. Il block-bau al piano superiore è separato dal
32
Fig. 12 - Tetto. Edificio nord
Fig. 13 - Tetto. Edificio nord
ni, 1995, d. 25). La citazione in questi documenti di numerosi microtoponimipermette di stabilire un uso già strutturato del territorio. L’insediamento com-pare poi tra quelli presenti nel 1482 negli atti relativi alla fondazione della par-rocchia di Rimasco (Fantoni e Fantoni, 1995, d. 40).
In un documento del 1538 (ASVa, FNV, b. 10367) sono citati alla Dorca untorbeto sito … ubi dicitur ad torbam de Mutaglis (?) e un’altra costruzione ubidicitur ad torbam Petri. In un documento del 1560 si cita un edificio seu corpusunius domus et torbe, descritto come partim murato et partim a torba (b. 8931).
La torba è citata in Manni (1975, f. IV, p. 184) e descritta in Dematteis(1984, p. 17, f. 17).
L’edificio è posto al margine sudorientale dell’abitato (edificio n. 186 nel-la mappa catastale del comune di Rimasco; n. 313 nella Mappa Rabbini).
La costruzione si sviluppa su tre piani. Presenta un basamento in pietra se-parato da un’intercapedine di circa 60 cm dalla sovrastante parte lignea, intronchi non tagliati, che sul lato a monte raggiunge direttamente il piano cam-pagna (figg. 14-16).
Il piano a terra, costituito da una struttura in muratura relativamente bas-sa, era adibito a stalla. Ai lati, nella metà a monte dell’edificio, sono presentidue appendici in muratura che occupano lo spazio del portico e ne sporgonoper circa 1 metro, originariamente adibite forse a trune.
L’intercapedine è realizzata mediante tre file di tre pilastri svasati, appog-giati su un’incastellatura di tre travi e sostenenti le tre travi longitudinali su cuipoggia il block-bau (cfr. fig. 2).
La parte superiore è costituita da un piano principale, diviso internamenteda una parete trasversale in grosse tavole di legno. La parte anteriore, a cui si ac-cede direttamente da due porte presenti sui lati del loggiato, è ventilata da unagrossa apertura frontale; la parte interna, a cui si accede solo dall’altro vano, pre-senta solo due piccole aperture laterali. Al piano sommitale, corrispondente alvolume compreso tra le falde del tetto, si accede da due botole disimpegnate dascale ubicate sia in posizione interna che esterna (sul loggiato frontale).
Il loggiato si sviluppa su tre lati e presenta una maggiore profondità in po-sizione laterale (circa 150 cm) che in posizione centrale (circa 100 cm) (cfr. fig.8). Sul fronte, ove è articolato in sei moduli (1+4+1), è sostenuto da una colon-na a sezione tonda in muratura di pietra e calce e sormontata da un piatto mo-nolitico, da un tronco in corrispondenza della linea di colmo e da un pilastro inpietra a sezione quadrata.15 I piedritti del loggiato sono costituiti da elementisquadrati. Le pertiche, prima di un recente restauro parziale, erano costituiteda elementi squadrati e da rami, frutto di risistemazioni estemporanee (cfr. fig.17, p. 17 in Dematteis, 1984); nel 1985 sono state sostituite da elementi squa-drati inchiodati esternamente ai piedritti, allineate orizzontalmente e con scan-sione regolare. In origine le pertiche dovevano essere incastonate sul lato in-terno dei piedritti. Su alcuni piedritti del lato NNW sono ancora presenti gli in-
35
basamento in pietra da un’incastellatura di tre travi.A questo piano è presen-te un unico vano, a cui si accede da un larga apertura sul lato a monte (ovest),tamponata lateralmente da due travetti in tronchi che interrompono il block-bau e chiusa al somma da un tronco del block-bau. Le pareti trasversali delblock-bau (sul fronte e sul retro) si arrestano verticalmente all’altezza delle tra-vi grondane, lasciando aperto il timpano. Sul lato frontale è presente un log-giato profondo, a tre moduli (1 + 2); che prosegue, meno profondo, sul lato Sud.I piedritti del loggiato sono costituiti da tronchi di piccole dimensioni non la-vorati. L’orditura del tetto è costituita da tre travi (centrale con due grondane)allineate con i piedritti del loggiato e le pareti del block-bau. Nell’estate del1997 la trave di colmo risultava spezzata, aprendo anche per quest’edificio unprocesso di degrado inarrestabile.
L’edificio a sud presenta, in pianta, una dimensione maggiore. Il basamen-to in pietra, costituente lo zoccolo a corpo pieno della costruzione, alto 150 cmal fronte, è costituito da grosse pietre, che in posizione angolare raggiungonodimensioni metriche. La parte superiore è in grossissimi tronchi; il fianco de-stro, ancora conservato, è costituito solo da sei tronchi. A questo livello la se-zione a monte, parzialmente interrata, è costituita per buona parte da pietra ele pareti del block-bau in legno si prolungano con i due tronchi superiori (didimensioni inferiori a quelli sottostanti) a coprire la parte in pietra. L’ingressoall’unico vano avviene sul lato nord nella parte in pietra e non nel block-bau,fronteggiando direttamente l’accesso alle stalle dell’altra costruzione. Sul latodestro sono ancora visibili piccole aperture di varie dimensioni alla giunzionedei tronchi (vaciarole). L’edificio non presenta loggiato.
I due edifici, che presentano caratteri fortemente arcaici, avevano proba-bilmente funzione separata: civile nell’edificio a sud, completamente chiuso eprivo di loggiato; rurale in quello a nord, aperto nel timpano e con loggiato. Ilcomplesso corrispondeva probabilmente a un unico podere unifamigliare che,ancora nell’Ottocento, costituiva un unico corpo catastale (Mappa Rabbini).La tradizione vuole che l’edificio a Sud servisse da sala consiliare della comu-nità del Seccio, che vi si ritrovava anche per i banchetti nuziali.
Dorca
L’insediamento è posto su un ripiano rilevato circa 300 metri sopra il fon-dovalle della Val d’Egua sul versante idrografico sinistro (1272 m).
La località è citata per la prima volta come Alpis Dorghazie tra le coeren-ze dell’Alpe Ragozzi in un documento del 1420 (Fantoni e Fantoni, 1995, d. 13).A pochi anni dopo risale la prima attestazione di un insediamento permanen-te (in territorio de la Dorchatia sive in comunibus Dorchatie), quando Antonioe Giovanni Scarognini di Varallo investono in perpetuo Albertus filius Antoniide la Dorcha di un appezzamento di terra a prato e pascolo (Fantoni e Fanto-
34
3736
Fig. 14 - Dorca. Edificio 186 (lato NO)
Fig. 15 - Dorca. Edificio 186 (lato SO) Fig. 17 - Priami. Edificio 137 (lato NNE)
Fig. 16 - Dorca. Edificio 186. Colonnain pietra e calce e pilastrini lignei so-stenenti il piano superiore in legno
mente da due travetti, che chiudono il block-bau, e da un tronco del block-baual sommo. Il loggiato si estendeva originariamente su tre lati con una profon-dità di circa 150 cm; recentemente è stato chiuso in lato frontale. L’accesso al-le gallerie laterali del loggiato avviene direttamente dal piano campagna sul la-to a monte. L’orditura del loggiato è costituita da piedritti di tronchi in piccoledimensioni tagliati solo sul lato interno, a cui sono fissate le pertiche, di variasezione. Sul fronte è presente una meridiana. La travatura del tetto è costitui-ta da 5 travi: centrale, mediane (innestate direttamente sul block-bau) e late-rali, con spaziatura non regolare (nettamente maggiore la distanza tra quellacentrale e quelle mediane).
Recentemente, oltre alla chiusura del loggiato frontale, è stato chiuso concemento a vista il lato E, su cui è stato aggiunto un balcone; sul fianco setten-trionale sono state aggiunte varie appendici in muratura.
Balmelle
La frazione sorge su un ripiano (1084 m) rilevato sopra il fondovalle del T.Egua.
L’insediamento compare per la prima volta nel 1482 negli atti di separa-zione della parrocchia di Rimasco (Fantoni e Fantoni, 1995, d. 40). Secondo unatradizione nella frazione esisteva un tempo almeno una torba; altre testimo-nianze citano invece un edificio rurale con assi di legno semplicemente inchio-date su un’intelaiatura di travi.
Molino
La piccola frazione è ubicata sul fondovalle in corrispondenza di un’ansadel T. Egua (~ 1100 m).
L’insediamento è uno degli ultimi documentati in valle, ed è probabilmen-te sorto in epoca tardiva attorno al vecchio mulino appartenente alla famigliaCravatia, residente nella frazione omonima. La frazione non è infatti nomina-ta negli atti di separazione della parrocchia di Rimasco e solo nel 1564 compa-re la località ad Molendinum de la Cravatia (Fantoni e Fantoni, 1995, d. 87).
Alcune testimonianze ricordano che un tempo nell’insediamento esistevauna torba.
Carvaccia
La piccola frazione, attualmente costituita da tre edifici, è posta su un pic-colo ripiano poco sopra il fondovalle del T. Egua (1193 m).
L’insediamento non compare tra quelli citati nell’atto di fondazione dellaparrocchia di Rimasco. Il primo abitante documentato della frazione è Petrus
39
cavi a sezione quadrata per l’inserzione delle pertiche; nel modulo centrale gliincavi presentano una guida che giunge sino al limite del piedritto in modo dafacilitarne la mobilità, agevolando il carico (cfr. fig. 10).
Il tetto è sostenuto da sette travi: centrale, interne (appoggiate ad un tron-co del block-bau), mediane (appoggiate alle pareti del block-bau) e grondane(appoggiate all’orditura dei loggiati). La partitura delle travi corrisponde aquella dei piedritti dei loggiati.
All’inizio degli anni Ottanta la costruzione, divisa tra una ventina di pro-prietari a seguito di successivi frazionamenti ereditari; mancava di manutenzio-ne (Dematteis, 1984). Nel 1985 l’edificio è stato parzialmente restaurato da par-te della commissione “Montagna antica, montagna da salvare” della sezione diVarallo del CAI. Attualmente è saltuariamente utilizzato con funzione rurale.
Priami
La frazione (1030 m) è posta al margine di un ripiano rilevato circa 150metri sul fondovalle della Val d’Egua sul versante idrografico destro, in frontealla frazione Dorca.
L’insediamento, con il toponimo Pariami, compare per la prima volta nel1482 negli gli atti di fondazione della parrocchia di Rimasco (Fantoni e Fanto-ni, 1995, d. 40). Il primo abitante di cui rimane traccia documentaria è Otolinusfilius quondam Pollini de Cantone e loco Paryaymi, attestato nel 1496 (Fanto-ni e Fantoni, 1995, d. 46).Ad inizio Cinquecento sono documentati coloni pro-venienti dalla bassa Val Sermenza (Albertinus, Milanus et Jacobus figli di Pe-trus Comoli Clarini de Fervento (1517,ASVa, FNV, b. 10439) e di coloni prove-nienti da Ca di Zelle originari di Pietre Gemelle.16
Domus, cassine e torbe sono citate a Priami in due documenti del 1579 dicompromesso e di divisione dei beni dei fratelli Antonio e Giovanni Zuccallatra Alberto, Giovanni e Antonio Clarini (b. 8935). La torbam de Gallino a Pria-mi è citata in documenti del 1558 e del 1563 (b. 10448).
La torba è citata in Manni (1980, f. IV, p. 188).La costruzione, marginale e separata rispetto al resto della frazione (edifi-
cio n. 137 nella mappa catastale del comune di Rimasco; n. 1561 nella mappaRabbini), è ubicata nel ripiano a campi e prati davanti all’abitato (fig. 17); inposizione isolata dalle restanti costruzioni era già cartografata in una carta del1759 (cfr. Peco, 1988). Nei prati a nord è quasi accostato alla torba il sedime diun’altra costruzione.
L’edificio presenta il colmo parallelo alla linea di massima pendenza, conil fronte esposto a SSW. La costruzione si sviluppa su due livelli con un pianoinferiore in pietra e un piano superiore in legno, con tronchi non lavorati di di-versa sezione. Danno accesso al vano superiore due porte in posizione analo-ga nelle gallerie laterali del loggiato. Le aperture sono delimitate orizzontal-
38
41
filius quondam Milani Johannis Petri de Manetta, appartenente alla famigliaoriginaria di Piè di Rosso e documentata dal 1531 alla Carvaccia (ASVa, FNV,b. 10366), ove questo ramo della famiglia assunse il nome della frazione.
In un documento del 1544 è citata una torba plodis coperta … in loco de laCravatia (b. 10368).Attualmente non rimane alcuna memoria storica della pas-sata presenza di edifici in legno.
Alpe Selle
L’alpe Selle costituisce un vasto alpeggio ubicato sulla dorsale tra il T. Car-vaccia e il T. Riale. Il gruppo principale di casere sorge su un ripiano a 1473 m.
L’alpeggio era originariamente parte dell’alpe Ragozzi, appartenente al ve-scovo di Novara (Fantoni e Fantoni, 1995, dd. 6, 11, 13-14, 19-20). Dopo il fra-zionamento dell’alpe i diritti di erbatico, trasario e pascolo dell’alpeggio furonoacquistati nel 1566 da Domenicus de la Cravatia (Fantoni e Fantoni, 1995, d. 92).
In un documento del 1544 è citata una torba … in loco de super sellis(ASVa, FNV, b. 10368). L’edificio si trovava probabilmente poco sotto il pia-noro principale, nella località che ancora viene appellato Piano della torba, ovesono ancora osservabili i residui di alcune mura perimetrali in pietra.
Oro superiore
La frazione è ubicata su un poggio rilevato dominante la media Val d’E-gua (1359 m).
L’insediamento compare per la prima volta, con il toponimo Super OroCassiveri, nel 1482 negli atti di separazione della parrocchia di Rimasco (Fan-toni e Fantoni, 1995, d. 40). In tutti gli atti del Cinquecento il toponimo (Superoro) è sempre associato a quello dell’alpe Cassiveri, citata dal 1416 (Fantoni eFantoni, 1995, d. 7), appartenente alla mensa vescovile di Novara (Fantoni eFantoni, 1995, d. 17) e assegnata in investitura a Giovanni Antonio Scarognininel 1443 (Fantoni e Fantoni, 1995, d. 26).
In un documento del 1563 è citata una torba et cassina seu tectum … ubidicitur ad torbam, confinante con la strada comunale (ASVa, FNV, b. 10439).
Attualmente è conservata al centro della frazione, sotto la mulattiera chela attraversa, una sola casa in legno, nota come Turbun. L’edificio (n. 155 dellamappa catastale) presenta il colmo parallelo alla linea di massima pendenza eil fronte esposto a sud. La costruzione presenta un piano basale in pietra e duepiani superiori in legno (figg. 18-18a). Il loggiato si sviluppa sul fronte e sul la-to est; la scansione dei moduli del loggiato è irregolare tra primo e secondo pia-no. Il piano basale, originariamente adibito a stalla, presenta ingressi frontali elaterali (sul lato est). Al primo piano si affacciano sul loggiato una finestra eduna porta; al secondo solo una porta.
40
Fig. 18 - Oro di Ferrate. L’edificio 155 prima della recente ristrutturazione (lato E)
Fig. 18a - Oro di Ferrate. L’edificio155 prima delle recente ristruttura-zione (fronte S)
vanni e Pietro del fu Milano de Petarello (Rizzi, 1983, dd. 54 e 74); nel 1513Antonio, figlio di Pietro (Rizzi, d. 1983, d. 87).
Nel 1540 il Magister Milanus filius Jannis del Molino de Rimella stipulavauna convenzione con Giovanni Ragozzi di Carcoforo per la demolizione di unatorba a Campo Ragozzi (ASVa, FNV, b. 10368)
Nella parte superiore della frazione esistevano un tempo una torba; si trat-ta probabilmente della torba a due piani con fusti squadrati citata a fine Otto-cento da Casaccia (1898, p. 262).
Sul sasso
L’insediamento è ubicato su un terrazzo rilevato dominante la Val d’Eguaa monte di Campo Ragozzi.
Nel territorio di questa frazione, in un documento del 1486, relativo ad unlascito di Guiglius filius quondam Milani de Cenghio alla Confraria Sancti Spi-riti Vallis Selmentie, è nominata la località ad torbatiam (ASPRi, b. 144, c. 1).
Piè di Rosso
La piccola frazione, costituita da cinque abitazioni e da una cappella cin-quecentesca, è ubicata lungo la mulattiera che costeggia il T. Egua tra Ferratee Carcoforo (1223 m).
L’insediamento compare per la prima volta, con il toponimo apud Ros-sum sive apud Rubeum nel 1482 negli atti di separazione della parrocchia diRimasco (Fantoni e Fantoni, 1995, d. 40).A inizio Cinquecento nella frazionesono documentati solo rappresentanti della famiglia Manetta, che nei secolisuccessivi comparve anche alla Carvaccia, ai Casoni e a Carcoforo. La fami-glia discende da Johannes dictus maneta, concessionario delle alpi del vesco-vo di Novara (Fantoni e Fantoni, 1995, dd. 9, 11, 13 19-20), figlio di uno Za-nolo di Pietre Gemelle che potrebbe essere identificato nello Zanolo delGabbio di Pietre Gemelle che già si dichiarava abitante della Val d’Egua inun atto del 1395 (Mor, 1933, c. CXXIV; Rizzi, 1991, c. 85, p. 56; Fantoni e Fan-toni, 1995, d. 3). Negli atti d’inizio Quattrocento il Manetta si dichiara sem-plicemente de Valle Eygue; i documenti quattrocenteschi non indicano la lo-calità della valle, ancora priva di toponimo, ove il Manetta fondò il suo po-dere, ma i numerosi atti della prima metà del Cinquecento indicano chiara-mente la presenza dei suoi discendenti a Piè di Rosso, unica località in cui eradocumentata la famiglia.18
In un documento del 1542 relativo a una divisione di beni tra i fratelli Al-bertino e Pietro Manetta sono citati domus ab igne, tectum e una torba, ubica-ta vicino alla cappella di S. Bernardo (ASVa, FNV, b. 10368).
Nella frazione erano presenti sino al 1990 due edifici in legno (censiti con
43
Sino all’inizio del Novecento l’edificio presentava una copertura in insel-le,17 sottili tavolette in larice note come scandole. L’originaria copertura del tet-to è stata sostituita negli anni Settanta. Recentemente l’edificio è stato ristrut-turato mantenendo la struttura originaria del block-bau ma variando l’orditu-ra del loggiato, già parzialmente compromessa negli anni precedenti.
A fianco di questa casa un piccolo edificio rurale in pietra a secco, notocome Turbun d’Iacumu (154), disposto su due piani ad un solo vano, presenta-va, sino alla sostituzione nel 1997, una copertura analoga.
La torba e l’edificio coperto in scandole si trovano sotto la mulattiera cheattraversa la frazione; in questa parte dell’abitato, probabilmente la parte piùvecchia dell’insediamento, a fianco e sotto queste costruzioni sono presenti ru-deri di altri edifici indicati come residui delle parti basali in pietra di edifici inlegno. Residui di mura perimetrali delle unità catastali 157-158 si trovano incorrispondenza di quella che era un tempo l’antica casa dei Manetta, forse unatorba bruciata a fine Settecento.
Campo Ragozzi
La frazione costituisce un grosso agglomerato ubicato alla base del ver-sante idrografico sinistro della Val d’Egua, presso la confluenza con il T. Porti-le (1197 m).
La prima attestazione documentaria dell’insediamento risale al 1387, quan-do Petrus quondam Petri de Aymoneto de Rimela abitante Campi Regoci ven-de ad Antonius, Zaninus, Johannes et Comolus fratres quondam Martini de Ped’Alagna de Petris zumellis habitatores vallis Rime, per 16 lire imperiali, unapezza di terra in territorio vallis magna ubi dicitur super rivam rogozoli, a cuiconfinano Milano, fratelli di Pietro de Aymoneto, riale regocii e a monte cla-sula (Rizzi, 1983, c. 24; Rizzi, 1991, c. 85, pp. 55-56; Fantoni e Fantoni, 1995, d. 2).
Anche quest’insediamento è chiaramente legato nella toponomastica al-l’alpe presente alle sue spalle, citata a partire dal 1413 (Fantoni e Fantoni,1995, d. 6), appartenente alla mensa vescovile di Novara (Fantoni e Fanto-ni, dd. 8-9, 11, 13-14) e assegnata in enfiteusi nel 1425 a Martinolio della Roc-ca e a Giorgio di Podogno (Fantoni e Fantoni, d. 20). Tra gli enfiteuti dellealpi della mensa vescovile nelle valli Egua e Sermenza compare Jacobus fi-lius quondam Milani Petarelli de Regotio (dd. 9, 19), che in atti successivi sidichiara semplicemente Jacobus Ragocis de Ragocio (d. 20).Al Petarelli/Ra-gozzi, in seguito allo scioglimento dell’impegno di conduzione solidale del-le alpi, furono assegnati i diritti di sfruttamento di metà dell’alpe Rima e diun quarto dell’alpe Egua (d. 20). Alcuni esponenti della famiglia Petarellisono documentati nel Quattrocento in frazioni walser della comunità di Pie-tre Gemelle: Jayni Petarelli è documentato nel 1438 ad apud oltrum (Rizzi,1983, d. 46); nella stessa frazione figurano nel 1468 e nel 1491 i fratelli Gio-
42
45
i nn. 25 e 27 nella mappa catastale del comune di Rimasco), descritti in De-matteis (1984, p. 102, f. 197) e in Fantoni e Ragozzi (1997).
Entrambi gli edifici presentano i colmi paralleli alla linea di massima pen-denza con fronti esposti a est.
L’edificio n. 25 è andato recentemente in rovina. Nell’inverno 1990 il cari-co della neve ha indebolito le strutture portanti del tetto, in condizioni già pre-carie nell’inverno precedente, e nella primavera seguente la vecchia torba pre-sentava il tetto completamente sfondato ed in pochi anni il processo di degra-do è avanzato inarrestabile, lasciando della vecchia casa solo le basi delle mu-ra perimetrali.
Prima del crollo la costruzione era costituita da una costruzione a due pia-ni, con piano basale in muratura e piano superiore in legno (fig. 19). Il pianobasale in pietra presentava due porte al fronte accostate in posizione simme-trica rispetto alla linea di colmo. Le pareti del piano superiore erano in grossitronchi non squadrati di dimensioni uniformi; il lato frontale non presentavanessun’apertura; l’accesso avveniva da un ingresso a piano campagna sul lato amonte (N, fig. 20). Il loggiato occupava il fronte e, con minor profondità, il fian-co sinistro (meridionale). Sul fronte presentava 4 moduli (1 + 3) estremamen-te aritmici. I traversini del loggiato erano fissati internamente ai piedritti. I pie-dritti del loggiato frontale erano in tronchi non lavorati di piccolo diametro ein elementi squadrati (forse di sostituzione successiva) di diversa sezione.
L’orditura irregolare dei moduli del loggiato si rifletteva nell’irregolaritànella travatura del tetto. Le travi stabiere erano a diversa distanza dalla trave dicolmo (e quindi a diverse altezze).Alla stessa distanza dal colmo erano la sta-biera sinistra e la grondana destra. I piedritti arrivano direttamente alle rispet-tive travi, senza l’interposizione di un corrente orizzontale all’altezza della ba-se del timpano. Le travi di colmo e stabiera erano costituite da grossi tronchi;di diametro leggermente inferiore erano quelli delle travi grondane.
La pavimentazione del loggiato è sostenuta da travetti longitudinali sor-retti frontalmente da una trave trasversale sostenuta da un muretto calcinato adestra, una colonna in pietra a secco a sezione quadrata allo spigolo anterioresinistro e da una colonna centrale in pietra calcinata, a sezione tonda legger-mente svasata verso il basso.
Il legno era presente anche nell’edificio n. 27, costituito da due corpi sfal-sati lungo la linea di colmo. Mentre il corpo di destra era interamente in pietranel padiglione di sinistra, sopra un basamento in pietra, il piano superiore è inlegno con uso di grossi tronchi non squadrati, analogo a quello che caratteriz-zava il limitrofo edificio 25. Al piano superiore è presente un piccolo loggiatofrontale sostenuto da una colonna a sezione quadrata allineata con la trave dicolmo. Ad edifici simili potrebbero forse riferirsi alcune citazioni che si trova-no in atti del Cinquecento: in un documento del 1567 compare un edificio ca-psine et torbe partim lapideo muro murate et partim ligneiis constructe nel ter-
44
Fig. 19 - Piè di Rosso. Edificio 25 (lato S)
Fig. 20 - Piè di Rosso. Edificio 25 (lati N e O)
47
ritorio di Rima dove si dice ad tectum della gravina (b. 8933). La separazionetra la parte lignea e la parte murata è forse la stessa esplicitata in altro modoin un documento del 1560 in cui si cita un edificium seu corpus unius domus ettorbe alla Dorca è descritto come partim murate et partim a torba (b. 8931).
L’edificio nel 1997 è stato ristrutturato e in gran parte ricostruito, con pre-gevole attenzione al recupero dei particolari architettonici originali.
Presso Piè di Rosso, in località ad pianellos Manete, nel 1531 era presenteun edificio in legno (tecto buschis seu lignamibus conserto seu constructo), ap-partenente alla famiglia Manetta, a cui confinavano in fundo Aqua Traxinere,ab alia parte riale Regucii (Fantoni e Fantoni, 1995, d. 67). La località è proba-bilmente identificabile con l’Alpe Pianelle, ubicata sul fondovalle della Val d’E-gua, sul lato idrografico sinistro, tra Campo Ragozzi e Carcoforo.Tra le caseretravolte da una valanga nel 1986 non erano presenti costruzioni in legno.
Tetto Minocco
La frazione, appartenente al territorio di Carcoforo, è ubicata nella pianadel T. Egua, a valle della confluenza del T.Trasinera.
L’insediamento è citato per la prima volta nel 1497 (Fantoni e Fantoni,1995, d. 47). I primi abitanti documentati della frazione risultano provenientida Ca di Zelle in Val Sermenza: nel 1497 è documentato Otolinus filius AntoniiMezolini e (d. 47); nel 1517 Milanus filius quondam Johannis Sicide; entrambisi dichiaravano de Cha de Zellis habitator in Tectum de Minocho de Charcofo.
Nella frazione è tuttora presente un edificio in legno (censito con i nn. 400-401-402), recentemente ristrutturato ed adibito a Museo Naturalistico del Par-co Naturale Alta Valsesia. In precedenza apparteneva a diversi proprietari edera adibito ad edificio rurale, con stalla nel piano basale e fienile in quello su-periore.
La costruzione presenta il colmo parallelo alla linea di massima pendenzacon un fronte esposto a sud. L’edificio si distingue da quelli precedentementedescritti per le dimensioni insolitamente ampie, che raggiungono in larghezzail doppio dei precedenti (fig. 21). Sopra il basamento in pietra, con un vano di-simpegnato da un ingresso frontale, è presente il corpo ligneo in grossi tronchinon squadrati (cfr. fig. 3). Sui due lati E e O sono addossate due appendici inpietra, su cui si prolungano le falde del tetto, probabilmente costituenti unachiusura del loggiato originario. L’appendice sul lato O è lunga quanto il block-bau e notevolmente profonda, con la falda del tetto che scende quasi sino alpiano campagna; quella sul lato E non arriva sino al fronte N e sul fronte sudtermina in corrispondenza della bella ed ampia scala in pietra che permettel’accesso al loggiato frontale.
Il loggiato si sviluppa, con una profondità di circa 140 cm, in corrispon-
46
Fig. 21 - Tetto Minocco. Edificio 400-401-402 (fronte S)
Fig. 22 - Tetto Minocco. Edificio 400-401-402 (lato N)
e da altre chiusure (159-160 e 198-199). D’altri due edifici rimane memoria sto-rica (234 e 192).Alcune costruzioni in legno nella parte superiore del paese (incima la villa) furono distrutte dall’incendio del 28 dicembre 1863.20 Tutte le ca-se, con la sola esclusione delle due sommitali, furono ricostruite completamentein pietra. Molte costruzioni furono inoltre abbattute dalle numerose alluvioni.La più devastante fu l’alluvione del 1755, che tirò seco quaranta corpi di case, lequali attualmente s’abitavano, co’ loro mobili, e quantità di bestiami (Boni,1756).21
Un edificio in legno (225) è ubicato nella parte inferiore dell’insediamen-to (in fondo alla Villa); presenta il colmo parallelo alla linea di massima pen-denza e il fronte esposto a sud. La base in pietra e il piano superiore in grossitronchi non squadrati sono separati da un’intercapedine di circa 60 cm di al-tezza, realizzata tramite una serie di pilastrini, che sostengono la travatura delpavimento del piano superiore, allineati sui due lati del block-bau. I pilastrinisono costituiti dalla base di grossi tronchi lavorati ad accetta a dare elementisvasati verso il basso, con pianta di 35 x 20 cm.
L’accesso al piano basale avviene attualmente dal lato E, contiguo ad unadelle vie principali del paese, verso cui è stata anche prolungata una tettoia inlamiera ad estendere il portico, attraverso una porta di recente apertura.
Il loggiato avvolge i quattro lati dell’edificio. In posizione frontale è artico-lato in quattro moduli (1 + 2 + 1). Attualmente piedritti e pertiche presentanoun estremo disordine, frutto di sistemazioni occasionali. L’accesso avviene sullato a monte (N) mediante una breve scala a tre gradini (fig. 23). Sul lato ovestdue larghe porte nel block-bau consentono l’accesso al locale destinato a fieni-le. La struttura del tetto è costituita da 5 travi simmetriche rispetto al colmo.
L’edificio è attualmente utilizzato unicamente con funzione rurale con stal-le e gabbie per piccoli animali al piano inferiore e fienile al piano superiore.
Nella stessa parte dell’insediamento, in corrispondenza dell’edificio at-tualmente presente a SE dell’abside della chiesa parrocchiale (234), esisteva,sino alla seconda guerra, una costruzione con il piano superiore in cui era con-servato sul lato ONO la struttura lignea. La casa era nota come ca d’Tossu (ca-sa del tessitore).
Un altro edificio in legno (185) è ubicato nella parte centrale dell’insedia-mento (in mezzo alla Villa). L’edificio è citato in Dematteis (1984, f. 18, p. 18; f.196, p. 102). L’edificio presenta la stessa orientazione del precedente, con fron-te a schema classico (1+2+1) esposto a sud. Dimensioni e struttura sono similia quelle dell’edificio 255 ma la costruzione si sviluppa su tre livelli ed è privadi intercapedine. Sul lato sud presenta una appendice al piano basale, con unatettoia che si estende sino alla casa a sud. Presenta due piani inferiori in pietra
49
denza del fronte, esposto al sole del mezzogiorno e all’asse vallivo. L’orditura,rifatta in occasione della recente ristrutturazione, è costituita da piedritti e dapertiche incastrate nei piedritti. Prima della recente ristrutturazione le perticheerano inchiodate esternamente ai piedritti.
La continuità lignea della facciata è interrotta da due muri in pietra a sec-co, ubicati in posizione centrale e allo spigolo SE, che arrivano a sostenere letravi di colmo e grondane, da una colonna a sezione tonda, che arriva sino alpavimento del loggiato. L’accesso al piano basale avviene attraverso una por-ta che disimpegna il corpo centrale e attraverso altre due porte che disimpe-gnano l’appendice sul lato O. L’accesso al loggiato è costituito da un’ampia sca-la curva all’angolo SE (cfr. fig. 4). L’accesso ai locali del piano superiore avve-niva attraverso una gran porta a due ante alte 160 cm, ubicata al centro del la-to frontale, e attraverso una serie di porte, aperte direttamente al piano cam-pagna, sul lato a monte (fig. 22).
La distribuzione delle travi del tetto è asimmetrica: due travi sono acco-state in posizione di colmo, mentre le travi mediane occupano diverse posizio-ni rispetto alle pareti del block-bau.
Un’altra costruzione in legno, che era presente sino agli anni Cinquanta, èstata demolita per costruire un moderno condominio (edificio 412). Si trattavadi un grande edificio in legno e pietra con struttura e planimetria simili a quelledell’edificio 400-401-402, ma sviluppato su tre piani (due in pietra e uno in le-gno). La vecchia torba, nota come Ca del Sarzin, è osservabile in una fotografiadel 1932.
Altre case in legno furono probabilmente distrutte durante l’alluvione del1755.
Carcoforo
Il villaggio costituisce un grosso insediamento compatto ubicato a montedella confluenza del T.Trasinera nel T. Egua (1304 m).
La prima attestazione dell’insediamento risale al 1462, quando sono docu-mentati alcuni coloni di Carcoforo che sfruttano beni degli Scarognini (Fanto-ni e Fantoni, 1995, dd. 32-33); nello stesso anno un testatore si dichiarava deOtro habitator Carchofi (d. 33a). Il villaggio è poi citato nell’atto di separazio-ne della parrocchia di Rimasco del 1482 (d. 40).
Numerosi documenti del Cinquecento, alcuni dei quali relativi alle riunio-ni assembleari degli uomini della comunità, sono rogati in strata pubblica ante(o apud) torbam heredum Petri de Jacho (1566, b. 10448; 1577, b. 8937).
La presenza di torbe a Carcoforo è citata da Dematteis (1984, p. 18, f. 18).Nel paese sono attualmente presenti due edifici in legno (225 e 182).Altri dueedifici in legno sono quasi totalmente mascherati da tamponamenti in pietra19
48
51
e piano superiore in legno, circondato da loggiato su 4 lati. L’accesso al loggia-to avviene sul lato a monte (N), mediante una breve scala in posizione centra-le a 3 gradini (fig. 24). Un’altra scala accede al loggiato sullo stesso lato in cor-rispondenza della galleria laterale del loggiato. L’accesso al locale superiore av-viene dallo stesso lato attraverso un’apertura del block-bau attualmente privadi porte. L’orditura del loggiato è attualmente irregolare e costituita prevalen-temente da pertiche inchiodate internamente ai piedritti.
Nel 1995 il comune di Carcoforo ha rifatto il tetto in piode e posto sullacostruzione il vincolo di interesse storico ed artistico come casa walser.
In questa parte dell’insediamento, nel luogo ove fu costruito ad inizio No-vecento l’edificio in pietra ospitante sino agli anni Ottanta un albergo (192),era presente un altro edificio in legno, ancora visibile in una fotografia succes-siva al 1865 e in un disegno di Vallino (1878).
Nella parte superiore dell’abitato (in cima la Villa) sono presenti due edi-fici in legno con tamponamenti in muratura. L’edificio 160-159 presenta il pia-no superiore in grossi tronchi (analoghi a quelli degli altri edifici) rivestitoesternamente in pietra. La costruzione ha orientamento, dimensioni e struttu-ra uguale a quella dei due edifici descritti in precedenza. Internamente è an-cora presente il legno del block-bau sul lato ovest, mentre sul lato est è statorecentemente rimosso; il loggiato oginariamente presente sul fronte (S) è at-tualmente chiuso con tamponature a graticcio e presenta nuovi balconciniesterni. L’accesso al piano superiore, adibito a fienile, avviene ancora attual-mente da due porte sul lato nord. Il piano inferiore era adibito a cucina, stallae cantina. Davanti alla casa è ancora ben conservata la curte.
L’edificio 198-199 presenta, ancora osservabile, il lato N e parte del lato Edel piano superiore in legno in grossi tronchi analoghi a quelli delle altre co-struzioni (fig. 25). Sul lato E è stata aggiunta una appendice muraria in corri-spondenza della galleria del loggiato; internamente sono ancora presenti le pa-reti in legno anche su questi due lati.
Nella località alle Torbe, situata presso la cappella omonima presente im-mediatamente a monte del villaggio,22 esistevano sino ad alcuni decenni fa i se-dimi di alcune costruzioni; le pietre vennero utilizzate nel primo Novecento perla costruzione del muraglione a monte. I sedimi potevano corrispondere ad edi-fici rurali, probabilmente in legno, collocati al margine dell’insediamento. Sitratta probabilmente della località citata come superius torbas (1568, b. 8931)o come ad torbas superius tecta Carcoffori nel 1558 e nel 1567 (Fantoni e Fan-toni, d. 93; b. 10448). In una Notta delli prati della seconda metà del Seicento fi-gura un prato chiamato alle torbe confinante con la strada delle torbe (ASPCa,b. 121, c. 33).
50
Fig. 23 - Carcoforo. Edificio 225 (lato N)
Fig. 24 - Carcoforo. Edificio 152 (lato N)
L’insediamento corrisponde probabilmente alla località ancora priva di to-ponimo della valle di Rima ove nel 1395 risultavano insediati Perotus filiusquondam Zanini Rave e Johannes filius quondam Petri Rave de Petris Gemel-lis (Fantoni e Fantoni, 1995, d. 3).
Nella frazione sono presenti due edifici in legno, riprodotti senza indica-zione geografica in Ciribini (1943, p. 96, t. 40). Entrambe le costruzioni, af-fiancate e parallele, presentano le linee di colmo parallele al pendio e fronteesposto a SE; si sviluppano su due piani, con basamento in pietra e piano su-periore in legno (fig. 26). L’edificio a sud (fig. 27) presenta un loggiato avvol-gente sviluppato su quattro lati; la sezione frontale è articolata in quattro mo-duli (1 + 2 +1). I piedritti laterali del loggiato, che sostengono le travi gronda-ne, sono disposti a sbalzo. Prima della ristrutturazione l’orditura minuta eracostituita da listelli e rami di probabile sistemazione occasionale, fissati inter-namente ai piedritti. Dopo la ristrutturazione le pertiche sono state incasto-nate nei piedritti, adottando una scansione simile a quella del settore meglioconservato del loggiato originario.
La costruzione a nord presenta il loggiato al piano superiore solo in posi-zione frontale, a due moduli, con orditura analoga a quella dell’edificio limitrofo.
Entrambi gli edifici sono stati ristrutturati nel 1990, conservando le origi-nali volumetrie, i materiali e le modulature dei loggiati.
Pietre Marce
La frazione è ubicata sul fondovalle del T. Sermenza (1223 m), tra i centriparrocchiali di S. Giuseppe e di Rima.
In un documento del 1657 (ASVa, FNV, b. 9884) è citato un techiallo ... par-te murato et parte torbato … ubi dicitur il techiallo de torbis e in un documentodel 1725 è citata una località ubi vulgo dicitur il Prato delle torbe (ASVa, FNV,b. 8984).
Rima
Il villaggio costituisce un grosso insediamento compatto ubicato alla te-stata della Val Sermenza (1411 m).
La letteratura valsesiana e la letteratura specializzata attribuiscono una-nimemente la prima attestazione di Rima come insediamento permanentead un documento del 1387 in cui sono citati Antonius, Zaninus, Johannes etComolus fratres quondam Martini de Pe d’Alagna de Petris Zumellis habita-tores vallis Rime (Rizzi, 1983, c. 24; Rizzi, 1991, c. 85; Fantoni e Fantoni, 1995,d. 2). In realtà i fratelli si dichiarano semplicemente abitanti della valle di Ri-ma e il documento non chiarisce quale sia la località, ancora priva di toponi-mo, di questa valle. L’arrivo più consistente di coloni avvenne comunque tra
53
Nella parte superiore dell’insediamento esistevano probabilmente altrecase in legno, distrutte dall’incendio del 1863 e successivamente ricostruite inpietra.
In Cima al Rivetto
La frazione è ubicata nel territorio di Carcoforo, in cima ai prati sul latoidrografico sinistro del T. Egua.
Sino agli anni Cinquanta del secolo scorso era presente una costruzionecon piano superiore in legno, abbattuta per costruire una nuova casa in pietra(216). L’edificio, disposto con il colmo parallelo alla linea di massima penden-za e fronte a sud, era composto da due piani; nel piano inferiore si trovavanostalla, stufa e una camera; al piano superiore il fienile.
A monte dell’edificio 220 esisteva un altro edificio con piano superiore inlegno, con struttura e orientazione analoghi a quelli dell’edificio 216.
Ca Ravotti
La piccola frazione, costituita da tre case e una cappella, è ubicata sul ver-sante idrografico destro della Val Sermenza (~ 1080 m), poche centinaia di me-tri a valle del centro parrocchiale (S. Giuseppe).
52
Fig. 25 - Carcoforo. Edificio 198-199
la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento, in seguito a un contratto dilocazione enfiteutico collettivo che si può ritenere l’atto di fondazione dellanuova colonia. Un primo gruppo di coloni che sfruttava l’alpe Rima, omnesde Petris Zemellis, è già documentato a partire dal 1383 (Fantoni e Fantoni,1995, d. 8); nel 1421 il gruppo è esteso a dieci persone, tutte chiaramente pro-venienti dalle frazioni walser di Alagna, alcune delle quali si dichiarano giàhabitator Rime: Johanes filius quondam Milani Ferari de Pedalagne, Petrus fi-lius quondam Johannis de Goreto de Pedalagne, Johanes filius quondam Al-berti de Roncho, Guidetus filius quondam Jacobis de Goreto, Antonius filiusquondam Johannis de Goreto de la costa, Bartolomeus filius quondam Petride Roncho habitator Rime, Johannes filius quondam Milani de Merletis habi-tator Rime, Milanus filius quondam Johannis de Loro, Antonius filius quon-dam Petri de Loro et Bartolomeus filius quondam Janne Johannis de Loro(Fantoni e Fantoni, 1995, d.16).
La presenza di edifici in legno a Rima è menzionata in Dematteis (1984,p. 101, f. 195), Mornese (1995, pp. 54-55),Axerio (2000, p. 42).
Nel villaggio sono presenti cinque torbe; quasi tutte le costruzioni sono sta-te ristrutturate con particolare attenzione alla conservazione della struttura ori-ginale. Tutti gli edifici sono ubicati nella parte centrale dell’insediamento (tredi loro sono allineati longitudinalmente) e presentano le linee di colmo paral-lele alle curve di livello (in direzione ONO-ESE).
La costruzione più orientale (45) presenta un basamento in pietra nel pia-no inferiore, leggermente rialzato rispetto al piano campagna, e in un piano for-temente interrato, accessibile solo dall’angolo SE, alla minima quota topografi-ca. Su questo lato presenta un loggiato anche al piano campagna (fig. 28), sor-retto da bassi pilastrini litici (fig. 29). Il piano superiore è in legno ed è circon-dato da un loggiato sviluppato su tre lati e caratterizzato in posizione frontaledalla presenza di cinque moduli (1+3+1). Il loggiato forse si estendeva origina-riamente su quattro lati, con un secondo fronte sul lato ONO, secondo uno sche-ma diffuso nelle altre costruzioni dell’insediamento. Lo spazio tra questa torbae un altro edificio in legno presente lungo lo stesso asse è infatti attualmente oc-cupato da una costruzione più recente in muratura. L’accesso al loggiato avvie-ne attraverso un’ampia scala ad andamento ricurvo nella parte alta (cfr. fig. 5).
Il block-bau è costituito da grossi tronchi di dimensioni irregolari; le paretilongitudinali sono sostenute da due grossi semitronchi (con diametro di circa 60cm) disposti con la parte piatta in posizione inferiore. La distribuzione delle tra-vi del tetto coincide con quella dei piedritti presenti sul loggiato frontale.
La casa è stata ristrutturata nel 1990, data incisa sull’architrave ligneo del-l’accesso sul lato sud.
Lungo lo stesso asse è presente un’altra costruzione in legno (edificio47). L’unico fronte conservato, sul lato ONO, presenta una parziale chiusu-
5554
Fig. 26 - Ca Ravotti
Fig. 27 - Ca Ravotti. Edificio sud
ra dovuta alla sovraimposizione di un’appendice, coperta da uno spioventedel tetto ortogonale alle altre due falde. Su quest’appendice è presente unpiccolo loggiato caratterizzato dalla persistenza di pertiche incastonate in-ternamente ai piedritti con soluzioni analoghe a quelle descritte per la tor-ba della Dorca.
Sopra al piano basale in pietra è presente un unico piano realizzato in gros-si semitronchi, che sul lato sinistro a monte (NNE) appoggiano direttamentesul piano campagna.Anche in questo edificio le pareti longitudinali del block-bau sono sostenute da due grossi semitronchi (diametro di circa 60 cm) dispo-sti con la parte piatta in posizione inferiore.
È l’unica costruzione di Rima a non essere interessata da ristrutturazionirecenti.
Lungo lo stesso asse, oltre un piccolo spiazzo, è presente un’altra torbacompletamente ristrutturata (edificio 48), che presenta un basamento inpietra e un piano superiore in legno. La costruzione, che risulta l’unica adessere rimasta libera su quattro lati durante l’infittimento edilizio avvenu-to nei secoli successivi, è caratterizzata dalla presenza di due fronti; conesposizione a ESE e a ONO. L’edificio presenta un loggiato avvolgente, chepresenta quattro moduli sui fronti (1 + 2 +1) e in, corrispondenza del fron-te ESE, raggiunge profondità superiori ai due metri (figg. 30-31); sul latoSSE il loggiato, parzialmente chiuso, è sostenuto da piedritti lapidei. L’or-ditura del tetto è costituita da cinque travi, parzialmente sostenute da gros-si tronchi ricurvi (fig. 31), secondo un modello diffuso tra le costruzioni diRima (cfr. fig. 28).23
Un’altra torba è ubicata lungo un allineamento più settentrionale di co-struzioni (edificio 43). Attualmente presenta un solo fronte, esposto a ONO(fig. 32). Sopra al piano basale in pietra è presente un piano caratterizzato dal-la presenza di pietra sul lato ESE e da tronchi di dimensioni irregolari, che di-vengono tendenzialmente più piccoli verso l’alto, sugli altri lati. Sul fronte èpresente un’appendice, limitata al piano basale, con tetto ad un solo spioven-te. Lo sviluppo del loggiato è stato probabilmente modificato rispetto alla ori-ginaria configurazione avvolgente dalla costruzione di un’altra casa sorta par-zialmente in adiacenza; in posizione frontale quattro moduli (1+2+1). L’edificioè stato ristrutturato nel 2000 senza interventi strutturali.
Lungo un altro allineamento è presente l’edificio 59-60, attualmente inristrutturazione. La costruzione presenta uno sviluppo in altezza anomalo,raggiungendo i quattro piani, grazie alla maggiore ripidità del pendio. I trepiani inferiori sono in pietra; solo il piano superiore, che sul lato NNO par-te direttamente dal piano campagna, è in legno. Il loggiato, originariamenteavvolgente, è stato chiuso con tamponature in muratura sul lato a monte(NNO). I piani sono disimpegnati da scale in legno interne al loggiato sul la-to SSE.
5756
Fig. 28 - Rima. Edificio 45(loggiato al piano campa-gna)
Fig. 29 - Rima. Edi-ficio 45 (pilastrinilitici di sostegno alloggiato)
MODELLI A CONFRONTO
Gli edifici in legno conservati nelle valli Egua e Sermenza presentano ca-ratteri generalmente ritenuti arcaici: numero limitato di piani, impiego di ma-teriale non sgrossato, distribuzione limitata, irregolare e non uniforme dei log-giati. Tutte queste costruzioni sembrano essere precedenti al modello alagne-se più diffuso e tuttora conservato, risalente al periodo della riedificazione del-le domus nove del Cinquecento e Seicento, quando un nuovo schema costrut-tivo fu normalizzato in funzione di nuove esigenze abitative e fu perfezionatoda una affermata scuola di maestri costruttori.
Le costruzioni esaminate sono invece confrontabili, per modalità di utiliz-zo dei materiali, per numero di piani e per l’adozione di un’intercapedine, conle più antiche case alagnesi, identificate dalla letteratura in un edificio al Ron-co Superiore (Giordani, 1890, p. 10; Mesturino, 1960; Rizzi, 1992, p. 204; Magu-gliani, in AA.VV., 1996, pp. 34-35) e con alcuni edifici delle frazioni alte dellaVal Vogna.Ad Alagna sono infatti poche le case antiche. Secondo i dati ripor-
5958
Fig. 30 - Rima. Edificio 48 (fronte ESE)
Fig. 31 - Rima. Edificio 48 (fronte ONO)
Fig. 32 - Rima. Edificio 43(fronte ONO)
Le prime case coloniche (Trecento e Quattrocento)
Alcune costruzioni censite nelle valli Egua e Sermenza possono essere con-siderate indicative del modo di costruire in legno nelle alte valli del Sesia in unperiodo prossimo a quello di fondazione delle colonie. Caratteristiche comunia questi edifici è il limitato sviluppo in altezza (due o al massimo tre piani), lapresenza negli edifici rurali di intercapedini tra basamento e piano superiore inlegno e l’utilizzo di materiale ligneo non lavorato. Quest’ultimo elemento, spes-so sottolineato dalla letteratura specializzata, era noto ed assimilato nella me-moria storica degli abitanti di queste valli. Casaccia (1898, p. 259), fissando que-sta memoria, scriveva che le costruzioni più antiche erano costituite da “baite inrozzo legname”, successivamente sostituite da costruzioni con fusti squadrati (p.262).
La presenza di edifici con e senza intercapedine, funzionali rispettivamen-te all’aerazione di vani destinati all’immagazzinamento delle risorse agricole eal riscaldamento dei vani adibiti al pernottamento, indicherebbe la presenza inquesto periodo di edifici separati, destinati rispettivamente all’uso rurale e aquello civile.
Caratteristica di questi edifici era, secondo Casaccia (1898, p. 262), la pre-senza di un focolare aperto, appoggiato direttamente sul pavimento della stan-za e collocato in posizione centrale.26 Le stanze non avevano sistema d’aspira-zione; il fumo era libero di espandersi nel locale e veniva dissipato dalle aper-ture delle pareti (finestre e porte), dalle fessure dei muri a secco e dalle piodedel tetto.
Gli ambienti con focolare libero, ancora ampiamente diffusi ad inizio Ot-tocento, venivano descritti dal canonico Sottile (1817, pp. 36-37):“il focolare èin mezzo, ed una piccola finestra, che dà luce, serve anche all’uscita del fumo”.Per mitigare l’effetto del fumo la famiglia stava “seduta in giro attorno al granfuoco, in mezzo a turbini di fumo, che punto non l’incomoda, perché seduta so-pra panche assai basse” sfruttando la stratificazione dell’aria. Il locale che ospi-tava il focolare, solo in parte equiparabile alla moderna cucina, è ampiamentecitato negli atti notarili come domus ab igne.27
Dal fuoco libero al camino
Una tappa intermedia nel processo di transizione tra fuoco libero e cami-no viene identificata da Casaccia (1898, p. 263) nello spostamento del focolareverso le pareti d’ambito,28 generalmente associato ad un rialzo del fuoco, chenon ha necessariamente comportato l’immediata comparsa di diverse moda-lità di dissipazione del fumo. Inoltre in molte località l’introduzione del cami-no è stata preceduta dall’apertura di uno sfiato a parete.29
Il camino, costituito da una cappa montata sopra il fuoco per incanalare ilfumo nel condotto che esce all’esterno tramite il comignolo sul tetto, introdus-
61
tati in Daverio (1985) su duecentodieci case con date, solo sei presentano datecomprese tra 1500 e 1550; venticinque tra 1550-1600.24 Una casa datata 1541in tronchi tondi e fronte asimmetrico è presente a Casa Giacomolo. Fronteasimmetrico ha anche un’altra costruzione del Cinquecento a in d’Ekku (1568).Alla Rusa una costruzione compatta ed irregolare a fronte 1+2+1 è datata1543.Ai Merletti sono presenti case in grossi tronchi datate 1590 e 1646 (in unfienile-granaio rialzato). A Goreto Daverio cita come casa più antica una co-struzione che presenta il piano del fienile staccato dalla parte sottostante conun’intercapedine aerata mediante bassi piedritti in legno. Case con soluzionisimili sono presenti anche al Ronco superiore e ai Merletti in una casa a gros-si tronchi datata 1646 (con pertiche a rami inchiodati ai montanti e fronte1+2+1 a larghe campate).
Le costruzioni delle valli Egua e Sermenza presentano inoltre una estre-ma diversificazione, probabilmente attribuibile proprio all’età precoce degliedifici, che risulterebbero antecedenti all’affermazione di un modello stabile.La diversificazione potrebbe inoltre essere legata all’estrema differenziazionedella provenienza dei coloni di queste valli e alla loro conseguente diversa ere-dità culturale. L’antichità delle case si correlerebbe con la probabile presenza diedifici con funzioni separate, generalmente ritenuti antecedenti a quelli confunzioni riunite, secondo un modello evolutivo discusso nei capitoli successivi.
Il confronto tra le poche costruzioni conservate nelle valli Egua e Ser-menza e quelle presenti in Val Grande (Alagna e Riva) e in Val Mastallone(Rimella) evidenzia le differenze esistenti tra le diverse aree ma anche quelleesistenti all’interno delle singole zone. La definizione del tipo costruttivo deveavere quindi precisi riferimenti temporali e spaziali; e su questa base va impo-stato un attento esame delle modalità di variazione spazio-temporale dei mo-delli costruttivi. L’evoluzione della tipologia edilizia nelle alte valli del Sesia haregistrato eventi sincroni (innalzamento, variazioni nei locali da fuoco) edeventi diacroni (abbandono dell’uso del legno nelle valli Egua e Sermenza ead Alagna), talora dilatati nel tempo all’interno della stessa comunità (l’ab-bandono del legno ad Alagna).
EVOLUZIONE DELLA TIPOLOGIA EDILIZIA IN ALTA VALSESIA
Sulla base delle testimonianze di cultura materiale, dell’analisi documen-taria e della memorialistica ottocentesca, che fissava la memoria storica (Gior-dani, 1891; Casaccia, 189825) o forniva particolari di cronaca (ms. Filippa, in Si-billa, 1985, pp. 95-182), è possibile delineare l’evoluzione della tipologia co-struttiva in alta Valsesia, distinguendo caratteri e cambiamenti coevi in tuttal’area e identificando i tempi dei processi diacroni.
60
documentata nel 1526, quando la casa apparteneva al notaio Antonio de Beto(p. 281b). Nel 1525 compare una stuva magna (p. 277). Nel 1549 compare unastuva scriptori nella casa del notaio Johannes Jacobi de Grande (d. 341; nel 1550,d. 343); successivamente appartenuta al notaio Petrus de Grande (1556, d. 356;1559, d. 358); un’altra stuva scriptori compare pochi anni dopo anche nella ca-sa di un altro notaio di Riva, Petrus de Clarino (1555, d. 351).
Nello stesso periodo l’area di distribuzione della stufa raggiungeva anchegli insediamenti della media valle. A Piode una stupa è documentata nel 1527nella casa di Battista de Nigro (p. 280); a Quare è attestata una stuva in domusnova nel 1548 (SID, b. 16, d. 340); a Campertogno è citata una stuva nella do-mus Zanini de Arienta nel 1578 (d. 371).
Anche nelle valli Egua e Sermenza le prime attestazioni di locali con stu-fe si trovano nelle case di notai. Numerosi atti del notaio Nicolao Mognetti del-la prima metà del Cinquecento sono rogati nella stuva della casa del padre Bet-tone a Rimasco (ASVa, FNV, b. 10448). Ma nel Cinquecento si diffondono ra-pidamente in tutta la valle: nel 1535 è documentata una torba cum stuva a Ri-ma ubi dicitur ad torbam illorum de Vyoto e una domus ab igne cum suo stu-veto ad domum veterem quondam Antoni Vioti (b. 10366; successivamente ci-tata nel 1563, b. 8931). Sempre a Rima un atto del 1546 è rogato in stuva Petrifilius quondam Antoni de la Vidua (b. 10368).
In un documento del 1562 è attestata una stufa cubiculari nella casa di Gio-vanni Maria Zamboni di Ca Forgotti (b. 10620). Nel 1567 è attestata una casacum stufiis a Campo Ragozzi (b. 8931). A Carcoforo in un inventario di benidella famiglia Peracini compare nel 1568 una casa cum duabus stuffis una superaliam (b. 8931). Nel 1576 ad cassina nova compare una domus cum stupha (b.8937); nello stesso atto, una divisione di beni tra i figli di Giovanni Silvestro Ra-gozzi, compare già una stupha vetere. A Rima una stuffa è indicata nella casaAxerio nel 1574 (b. 10620) e una stuva nel 1563 a casa Viotti (b. 8931). Una do-mus ab igne cum stufa a Fervento nel 1559 (b. 8931).
In un documento del 1637 (ASVa, FNV, b. 9884), relativo ad un edificio diPietre Marce, è esplicitata la presenza del fornetto nel locale (stupha cum unofornetto). In un documento del 1720 relativo al mulino di Priami è descritta unastupha annexa et fornello intus (b. 8992); analogamente si trova una stuffa conil suo fornetto in una casa sul Sasso in Val Vogna nel 1690 (SID, Fca, b. 17, dd.157.158).
In alcune località l’introduzione della stufa sembra avvenire parallela-mente alla sopraelevazione degli edifici documentata a fine Cinquecento; nel1595 è documentata una convenzione per l’inserzione di un piano adibito astupha tra la casa da focho e la torba a Villa inferiore di Rimella (Pizzetta, 1996,d. 3, pp. 15-16). Nel 1601 è documentata un’altra sopraelevazione alla Sella di
63
se l’aspirazione del fumo.30 La sua introduzione sembra essere relativamentetarda. A Rimella, ad esempio, è documentata nella seconda metà del Sette-cento. In un atto del 1769 è citata una lite per un camino appena costruito inuna casa della frazione Sella ed altri due erano già presenti in altre case dellastessa frazione. Un atto di vendita di una casa al Rondo del 1770 riguarda unacasa nova con camino (Pizzetta, 1999).
L’introduzione del camino e del sistema di aspirazione servì a liberare lastanza dal fumo ma aumentò la dissipazione del calore, rendendo ancora piùfreddo l’ambiente.
L’introduzione della stufa
Con l’aumento delle volumetrie offerto dalle domus nove, edificate a par-tire dal Cinquecento, iniziò ad affermarsi l’uso della “stufa”,31 un locale riscal-dato dal fornetto, una struttura in lastre di pietra ollare, generalmente colloca-to contro la parete divisoria con la domus ab igne. La comunicazione con il lo-cale ospitante il focolare permetteva l’alimentazione, tramite uno sportello si-tuato in corrispondenza del camino, con la brace del camino. Il riscaldamentoavviene per irraggiamento del calore dalle lastre arroventate.32
L’invenzione della stufa,33 e di stanze di soggiorno riscaldate senza fuoco li-bero, risale all’inizio del millennio. La sua presenza in Baviera è documentatanel Duecento nei canti del poeta popolare Neidhart von Revental (Rizzi, 1992,p. 209; 1996, p. 61). Nell’area alpina meridionale la più antica documentazionedi una stufa risale ad un documento del 1328 relativo al territorio dell’attualeCortina d’Ampezzo.34 Nell’area walser la prima attestazione risale al 1372,quando la comunità di Bosco Gurin acquistò quattro case con stufa nel territo-rio di Cevio da Filippo Marzollo di Cevio (Rizzi, 1991, d. 163, p. 107; 1996, p. 62).
La prima comparsa di questo ambiente in atti riguardanti la Valsesia risa-le al 1456, quando è citata la stuffa habitationis domini presbiteri Milani de Mo-rondo nella frazione alagnese della Rusa (SID, FCa, b. 15, p. 106). Dalla finedel Quattrocento le stufe sono poi ampiamente diffuse in tutto il territorio diPietre Gemelle. Nel 1483 è citata una stupha nella casa di Zanolo Ferrari delRiale di Alagna (p. 153). A Supra Rippam nel 1495 una stufa è documentatanella casa del padre del notaio Bartholomeus de Beto (p. 176; nuovamente ci-tata nel 1497, 1499 e 1518, pp. 180; 185, 246). Nello stesso periodo nell’abita-zione del notaio Petrus de Clarino si rogavano ancora atti in domo ab igne(1473, p. 133; 1480, p. 150). Una stufa è documentata nel 1498 a Pedis Alanie(pp. 181-182; nuovamente documentata nel 1499, p. 184). Una stupa aveva an-che la domus comunis ad Alagna (1519, p. 249; 1520, p. 257; 1521, p. 260).35
Nelle case di Riva le stuve erano talora duplicate e differenziate. Nel 1495e nel 1497 (SID; FCa, b. 15, pp. 176, 180) nella casa del padre del notaio Bartho-lomeus de Beto de Supra Rippam compare una stupha superiori, nuovamente
62
A fianco delle domus nove comparve negli atti della seconda metà del Cin-quecento la definizione di domus veter. In un documento del 1562 sono citatiedifici novi ed edifici veteri alla Munca (b. 8931). Una domus ab igne veteris ècitata in una divisione di beni tra gli eredi di Zanino de Viotto di Pietre Marcedel 1567 (b. 8931). In una divisione di beni alla Dorca la casa assegnata al se-condo figlio è detta ad domum veterem (b. 8931). Un atto del 1567 è stipulatoa Rimasco in porticu domus veteris Betoni Milani Mogneti (b. 8931), citata co-me tale ancora nel 1578 (b. 8934).
Il processo di trasformazione delle abitazioni è ben documentato a Ri-mella, dove gli atti notarili della fine del Cinquecento attestano variazioni so-stanziali delle vecchie case, con sopraelevazioni (a 3 o 4 piani), aggiunte, di-visioni interne. Nel 1595 è documentata una convenzione per l’inserzione diun piano adibito a stupha tra la casa da focho e la torba a Villa inferiore diRimella (Pizzetta, 1996, d. 3, pp. 15-16). Nel 1601 è documentata un’altra so-praelevazione alla Sella di Rimella con l’inserimento di stupha e stuphetto(Pizzetta, 1992, p. 282; 1996, d. 4, p. 16). Nella convenzione36 il maestro co-struttore si impegnava di levar il tetto di detta torba et torbetto sino sopra lemura de la casa da foco, et doppo sopra esse mura a, loco odove hora è la tor-ba et il torbetto fare construere et fabricare una stupha et stuphetto conformeal solito di esso loco di Ramella et sopra questa stupha et stuphetto poi collo-care e sue debite torba et torbetto coprendoli poi laudabilmente et honorevol-mente di debita copertura di piode con le dovute sue logge (Pizzetta, 1995, p.282; ASVa, FNV, b. 1790). Negli stessi documenti è registrata la contempora-nea aggiunta di loggiati. Le sostituzioni di case vecchie, la costruzione di nuo-ve case, l’introduzione di modifiche, ampliamenti e rifacimenti di case già esi-stenti sono ampiamente documentate negli atti del notaio rimellese Emilia-no Calcino tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento (ASVa, FNV, b.1790). Le case vecchie, cadute in disuso, venivano ridotte a sedimi su cui ri-costruire nuovi edifici riutilizzando talora materiale di recupero dei vecchiedifici (Pizzetta, 1996, p. 13). Un esempio ancora conservato di domus vete-ris e di domus nova accostate è costituito dalle case Robbo alla frazione Sel-la (Pizzetta, 1999), dove ad una casa a tre piani venne appaiata una casa a 4piani; il piano aggiunto, destinato a separare la cascina dalla cucina, è in pie-tra, come in altre due case della frazione Sella. La casa, datata 1593, presen-ta la struttura a block-bau avvolta da una cintura muraria (Remogna, 1993,p. 27; Pizzetta, 1993, p. 273).37
Negli atti della metà del Cinquecento sono inoltre citati sedimi di case, in-dicati nel dialetto valsesiano dalla voce “seccio”. In un documento del 1531 è ci-tato un sethium situm in loco de super Oro (b. 10366).Alcune case sono derupteper nivem (domo illorum de Zanoletto a Rima nel 1563, b. 8931).Alcuni di que-sti sedimi erano già recuperati come orti (petiam terre orti sitae in medietate
65
Rimella con l’inserimento di stupha e stuphetto (Pizzetta, 1995, p. 282; 1996, d.4, p. 16). In questa configurazione però la stufa non trova posto nel locale atti-guo a quello ospitante il fuoco libero (o del camino).
Negli atti tardomedievali in domo ab igne designava non solo l’intera casama anche la stanza per eccellenza. Questa associazione fu successivamente so-stituita con il locale che ospitava la stufa: domo seu stuva (ad esempio in un do-cumento del 1498 relativo a Pedis Alanie; SID, FCa, pp. 181-182, 184). Infattinella gestione del calore nelle case di abitazione l’impatto della stufa e l’intro-duzione di un locale completamente privo di fumo ebbe un’importanza netta-mente superiore a quello dello spostamento del focolare verso pareti d’ambi-to e dell’introduzione del camino. Le attestazioni documentarie indicano inol-tre che l’introduzione della stufa non fu successiva a quella del camino; en-trambi i fenomeni furono relativamente dilatati nel tempo e in molte localitàl’introduzione della stufa precedette lo spostamento verso pareti laterali delfuoco e l’introduzione del camino.
Le domus nove (Cinquecento)
Una variazione sostanziale della tipologia edilizia si realizzò durante il Cin-quecento con l’innalzamento delle costruzioni, che iniziarono a svilupparsi su trelivelli, con una ridistribuzione della destinazione d’uso dei locali e con l’introdu-zione di un piano destinato quasi esclusivamente alle camere ubicato tra la se-zione rurale (stalla), abbinata alla domus ab igne al piano terreno, e la sezionerurale al piano sommitale (fienile).Anche la nozione dell’innalzamento delle co-struzioni, seppur cronologicamente confusa, rimase fissata dal Casaccia (1898).
Con questa modifica, che introdusse un modello stabile nel tempo, si ge-nerò la “tipica” casa alagnese. Mentre nell’area di Alagna questa evoluzioneavvenne mantenendo l’utilizzo del legno, nelle valli Egua e Sermenza coincisecon il suo abbandono.
Questa fase di rinnovo del patrimonio edilizio è attestata dalla presenza dinumerosissime citazioni nei documenti del Cinquecento di domus nove. In unatto del 1518 compare a Boccioleto la domus nova Jacobi de Preto (ASVa,FNV, b. 10431). Il fenomeno è documentato anche a Riva. La casa di GiacomoClarino, padre del notaio Pietro, a Supra Ripam, citata nel 1500 come torba(SID, FCa, b. 15, d. 189) è sostituita da una domo nova a partire dal 1506 (d.209) e come tale è ancora menzionata nel 1512 e 1525 (b. 16, dd. 229, 279).
Una domus nova, successivamente indicata come appartenente al notaioAlberto Clarini, è citata a Pedis Alanie nel 1520 (SID, FCa, b. 16, p. 256). Nel1525 compare la domus nova de Clarino a Riva (d. 279, successivamente men-zionata anche nel 1535, d. 303). Un atto del 1569 è stipulato a Carcoforo in so-lario domus nove (ASVa, FNV, b. 8931).
64
Dal legno alla pietra (un evento diacrono)
Nelle valli Egua e Sermenza alla fase di innalzamento si sovrappose la fa-se di sostituzione del block-bau in legno con un corpo in muratura, mantenen-do, o addirittura sviluppando ulteriormente, il tradizionale sistema di loggiati.Anche questa trasformazione veniva annotata a fine Ottocento da Casaccia(1898), che citava la presenza di case simili alle precedenti nella forma, ma co-struite in pietra.
Nello stesso periodo i notai annotavano la prima comparsa anche nell’a-rea alagnese di domus lapidee. A Pedis Alanie alcuni atti d’inizio Cinquecentovenivano stipulati super lobieto domus lapidee Adami Salini (1502, SID, FCA,b. 15, p. 192; 1519, b. 16, p. 253, 1528, b. 16, p. 290). Nella stessa località una do-mus lapidea è citata in un atto del 1535 (b. 16, p. 308). Ma ad Alagna la sostitu-zione del block-bau in legno con un corpo parzialmente o totalmente in mura-tura fu prevalentemente tardiva e si realizzò massicciamente solo nell’Otto-cento. Giordani (1891, p. 11) a fine Ottocento annotava che “da qualche tempoanche la costruzione delle case va soggetta a modificazioni, sostituendo la mu-ratura in pietra”. Piani in muratura compaiono infatti in case recanti una datadi costruzione/ricostruzione ottocentesca: a Casa Prato (1838); parte in legnoe parte in muratura a Pedemonte (1842); al Riale (1799); alla Bonda (1871); al-le Piane (1892, 1900), a Pedemonte (1912), con loggiati tradizionali, in sostitu-zione di una casa documentata da fotografia del 1882; a Pedemonte (1905), converande e griglie solo al piano superiore e solo frontali, costruita al posto diuna casa in legno visibile in una foto d’epoca (cfr. Daverio, 1995). Daverio(1985) segnala come ultima costruzione in legno quella datata 1890 alle Piane.Il periodo di transizione va dunque dal 1799 al 1890.
Nel diario del rimellese Filippa (in Sibilla, 1985, p. 161) si ha una testimo-nianza di questo abbandono ottocentesco del legno a favore della pietra; l’e-vento colpì probabilmente il narratore, in quanto venivano abbandonati i si-stemi costruttivi in atto a Rimella da secoli. Nelle sue memorie annotava chenella corente primavera e nella villa del Neder-Dorf di sotto anno rifatto quasidi novo una casa di un certo Vasina in milior modo construtta e a ristaurata et alevando il legname detto quette e a rifarlo in muro dai muratori fratelli Scolaro.Le nuove soluzioni furono introdotte dai muratori rimellesi attivi in altre re-gioni alpine. In pochi decenni l’introduzione del nuovo modello costruttivocambierà notevolmente i lineamenti del paesaggio antropico di Rimella (Si-billa, 1985, nota 131, pp. 161-162).
Molte case vennero ricostruite in muratura dopo incendi che distrusseromolte case in legno.41 Al Dosso, dopo l’incendio del 1866, vennero ricostrui-te in muratura le case datate 1867, 1867, 1868, 1868. Analogamente al Ponte,dopo l’incendio del 1819, venne costruita parzialmente in muratura la casadatata 1826 e completamente in muratura quella datata 1837. A Rimella, le
67
unius setii; 1563 a Rima, b. 8931). Il materiale delle case distrutte aveva co-munque un suo valore, veniva citato nei lasciti testamentari ed era oggetto divendite (ad es. sethium cassine derupte cum suis plodis et lapidis ad Oro di Boc-cioleto nel 1537, b. 10367; petia terre sethii domi derupti cum suis lapidibus nel1566 a Ormezzano, b. 10439). Quest’opera di recupero di materiali coinvolsesicuramente molte torbe. Nel 1635 è registrata la vendita di un tectus deruptuscum suis lapidibus et plodis et buschis et assi. Il materiale delle case vecchie erasempre impiegato nelle ricostruzioni; le convenzioni con i mastri costruttori in-dicavano esplicitamente che il proprietario/committente doveva dare ai co-struttori “tutte le pietre piode travi canteri tempiasi et assi di quella sua casavecchia” (Pizzetta, 1996, d. 2, pp. 14-15).
Se è difficile ricostruire con sicurezza la destinazione d’uso delle case del-la prima fase di colonizzazione è più semplice ricostruire quella delle domusnove edificate su tre livelli a partire dalla fine del Cinquecento, per la loro con-servazione sino a tempi recenti e per la ricchezza di fonti documentarie. Gli at-ti di vendita, ma soprattutto i dettagliati inventari e le divisioni di beni, offronodettagliate citazione degli edifici presenti e della destinazione d’uso degli am-bienti che li componevano.
Il piano basale seminterrato ospitava il locale in cui si faceva fuoco (do-mus ab igne; ca da focho nel dialetto valsesiano; firhus nel dialetto walser ala-gnese), il locale per la lavorazione del formaggio e la stalla (capsina). In alcunearee la stanza di soggiorno era costituita direttamente dalla domus ab igne; inaltre un’area adiacente alla stalla, separata da un tramezzo basso in legno e di-sposta su un assito, ospitava la stufa. Spesso un’appendice ospitava la cantinadei formaggi (truna). Al piano superiore si trovavano le camere e all’ultimofienili, magazzini e locali per la lavorazione di cereali.
Un buon esempio di una descrizione completa di tutti gli ambienti di unacasa cinquecentesca è la citazione della casa Viotti a Rima in un inventario del1563: domus ab igne cum stuva una ac canvello uno, et solario ac capsina et cumtecto a feno (b. 8931). Nel piano basale si trovava la truna,38 un locale general-mente ubicato in un’appendice della casa, destinato alla stagionatura e alla con-servazione del formaggio.
Le case delle famiglie che non erano dedite esclusivamente all’attività agro-pastorale presentavano una maggiore articolazione. Le case di famiglie dediteall’attività notarile erano dotate di apotecha e thalamo (casa Preti a Bocciole-to);39 di cubiculario (casa Sceti a Quare nel 1567, b. 10620), di scriptorio seu ca-mera (casa del notaio Pietro Clarino di Riva nel 1467).
Dalle case dei conduttori di aziende agricole si discostavano anche le casedei parroci, che assumevano spesso dimensioni notevoli (come a Boccioleto)e avevano talora un insolito giardino chiuso (come a Carcoforo).40
66
nelle valli Egua e Sermenza, sia ad Alagna e Riva, presentano inoltre una tipo-logia nettamente differenziata dalla presenza/assenza di un’intercapedine trapiano basale in pietra e piano superiore in legno che scompare nelle costruzio-ni polifunzionali a partire dalla seconda metà del Cinquecento, al debutto del-la Piccola Età Glaciale. L’intercapedine continuò invece ad essere utilizzata ne-gli edifici rurali in quelle comunità in cui le funzioni rimasero separate. Se lacoincidenza cronologica fosse confermata la causalità climatica potrebbe effet-tivamente essere invocata per questa trasformazione. La riunione delle funzio-ni dal punto di vista della gestione termica garantiva infatti un addizionamen-to calorico fornito dagli animali e una minor dissipazione fornita dalla coiben-tazione al piano superiore offerta dal fieno secco accumulato per l’inverno.
Ma, ammesso che anche nelle valli del Sesia e a Gressoney le funzioni fos-sero originariamente separate, perché in queste località si operò una trasfor-mazione che altre comunità non ritennero necessaria? Rizzi (1996, pp. 56-57)spiega la diversa soluzione adottata a Gressoney e ad Alagna con le diverseabitudini socio-economiche di altre comunità walser, come Formazza, ove lacoltura dei cereali era scarsa e non servivano loggiati, mentre il prevalere del-l’allevamento e della someggiatura richiedeva stalle più ampie e necessaria-mente separate dalle abitazioni. La diffusione di campi coltivati, discussa nelcapitolo successivo, sembra confermare questa ipotesi.
Lo sviluppo dei loggiati
Tutte le case valsesiane, nell’area delle costruzioni in legno e in quella del-le costruzioni in pietra, presentano un notevole sviluppo dei loggiati. Il mag-giore sviluppo del loggiato rispetto alle costruzioni walser di altre valli può es-sere dovuto, come viene spesso segnalato in bibliografia, alla maggior piovo-sità del territorio valsesiano. Un altro fattore determinante questa scelta co-struttiva potrebbe inoltre essere legato al maggior sviluppo in questi insedia-menti di quota non elevata della cerealicoltura e della fienagione.
Ma anche lo sviluppo dei loggiati ha avuto sensibili variazioni nel tempo.Rizzi (1996, p. 54) ritiene che nelle più antiche case alagnesi, risalenti al Cin-quecento, il loggiato fosse presente solo su uno o due lati e nei secoli successi-vi si sia esteso a circondare l’edificio e la tipologia classica si sia diffusa nel Set-tecento. Anche nelle dimore più antiche censite nelle valli Egua e Sermenza iloggiati sono distribuiti in modo irregolare, si sviluppano solo su alcuni lati epresentano profondità talvolta limitate. Un ampliamento dei loggiati accom-pagna ovunque in Valsesia lo sviluppo delle nuove case sei-settecentesche e nelmodello alagnese affermatosi in questo periodo il loggiato si sviluppa in modoavvolgente su tutti i piani. La trasformazione è dunque parzialmente coeva al-la riunione delle funzioni rurali e civili sotto un unico tetto e coincide con la fa-se di innalzamento che caratterizza le domus nove.
69
case della frazione Prati furono ricostruite in legno dopo l’incendio del 1853(Bauen, 1978, pp. 397, 399).A Campello Monti, dopo l’incendio del 1843, ven-ne offerta da un emigrante una cospicua somma per la ricostruzione a pattoche fosse utilizzata per l’acquisto di calce e per la costruzione di fornaci e perl’esecuzione di opere murarie per dissuadere gli abitanti dall’uso del legno(Rizzi, 1996, p. 60).
Le case nuove di artigiani e professionisti (Ottocento e Novecento)
Un ulteriore innalzamento avvenne con il rinnovamento edilizio otto-centesco. In questo periodo fanno la loro comparsa anche case compatte pri-ve di loggiati, già testimoniate in Casaccia a fine Ottocento (1898, p. 267).Quest’ultimo tipo coincide con il definitivo abbandono dell’attività agricolada parte di alcune famiglie residenti soprattutto negli insediamenti di fondo-valle costituenti il baricentro geografico della comunità (spesso ospitante ilcentro parrocchiale).42 Un bell’esempio di questa trasformazione è offertoda tre costruzioni compatte a pianta quadrata, prive di loggiato, poste a Fer-rate in fronte alla casa comunale datata 1896, costruite da famiglie di artigia-ni e professionisti tra fine Ottocento ed inizio Novecento (assenti nella map-pa Rabbini).43
La riunione delle funzioni civili e rurali
Un problema spesso dibattuto nella letteratura specializzata è costituitodalla distribuzione spaziale e temporale delle funzioni rurali e civili. La riunio-ne di queste funzioni sotto un unico tetto in una casa unitaria nell’area alagnesee gressonarda44 fu associata da Monterin (1937) al deterioramento climaticonoto in letteratura come Piccola Età Glaciale.45 L’ipotesi di una connessionedi questa trasformazione ad un evento climatico è accettata da Rizzi (ad. es.1992) e continuamente riproposta in letteratura (ad es. Mirici Cappa, 1997, pp.8-9). Rizzi, come testimonianza della originaria separazione, accenna ad atte-stazioni documentarie (1996, p. 54) e cita un documento del 1331 relativo a Pe-demonte in cui sono nominate “case, cascine e stalle, rivelando come in queltempo le abitazioni e i rustici fossero ancora organizzati in edifici separati”(1992, p. 207). L’indizio è in realtà abbastanza debole in quanto queste formesono presenti anche negli atti successivi ad indicare gli edifici rurali che rima-sero con questa funzione a fianco dei nuovi edifici polifunzionali.
In assenza di valide conferme documentarie un supporto alla originalepreesistenza di edifici a funzioni separate può essere offerto da alcune testi-monianze archeologiche.A funzioni separate sembrano infatti assolvere alcunecoppie di edifici accostati (Tetto, Ca Ravotti), caratterizzati da dimensioni ri-dotte e da uno sviluppo verticale limitato a due piani. Gli edifici più vecchi, sia
68
media tra villaggi e alpeggi. Questa potrebbe essere anche la ragione percui queste comunità, a differenza di tutte le altre presenti nelle valli esami-nate, caratterizzate da insediamenti sparsi, abbiano sviluppato insediamen-ti accentrati.50
Oltre alla sezione rurale degli edifici polifunzionali erano dunque pre-senti diverse tipologie di edifici esclusivamente rurali concentrati negli inse-diamenti permanenti (in posizione talora marginale) e/o dispersi nei prati/pa-scoli del territorio comunale o consortile, differenziati in funzione del tipo digestione del territorio e della destinazione dell’appezzamento di terreno. Neiprati era comune la presenza dei tecti a feno, costruzioni rurali con il solo fie-nile con funzione di deposito temporaneo (petia terre prati cum suis tectis etcasonis et cum suis rugis et aqueductibus, 1562,ASVa, FNV, b. 10439; petia ter-re prati cum suis rugiis et aqueductis et cum tecto uno in Val d’Egua ubi dici-tur ad pratum de la Galmanna Ori inferioris Cassiveri, 1563, b 10448; petia ter-re prati cum suis rata parte tecti et cum suis rugiis et aqueductibus a Tetto Mi-nocco, 1521, b. 10366). Questi edifici rurali erano costituiti da fienili, taloracon aperture e piccoli loggiati (tectum seu cassinam a feno cum sua strayghaet lobiis; 1532, b. 10366).
Nei pasqueri,51 dimore temporanee in prati/pascoli di media quota utiliz-zate prima del trasferimento all’alpe, generalmente note come maggenghi, gliedifici rurali erano costituiti da cassine (stalle) al piano inferiore e da fienili,che assicuravano una scorta di fieno agli animali, al piano superiore (edificiumcassine et tecto a feno murato et coperto plodis cum portichu et lobia a Rima,1566, b. 10448; pasqueri cum uno tecto, nel 1531 ad Oro ubi dicitur ad tectum desuperius, b. 10366, nella località ancora attualmente chiamata Ai tetti, ubicatanei prati-pascoli immediatamente a monte della frazione). Questi edifici rura-li polifunzionali erano costituiti da stalle e fienili (tectus a feno e cassina; 1532,b. 10366); una buona descrizione di quest’ultimo tipo di edifici è costituita dal-la citazione in un documento del 1560 di una capsina murata solariata e strai-gata cum suis lobiis alla Dorca; il documento precisa che la parte superiore del-l’edificio era costituito dalla straiga seu tecto a feno, la parte centrale dal solario,quella inferiore dalla capsina (b. 8931). Nei maggenghi, ad uso primaverile, ilcarico avveniva con pasto misto: pascolo diurno integrato con foraggio secconelle ore serali.Altre costruzioni, nei pasqueri distanti dall’abitato, avevano unlocale adibito ad abitazione temporanea per le persone addette alla gestionedel bestiame.
Nelle località in cui veniva attuato il trasporto differito del foraggio era-no presenti i terragni, piccoli edifici rurali monofunzionali destinati all’im-magazzinamento temporaneo del fieno (terragno a Fervento nel 1480 adSaxelum rotondum, Fantoni e Fantoni, 1995, d. 43; nella Valle di Piaggiognanel 1531, b. 10366; terragno murato et plodis coperto alle Balmelle nella valledi Rima, 1567, b. 8933).
71
In questo caso sembrerebbe che riunione delle funzioni e sviluppo dei log-giati possano essere le risposte al deterioramento climatico.46 Le cause dellatrasformazione possono però essere ricercate più plausibilmente nella neces-sità di nuovi spazi prodotta dalla concentrazione in un’unica costruzione delleattività civile e rurale.
GLI EDIFICI RURALI PRESSO GLI INSEDIAMENTI PERMANENTI
Con la progressiva risalita del limite altitudinale degli insediamenti per-manenti aumentò la dipendenza della sopravvivenza dalla capacità di imma-gazzinamento delle risorse destinate a uomini e animali. Durante il Cinque-cento il patrimonio zootecnico medio di ogni gruppo famigliare può essereidentificato con quanto inventariato nel 1563 tra i beni lasciati da Pietro Viot-ti a Rima, che sfruttava il pasquerio del Presallo e godeva dei diritti di erbati-co di due vacche all’alpe Vallè: tre vacche, due manze, quattro capre e tre pe-core (ASVa, FNV, b. 8931). Un altro inventario di beni della famiglia Peracinoa Carcoforo indica in quattro vacche, una capra e un cacabu il patrimonio zoo-tecnico dell’azienda agricola familiare (1568, b. 8931).
Gli appezzamenti di terreno erano costituiti da campi, prati, meali, pa-squate e alpi. I prati, considerati meno importanti dei campi, occupavano le zo-ne periferiche rispetto agli insediamenti. Nei prati grassi venivano eseguiti dueo più sfalci; nei prati magri un solo sfalcio. Nelle pasquate (maggenghi) veni-vano generalmente praticati sfalci ad anni alterni.
La distribuzione e la tipologia degli edifici esclusivamente rurali nell’areaalpina è determinata da diverse modalità di gestione del territorio. Nel model-lo che prevede il trasporto del foraggio47 si rende necessaria la presenza di fie-nili o sezioni a fienile negli insediamenti permanenti. Una variante a questomodello prevede un trasporto differito del foraggio48 e richiede la presenza difienili presso i prati. Un secondo modello prevede infine il movimento del be-stiame49 ed utilizza edifici rurali misti (stalle con fienili) sparsi nel territorio perun foraggiamento temporaneo decentrato.
Al primo modello è legata una gestione centralizzata del territorio. L’a-zienda agricola si basa sostanzialmente su un solo centro gestionale, costi-tuito da stalle/fienili centralizzate e solitamente aggregate ai villaggi. Il se-condo modello prevede invece la distribuzione di numerosi edifici rurali,con tipologie e funzioni differenziate, ordinatamente dispersi sul territorio.Nell’area esaminata i due modelli coesistono. Ma il primo modello (o per-lomeno la coesistenza del primo con il secondo) sembra prevalere nelle co-munità alla testata delle valli (Rima e Carcoforo), ove si riduce, per ragio-ni altitudinali, la fascia dei prati e dei maggenghi ubicati in posizione inter-
70
LE STRUTTURE DI SERVIZIO
Gli insediamenti permanenti si dotarono presto di strutture per la trasfor-mazione dei prodotti agro-pastorali. I cereali erano coltivati sino in alta valle;la loro diffusione fu probabilmente maggiore e maggiormente diversificata du-rante le prime fasi della colonizzazione.
La diffusione dell’agricoltura nel Quattrocento e Cinquecento è testimo-niata dall’elevato numero di appezzamenti di terra a campo, citate negli attinotarili, destinate a colture cerealicole.53 Nei documenti del Cinquecento sonoindicati cereali microtermici (segale, frumento, orzo e avena) e macrotermici(miglio e panico). La specie più diffusa (anche alle alte quote, ove rimase per-sistente nel tempo) era la segale (secale cereale), la specie più resistente allebasse temperature tra i cereali vernini grazie alle limitate esigenze termiche,caratterizzata da una germinazione rapida anche alle basse temperature e daun breve ciclo vegetativo. Ma era presente in maniera diffusa anche l’orzo (hor-deum vulgare), che, sebbene meno resistente al freddo della segale, crescevaanche dove il frumento non si adattava bene e costituiva la principale fonte ali-mentare per un gran numero di popolazioni che vivevano in zone fredde (altelatitudini e alte quote). In alcune località della val Grande e della bassa val Ser-menza era presente anche il frumento. Non mancavano inoltre cereali che rag-giunsero la massima diffusione nel Medio Evo, poi soppiantati dalla comparsadi cereali di maggior valore produttivo e qualitativo, come il miglio e il panico,specie macrotermiche, che richiedono un minimo termico di 10-12°C per la ger-minazione e di 17-18°C per la fioritura e maturazione. Il miglio (panicum mi-liaceum) era scarsamente produttivo ma rustico; il panico (setaria italica), simi-le al miglio, era coltivato più sporadicamente nell’arco alpino, mentre era dif-fuso in pianura. Non mancavano, anche negli insediamenti più elevati e fred-di, coltivazioni anche di avena, meno resistente alle basse temperature di se-gale ed orzo. Successivamente venne introdotto anche il grano saraceno giun-to in Europa nel Cinquecento.
Nel contratto d’affitto tra Gaudenzio delle Balmelle e Pietro della Ferre-ra di Isola di Vocca per un campo nel territorio di Isola l’affitto, da versare a S.Martino, è costituito da 24 starie di grano, 8 di segale, 9 di miglio e 7 di panico(1563, b. 10448).
Le decime che il prete Zali riscuoteva nel 1617 nel territorio di Rossa (Ca-setti, all’Oro di Rossa, Zenestreto, Cha de Secchi, Follecchio, Salerio, Cha deBianchi et Casa de Zocchi, Fontane et la Piana di Rossa, consistevano nella se-gale, panico et canapo et formento et anco delle arbelie et orzo. Annualmentevenivano corrisposte 15 some di segale (corrispondenti a 300 lire), 13 some dipanico (40 lire), 10 rubbi di canapo (70 lire), 2 stare di formento (4.5 lire), 2 sta-ra di arbelie et orzo (3.5 lire) (Fantoni e Cucciola, 1999).
A Carcoforo ancora ad inizio Novecento erano coltivati segale, orzo e gra-
73
Le costruzioni rurali attualmente conservate sono esclusivamente in pie-tra. Ma in un documento del 1531 (Fantoni e Fantoni, 1995, d. 67) è citato an-che un tecto buschis seu lignamibus conserto seu constructo in Val d’Egua ubidicitur ad pianellos Manete, che attesta nel Cinquecento la presenza di edifi-ci rurali in legno ubicati anche lontano dagli insediamenti permanenti. An-che nel territorio di Alagna e in Val Vogna sono estremamente rari gli edifi-ci in legno nella fascia dei prati e dei maggenghi. In Val Vogna, oltre che al-l’alpe Larecchio, un tempo insediamento permanente, sono presenti edificiin legno all’alpe Spinale (1920 m), ove rimane una costruzione a due pianidatata 1897.52 Ad Alagna sono in legno le costruzioni di un consistente inse-diamento stagionale all’alpe Vittine (1598), con costruzioni datate tra 1614 e1801 (Daverio, 1985).
I documenti cinquecenteschi descrivono l’accurato sfruttamento delle po-tenzialità dei prati e dei pascoli attraverso un adeguato sistema irriguo; fre-quenti sono le petie terre prati (et campi et pasqueris) cum suis rugis et aque-ductibus (a Tetto Minocco, 1521, b. 10366; al Pianello dei Manetta in Val d’E-gua, 1531, ASVa, FNV, b. 10366; a Ca Forgotti, 1563, b. 10448). Per il territoriodi Pietre Gemelle, ove sono documentati nel Cinquecento molti prati con ac-quedotti, sono testimoniate anche regolamentazioni dei diritti d’uso delle ac-que (per l’Alpe Larecchio nel 1534, SID, FCa, p. 306; per la derivazione delleacque del T.Vogna con una roggia nel 1537, b. 17, d. 16).
LE COSTRUZIONI NEGLI ALPEGGI
Lo sfruttamento dei pascoli negli alpeggi, ove non era praticato lo sfalcio,richiedeva solo lo sviluppo di costruzioni per il ricovero degli animali (cassine,giacis), per la trasformazione dei prodotti caseari (casere) e per il soggiorno deipastori (casoni), ampiamente citati negli atti notarili. Alcune volte era ancheesplicitamente citato il locale per la conservazione dei formaggi (canevello su-per giacio inferioris Eigue, 1576,ASVa, FNV, b. 8937).
Una costruzione di piccole dimensioni ospitava la stalla per le capre, cheviene talora distinta anche nei documenti cinquecenteschi. In un documento didivisione di beni della famiglia Ragozzi nel 1576 sono citate all’alpe Egua cas-sine cum cassinella una a capris sul Selletto; casere sive cassine cum canevelloet cassinelli caprarum ai Giacc inferiori, una casera grande cum canevello ac cas-sina a capris alla Piana (b. 8937).
Oltre a questi edifici erano utilizzati come ricoveri naturali le balme, talo-ra parzialmente chiuse da muretti a secco. Nei pascoli erano sfruttate come ri-covero di animali; nei prati e nei meali come ricovero per il fieno. In letteratu-ra è nota la balma presso l’alpe omonima, nel vallone del T. Nonai (nel territo-rio di S. Giuseppe, alta Val Sermenza).
72
del 1446 è rogato ad molandina et super domo nova molandini mei Zanoli nota-ri56 (Fantoni e Fantoni, 1995, d. 27). Un mulino nel territorio di Rossa è citato inun atto del 1489 (appunti di don Ferri,ASPB, b. LII). Nel territorio di Ormezza-no è citato nel 1537 una località ubi dicitur ad Molinum (b. 10367).A Palancatonel 1538 era citato un sedime et artificio molendini et pisse cum suis rugiis et …molis … ubi dicitur ad molendinum de Zoloto (b. 10367).A Fervento, in un attodel 1518 (b. 10439) era citata parte una tecti molendini derupti plodis coperti cumsuis rugiis et aqueductibus et cum suis iuris et rationibus et pertinentiis … ubi dici-tur ad molinarium sive ad ortos a cui confinava l’aqua Salmentie.
A Rimasco nel 1665 era citato il toponimo Molino Rimaschi. In documen-ti della metà del Settecento (1746, b. 8986) il Molendini Rimaschi, in cui lavora-no e vivono i Chiarini, è specificato essere presso l’oratorio di S.ta Croce (di cuii Chiarini avevano il patrocinio). Potrebbe trattarsi dell’edificio ancora ricorda-to localmente al Pian delle Bocciole (nello stesso atto è citato un prato al pianodella boccia, b. 3136), località a monte di Rimasco lungo la mulattiera della Vald’Egua in cui la Carta del 1759 (in Peco, 1988) riporta il toponimo li molini.
A Ca Bastucchi, tra i confini della rippam de Domo Bastuchi era citata infundo rugia molendini (1532, b. 10366). A Sause nel 1578 un terreno era dettoad pecia de Molino (b. 8934). Nel 1635 è citato un appezzamento a prato in ter-ritorio sausus ubi dicitur il Prato dil Molino, confinante con la strada comune(b. 9884). Nel 1635 (ASVa, FNV, b. 9884) è citato un appezzamento di prato aCa Ravotti ubi dicitur ad Gabietum a cui confinava in fundo ruggia molandiniet crosus buzzi … et strata comunis. Al Buzzo è documentato nel 1728 un mu-lino cum rugis et acqua ubi dicitur ad molendini Jacobi Valentine (b. 8984). Al-la Piana è citato nel 1548 un prato de la Plana retro molendini con una rugiamulendini tra le coerenze (b. 10369). Nel testamento del 1570 di Zanollus fqPetri Violli de Plana Chiapeii compare un mulino cum duabus molis et aliis asia-mentis (?) … artificiis tam fereis quam lignei spettanti al mulino iacens in terri-torio Vallis Rime in loco Plana Chiapei (b. 8937); nello stesso insediamento nel1731 è citata la località ad Molendini Johannis Marie de Job (b. 8984).A PietreMarce si trovava il mulino de Viotto murato et plodis coperto (1567, b. 8931).AlPonte di Rima è citato in un documento del 1708 un molino disertato senza mo-le ne altri utensili per il detto molino con una camera sopra, et uno furno (b.8983). Alle Quare di Rima nel 1758 si trovavano il mulino e la domus ab ignedi Bartolomeo de Pauli (b. 8986). A Rima è documentato un mulino a partiredal 1537, quando Zanolus filius quondam Petri Zanoletti de Rima vendette aJohanne filius quondam Petri Johannis Zanoli de Rime la suam ratam molen-dini (b. 10367). Sempre a Rima compare in un inventario di beni Viotti del 1563la località ad Molendini de Presallo (b. 8931) e nel 1546 è citato il molendinum… intus fontanis super Aqua Rime (b. 10368). In un documento del 1707 unaruggia molendini è descritta come confinante, in fondo, con il prato ubi diciturvon strich (b. 8983).
75
no saraceno.A Rimella la tradizione vuole che vi crescessero solo segale e or-zo (ms. Rinoldi, 1943; in Bauen, 1978, p. 416).
In documenti del 1531, 1537, 1547 e del 1563 viene citato a Rima una pez-za di terra a campo intus campos de avena (o campos avene) (bb. 10366, 10368,8931) del 1578 (b. 8934); il toponimo è ancora presente nel Settecento (forsesolo come relitto non più corrispondente alla destinazione d’uso) (bb. 8986,8988).
A Macugnaga, secondo quanto riportava una relazione di Joachim de An-nono del 1553 non si fa salvo che un seminerio, cioè di segale, o di miglio, o dipanico (Bianchetti, 1878, v. II, d. CLXXVI). La coltivazione dei cereali arriva-va nella vicina valle di Gressoney sino all’insediamento di Tschaval (1823 m),ove è attestata da un documento del 1440 relativo al pagamento di alcuni fittiin orzo (Rizzi, 1992, p. 58).
Nel tardo medio Medio Evo i mulini, definiti da Bloch (1974) un’“inven-zione medievale” (Chiappa Mauri, 1984, p. 6), si diffusero anche in Valsesia, ovesostituirono le macine a mano ancora persistenti nel basso Medio Evo e anco-ra presenti (in abbandono) in molti insediamenti della valle. La costruzioned’edifici di servizio accompagnò direttamente la fondazione dei nuovi insedia-menti colonici in alta valle.54 Nel 1270 il capitolo di S. Giulio d’Orta concede-va a titolo enfiteutico a coloni walser l’alpe Rimella affinché vi potessero abi-tare con le loro famiglie e domos et molendina extrahere (Fornaseri, 1958, d.113; Rizzi, 1991, d. 89). Nello stesso periodo è documentato un mulino a Boc-corio (1282, SID, FCa, b. 15, p. 12; Mor, 1933, c, LVIII).
Le ruote erano generalmente azionate dalla corrente di un’opera di deri-vazione (rugia o aqueductus); in questo modo si evitava di ostruire l’alveo construtture ingombranti facilmente soggette al rischio di piene e si controllava laforza dell’acqua. La derivazione di acque per mulini, peste e folle era regola-mentata negli statuti della valle (Liber tertius, capp. 144-146, in Tonetti, s. III, pp.81-82) e il loro sfruttamento era oggetto di specifiche convenzioni da parte del-le comunità di villaggio. Per i diritti su una condotta d’acqua destinata forse al-lo stesso mulino citato nel 1282 fu stipulata nel 1464 una convenzione tra gli uo-mini di Boccorio e quelli del Buzzo (SID, b. 15, d. 117).55 Ad analoghe conven-zioni erano soggette anche le derivazioni d’acqua destinate ad altre attività. Nel1691 una convenzione della comunità locale con Johannes Bettone … de Rima-scho stabiliva le regole per la gestione di una chiusa nel fiume di Rimma qualesi serve dell’acqua o sia roggia per la sua fucina (ASVa, FNV, b. 9772).
Nelle valli Egua e Sermenza la presenza di mulini è documentata, per ilQuattro-Cinquecento, quasi in ogni insediamento.A Balmuccia sono documen-tate nel 1531 due pezze di terra a campo ubi dicitur superìus rugiam Molendinisuper Rippam et ad Molendinumi apud Salmentiam (b. 10366).A Rossa un atto
74
Ca, b. 121, d. 33). Nell’Ottocento, alimentati dalla roggia detta della Gula, era-no presente due mulini alla Ca del Ponte (edificio 258) e al Terragno.
In Val Cavaione, sulla base di testimonianze materiali, antiche mappe ca-tastali, documenti notarili e memoria storica, è ancora possibile censire la pre-senza nell’Ottocento di oltre dieci mulini. I mulini ubicati più a monte eranopresenti in regione Vargoo e sotto l’alpe sull’Oro. Più a valle erano presentimulini in sponda idrografica destra, presso l’alpe Tu dal mestro, e sinistra, sot-to l’urel grant. Ancora più a valle vi erano il Mulino Stroli (edificio n. 737 nel-la mappa Rabbini) e il Mulino Gabbio (783).
In prossimità della confluenza del Rio del Cavallo, sotto la mulattiera bas-sa della Val Cavaione, vi era il Mulino del Cascinale (edifici censiti con i nn.1769 e 1786 nella mappa Rabbini, in cui non viene però cartografato il canaledi derivazione). Immediatamente a valle della confluenza del Rio del Cavallouna roggia alimentava una pista (n. 1786) e il mulino del Cascinale sotto (edi-ficio n. 1798) e rientrava nel T. Cavaione.
Più a valle, sul lato idrografico destro, vi era il mulin du Dante, con due ma-cine ancora funzionanti nella prima metà del Novecento e con forno.
Sempre sul lato idrografico sinistro (sotto la Madonna delle Giavinelle) unanuova roggia alimentava i mulini Sottile e Tamiotti. Un disegno di metà Otto-cento (ACu) descrive il Mulino Sottile (noto anche come mulin du rat) (edificinn. 1828-1829 nella mappa Rabbini), come un grosso complesso costituito dauna casa di abitazione con forno e da tre edifici, alimentati da un complesso si-stema di chiuse e derivazioni secondarie, che ospitavano le macine per grano ecastagne e per panico, segale e frumento, la pista per le noci, la pista per la ca-napa.Ancora recentemente l’edificio adibito ad abitazione ospitava un forno ri-vestito in pietra ollare ed erano visibili una bellissima macina e una pista. Laroggia proseguiva poi ad alimentare il Mulino Tamiotti (edificio n. 1845 nellamappa Rabbini), noto anche come mulin dal mutti, dal soprannome di un con-duttore muto, costituito da un caseggiato ancora esistente con la sua macina.L’edificio che ospita il forno è datato 1685. La roggia raggiungeva poi un altropiccolo fabbricato dove vi era una macina, poco a valle era presente una stu-penda pesta datata 1845 distrutta per recuperarne le ruote (edificio n. 1847).
Pochi metri a valle un’altra roggia alimentava gli edifici del Mulino Dedo-minici (nn. 1860-1862), ove è ancora presente una bella costruzione che ospi-tava l’abitazione con uno stupendo forno e il mulino. Più a valle vi era un ca-seggiato con una roggia di cui non rimane ricordo dell’esistenza di un mulino.Presso questa costruzione era presente un’altra abitazione un forno e una pe-sante pietra artisticamente lavorata che serviva a pigiare le noci e un’altra co-struzione con un forno e una pista ancora attiva nella prima metà del Nove-cento. Un’altra pista fu asportata da un’alluvione.
Più a valle si separa dal T. Cavaione la Roggia dei Molini, che alimenta-
77
Alla Dorca una località Piana del Molino, confinante con il croso è citatain un documento del 1544 (ASVa, FdA, s.1, b. 9); in un atto del 1560 è oggettodi una vendita un prato ad gabium con la possibilità di erigere un mulino (b.8931). Nel territorio di Priami compare nel 1720 un edificio citato come Mo-lendini Priami (b. 8984), gestito e abitato da rappresentanti della famiglia Chia-rini; nel 1738 compare nuovamente il molendinum Priami Rimaschi (b. 8988),che in documenti successivi appare di proprietà dei Clarini (Molendino Pria-mi, 1758-9, b. 8988). Al Molino un mulino è documentato a partire dalla metàdel Cinquecento; nel 1544 è citato come molendinum … in loco de Rabioso57
(b. 10368), nel 1567 e nel 1588 come Molendinum Cravatie (b. 8933) o Molinodella Cravatia (b. 10254); un documento del 1564 ne precisa la proprietà (adMolendini quondam Dominici de la Cravatia, Fantoni e Fantoni, 1995, d. 87).Nel 1596 Giovanni Zamboni di Carcoforo ricevette da Domenico Zamboni dilMolino della Cravatia 22 lire per la cessione della sua rata edificii unius mo-lendini jacens in territorio et loco dil Molino della Cravatia (b. 10254). Il mulinoera ancora presente nel nel 1720 (Molendini Cravatie, b. 8992). Le rogge furo-no in seguito destinate ad alimentare una segheria, attiva sino agli anni Ses-santa. In quegli anni era ancora presente una macina datata 1534 (La Valsesia,a. XIV, nn. 4-5, p. 32). A Ferrate esisteva un mulino, di cui non sono sinoraemersi riscontri documentari cinquecenteschi, attivo sino alla metà del Nove-cento. Un mulino era presente sotto Campo Ragozzi in località Pra d’Gian, ovesorgeva una bella casa con affreschi abbattuta per la costruzione della nuovastrada provinciale nella prima metà del Novecento; potrebbe trattarsi dellostesso edificio citato a Campo Ragozzi in un documento del 1569 (molendinumplodis coperto con suiis molis, pistis et aliis artificiis in loco de super ripam Cam-pi Reguci ubi dicitur ad molendini de Campo Regucio, b. 10620).A Piè di Ros-so in un documento del 1564 era citata una pezza di terra ad planellum de mo-lendini, confinante con l’aqua Trixinere da una parte e con la strada comunisdall’altra (b. 8932). Nel 1542 (b. 10368) è citato tra i beni dei fratelli Alberto ePietro Manetta di Piè di Rosso un prato cum uno tecto ac uno artificio … mo-lendini … situato ubi dicitur ad gabietu(m) a cui confinavano la strada comunee l’aqua Eijgue. Si trattava forse dello stesso edificio servito da una roggia im-mediatamente a valle della frazione, utilizzato nell’Ottocento come segheria.
A Carcoforo una sentenza di arbitrato nel 1570 riguardava un edificio mo-lendini prope aqua de traxineri (b. 10620). Nel 1579 (b. 8935) è citato un mo-lendinum cum suis rugis … ubi dicitur ad Molendini. Nel 1656 sei persone del-la famiglia Bertolini donarono alla fabbrica della chiesa molendinum unumvulgo d avvantaggio cum suis molis … rotis, aquis ed aqueductis solitis in Car-coforo ubi dicitus ad molendinettum sive ad Molinettum del Ponte cui coheretab una parte via comunis ab alia gabbium sive flumeni Eigue (ASPCa, b. 121,d. 19). In una Notta delle prati della fine del Seicento figurava un prato al Mo-lino di Minocho confinante con il Riale comune e il chroso della stuva (ASP-
76
po la loro asportazione o il loro danneggiamento da parte delle alluvioni. L’al-luvione del 1755 travolse un mulino a Carcoforo e due mulini al Molino (Boni,1756; Memoria della innondazione seguita nella vale Sesia in detto anno comesopra 1755 ed alli 14 8bre di Giovanni Battista Regozio, copia del 2 giugno 1854di Carlo Zamboni del Molino di Ferrate; pubblicata in Fontana, 1994, p. 91). L’al-luvione del 27 agosto 1834 distrusse al Grondo di Rimella la fugina col edificiodel majo e pesta della canepa e mollino da grano; a Ecchelte un corpo di eddifi-co qual conteneva due fucine una mola il majo con un mulino da grano e la pe-sta della canepa che appena salvo la resega ma non la rogia che conduceva laqua;al Pianello la casa dove un tempo vi esisteva un molino grano e forno e prima unedifico di fucina. Oltre a questi mulini furono distrutti anche quattro mulini perla macinazione della roccia aurifera nell’acqua del Rondo. In occasione di alcu-ne piene poi ricomparivano i resti di mulini abbattuti da precedenti alluvioni esepolti dai depositi; sempre in occasione dell’alluvione del 1834 ricomparverodue pietre (probabilmente le mole) testimonianti l’esistenza di un mulino di cuisi era persa la memoria nel luogo ove esisteva una segheria (Filippa, in Sibilla,1985, pp. 149-151). Numerosi edifici in località Tse Mijne (i Molini) al Grondofurono portati via da un’alluvione nel 1882 (Bauen, 1978, p. 400).
Altrettanto diffusi erano i forni, che talora sono esplicitamente citati neidocumenti cinquecenteschi; spesso la loro presenza è invece denunciata dallamicrotoponomastica. Nel territorio di Rossa e Boccioleto sono documentatinel Cinquecento i forni di Oro (1563, ASVa, FNV, b. 10439), di Casetti (1537,b. 10367) e della Valle di Piaggiogna (uno furno et uno stagno (?) et aliis baytis(?) coperte plodis ... ubi dicitur ad domum Johannis de la Valle Piazogne nel1531, b. 10366). Nel territorio di Rimasco sono documentati un prato del fornoa Ca Bastucco (1674, b. 3136) e una pezza di terra retro forno alla Dorca (1560,b. 8931). Nel territorio della Val d’Egua erano presenti forni alla Carvaccia(1588, b. 10254) e Sul Sasso, ove era citato in un documento del 1534 la localitàad campum del furno (b. 10366).A Carcoforo era citato un prato ubi dicitur su-per furni (1568, b. 8931).
Oltre agli edifici esplicitamente utilizzati con questa funzione erano pre-senti forni anche in alcune abitazioni: in un documento del 1567 di divisionetra i fratelli Zanino, Albertino e Giacomo Pironzolli di Campo Ragozzi com-pare una domus murate solaria cum stufis et capsina et canevello et forno et plo-dis coperta (b. 8931). Questa differente ubicazione è osservabile anche in alcu-ne strutture tuttora esistenti in Val Vogna. A fianco dei forni dislocati in edifi-ci appositamente attrezzati, tuttora presenti a Vogna di sotto, Ca di Janzo, Oro,ca Morca, Sant’Antonio e Rabernardo (Bellosta e Bellosta, 1988, pp. 59, 71, 77,89, 97, 103, 112), erano presenti forni ubicati in locali appositamente destinatinel piano seminterrato di costruzioni polifunzionali, tuttora presenti a Ca Ve-scovo (Bellosta e Bellosta, 1988, p. 97).
79
va i diversi edifici della frazioni Molini e di Boccioleto. La configurazione diquesto complesso sistema è visibile in un disegno del misuratore GiuseppeCarestia allegato ad un documento del 13 marzo 1853 (ACu). Alla frazioneMolini la roggia alimentava prima la pista e il mulino da grano degli eredi DeGiuli, (edificio n. 5035 nella mappa Rabbini; n. 27 nella attuale mappa cata-stale del comune di Boccioleto). La roggia raggiungeva poi l’abitazione e ilmulino di Francesco Zali (5033-5034; 24), passando sotto il caseggiato, ovel’acqua azionava una ruota con trasmissione orizzontale che serviva una ma-cina e altri attrezzi (mola e burat). L’edificio, che divenne poi proprietà Pa-gani, ospitava anche un forno e una rivendita di pane con vetrina aperta lun-go la mulattiera che collegava Boccioleto alla frazione Oro e a Rossa.58 Laroggia giungeva poi alla pista e al mulino di Giovanni Battista Alberti (5024;20); successivamente vi era una pista per la pigiatura delle noci e un grandetorchio per l’olio demolito nel 1935. Il canale serviva poi il mulino di Mad-dalena Fioroni (5015), successivamente abbandonato perché troppo vicino alT. Cavaione e soggetto a frequenti danni durante le piene. La roggia prose-guiva a fianco della mulattiera; una derivazione secondaria che alimentava lapista di Pietro Fiorone e dei suoi fratelli, figli di Maddalena (5000), che di-venne successivamente una pista della canapa. La roggia principale raggiun-geva invece il Mulino Fioroni (4999, 87) che fu successivamente modificatodai nuovi proprietari (Pagano) da verticale in orizzontale. In questo edificio,attualmente ridotto al solo sedime, vi era una macina e un locale per la lavo-razione della tela con due telai a pedale.
La roggia attraversava il T. Cavaione sotto il ponte dei Molini, tramite unacanalizzazione in legno, e raggiungeva nella parte bassa di Boccioleto la pistadegli eredi di Giuseppe Alberti, abbandonata da tempo. Dieci metri a valle unapiccola chiusa originava una cascata che alimentava una fucina, situata nellacasa di abitazione dello stesso Giuseppe Alberti (che poi divenne proprietà diMichele Martire e successivamente di proprietà Topini e più recentementeRossigni, sino ad essere abbandonata e diventare deposito). La roggia alimen-tava poi il mulino di Giovanni Preti. Il mulino, nota come mulin sot la preja,ospitava anche un forno. La roggia raggiungeva infine la pista antica dello stes-so Giovanni Preti. La pista rimase attiva sino al 1932. Più recentemente la stes-sa roggia alimentava poi la segheria di Pietro Antonietti, demolita nel 1950.
Nel territorio di Boccioleto erano ancora recentemente attivi mulini an-che a Piaggiogna (con due macine attive sino al 1950); a Fervento, nella rivasotto la chiesa parrocchiale; sotto la Cunaccia, ove era attiva una pista che fun-zionò sino al 1930. Nel territorio di Rossa esisteva un mulino in una bella co-struzione con affreschi, ora demolita, presso il ponte Mulinetto; in localitàmuin, tra l’alpe Turzin e la frazione Montata, sino a poco tempo fa era visibileuna roggia e rimanevano due stupende ruote.
Per la loro posizione i mulini furono soggetti a numerose ricostruzioni do-
78
to a mulino e segheria (Chiarini); poco a monte, alle Giare del pian delle Boc-ciole era attiva un’altra segheria (Ceruti). Nella media Val d’Egua gli edifici siconcentravano nei gabietti, gli alvei ghiaiosi del torrente. Al Gabietto eranocensiti un mulino (Agnesetti) e una segheria (Antonini); al Gabietto del Moli-no un mulino (Preti) e una segheria idraulica (Zambone); al Molino un’altrasegheria (Ragozzi); al Gabietto di Ferrate tre segherie (Preti, Viani e Ragoz-zi).A Ferrate era inoltre presente un mulino (Antonini) e un’altra segheria inlocalità Vallaccia (Ragozzi). Infine erano presenti due mulini al Prato Gian(Campo Ragozzi) (Pensa) e alla Roggia (Ragozzi).
RISORSE, LUOGHI DI TRASFORMAZIONE E TRASPORTO
Le risorse utilizzate nella costruzione delle case erano sostanzialmente ap-partenenti a due gruppi: ligneo e lapideo.
Il materiale ligneo, destinato alla struttura portante e alle opere di carpen-teria, era costituito esclusivamente da conifere (abete e conifere)60 che offronouna buona resistenza agli agenti atmosferici e ai parassiti (grazie all’elevata re-sinosità che, affiorando in superficie sotto l’effetto dei raggi solari, forma un ri-vestimento protettivo) e si prestano a coprire la lunghezza del block-bau con iloro tronchi lineari e lunghi. Nelle opere di carpenteria era preferito il larice,che presenta maggior durezza.61
Il legno, essendo un buon isolante termico, è il miglior materiale da co-struzione in climi freddi. Il suo uso è sempre limitato ai piani fuori terra inquanto l’appoggio diretto del legno comporterebbe seri danni di umidità. Incorrispondenza delle sezioni ad uso rurale venivano lasciate le aperture natu-rali in corrispondenza delle giunzioni dei tronchi. In corrispondenza delle se-zioni abitative si riduceva l’apertura con un attento uso del legname e si au-mentava la coibentazione chiudendo le fessure residue con sigillanti come mu-schio, torbe. Il legno richiede però l’impiego di grandi quantità di materiale perogni metro cubo di volume disponibile; la sua diffusione era dunque vantag-giosa nelle zone ove vi era grande disponibilità della risorsa adatta o quandola ristrutturazione del territorio, con la trasformazione del bosco in campi e pra-ti nella fase di colonizzazione, rese disponibili grandi quantità di materiale.
Il materiale lapideo era destinato alla muratura del basamento, a pavi-mentazione e scale, ad alcuni pilastri e alle coperture del tetto. Per le prime fun-zioni non era richiesto materiale particolare, essendo sufficienti le rocce meta-morfiche o ignee a struttura massiva ampiamente diffuse in valle. Per le co-perture dei tetti era richiesto materiale metamorfico a struttura scistosa (piode)di più difficile reperibilità.62
Nel territorio di Boccioleto e Rossa le principali cave di piode erano atti-
81
Il funzionamento di questi edifici giunse sino ai primi decenni del Nove-cento. Nelle statistiche di Morozzo della Rocca del 1856 compaiono ancora 104mulini nel mandamento di Varallo e 54 in quello di Scopa (Cesa, 1997, p. 43).A Boccioleto e Rossa numerosi forni erano associati ai mulini. Oltre ai forniassociati ai mulini si ricordano i forni Pagnoni, Zali e Anselmi a Boccioleto; ilforno Fontana presso la chiesa parrocchiale a Rossa.A Carcoforo a fine Otto-cento erano funzionanti i forni nell’edificio 191 (quando era osteria; Casa La-na, nota come Ca’ dal Cruzzio59) e al Terragno.
L’acqua era utilizzata per azionare anche altri edifici di servizio, come se-gherie e fucine, già documentati a partire dal Cinquecento.A Carcoforo in undocumento del 1568 era citato un appezzamento di terra ubi dicitur ad pratumde la resiga (b. 8931). L’edificio potrebbe corrispondere alla segheria ancora at-tiva alla fine dell’Ottocento a Tetto Minocco (Carcoforo), alimentata dalla rog-gia derivata della gula del T. Egua. Un’altra segheria era attiva nell’Ottocentoa Piè di Rosso, alimentata da una roggia ancora visibile. Potrebbe trattarsi del-lo stesso sistema che alimentava il mulino citato in questo territorio a metà Cin-quecento in località ad Gabietum.
Una fucina è documentata nel 1566 a Boccioleto, quando Giovanni Albertidi Boccioleto, anche a nome dei suoi fratelli Alberto e Antonio, investe a tito-lo di locazione per tre anni Giacomo Fiore di Boccioleto de incude una ferriche Giovanni e i suoi fratelli avevano in fucina seu officina per un affitto an-nuo da versare nella festa di S. Martino (b. 10439).
L’attività di tutte queste strutture di servizio ha caratterizzato la vita diqueste comunità nei secoli e la loro presenza era ancora capillarmente diffusanel territorio nell’Ottocento. Nel Rapporto Statistico per l’anno 1828 della pro-vincia di Valsesia (ASTo, Corte, paesi in generale, province, Varallo, m. 101; inPeco, 1993, p. 204) comparivano due mulini a due macine (di cui uno rovina-to), una pista da canapa e una segheria a Balmuccia; cinque mulini a due ma-cine e un torchio a Rossa; sette mulini a due macine, una pista di canapa e untorchio (oltre ad altri due mulini inoperosi) a Boccioleto; due mulini, un tor-chio e due seghe a Fervento; due mulini a Rimasco; uno a S. Giuseppe, due aRima; uno a Carcoforo, tre ad una macina a Ferrate. Nella prima metà del-l’Ottocento un mulino a Rossa (ASVa,Viceintendenza, b. 168), segherie a Boc-cioleto, Rimasco e Rima (b. 179), fucine a Boccioleto, Rossa e Rimasco (b. 178).
Il Catasto dei fabbricati di fine Ottocento indica la presenza nel territoriodi Rimasco e Ferrate di un numero ancora elevato di edifici di servizio (ASVa,Catasto dei fabbricati, Rimasco, Registri delle partite).Al Casetto era presen-te un mulino (Joli); all’imbocco della valle di Rima erano attive una fucina euna sega alla Pianella (Bettone e Ceruti) e un’altra sega alle Cascine (Preti).All’imbocco della Val d’Egua era presente un mulino (Zambone); al Pian del-le Bocciole funzionava un edificio adibito a mulino (Bettone) e un altro adibi-
80
altre fornaci ne estrarre materiale ad uso proprio; si ordinava inoltre che la for-nace fosse utilizzata solo a beneficio della comunità di Carcoforo, stabilendoun’ammenda di uno scudo a chiunque avesse venduto a titolo personale la cal-ce a forestieri (Fontana, 1994, p. 128).
Nella carta del 1759 (Peco, 1988) sono cartografate cave di calcina presso Pie-tre Marce e nel vallone di Grega. Potrebbero essere le cave che fornivano il ma-teriale destinato ad una fornace già citata in un documento del 1558 nel territo-rio di Sause (ASVa, FNV, b. 10448).A Rima una cava era aperta sui monti (Cu-pia, 1895, p. 44). Il materiale era cotto in una piccola fornace trovata vicino al-l’attuale piazza della chiesa facendo scavi per fondazioni durante l’Ottocento(Cupia, 1895, p. 44). La fornace era citata in documenti dell’inizio del secolo(ASVa,Viceintendenza b. 179). Il materiale fu usato alla fine del Seicento per lacostruzione dell’oratorio di S. Giovanni (Cupia, 1895, p. 44; Axerio, 2000, p. 64).
Alcune fornaci per la cottura di calce o argilla sono ancora visibili alla Col-ma Galmanna (Rossa), presso l’alpe Tu ’d Martin a Boccioleto, all’alpe Cuc-ciola (quasi distrutto) e in Val Piaggiogna (un piccolo forno davanti alla chiesadell’alpe Sort). I resti delle mura di un’altra fornace alla Pianella, vicino al Sec-cio, erano visibili sino a pochi anni fa.
Il prodotto, ottenuto dopo sette giorni di cottura (grassello, calce “viva”),veniva conservato in apposite buche coperte con piode, ove veniva ridotto, conl’aggiunta di acqua, a calce “spenta” (cfr. per Rimella Filippa, in Sibilla, 1985,p. 138; Sibilla, 1985, nota 79, pp. 138-139).
Per le necessità di quantità più elevate di calce destinate agli edifici reli-giosi le comunità ricorrevano alle cave presenti nei lembi carbonatici della bas-sa valle e delle zone limitrofe,65 destinando al trasporto un notevole impiegodi risorse umane. Nella prima metà del Settecento l’oratorio della Madonnadel Sasso di Boccioleto acquistava la calce al S. Monte (al prezzo di due lire asoma) o a Maggiora (a tre lire a soma). Il trasporto veniva pagato da Varalloal ponte di Piaggiogna e da qui all’oratorio (ASPB, b. XXXIII, Libro dei conti1705-1764; Fantoni, 1999).Analogamente per l’Oratorio del Tizzone gli abitantidella Val Mastallone nel 1820 si rivolsero alle cave di Maggiora (Dellarole,1999). Gli approvvigionamenti di calce per l’oratorio di S.Antonio a Borgose-sia nella seconda metà del Settecento provenivano da Magiora; dal Bocheto aBorgosesia (di Crevacuore), dal Fenera (Sitzia, 1997, p. 83, nota 52; pp. 236-242).
Particolare attenzione era dedicata alla coltivazione e al trasporto di mate-riale pregiato destinato a finiture lavorate e stufe. Per queste ultime si usava lapietra ollare, una categoria mercelogica che raggruppa litotipi costituiti preva-lentemente da clorite, talco e serpentino, che godono di una elevata refrattarietàtermica (e quindi resistono agli sbalzi di temperatura) e di una durezza moltobassa (che ne favorisce la lavorazione a mano e al tornio). I materiali più tene-ri erano destinati alla produzione di lavecc,66 quelli più duri alla fabbricazione
83
ve al pra dal troghi (Seccio) e in regione Snun (Rossa).Altre cave minori era-no presenti presso le frazioni Moline e Oro e alla Gula. La produzione di pio-de nel territorio di Boccioleto doveva essere notevole in quanto lo stesso Ciri-bini (1943, p. 23)63 lo indica come località di cava assieme a Rimella. In questalocalità erano sicuramente attivi cavatori di professione. In una convenzionestipulata nel 1776 Giovanni Battista Vasina, ed un altro suo compagno di Ri-mella, entrambi fabbricatori di piode, accettano di condurre per dodici anni unacava da cui ricavare piode dogni qualità piedini, scalini, cordoni gronde e sassi(Sibilla, 1985, d. 2, pp. 185-187). Boccioleto e Rimella sono ancora oggi gli uni-ci paesi della valle in cui sono attive maestranze dedite alla messa in opera ealla manutenzione di questo tipo di copertura dei tetti.
Il trasporto avveniva tramite slitte nella stagione invernale, o a spalla, conla caula, spesso anche su lunghe distanze. Dalle località citate il materiale ve-niva trasportato, per lo più da donne, anche a Varallo, ove era destinato anchealla copertura delle cappelle del Sacro Monte.
I materiali impiegati come leganti o sigillanti erano costituiti da argilla ecalce.
Le fessure tra i tronchi erano sigillate con impasti d’argilla e/o letame, op-pure con muschio. Presso l’alpe Tu delle Piane (presso l’alpe Tetto) si cavavaun’argilla molto grassa, chiamata localmente torba. L’argilla, cotta, veniva uti-lizzata anche per intonacare i muri.
La calce era utilizzata come legante e come materiale da intonaco. In val-le la distribuzione di rocce carbonatiche adatte ad essere coltivate per la pro-duzione di questo materiale è estremamente ridotta.64 Spesso in assenza di li-totipi carbonatici puri si utilizzavano probabilmente anche calcescisti, non co-muni ma comunque presenti in alta valle. Al loro utilizzo è probabilmente le-gata la presenza di mica, che rende talora luccicanti certi intonaci.
Una fornace per la cottura della calce nel territorio della Dorca fu ogget-to di un lungo contenzioso nel Seicento. In una lettera a Gerolamo d’Adda del16 novembre 1616 gli abitanti della Dorca si lamentavano che Antonio e Al-bertino Vietti hanno ardire di fare una fornace di calcina et tagliare il boscho,pregiudicando l’utilizzo della località per cui i consorti della Dorca pagano ald’Adda un affitto annuo di 13,10 lire (ASVa, FdA, s. I, b. 9; Istruzione …). Al-cune fornaci da calce esistevano presso Piè di Rosso; venivano indicate comesemidistrutte già a fine Ottocento (Casaccia, 1898, p. 265). Nel territorio di Car-coforo erano attive le cave di calce della Scarpia e della Costa caucinera (Fon-tana, 1994, p. 94). Una località ancora attualmente indicata come Costa cau-ciunera è ubicata sul lato meridionale del Colle del Termo, ove affiorano mar-mi e calcescisti. Lo sfruttamento di una fornace di calce situata nel territorio diCarcoforo fu regolamentato il 17 luglio 1743 da prefetto che, su istanza dei sin-daci della comunità; nell’ordinanza si stabiliva che non si dovevano costruire
82
Val d’Egua: nel 1540 il Magister Milanus filius Jannis del Molino de Rimella sti-pulava una convenzione con Giovanni Ragozzi di Carcoforo per la demolizio-ne di una torba a Campo Ragozzi (ASVa, FNV, b. 10368)
VALENZA ETNICA DELLE COSTRUZIONI IN LEGNO
Nella relazione stesa in Arona il 26 maggio 1553 Joachim de Annono, fun-zionario dello Stato di Milano, scriveva di aver trovato a Macugnaga case fattedi pietre grosse, ma con pochissima calcina, e quasi tutte senza camino, e dallamitta in entro, o circa, sono in parte di pietre e in parte di asse, e aggiungeva cheerano fatte di asse alla tedesca (Bianchetti, 1878, v. II, d. CLXXVI).Alcuni secolidopo, un viaggiatore inglese, il reverendo King, visitando le valli alpine a suddel Monte Rosa, descrisse la presenza di case di inequivocabile costruzione te-desca a Rima (1858, in Cerri, 1997, p. 128) e un’espressione analoga (baite te-desche, disposte in modo senza uguali, in sparpagliati gruppi) veniva usata perAlagna e Rimella (in Cerri, 1997, pp. 128, 108 e 148). Un altro viaggiatore,Halbfass (1894), scriveva di non aver ritrovato a Rimella le case svizzere de-scritte ad inizio secolo da Schottky (1836, citati in Bauen, 1978, p. 400).
Un proverbio alagnese ricordato negli stessi anni da Giordani (1891, p. 10),ampiamente citato nella letteratura locale vuole che dove vi siano case di le-gno e capelli biondi si parli tedesco (Wo holzerne hauser sind und blonde haa-re da spricht man deutsch). Il proverbio fissava l’idea da tempo radicata nell’a-rea alpina dell’associazione tra costruzioni in legno e popolazioni tedesche, an-notato da molti cronisti dell’Ottocento. L’abbinamento delle costruzioni in le-gno ad una cultura tedesca, o più specificatamente vallesana, fu assimilato an-che dalla letteratura specializzata italiana; nelle loro opere sulle case valsesia-ne Ciribini (1943) e ancora Comoli Mandracci (1967, p. 7) indicavano una “ti-pologia vallesana” contrapposta ad una “tipologia valsesiana”.
L’applicazione di questa associazione ha portato alcuni ricercatori ad uti-lizzare la presenza di questa tipologia costruttiva come tracciante etnico. Bauen(1978, p. 36) indicava proprio nella presenza di case a tronchi “col sistema adincastro di travi delle Gwatt” un possibile indizio della presenza walser a Car-coforo. Successivamente Castagno (1984, p. 117) segnalava la probabile colo-nizzazione walser delle valli ora francofone d’Herens e d’Entremont sulla ba-se di costruzioni a block-bau (successivamente confermata su basi documen-tarie da Zanzi e Rizzi, 1988). In assenza di documentazione d’archivio Rizzi(1989, p. 151; 1992, p. 99) riteneva probabile, per la presenza della tecnica co-struttiva a block-bau, la colonizzazione walser della conca di Livigno.
Una rigorosa applicazione di questa metodologia ha portato Dematteis al-la mappatura della colonizzazione walser nell’area alpina basata esclusiva-mente sulla presenza di queste costruzioni. In Val d’Aosta, sulla base del tipo
85
di stufe e di componenti architettonici. L’area di affioramento di questi litotipiattraversa, con andamento OSO-ENE le testate delle valli. Cave di questo ma-teriale erano presenti ad Alagna, a monte del centro parrocchiale e sopra l’al-pe Stofful inferiore (Mirici Cappa, 1997, p. 39); presso l’alpe Lampone, nel ter-ritorio di Ferrate; alla Gula di Carcoforo. In una Notta delie prati della fine delSeicento compare tra le coerenze di un prato al Molino di Minocho il Riale co-mune e il chroso della stuva, toponimo probabilmente derivato dalla presenzadi materiale adatto alla coltivazione per fornetti (ASPCa, b. 121, c. 33).
Un altro materiale pregiato era costituito dai litotipi destinati ad essere uti-lizzati come mole; da queste, che dovevano essere omogenee e possedere un’a-deguata durezza, dipendeva il buon funzionamento del mulino. Le pietre damacina avevano un gran mercato, soprattutto dall’area alpina e prealpina ver-so l’area padana.67 Una cava di questo materiale era ubicata in località Stroli,lungo il lato idrografico sinistro il T. Cavaione (a monte dei mulini Stroli e Gab-bio). Il trasporto delle mole dalle località di cava a quelle di utilizzo richiedevaun impegno notevole: il peso delle mole era ordinariamente di 4-5 quintali maraggiungeva talora anche 10-15 quintali.
Costruzione della casa
In letteratura è diffuso il mito della costruzione comunitaria della casa, ri-preso anche nei lavori più recenti. In realtà quest’usanza, secondo le testimo-nianze ottocentesche, era limitata al tiro in comune, per cui ogni famiglia man-dava un suo rappresentante ad aiutare a trasportare i tronchi dalla selva al luo-go di costruzione; ai partecipanti veniva offerto pane di segale ed acquavite(Giordani, 1981, p. 17; citato anche in Ciribini, 1943, p. 108). Il concetto di co-struzione comunitaria delle case è spesso associato in letteratura al concetto dispontaneità nell’architettura, già ampiamente ridimensionato da Zanzi (1986,pp. 92-94) e da Comoli Mandracci (1986, p. 131).
L’emergenza di nuove testimonianze documentarie sembrano indicarela presenza, almeno a partire dal Cinquecento, di maestranze specializzateche operano secondo precisi progetti talora corredati da disegni allegati al-le convenzioni (Pizzetta, d. 2, pp. 14-15). A Rimella le opere sono sempre af-fidate a mastri costruttori,68 formalizzate in contratti o convenzioni di dura-ta variabile da uno a quattro anni a decorrere dalla festa di S. Giovanni (Piz-zetta, 1995, p. 282; 1996, dd. 1-2). I costruttori si impegnavano anche a forni-re tutto il materiale (“Mettendo essi … ogni qualsivoglia prede, sassi, piode,assi, travi, legnami, canteri, pertiche e altra cosa […] che spetteranno ad es-so lavoro […] integralmente a loro spese eccetto le ferramenta” (Pizzetta,1996, d. 1, pp. 13-14).
L’impiego di maestranze professionali doveva essere ampiamente affer-mato se la presenza dei maestri costruttori di Rimella è documentata anche in
84
(1986, p. 109) sostiene invece che “ il sistema a block-bau … è riscontrabile so-lo nelle aree che corrispondono ai nuclei storici d’insediamento walser”, che,con i funghi, ritiene siano la “spia” certa di una comune eredità culturale.
Le critiche ad un uso forse troppo libero del significato etnico delle case inlegno hanno prodotto, o rilanciato, una visione che prevede l’uso nel legno svin-colato da tradizioni culturali e associato esclusivamente ad una ubicazione en-tro la fascia altitudinale delle conifere, sostituendo il determinismo etnico conun determinismo ambientale, talvolta applicato altrettanto disinvoltamente.71
Volgendo il problema ci si potrebbe chiedere perché, rimanendo in ambito lo-cale, in condizioni morfologiche e vegetazionali simili a quelle di Rimella nonvi siano, ad esempio, case in legno a Fobello.72
La disponibilità di risorse e l’assimilazione di tecniche costruttive che neprevedano l’uso possono essere condizioni talora necessarie e determinanti masicuramente non sufficienti. Per superare il determinismo etnico e ambientalesi deve riconoscere alle singole comunità una specifica capacità progettuale le-gata ad una complessa interferenza di assimiliazione culturale, adattamento anuove condizioni ambientali e climatiche, ricezione di modelli importati da po-polazioni migranti o da maestranze operanti in altri ambiti culturali. Significa-tivo, nella capacità di elaborazione autonoma di nuove soluzioni progettuali, èun modesto particolare segnalato in un lavoro sulle dimore alpine del CantonTicino: un solo insediamento su cinque in Val Malvaglia (Valle di Blenio) pre-senta dei corridoi sviluppati tra il pendio e il lato a monte delle case. La stessasoluzione è adottata nella località pedemontana dove svernano le famiglie diquesta villa (Buzzzi, 1996, pp. 271-273). Lo sviluppo di varianti tipologiche è av-venuto dunque indipendentemente dai condizionamenti geografici e culturali,attuandosi a livello di insediamenti appartenenti a singoli gruppi famigliari.Nella stessa zona è significativa anche la distribuzione della stufa, ampiamen-te discussa nella letteratura specializzata, presente solo in uno dei cinque inse-diamenti (Buzzi, 1996, p. 274).
Come rileva Castagno (1996, p. 80), se la presenza (a scala regionale) delblock-bau non significa necessariamente walser, né walser significa sempre e so-lo block-bau, è pur vero che nella quasi totalità degli insediamenti walser è pre-sente questo sistema costruttivo ligneo. L’Autrice ritiene che “la presenza sulterritorio di segni materiali o tecnologie” sia “un indizio valido, che non deve es-sere trascurato, ma che deve essere naturalmente opportunamente verificato,per supporre la presenza … sul territorio di quella etnia o di individui apparte-nenti a quella etnia o a quel tessuto culturale” (p. 74). L’attribuzione, a scala lo-cale, della costruzione di certe case a popolazioni walser deve dunque avere ilconforto di attestazioni documentarie o di attente ricostruzioni storiche.73
In ambito locale si può constatare come le case in legno siano presenti ininsediamenti fondati da coloni provenienti da diverse frazioni di Pietre Ge-
87
costruttivo, l’Autore ritiene probabile la presenza walser nel territorio di SaintVincent (1984, pp. 70-71); in alta Valpelline (p. 21), ove sono presenti case in le-gno e funghi (pp. 72-79). Nell’Ossola viene indicata una presenza walser a Cra-vegna, frazione di Crodo (1985, pp. 80-81); a Case Ligni, nel territorio di Pre-mia (pp. 84-85); ritiene inoltre probabile una compresenza anche a Ceppo Mo-relli, in Valle Anzasca (pp. 35, 58-59). Nelle Alpi Retiche l’Autore ritiene ac-certata la presenza walser a S. Stino (1987, pp. 22-25, 116-117) e in Val Febbra-ro (pp. 24, 118-119) in alta Val S. Giacomo. Sempre sulla base della tipologiacostruttiva, ritiene la presenza walser sia stata probabile a Dalò (pp. 18, 23) ein altre frazioni della bassa Val S. Giacomo sopra Chiavenna; a Bondeno e Ave-ro nell’alta Val S. Giacomo (pp. 114-115); a Sarogno (pp. 108-109) e Soglio (pp.18, 112-113) nella bassa Val Bregaglia; in alta Val Tartano (sul versante orobicodella Valtellina, p. 48-49); in Val Grosina (pp. 72-73), a Madonna dei monti (inValfurva, pp. 62-63), a Fumero e in altre località della valle Rézzolo (pp. 58-59),ad Arroga, in Val Viola sopra a Bormio (p. 67); a Livigno (pp. 25, 33, 68-69); laritiene inoltre possibile, ma molto dubitativa a Chiareggio. In un lavoro suc-cessivo lo stesso Autore estende l’area di colonizzazione walser comune di Val-leve (nell’alta Val Brembana, confinante con la testata della Val Tartano), ovesono presenti fienili con struttura a block-bau (1992, pp. 34, 37).
Dopo un secolo di studi la letteratura è ormai concorde nell’affermare chenon esiste un solo tipo di costruzione identificabile come casa walser (Zinsli,1970, p. 93; Carlen, 1986, p. 13), in quanto è ormai accertato che le popolazioniwalser hanno adottato in luoghi diversi soluzioni diverse.69
È del resto naturale che in queste popolazioni colonizzatrici, che fondaro-no nuovi insediamenti per migrazione attraverso vaste aree alpine, si sia veri-ficata una complessa interferenza tra modelli consolidati e soluzioni indotte danuove situazioni ambientali. Per le popolazioni stanziali le causalità naturalideterminano invece una tradizione più radicata nel tempo (salvo le variazioniinodotte da cause climatiche o dall’eventuale confronto con modelli innovati-vi esterni). Per le popolazioni migranti la tradizione culturale si interfacciò con-tinuamente con le caratteristiche del territorio di neocolonizzazione; la mobi-lità favorì inoltre il contatto con diverse forme culturali e la flessibilità ne per-mise numerosi prestiti.
Ma se è ormai chiaro che i walser non ebbero un modello di casa unico nel-lo spazio, ma ancor più nel tempo,70 rimane tuttora aperto il problema dell’u-so di certi materiali e di certe tipologie costruttive come traccianti etnici. Il prin-cipio dell’architettura etnocentrica, che vede contrapposto un modello tedesco(o nordico) ad un modello latino (o meridionale) è rifiutato da Zanzi (1986,pp. 86-92; 1996, pp. 31-32) e da Rizzi (1996, p. 53), che ammette comunque co-me il più significativo denominatore comune nelle case costruite dai walser sial’utilizzo del legno con la tecnica dei tronchi incastrati a block-bau. Gambi
86
la straiga seu tecto a feno, la parte centrale dal solario, quella inferiore dalla capsina(b. 8931). La voce cassina compare anche negli Statuti della Valsesia (Liber quartus,cap. 197; in Tonetti, s. III, p. 99). In Tonetti (1894, p. 103) la voce dialettale cassina è at-tribuita solo al “fabbricato in campagna … che serve al ritiro delle bestie bovine, delfieno, ecc.”. Secondo Borasi (1960, p. 328) indicava tutto il complesso rurale.Cardenza con tirabutti: mobile da cucina con cassetti.Caseris, caxeris: costruzione d’alpeggio.Casonis: costruzione d’alpeggio. Secondo Borasi (1960, p. 325) la voce indica la mar-ghera.Cassus: spazio tra due pilastri di sostegno di ogni fabbricato, ma in particolare diportici e di fienili.Casettus: locale per la conservazione del latte, corrispondente alla voce dialettalecasèt (assente in Tonetti, 1894).Curtis: vasca del letame antistante la stalla (curte ante capsina 1576, Campo Ra-gozzi, b. 8937); ma più in generale lo spazio aperto antistante le costruzioni civili erurali (capsina una cum una curte … ad Prata de Braccha a Campo Ragozzi nel1576, b. 8937). Sovente vi venivano rogati gli atti notarili.Domus: casa di abitazione.Domus ab igne: locale in cui si faceva fuoco; ma anche l’intera casa ospitante unastanza da fuoco. Domus ab igne Johannis filius quondam Antonii al Riale della Dor-ca nel 1497 (ASPF, b. XXVIII, Pergamene, f. 213). Ca da focho nel dialetto valsesia-no; firhus nel dialetto walser alagnese. Ca d’la fum nella letteratura etnografica.Fornello, fornetto: stufa in pietra ollare.Giacis: ricoveri precari negli alpeggi. Secondo Tonetti (1894, p. 172) la voce giacc in-dicherebbe i prati situati presso le capanne.Lobia: loggiato, galleria coperta distribuita su uno o più piani, e su uno o più lati,degli edifici polifunzionali (domus ab igne) e rurali (tectus a feno) presenti negli in-sediamenti permanenti e dislocati nei prati e nei pasqueri. Torba cum suis lobiis aRima ubi dicitur ad torbam illorum de Vyoto nel 1535 (b. 10366); domus et capsinecum torba solariata et partim lapideo muro murata et plodis coperta cum lobiis, por-ticu et curte nel 1567 a Campo Ragozzi (b. 8931); cassina et tectum a feno cum lobiiscurte et canevello a Ca Forgotti nel 1579 (b. 8935).Lobietus: piccolo loggiato; generalmente indica il piccolo loggiato limitato al pianosuperiore adibito a fienile. Domus … cum tecto a feno cum lobieto a Ferrate (ASVa,FNV, b. 8931).Porticus: galleria coperta al piano campagna.Romanellus: ripostiglio basso tra la trave di colmo e il soffitto del locale sottostan-te, generalmente privo di luci e disimpegnato dal loggiato; negli atti notarili la voceviene parzialmente sostituita dalla voce spazza cha a partire dalla seconda metà delCinquecento (in un documento del 1576 a Carcoforo Ca spaza domo sive Roma-nello; b. 8937)Sala: stanza. Stanza per magazzini accanto alla domus in Borasi (1960, p. 339).Scriptorio: studio. Scriptorio seu camera nella casa del notaio Pietro Clarino a Rivanel 1467 (SID, Fca, b. 15, p. 123) e del notaio Giovanni Grandi nel 1520 (d. 259).Setius: sedime di costruzione.
89
melle. Il gruppo di torbe più consistente, e con caratteristiche originarie omo-genee, è conservato a Rima, che fu fondata collettivamente da un gruppo di co-loni di provenienza alagnese e fu caratterizzato dalla presenza persistente del-l’etnia walser. Altri edifici, con tipologie costruttive molto diversificate, sonoconservati in insediamenti in cui è attestata la presenza di coloni provenientidal territorio multietnico di Pietre Gemelle (Priami, Campo Ragozzi,Tetto Mi-nocco, Carcoforo, Ca Ravotti). Si può pertanto plausibilmente affermare chela loro presenza sia direttamente correlabile alla presenza walser o sia legata,almeno indirettamente, al suo influsso culturale.
Glossario
Le voci presenti nei documenti del Quattrocento e Cinquecento citate nel te-sto sono riportate in un breve glossario. Oltre al significato della voce sono segna-late alcune citazioni esemplificative, generalmente selezionate tra quelle presentinei documenti cronologicamente più antichi. Viene inoltre segnalata l’eventualepresenza del termine in altri glossari di voci tardomedievali e il significato della di-zione dialettale riportata in Tonetti (1894).
Andamenta: strade e spazi di proprietà collettiva indivisa che disimpegnano gli ac-cessi alle case. Domus ab igne … cum suis viis et andamentis et pertinentiis a Rimanel 1535 (b. 10366).
Apotecha: magazzino. In apotecha Johannis de la Vogna (1490, SID, Fca, b. 15, d.166; nel 1492, d. 170).
Camera: camera. In camera del notaio Petrus de Clarino sulla Riva (1465, p. 120).
Camera cubiculari: camera da letto. Camera cubiculari a Rima (1568, ASVa, FNV,b. 10448).
Caminata: vano che ospita il camino.
Canepa, caneva: camera. Canepa a Riva (1426, SID, Fca, b. 15, d. 56); in un docu-mento del 1450 relativo ad un edificio di Boccioleto si trova espressa la sinonimiacanepa sive domo (SID, d. 95). Per canepa, caneva Borasi (1960, p. 328) rimanda acasa.
Canevellus, canvellus: cantina, locale per la conservazione dei formaggi ed altri ge-neri alimentari presente nelle residenze permanenti (domus ab igne cum suo cane-vello a Rima nel 1535, ASVa, FNV, b. 10366) e nelle costruzioni d’alpeggio (cane-vello super giacio inferioris Eigue, 1576, b. 8937). La voce, utilizzata in alcune loca-lità dell’alta valle, equivale alla voce truna, maggiormente diffusa in valle.
Capsina: stalla, edificio o parte di edificio adibito a ricovero di animali negli inse-diamenti permanenti, in quelli stagionali e negli alpeggi.Talora la voce è estesa a tut-to l’edificio rurale: nel 1560 alla Dorca una capsina murata solariata e straigata cumsuis lobiis; il documento precisa che la parte superiore dell’edificio era costituito dal-
88
Truna: cantina; locale generalmente ubicato in un’appendice al piano terra, taloraseminterrata, nelle costruzioni degli insediamenti permanenti o piccoli edifici neglialpeggi adibiti alla stagionatura e conservazione del formaggio. Truna posita sub-tus domum … cum porticu … ubi dicitur ad truna prope torbam a Carcoforo nel1565 (ASPCa, b. 122, c. 6). Truna una contigua … domus ab igne cum eius parte por-ticus et curtis ante et prope dicta truna alla Carvaccia nel 1576 (b. 10443). Voce dif-fusa equivalente alla voce canevellus diffusa in alcune località della valle. In Tonet-ti (1894, p. 313) truna, cantina.
Trunet: piccola cantina presente nelle casere degli alpeggi; la voce è presente anchenei documenti relativi al territorio di Rimella (Pizzetta, 1995, p. 276).
Appendice 1
GLI INCENDI IN VALSESIA
Le aree a maggior rischio di incendio si collocavano nella bassa valle, per lapresenza di coperture in paglia, e nell’alta valle, per la diffusa presenza del legno.74
Incendi nell’area dei tetti in paglia
A Quarna sotto, nella lunetta sotto il portico della chiesa parrocchiale, in unaffresco datato 1711, è raffigurato il patrono S. Nicola mentre arresta un incendio.A destra del santo sono raffigurate le case attorno alla parrocchiale, coperte a cop-pi; a sinistra le case rurali coperte a paglia (Dematteis, 1985, pp. 44-45).
Un incendio nel giugno 1852 incenerì i tetti delle case coperte in paglia a Ma-retti (ASVa,Viceintendenza, b. 192). Nel 1821 un incendio colpì una casa con tettocoperto in paglia alla cascina Girompina (Valduggia) (ASVa, Viceintendenza, b.192).
La Colma fu colpita da incendi nel 1759 e nel 1802; quest’ultimo distrusse 22case (Lana, 1840, p. 309).
Il 25 gennaio 1818 un incendio distrusse numerose case a Valbusaga. Il comu-ne di Borgosesia emise un’ordinanza con misure antincendio, tra cui la sostituzionedei tetti in paglia (Peco, 1993, p. 55).
A Quarona il 1 febbraio 1821 un fuoco, acceso da due bambini in un cortile, sipropagò come un fulmine ai coperti di paglia delle altre case contigue. Il 21 agosto1854 il fuoco, appiccato inavvertitamente da un altro bambino, provocò un altro in-cendio (ASVa,Viceintendenza, b. 192). L’abitato fu infine colpito da un incendio divaste proporzioni nel 1866 (Tonella Regis, 1991, p. 48, nota 3).
Civiasco, ove le abitazioni erano quasi tutte coperte a paglia, fu colpito dal fuo-co nel 1770. La notte del 2 marzo 1779 un nuovo incendio investì il paese. In unoZibaldone manoscritto di notizie e materiali raccolti (1824-1828), redatto da un ano-nimo, venivano annotate 52 case distrutte, 9 morti e 139 bestie perdute (Durio, 1926,p. 12-14). Dopo l’intervento del parroco,Vittorio Amedeo II stanziò una cifra per ri-fare la copertura dei tetti in tegole onde evitare il ripetersi di tali sciagure (Sottile,
91
Solarium: locale adibito al ricovero di fieno e granaglie, generalmente ubicato alpiano superiore delle domus ab igne e dei tecti (solarium situm in summitate penesculmeniam; solarium de summitate unius tecti).Nel 1560 alla Dorca una capsina murata solariata e straigata cum suis lobiis. Il do-cumento precisa che la parte superiore dell’edificio era costituito dalla straiga seutecto a feno, la parte centrale dal solario, quella inferiore dalla capsina (b. 8931).Solaio, orizzontamento portante in Borasi (1960, p. 339); solarium astregatum in Bo-rasi (1960, p. 326) orizzontamento pavimentato.
Spazza cha: ripostiglio basso tra la trave di colmo e il soffitto del locale sottostante,generalmente privo di luci e disimpegnato dal loggiato; voce diffusa negli atti no-tarili a partire dalla metà del Cinquecento in parziale sostituzione della voce ro-manellus. In Tonetti (1894, p. 287) spassaca, sottotetto che serve di ripostiglio.
Stantiis: stanze, disposte su uno o più piani. Edificium … cum suis stantiis superio-ris et inferioris a Rima nel 1723 (b. 8992).
Straygha: locale adibito a fienile, ubicato nel piano sommitale (talvolta direttamentetra le due falde del tetto), generalmente aperto in posizione frontale, presente nel-le costruzioni polifunzionali (domus ab igne) e negli edifici rurali. In un documen-to del 1560 alla Dorca compare una capsina murata solariata e straigata cum suislobiis. Il testo precisa che la parte superiore dell’edificio era costituito dalla straigaseu tecto a feno (b. 8931). In Tonetti (1894, p. 293) straiga, fienile col suolo non adassi ma a travetti sconnessi. Nel Biellese indica i fienili coperti (Calleri, 1966).
Stuva, stupha, stuffa: locale di soggiorno contenente il fornetto, generalmente con-tiguo al locale ospitante il focolare. Domus ab igne cum stupha annexa et fornellointus al mulino di Priami nel 1720 (b. 8992); stupha una cum uno fornetto a PietreMarce 1637 (b. 9884). Secondo Tonetti (1894, p. 296) indica sia la stufa che la stan-za ospitante la stufa. Giordani (p. 172) attribuisce la voce stuba alla camera; haitz-stuba alla camera con fornetto.
Stuphetto: locale di piccole dimensioni contenente il fornetto. Domus ab igne cumsuo stuveto a Rima nel 1535 (b. 10366). La voce è presente anche in documenti re-lativi al territorio di Rimella (Pizzetta, 1995, p. 276).
Tecchiallus: edificio rurale.
Tectum: edificio rurale, generalmente ospitante la cassina al piano basale e un so-larius al piano superiore, spesso con suis lobiis et suis portichu et curte. La voce, in-dicante nel latino medioevale le capanne isolate, è tuttora diffusa in tutto il Pie-monte. In Borasi (1960, p. 341) capanna, stalla a due piani, sopra per il fieno, sottoper gli uomini e le bestie.
Terraneum: piccoli edificii rurali monofunzionali destinati all’immagazzinamentotemporaneo del fieno. Terragno a Fervento nel 1480, (Fantoni e Fantoni, 1995, d.43); nella Valle di Piaggiogna nel 1531 (b. 10366); terragno murato et plodis copertoalle Balmelle nella valle di Rima (1567, b. 8933). La voce terragno (e terragno foe-ni) compare anche negli Statuti della Valsesia (Liber quartus, capp. 197, 211; in To-netti, s. III, pp. 99, 108). In Tonetti (1894, p. 305) teragn, specie di tettoia bassa, so-stenuta da pali ove si raccoglie paglia, letame. Nella bassa Valsesia la voce indica lestalle-fienili coperte a paglia e, per estensione, tutti gli edifici con copertura in pa-glia.
Torba, torbetto: cfr. discussione nel testo pp. 19-21. Nel glossario in Borasi (1960)indica granaio, cascina, podere.
90
colo di un incendio che si stava propagando ad una cascina coperta in paglia.A Valbella superiore un incendio scoppiato mercoledì 25 marzo 1868 distrus-
se 32 delle 33 case dell’abitato, di cui molte coperte a paglia (Sylva, 1889; Fontana,1997, pp. 45-46).
A Morca alcune case coperte a paglia bruciarono nel 1828. La Baraggia diMorca fu colpita da un incendio il 3 febbraio 1831 (ASVa,Viceintendenza, b. 192).
Nei documenti della prima metà dell’Ottocento numerose altre richieste di sus-sidio documentano altri incendi, senza specificarne la causa e senza indicare la ti-pologia degli edifici colpiti; ne furono interessati Valduggia (1825, 1826 e 1856), Cel-lio (1851), Zuccaro (1858), Foresto (1851), Parone (1825),Varallo (1843, 1850, 1857),Cervarolo (1851), Scopa (1826), Scopello (1826). (b. 192, ASVa, Viceintendenza)
Incendi nell’area delle costruzioni in legno
A Rimella in data imprecisata si verificò un grosso incendio alla Villa superio-re; nel 1818 bruciò l’intero villaggio della Chiesa ad eccezione della chiesa parroc-chiale). Il 26 febbraio 1833 un incendio bruciò una casa della famiglia Tosseri. Il 18dicembre 1853 un grosso incendio distrusse tutto il villaggio dei Prati con la sola ec-cezione di due case; il villaggio fu ricostruito in pietra (Bauen, 1978, pp. 397, 399).La frazione Riva fu colpita dal fuoco nel luglio 1855 (ASVa,Viceintendenza, b. 192).A Campello Monti, dopo l’incendio del 1843, venne offerta da un emigrante unacospicua somma per la ricostruzione a patto che fosse utilizzata per l’acquisto dicalce e per la costruzione di fornaci e per l’esecuzione di opere murarie per dis-suadere gli abitanti dall’uso del legno (Rizzi, 1996, p. 60).
Incendi di probabili edifici in legno sono documentati al Seccio da diffusi restidi legno carbonizzato rinvenuti durante numerosi scavi presso sedimi.
Ferrate fu interessata da un incendio nel 1834 (ASVa,Viceintendenza, b. 197).Carcoforo fu colpito da un incendio doloso il 28 dicembre 1863; il fuoco, appiccatoda Pietro Giovanni Josti, distrusse una ventina di case (Dionisotti, 1871, p. 33; Man-ni, 1980, f. IV, p. 238; Dematteis, 1984, p. 18; G.M., 1989, Fontana e Ferraris, 1991, p.8; Fontana, 1994, p. 133).A Rima un incendio il 12 novembre 1853 incendiò due ca-se (Axerio, 2000, p. 42). Un altro incendio è documentato nel 1856 (ASVa, Vicein-tendenza, b. 192).
Alla Peccia, in Val Vogna, Bellosta e Bellosta (1988, p. 126) ricordano nume-rose distruzioni di case provocate da incendi. Da un incendio fu colpita la frazioneMontata nel 1899 (Bellosta, p. 131). Un incendio nel marzo 1853 distrusse quattrocase a Selveglio (ASVa,Viceintendenza, b. 192).Altri incendi in Val Vogna sono se-gnalati da Bellosta (p. 137) a Ca Piacentino, Ca Vescovo, Rabernardo e Oro.
Un incendio, provocato dal fuoco acceso in un fienile da due bambini il 3 gen-naio 1819, distrusse le otto case della frazione Ponte ad Alagna, lasciando 15 fami-glie senza tetto (Daverio, 1985; Fontana e Ferraris, 1991, pp. 7-8). Nella frazione Pia-ne una casa fu distrutta da un incendio nel 1892 (Daverio, 1985). Un incendio di-strusse il 18 giugno 1866 metà delle case al Dosso; l’evento è ricordato da un’iscri-zione su una casa ricostruita in muratura dopo il funesto evento: il 18 giugno 1866dalle fiamme divorata/in maggio 1868 ricostruita. Un’altra casa ricostruita in mura-tura l’anno seguente l’incendio, siglata e datata MMVaR 1867, reca sull’architraveligneo del fronte l’iscrizione: Haec domus in cinerem redacta die XVIII iuniiMDCCCLXVI herus obiit die IV iulii ex rupe cadendo et vidua reaedificavit subse-quenti anno (Daverio, 1985).
93
1817, p. 43;Tonetti, 1891, p. 271). Successivamente la copertura delle case fu rifattaa piode e tegole (Lana, 1840, pp. 283-284).75 Ma l’opera non doveva essere statacompletata. Infatti, per favorire la sostituzione dei pericolosi tetti in paglia, il Con-siglio Comunale, riunito il 12 novembre 1849, deliberò di riscuotere 50 centesimiper il suono delle campane in occasione di funerali, anniversari e matrimoni da uti-lizzare per sostituire le coperture. La deliberazione non fu approvata dal Reggen-te dell’Intendenza (Durio, 1926, p. 17).
A Varallo vecchio un incendio il 15 dicembre 1831 distrusse alcune case e traqueste una con il tetto in paglia. Il Consiglio comunale, discutendo i provvedimen-ti per la sostituzione delle coperture in paglia con piode o coppi accennava che lacausa maggiore degli incendi erano indubitativamente li tetti delle case coperti di pa-glia (ASVa,Viceintendenza, b. 192; Peco, 1993, p. 55).
La Mantegna e il Cucco furono colpiti da un incendio nel 1894 (Dellarole,1999, p. 31)
Camasco fu colpito da un incendio nel 1737; ne rimane testimonianza in unquadro ex voto conservato nella sacrestia della Chiesa parrocchiale (Zacquini, 1993,pp. 129-132). Un altro incendio, scoppiato il 20 maggio 1787, coinvolse trentaduecase e provocò tre vittime; Maria Comola Zacquini ritenuta colpevole di incendiodoloso da parte della popolazione fu scagionata nel successivo processo (Manni,1974, f. II, p. 210; Dellarole Cesa, 1989; Zacquini, 1993, p. 132, nota 1).
A Morondo nel 1833 bruciarono nove casolari coperti a paglia (ASVa,Vicein-tendenza, b. 192). A Locarno per la caduta di un fulmine nel luglio 1827 bruciaro-no quattro case; una era coperta in parte in piode ed in parte in paglia; le altre trecompletamente in paglia (ASVa,Viceintendenza, b. 192).
A Cervarolo quasi tutte le case erano coperte a paglia sino all’incendio del 31marzo 1822, che distrusse 63 costruzioni a Villa superiore (Lana, 1840, pp. 240-241;Casalis, 1856, v. XXVIII, p. 78; 1999, p. 106; Manni, 1974, f. II, p. 237; Crippa, 2001).L’incendio del 2 gennaio 1834 al Sasso di Cervarolo (Crippa, 2001) è ricordato nel-le memorie del Filippa (in Sibilla, 1985); dopo questo fatto in Val Mastallone pergarantire la sicurezza fu impiegata la guardia nazionale e al minimo sospetto veni-va dato l’allarme suonando a martello le campane (Filippa, in Sibilla, 1985, pp. 143-144). Il 30 aprile 1844 fu quasi interamente distrutta Villa inferiore; l’incendio cau-sò quattro vittime (Casalis, 1856, v. XXVIII, p. 78; 1999, p. 106; Manni, 1974, f. II, p.237). Il 20 marzo 1898 il fuoco colpì le frazioni Volta e Solivo, provocando una vit-tima. Il 1 agosto 1907 fu infine distrutta la frazione Sassello (Ravelli, 1924, v. 2, p. 9).A Cervarolo si ricordano anche gli incendi del 1764 (nelle frazioni Corte e Solivo),1781, 1822, 1844, 1851 (a Villa superiore), 1879 (al Molinaccio, ove distrusse settecase), 1892 (ancora a Villa superiore) (Manni, 1974, f. II, p. 237; Cesa, 1997, p. 44)
Sabbia fu colpita da un primo incendio il 23 novembre 1666. Un’altro incendioinvestì la parte orientale del paese il 9 marzo 1902, distruggendo 28 case e facendostrage di bestiame nelle stalle. Gli anni successivi furono colpite alcune frazioni delcomune; il fuoco distrusse Massera la notte tra il 12 e il 13 luglio 1903; nel 1907 unincendio divampò ad Erbareti, che venne quasi completamente incenerito e subìdue vittime; il 22 marzo 1917 fu incendiata la Piana (Ravelli, 1924, v. 2, p. 16; Fonta-na e Ferraris, 1991, p. 6). Un incendio, il 9 marzo 1910, distrusse altre 28 case a Sab-bia (Pastore, pp. 8-9).
Cravagliana fu colpita da un incendio che incenerì il paese il 1 gennaio 1616(Ravelli, 1924, v. 2, p. 26). Una leggenda vuole che il santuario della Madonna delTizzone sia stato fondato sul luogo ove apparve la Madonna scongiurando il peri-
92
Varallo
La presenza di coperture in paglia a Varallo è confermata da numerosi atti delCinquecento e Seicento. Un’aia murata coperta di paglia con stalla a Sottoriva aVarallo è citata in un atto di compravendita del 1505 (ASVa, FdA, s. I, pergamene,15). Nel 1530 una casa venduta da Battista Manetta de Tato a Antonio Scarognini aVarallo è murata et coperta partim plodis et partim paleiis (FdA, s. I, b. 6). Case etrunetti coperti a paglia a fine ’600 fuori Varallo, ai Monticelli, sono citate in un do-cumento pubblicato in Dellarole Cesa (1992, pp. 87-88).
Val Grande e Val Sermenza
In un documento del 1537 è citata una cassina paleis coperta in villa Scoete ubidicitur intus curtem … de Zento (ASVa, FNV, b. 10367). Nel testamento del 1571del prete Guglielmo Alberganti, parroco di Boccioleto, sono citate due cascine unapaleiis coperta et altera discoperta nel territorio di Scopa ubi dicitur ad domos illo-rum de Blasio (b. 10620).
In un atto del 1574 (b. 3937) viene citato un casetus cum solarollo … murato etpaleis coperto nel territorio Techialli Rosse. Ai Casetti nel 1537 è documentata lavendita di una domus plodis coperta con la sua cassina paleis coperta; tra gli altribeni ceduti compare anche una parte di un torbeto paleis coperto in loco ubi dici-tur super planam de Cassetis (b. 10367).
La presenza di copertura in paglia è documentariamente provata sino entrol’area delle costruzioni in legno. In un atto di vendita di beni alla Dorca nel 1531veniva citata una capsina coperta partim paleis et partim plodis (b. 10366). Nel1538 veniva nuovamente citato un tectum copertum partim plodis et partim paleis(b. 10367).
In Val Vogna un alpeggio con un baitello oggi abbandonato nel territorio del-la Peccia è nominato benule. Molino (1997, p. 91) cita la voce benal, analoga a ben-ne, ad indicare nelle valli di Lanzo le stalle-fienili con tetto vegetale.
La distribuzione nell’Ottocento
Un rapporto sulla valle nel 1828 (Peco, 1993, p. 20), descriveva le abitazioni co-me coperte per lo più a paglia sopra travicelli. Nel 1840 Lana precisava che le caseerano per la maggior parte coperte a paglia a Merlera, Arlezze, Castagnola, Rasti-glione, Zuccaro, Breia, Cavaglia e Crevola; erano in parte coperte a paglia a Val-duggia, Agnona, Locarno, Quarona e Rocca. Ma ricorda che prima che gli incendile colpissero, le case erano quasi tutte coperte a paglia a Civiasco e Cervarolo. In ma-niera analoga si esprimeva negli stessi anni Casalis (1833).
A Civiasco ancora nel 1926 esistevano sei case con tetto in paglia (Durio, p.17). A Camasco case coperte con paglia sono ricordate ancora nel 1943 nel diariodi Letizia Folghiero (Dellarole Cesa, 1989). Nel diario di Luigia Zacquini redattoalla fine Ottocento a Solaro di Camasco si cita una sola casa priva di tetto in paglia.(Zacquini Scabbia, 1997, p. 237).
In Val Mastallone le coperture in paglia erano ancora diffuse a fine Otto-cento, nonostante i numerosi incendi che avevano colpito molti villaggi; un ver-bale relativo all’incendio del 1844 alla frazione Villa Inferiore di Cervarolo ri-peteva che le case, con la sola esclusione della chiesa, erano coperte in paglia(Crippa, 2001). In una Relazione del 1889 sul Comune di Cravagliana veniva
95
Appendice 2
LE COSTRUZIONI CON TETTO IN PAGLIA IN VALSESIA
Le costruzioni con tetto in paglia, indicate nell’area valsesiana come taragn,76
sono menzionate in tutti i lavori sulla casa tradizionale valsesiana (Ciribini, 1943;Comoli Mandracci, 1967; Dematteis, 1984). Indagini specifiche su questo tipo di co-struzioni sono state condotte da Gabetti (1960) e da Bondetti et alii (1993). I tetti inpaglia nell’area valsesiana sono stati inclusi in una rassegna più ampia da Molino(1997). Tra gli edifici ancora discretamente conservati gli Autori citavano quelli diInvozio (Valduggia, Comoli Mandracci, 1967, p. 120), Castagnola e Valgemelle, So-liva (Gabetti, 1960; Bondetti et alii, 1993), Roccapietra (Gabetti, 1960), Parone (Ga-betti, 1960), Doccio e Crevola (Molino, 1997, pp. 94-95), Roncaglio (Dematteis,1984, p. 75; Molino, 1997, p. 95), Valsessera (Dematteis, 1984), Valmaggia (ComoliMandracci, 1967, p. 118).Alpeggi con copertura in paglia sono conservati ormai so-lo in forma estremamente degradata nella valle di Doccio e sopra Roccapietra (De-matteis, 1984, pp 76-77 e 118).
La diffusione di questa tipologia costruttiva, attualmente osservabile solo in al-cune località della bassa valle, era un tempo molto più ampia e quanto rimane è cir-coscritto ad un residuo di un areale ben più vasto, documentato sino dal Trecentoanche nelle città di pianura (Novara, Vercelli, Alessandria, Torino e Cuneo; Moli-no, 1997, pp. 7-8). Il limite superiore dell’area di distribuzione, nella letteratura lo-cale, a partire da Ciribini (1943), veniva ubicato immediatamente a monte di Va-rallo (1943, p. 23), seguendo una separazione tra la copertura in paglia e in piodetra bassa e alta Valsesia già enfatizzata da Sottile (1817). Ma l’esame della memo-rialistica valsesiana dell’Ottocento e un’estemporanea analisi di fonti documentarieedite ed inedite evidenziano, oltre ad una forte persistenza nel tempo, una maggio-re estensione all’interno delle valli a nord di Varallo di questo tipo di copertura ri-spetto a quanto generalmente riportato in letteratura.
Borgosesia
Il Liber Primus Burgi Sexii, redatto alla fine del Cinquecento (Appendice 1 inBonardi, 1997, pp. 73-123; Bonardi, 1999, pp. 238-248), documenta come a Borgo-sesia la maggior parte delle case fosse paleis coperta. Solo alcune abitazioni eranocopertis coppis mentre gli edifici rurali erano sempre copertis paleis. La trasforma-zione era comunque in atto, poiché alcune case erano citate come coperte partimpaleis et partim coppis. Circa un secolo dopo, nel Libro delli luoghi del 1669 (Ap-pendice 2 in Bonardi, 1997, pp. 125-173; Maglione, 1999, pp. 260-272), sono più nu-merose le coperture in coppi, anche se sono ancora frequenti le coperture in paglia(soprattutto in Sacciola, al Borghignone e nella Ruaraygha; Bonardi, 1997, p. 56),persiste la presenza di coperture miste e permane la tendenza a ricoprire a coppigli edifici civili, mentre la sezione rurale della stessa proprietà rimane coperta a pa-glia (Maglione, 1999, p. 253; cfr. ad es. p. 263). L’utilizzo delle coperture in paglia eracompletamente radicato nella cultura locale ed anche gli edifici religiosi, cui era ge-neralmente dedicata una particolare attenzione, rientravano in questa tipologia. Inpaglia era coperto nel 1594 anche l’oratorio di S. Bernardo alla periferia di Borgo-sesia (Tonella Regis, 1997, p. 154).
94
Sigle e abbreviazioni
ASDN Archivio Storico Diocesano di NovaraASPBo Archivio Storico Parrocchia di BoccioletoASPCa Archivio Storico Parrocchia di CarcoforoASPFe Archivio Storico Parrocchia di FerrateASPFr Archivio Storico Parrocchia di FerventoASPRi Archivio Storico Parrocchia di RimascoASPRm Archivio Storico Parrocchia di RimaASVa Archivio di Stato di Vercelli, sezione di VaralloFCa Fondo Carestia (appartenente a SID, depositato presso ASVa)FdA Fondo d’Adda (in ASVa)FNV Fondo Notarile Valsesiano (in ASVa)SID Società di Incoraggiamento allo studio del Disegno,VaralloIstruzione … Istruzione circa li livelli di Dorcha che si pagano all’Illustrissimi Mar-
chesi D’Adda come successi all’Illustrissimi Scarognini (1625)(ASVa, FdA, s. I, b. 10)
b. bustac. cartacfr. confrontad. documentods. dattiloscrittof. fogliofasc. fascicolofn. fondoms. manoscritton. numerop. paginaperg. pergamenaq. quadernor. rectorist. ristampas. serieseg. seguentevol. volumev. verso
Nel testo i riferimenti alle fonti inedite sono costituiti dalla loro collocazionearchivistica; i riferimenti alle fonti edite presentano anche la collocazione archivi-stica solo quando questa è mutata rispetto a quella originaria. Negli elenchi di do-cumenti citati nel testo il riferimento archivistico è completo solo per la prima ci-tazione e ridotto alla sola collocazione quando il fondo e l’archivio sono uguali aquelli del documento precedente.
97
dettagliata la presenza di 3 case con tetti in paglia su 9 a Bocciolaro, 10 su 30 aBrugarolo, 11 su 39 a Brugaro, 5 su 20 ai Giavinali, 10 su 34 a Cravagliana (Syl-va, 1889).
Alle Piane di Cervarolo era ancora coperta in paglia negli anni Cinquantal’edificio che sarà trasformato ed ampliato come Rifugio dal Gruppo Camoscidel CAI di Varallo (Notiziario CAI Varallo, a. 10, n. 2, p. 3) e l’edificio attiguo(Notiziario CAI Varallo, a. 10, n. 2, fotografia p. 79). In una fotografia di fine Ot-tocento riprodotta in Cesa (1997, p. 26) si vedono le baite dell’alpe ancora tuttecoperte in paglia. Una cartolina d’inizio Novecento ritrae un bell’edificio rurale(stalla e fienile con loggiato frontale) con copertura in paglia a Brugaro (Moli-no, 1997, pp. 94-95).
Ringraziamenti e collaborazioni
La realizzazione del Censimento delle case in legno è stato effettuato con lacollaborazione di Lietta Ragozzi. Il paragrafo relativo al censimento dei mulini pre-senti nell’Ottocento in Val Cavaione è basato su appunti e materiale d’archivio diPino Cucciola, a cui sono debitore anche delle numerose informazioni sulle attivitàe sulle tradizioni di queste valli sparse nel testo.
Le fotografie nelle figg. 1-4, 8-10, 12-13, 18-25, 28-31 sono di Lietta Ragozzi;quelle nelle figg. 6-7, 11 di Pino Cucciola.
Si ringraziano Maurilio Della Vedova (Carcoforo) per la segnalazione e laguida alla visita alle torbe “mascherate” e per le informazioni sugli edifici in le-gno presenti in passato a Carcoforo; Maria Martinetti e Margherita Maccagno(Ferrate) per le informazioni fornite sugli edifici presenti e su quelli scomparsinelle frazioni della Val d’Egua e nella valle del Lampone; Valentino Tapella (Or-mezzano di Boccioleto) per le informazioni sugli insediamenti di Seccio e Tettoin Val Cavaione.
Si ringrazia inoltre, per la gentile assistenza fornita durante la ricerca docu-mentaria, tutto il personale e tutti i custodi degli archivi consultati.
96
tura tecnologica, tipologica ed insediativa della gente walser, in “La regola e il com-portamento: verso una nuova concezione della normazione edilizia”, Franco Angeli.
CASTAGNO L. (1986), Problemi di analisi comparate degli strumenti tipologici etecnologici degli insediamenti walser, in “La casa rurale negli insediamenti walser.Atti della terza giornata internazionale di Studi walser,Alagna Valsesia, 15 giugno1985”, pp. 197-210.
CASTAGNO L. (1996), Problemi di analisi comparate dei sistemi di segni mate-riali degli insediamenti walser, in “Le case dei walser sulle Alpi”, Fondazione Ar-chitetto Enrico Monti,Anzola d’Ossola, pp. 73-88.
CARESTIA (s.d.), I pregiudizi popolari della Valsesia, Soc.Vals. Cult., q. 2, pp. 36.CARLEN L. (1986), All’esplorazione delle case walser, in “La casa rurale negli
insediamenti walser. Atti della terza giornata internazionale di Studi walser, Ala-gna Valsesia, 15 giugno 1985”, pp. 13-23.
CARLEN L. (1986), All’esplorazione delle case walser, in “Le case dei walser sul-le Alpi”, Fondazione Architetto Enrico Monti,Anzola d’Ossola, pp. 13-16.
CIRIBINI G. (1943), La casa rustica nelle valli del Rosa, pp. 132.COMOLI MANDRACCI V. (1967), Le antiche case valsesiane, pp. 175.COMOLI MANDRACCI V. (1979), La presenza walser nella cultura del territorio
valsesiano, in “Catalogo del Museo walser”, pp. 5.COMOLI MANDRACCI V. (1986), Aspetti della struttura del territorio walser in Val-
sesia, in “La casa rurale negli insediamenti walser. Atti della terza giornata inter-nazionale di Studi walser,Alagna Valsesia, 15 giugno 1985”, pp. 127-137.
CRIPPA C.A. (2001), Cervarolo si racconta, Il Varallino, a. III, nn. 7-8.CUPIA G. (1895), Rima e il suo santuario della B.V. delle Grazie, Novara, pp. 79,
XXXIII.DAVERIO A. (1983), L’architettura delle case di Alagna, in “Alagna Valsesia. Una
comunità walser”, pp. 193-224.DAVERIO A.(1985),Alagna Valsesia.Censimento delle antiche case in legno,pp.205.DEBIAGGI (1989), Aspetti dell’emigrazione valsesiana prima del secolo XIX, pp.
171-180.DELLAROLE CESA R. (1989), Camasco, paese di fuoco, CV, a. 94, n. 36, 29 set-
tembre 1989.DEMATTEIS L. (1984), Case contadine in Valle d’Aosta, Priuli e Verlucca, pp. 127.DEMATTEIS L. (1984), Case contadine nel Biellese montano e in Valsesia, Priuli
e Verlucca, pp. 127.DEMATTEIS L. (1985), Case contadine nelle Valli dell’Ossola, Cusio e Verbano,
Priuli e Verlucca, pp. 127.DEMATTEIS L. (1987), Case contadine in Valtellina e Valchiavenna, Priuli e Ver-
lucca, pp. 127.DEMATTEIS L. (1996), Il fuoco di casa nelle tradizioni dell’abitare alpino, Priuli
e Verlucca, pp. 87.DIONISOTTI (1871), La valle Sesia e il Comune di RomagnanoDURIO A. (1926), Civiasco. Memorie storiche. Contributo alla storia della Valle
Sesia, rist. anast. 1989, Soc.Vals. Cult., Comune Civiasco, pp. 233.FANTONI E. e FANTONI R. (1991), Geologia del M. Fenera: ipotesi sulla genesi
del sistema carsico, de Valle Sicida, a. II, n. 1, pp. 11-22.
99
Riferimenti bibliografici
AA.VV. (1979), Catalogo del Museo walser, pp. 4, 8, 28, 40.AA. VV. (1986), La casa rurale negli insediamenti walser. Das bauernhaus in
den walsersiedlungen.Atti della Terza giornata internazionale di studi walser.AlagnaValsesia-15 giugno 1985, Fond.Arch. Enrico Monti, pp. 315.
AA. VV. (1996), Le case dei walser sulle Alpi. Fondazione Architetto EnricoMonti,Anzola d’Ossola, pp.179.
ASTRUA P. (s.d.), Quattrocento in Valsesia.Tutela storica ed emergenza, Min. Be-ni Cult.Amb.
AXERIO M.C. (2000), Rima e il suo territorio. La “perla della Valsesia” tra natu-ra e storia, Novara, pp. 110.
BAUEN (1978), Sprachgemischter Mundartausdruck in Rimella (Valsesia, Pie-mont), Verlag Bern Stuttgart; trad. it. a cura di E.Vasina, 1999, pp. 460.
BELLOSTA S. e BELLOSTA R. (1988), Valle Vogna. Censimento delle case di legno,pp. 189.
BENETTI D. (1996), A confine tra diverse culture: le tipologie delle dimore rura-li in Valtellina e Valchiavenna, in “La dimora alpina. Atti del convegno di VarennaVilla Monastero. 3/4 giugno 1995”, pp. 307-332.
BONDETTI P., DEL BUONO G., FAVERO A. e LORA LAMIA A. (1933), Il “taragn”di Sorzano, de Valle Sicida, a. IV, n. 1, pp. 309-314.
BONARDI C. (1997, a cura di), Borgosesia 1247-1997.Vicende di un insediamen-to prealpino tra Medioevo ed Età Moderna, Comune Borgosesia, Politecnico Tori-no, Soc.Vals. Cult., pp. 188.
BONARDI C. (1997), L’architettura domestica, in “Borgosesia 1247-1997.Vicen-de di un insediamento prealpino tra Medioevo ed Età Moderna”, Comune Borgo-sesia, Politecnico Torino, Soc.Vals. Cult., pp. 40-42.
BONARDI C. (1999), Borgosesia e Montrigone: vicende insediative di due realtàcontermini, dalla “curtis” all’età moderna, in “Borgofranco di Seso 1247-1997. I tem-pi lunghi del territorio medievale di Borgosesia. Atti del convegno-Borgosesia 7 e8 novembre 1997”, Soc.Vals. Cult., pp. 223-248.
BORASI V. (1960), Cenni filologici sulle aggregazioni valsesiane: dagli statuti lo-cali e dalle carte notarili,Atti e mem. Congr.Varallo Sesia, Soc. Piem.Arch. e BelleArti, pp. 313-363.
BUZZI G. (1996), L’atlante dell’edilizia rurale in Ticino (AERT). Obiettivi, con-tenuti e prime conclusioni, in “La dimora alpina.Atti del convegno di Varenna Vil-la Monastero. 3/4 giugno 1995”, pp. 259-279.
CASACCIA P. (1898), Qua e là in Valsesia. Descrizioni - racconti - leggende, pp.301.
CASALIS G. (1833-1856), Dizionario Geografico Storico - Statistico - Commer-ciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, ed. 1999, CAI Varallo, pp. 502.
CASTAGNO L. (1979), Gli insediamenti walser nella dinamica del popolamentomedioevale, in “Catalogo del Museo walser”, pp. 9.
CASTAGNO L. (1984), Un esempio di norma aperta del passato.Analisi della strut-
98
MOLINO G. (1985), Campertogno. Vita, arte e tradizioni di un paese di monta-gna e della sua gente, EDA,Torino, pp. 311.
MOLINO A. (1997), Tetti di paglia, Priuli e Verlucca, pp. 111.MORNESE C. (1995), Rima-Rimmu. Ieri oggi domani, Novara, pp. 165.MONTERIN U. (1937), Il clima sulle Alpi ha mutato in epoca storica?, CNR,
Comitato per la geografia, II Ricerche sulle variazioni del clima italiano, 2,pp. 53.
NIEDERER A. (1986), La casa rurale nell’alto vallese alpino, in “La casa ruralenegli insediamenti walser”.Atti della terza giornata internazionale di Studi walserAlagna Valsesia-15 giugno 1985, pp. 113-125.
PAPALE (1988), Introduzione, in Bellosta e Bellosta, 1988, pp. 9-17PASTORE C. (1963), La nonnina di Sabbia ha compiuto i 100 anni, La Valsesia,
a. XI, n. 1, gennaio 1963.PECO L. (1989), La grande carta della “Valle di Sesia” del 1759, Soc. Vals. Cult.PECO L. (1993), Dopo la bufera napoleonica. Restaurazione e provincia di Val-
sesia, Edizioni Zeisciù, pp. 214.PIZZETTA S. (1993), Introduzione ad uno studio sulle antiche case walser di Ri-
mella, de Valle Sicida, a. IV, n. 1, pp. 267-281.PIZZETTA S. (1995), Il notaio Emiliano Calcino di Rimella, de Valle Sicida, a.
VI, n. 1, pp. 275-301.PIZZETTA S. (1996), La casa a Rimella tra il ’500 ed il ’600 negli atti del notaio
Emiliano Calcino, Remmalju, a.VII, pp.13-17.PIZZETTA S. (1999), Le case walser di Rimella, Remallju, a. X, pp. 32-40.RAVELLI L. (1924), Valsesia e Monte Rosa, Novara; rist. anast. Arnaldo Forni
editore, Sala Bolognese, 1980, vv. 2, pp. 280 e 364REMOGNA M. (1993), Casa Robbo a Sella, Remmaljiu, a. IV, p. 27.RIZZI E. (1981), Walser. Gli uomini della montagna, die Besiedler des Gebir-
ges, Fondazione Arch. Enrico Monti, pp. 79RIZZI E. (1983), Sulla fondazione di Alagna, Boll. St. Prov. No., a. LXXIV, n. 2.RIZZI E. (1989), Appunti per una mappa delle colonie walser “sommerse”: casi
di estinzione della cultura e della lingua in epoca storica, in “Lingua e comunicazio-ne simbolica nella cultura walser.Atti del VI convegno internazionale di Studi wal-ser. Gressoney St. Jean, 14-15 ottobre 1988”, Fondazione Arch. Enrico Monti, An-zola d’Ossola, pp. 147-156.
RIZZI E. (1991), Walser regestenbuch. Fonti per la storia degli insediamenti wal-ser, Fondazione Arch. Enrico Monti,Anzola d’Ossola, pp. 351.
RIZZI E. (1992), Storia dei walser, Fondazione Arch. Enrico Monti, Anzolad’Ossola.
RIZZI E. (1996a), Elogio dei walser, dell’”hof”, del legno e della “stube”, in “Lecase dei walser sulle Alpi”, Fondazione Architetto Enrico Monti,Anzola d’Ossola,pp. 49-64.
RIZZI E. (1996b), Dimore alpine e colonizzazaione walser in Val Formazza, in“La dimora alpina.Atti del convegno di Varenna Villa Monastero. 3-4 giugno 1995”,pp. 231-241.
ROMANO G. (1976) in Opere d’arte a Vercelli e nella sua provincia. Recuperi erestauri 1968-1976. Catalogo della mostra.
101
FANTONI B. e FANTONI R. (1995), La colonizzazione tardomedioevale delle Val-li Sermenza ed Egua (alta Valsesia), de Valle Sicida, a.VI, n. 1, pp. 19-104.
FANTONI R. e CUCCIOLA P. (1998), Antichi insediamenti della Valsesia. Oro diBoccioleto, de Valle Sicida, a. IX, n. 1, pp. 205-239.
FANTONI R. e RAGOZZI L. (1997), Piè di Rosso, Notiziario C.A.I.Varallo, a. 11,n. 1, pp. 47-53.
FILIPPA G.B. (s.d.), Memorie della Vicinanza della Sella ed altre memorie patrieraccolte dal Sig.or Gio. batta Filippa fu Michele Tesoriere e Benefattore dell’Oratorioe fondatore del Museo (ASPRm, ms., in Sibilla 1985, pp. 95-182).
FONTANA E. e FERRARIS P. (1991), La compagnia dei pompieri di Alagna Val-sesia, pp. 58.
FORNASERI G. (1958), Le pergamene di San Giulio d’Orta dell’Archivio di Sta-to di Torino, Bibl. St. Subalpina, v. CLXXX, p. I.
FERRI L. (1960), La cappella di S. Pantaleone ad Oro di Boccioleto, Atti e Mem.Congr.Varallo Sesia, pp. 13-17.
GABETTI R. (1960), Tetti di paglia,“taragn”, nella Valsesia inferiore, Atti e mem.Congr.Varallo Sesia, Soc. Piem.Arch. e Belle Arti, pp. 369-381.
GABRIELLI (1956), La pittura in Valsesia prima di Gaudenzio, in “GaudenzioFerrari”. Catalogo della mostra.
G.M. (1989), CV a. 94, n. 6.GAMBI L. (1986), Riflessioni metodologiche sullo studio dell’abitazione rurale, in
“La casa rurale negli insediamenti walser. Atti della terza giornata internazionaledi Studi walser,Alagna Valsesia,15 giugno 1985”, pp. 105-111.
GIORDANI G. (1891), La colonia tedesca di Alagna Valsesia e il suo dialetto, pp.201.
GUICHONNET P. (1996), La dimora alpina nelle Alpi Occidentali franco-pie-montesi, in “La dimora alpina. Atti del convegno di Varenna Villa Monastero. 3-4giugno 1995”, pp. 133-149.
HALBFASS W. (1894), Rima und Rimella, zwei deutsche Sprachinseln in Piemont,in “Mitteilungen des deutschen und osterreichischen Alpenvereins”, n. 3, pp. 29-31,n. 4, pp. 41-43.
HUNZIKER J. (1900-1911), Das Schweizerhaus nach seinen landaschaftlichenFormen und seiner geschichtlichen Entwicklung, Aarau, vv. 8.
LANA G. (1840), Guida ad una gita entro la Vallesesia, Tip. Merati e comp., No-vara; rist. anast. Libreria Alpina, Bologna, 1977, pp. 389.
LONGO P. G. (1987), Fonti documentarie sui Francescani a Varallo Sesia tra XVe XVI secolo, Sacro Monte di Varallo, quaderno di studio n. 5, pp. 29-108
MAGLIONE O. (1999), Montrigone: studio di un antico insediamento incastellatotra età moderna ed età contemporanea, in “Borgofranco di Seso 1247-1997. I tempilunghi del territorio medievale di Borgosesia. Atti del convegno, Borgosesia 7 e 8novembre 1997”, Soc.Vals. Cult., pp. 249-274.
MANNI E. (1980), I campanili della Valsesia. La Valsermenza, pp. 309.MESTURINO V. (1960), Le case rustiche di Oubre Rong, Atti e mem. Congr.Va-
rallo Sesia, Soc. Piem.Arch. e Belle Arti, pp. 365-369.MIRICI CAPPA M. (1997), Ambiente e sistema edilizio negli insediamenti walser
di Alagna Valsesia, Macugnaga e Formazza, Priuli e Verlucca, pp. 99.
100
etiam per aguadagnare qualche cosa, come è suo costume, et sono in lontani pay-si. Solum veneno una volta l’anno a casa del Natale (Longo, 1987, p. 66; Debiag-gi, 1989, p. 117).
Un indice sensibile al fenomeno migratorio è offerto dalla stagionalità dellenascite, che negli insediamenti caratterizzati da migrazione stagionale con rientroa dicembre-gennaio (caso diffuso in Valsesia) determina una forte natalità nei me-si di settembre-ottobre. Un forte incremento delle nascite in questo periodo è de-scritto da Viazzo, su serie purtroppo discontinue ma esenti da elementi perturban-ti, a partire dal 1590 (1990, pp. 80-81; 1990, pp. 177-178). La proporzione delle na-scite registrate nel trimestre autunnale nei decenni a cavallo tra fine Cinquecento einizio Seicento è analoga a quella registrata nell’Ottocento.
Una conferma qualitativa a questa fonte viene dal Giordani (1891, p. 7), che ri-teneva che gli Alagnesi avessero iniziato ad emigrare verso il Seicento.
L’analisi di un documento quasi sincrono fornisce un quadro dell’intensità del-l’emigrazione in Valsesia. Negli Atti di visita di Antonio Tornielli del 1641 (ASDN,vv. 133-134) si legge che plerique exeunt da Alagna, fere omnes da Rimasco, multida Riva, Scopello, Scopa, Rimella e Rossa, evidenziando la diffusione del fenome-no nelle comunità dell’alta valle. In contrasto si scopre che gli emigranti dalle co-munità della bassa valle erano nonnulli a Borgosesia, Cellio,Valduggia, Ferruta, Lo-carno e Colma, pauci a Plello, Agnona e Doccio, nulli a Foresto (Viazzo, 1990, p.82). La distribuzione evidenzia il forte impatto ambientale sul fenomeno, che inve-ste soprattutto le comunità di frontiera ecologica dell’alta valle, analogamente aquanto è documentato in Ossola (Mortarotti, 1985, pp. 175-176) ed a quanto è lo-gico aspettarsi in altre aree alpine.
Viazzo (1990, p. 82) a conferma della persistenza delle stesse condizioni nel-l’Ottocento cita Lana (1840) estraendone alcune citazioni sull’intensa emigrazionenei paesi dell’alta valle in contrasto a quanto avveniva nella comunità di Breia, ovei più si applicano in patria colle donne a tessere tela, all’agricoltura ed alla custodiadell’armento. Ma, come invita lo stesso Viazzo, lo studio delle variazioni dell’inten-sità dell’emigrazione e l’analisi della proporzione tra intensità nell’alta e nella bas-sa valle devono essere approfonditi con l’analisi di serie storiche quantitative.
Una correlazione tra deterioramento climatico ed aumento dell’intensità del-l’emigrazione è ipotizzato da Guichonnet (1980), che accenna all’emigrazione apartire dalla metà del Cinquecento (p. 257) nel capitolo che significativamente ti-tola “Le Alpi si richiudono”, in contrapposizione alla sua definizione di “Alpi aper-te” dei secoli precedenti.
Un’altra importante fonte è costituita dagli atti redatti in occasione dei sinda-cati, riunioni assembleari delle comunità di villaggio. Mentre nella prima metà delCinquecento compaiono quasi tutti i capifamiglia, dalla fine del secolo sono semprepiù frequenti i rappresentanti di interi gruppi assenti. Nel Seicento e Settecento i sin-dacati vengono tenuti solo nel periodo invernale e nei rari casi di riunioni svoltesi inaltre stagioni compaiono rappresentanze quasi esclusivamente femminili.
A partire dalla metà del Cinquecento si registra inoltre l’arrivo di pastori oro-bici (cfr. Fantoni, 2000, nota 47, pp. 283-284), che sfruttarono probabilmente la di-minuzione del carico degli alpeggi, indotta dalla riduzione del numero di bestie af-fidate alla cura della sola componente femminile delle comunità alpine.
3 Anche in altre valli le case più antiche, rispondenti a logiche insediative su-perate, sono da tempo retrocesse a edifici rurali (cfr. ad es. Niederer, 1986, p. 118,per la Loetschental).
103
RONCO E. (1997), I maestri prismellesi e il tardogotico svizzero (1490-1699),Edizioni Zeisciù, pp. 212.
SCOTTKY J.M. (1836), Das Thal ven Rimella und seine deutschen Bewohner,SOTTILE N. (1817), Quadro della Valsesia, Novara, rist. anst. 1979, Ed. Corradi-
ni, pp.314.TONELLA REGIS F. (1991), La chiesa di S. Giovanni al Monte dei Tucri: i silenzi
della storia, in “La Chiesa di S. Giovanni al monte a Quarona”, pp. 15-56.TONETTI F. (1884), Condizioni agricoleTONETTI F. (1875-1891), Museo storico ed artistico valsesiano, ss. II-V, rist. ana-
st. 1973, Borgosesia, pp. 280, 136, 144.TONETTI F. (1891), Guida illustrata della Valsesia e del Monte Rosa, rist. anast.
1995, Borgosesia, pp. 532.TONETTI F. (1894), Dizionario del dialetto valsesiano, rist. anast. 1983, Bologna,
pp. 334.VASINA E. (1995), Per una storia di Rimella, Remmalju, a.VI, pp. 6-14.VIAZZO F. (1990), Comunità alpine.Ambiente, popolazione, struttura sociale nel-
le Alpi dal XVI secolo a oggi, pp. 427.ZACQUINI R. (1993), Una storia di “Grazia”, de Valle Sicida, a. IV, n. 1, pp. 129-
132.ZANZI L. (1986), Architettura e “civilizzazione” nella storia dei walser, in “La
casa rurale negli insediamenti walser”. Atti della terza giornata internazionale diStudi walser Alagna Valsesia-15 giugno 1985, pp. 25-103.
ZANZI L. (1986), Architettura e “civilizzazione”, in “Le case dei walser sulle Al-pi”, Fondazione Architetto Enrico Monti,Anzola d’Ossola, pp. 25-40.
Note
1 Case in legno, oltre che nelle località citate e in quelle esaminate in questolavoro, erano presenti nei territori di Cervatto e Campertogno.A Cervatto è pre-sente una torba molto rimaneggiata (Dematteis, 1984, p. 111).A Campertogno unedificio in legno, identificato con il nome di ca d’torba, era ancora presente all’i-nizio degli anni Ottanta nella frazione Cangello (Molino, 1985, p. 172). Un’altraca d’torba, nota come ca ’dj avji, fu distrutta da una valanga nel 1888 ad Otra (Mo-lino, 1985, p. 175).
2 Il periodo di inizio dell’emigrazione in massa in Valsesia è variamente (e spes-so liberamente) citato nella letteratura locale.
La prima segnalazione di emigrazione della popolazione valsesiana è citatain una lettera del 1495 dei fratelli Scarognini al Duca di Milano. Nel contestodelle lotte tra Francesi e Sforza il duca di Milano chiedeva agli Scarognini di rac-cogliere il maggior numero di uomini possibile. Nella risposta dei fratelli Mila-no e Francesco Scarognini del 12 giugno 1495 si impegnano a raggrupparne ilmaggior numero possibile ma precisavano che la mazor parte de li homeni dellaValle più apti a manezare l’arme, se trovano absenti de qui sì per la penuria, si
102
13 1530, 1548 (ASPB, b. XIX, f. 155); 1537-1538 (ASVa, FNV, b. 10367); 1560,1562 (ASVa, FNV, b. 8931); 1571 (ASPB, b. XXI, f. 158). Del prete Zali sono docu-mentati due fratelli, già deceduti nel 1537. Una sua nipote (Chatarina filia quon-dam Antonii) era moglie di Michel filius quondam Anselmi de Alberganti di Crava-gliana (ASVa, FNV, b. 10367), fratello del venerabilis dominus presbiter Antonius,che aveva i benefici dell’altra metà della parrocchia di Boccioleto (1530, ASPB, b.XIX, f. 155; 1535,ASPB, b. XXIII, f. 163; 1549,ASPB, b. LIII).
14 In altri documenti compare come Antonius filius quondam Gasparis de Oro(ASPB, b. XXXV).
15 Alla Dorca numerose case in pietra, per lo più datate o attribuibili al Cin-quecento, presentano una o più colonne tonde a sostenere il loggiato frontale. L’u-so è diffuso in altre case come in altri insediamenti della val d’Egua. L’uso di pila-stri “murati in calcina” è documentato nelle convenzioni per la costruzione di casea Rimella alla fine del Seicento (cfr. Pizzetta, 1996, d. 1, pp. 13-14).
16 Tra 1537 e 1548 è documentato Antonius filius quondam Alberti de Sarto diCa di Zelle abitante a Priami (ASVa, FNV, bb. 10367-10369 e ASPB, b. XXIII, f.163), nello stesso periodo i suoi fratelli Johannes e Franciscus sono ancora docu-mentati a Ca di Zelle (1531,ASVa, FNV, b. 10366). La provenienza dei De Sarto aCa di Zelle risale alla fine del Quattrocento, quando compare Otolinus filius quon-dam Petri de Sarto de Petris Gemellis habitator ad domo de Cha de Zellis (1497, Fan-toni e Fantoni, 1995, d. 47).
17 Cfr. § precedente.18 Sulla famiglia Manetta cfr. Fantoni e Fantoni (1995, p. 51) e Fantoni e Ra-
gozzi (1997).19 Tamponamenti in muratura sono comuni anche a Rimella. Tamponamenti
in muratura costruiti in aderenza alle pareti lignee presentano le case Robbo e Fi-lippa, entrambe su quattro piani, di cui i due superiori in legno, alla frazione Sella.In un’altra casa della stessa frazione la parete in muratura ha invece sostituito quel-la in legno (Pizzetta, 1999, p. 38). Pizzetta (1993, p. 279; 1999) ricorda la presenza aRimella di oltre una decina di case in legno e di altre che hanno conservato il nu-cleo in legno dietro le nuove facciate in pietra. Sono segnalate otto case antiche inlegno a S. Gottardo; quattro alla Villa inferiore (con altre due che conservano in-ternamente la struttura in legno); due al Grondo (1999, p. 40); una alla Chiesa; no-ve complessivamente alla Sella (1999, p. 34).
L’uso del rivestimento in muratura fu introdotto in Val Formazza nella frazio-ne S. Michele per protezione dopo un incendio avvenuto nel 1765 (Dematteis, 1985,p. 89). Analogamente a Carcoforo l’introduzione potrebbe essere avvenuta dopol’incendio del 1863.
Tamponamenti in muratura delle strutture lignee sono presenti anche in al-tre località dell’arco alpino. Block-bau in legno incastonati all’interno di struttu-re più recenti in muratura sono presenti in alcune località dell’alta Val S. Giaco-mo (prov. SO) (Benetti, 1996, pp. 317, 321-322). Le facciate degli edifici lignei so-no ricoperte da un muro di pietre intonacato con calce a Osiadigo, un piccolo in-sediamento dell’alta Val Leventina (Canton Ticino), ove sono anche conservatialtri edifici in cui il legno è rimasto a vista.
20 L’incendio fu appiccato da Pietro Giovanni Josti, appena rientrato in paese
105
4 Gli incendi furono la causa principale della distruzione di molti edifici in le-gno, che vennero successivamente ricostruiti secondo le nuove tipologie. Emble-matico è il caso di Rimella, ove Halbfass (1894) scriveva di non aver ritrovato (do-po i numerosi incendi avvenuti nell’Ottocento) le case svizzere descritte ad iniziosecolo da Schottky (1836) (citati in Bauen, 1978, p. 400).
5 Ancora emblematico è il caso di Rimella, ove numerose case in legno in lo-calità Tse Mijne (i Molini), al Grondo, furono travolte da un’alluvione nel 1882 evennero successivamente ricostruite in muratura (Bauen, 1978, p. 400).
6 Dalla voce block, tronco di legno. Negli atti rimellesi ricorre la voce incava-dura, che Rinoldi (1943) traduceva in incastratura e Pizzetta (1996, p. 14) ritiene in-dichi l’incastro a block-bau.
7 È attualmente diffusa anche nella letteratura valsesiana l’esistenza della tra-dizione in Valsesia della finestra dell’anima, aperta solo quando una persona stavaper morire (o appena era morta) per consentire il passaggio dell’anima del defun-to. In realtà la sua enunciazione risale al 1938 per la regione walser dei Grigioni(Davos e Avers) (Stoffel, 1938; Zinsli, 1970) e la tradizione fu successivamente in-dividuata anche per il Vallese (Schnidrig, 1971) e poi ripresa altrove anche se non viera traccia documentaria o tradizione orale. In Valsesia la tradizione era probabil-mente assente. Non ne faceva cenno a fine Ottocento l’abate Carestia in una notasui “pregiudizi popolari in Valsesia”.
8 Il materiale doveva essere noto in alta valle e nell’area ad etnia prevalente-mente walser poiché la voce compare nel dialetto alagnese (cfr. Ciribini, 1943, p. 41,che in un breve glossario cita schindlu ad Alagna e schindla a Macugnaga, proba-bilmente derivate dalla voce schind, che ad Alagna indica un pezzo di legno spac-cato). Secondo Giordani (1891, p. 166) la voce schindla, scandola significa “assicel-la verticale di steccato”.
Le coperture in scandole dovevano un tempo essere diffuse nell’area wal-ser. Secondo (Rizzi 1996, p. 60), nell’area della colonizzazione walser sino alCinquecento, la copertura in scandole dominava incontrastata. In numerosepergamene del Quattrocento relative a Bosco Gurin sono più volte citati “fab-bricati coperti in scandole”; in un atto del 1598 è citata a Formazza una casa inpietra con coperture in scandole. In un atto del 1621 è una casa in legno di Can-za (Val Formazza) ad essere coperta in scandole (Rizzi, 1996, p 60). Alcune ca-se con copertura in legno sono ancora presenti in Val Formazza (Dematteis,1985, pp. 88-89).
9 Nella prima metà del secolo un artigiano di Ca Forgotti, frazione alla basedella valle di Oro superiore, produceva ancora il materiale per questo tipo di co-pertura.
10 In Val Vogna un alpeggio con un baitello oggi abbandonato nel territorio del-la Peccia è nominato benule. Molino (1997, p. 91) cita la voce benal, analoga a ben-ne, ad indicare nelle valli di Lanzo le stalle-fienili con tetto vegetale.
11 Sulla cappella di S. Pantaleone cfr. Gabrielli (1956), Ferri (1960), Romano(1976),Astrua (s.d.), Fantoni e Cucciola (1998).
12 Il telaio di un antico letto proveniente da questa casa, che la tradizione vuo-le sia appartenuto al prete Zali, è attualmente conservato nella sacrestia dell’ora-torio dell’Annunziata a Boccioleto.
104
anche nell’area walser occidentale (Formazza, p. 54), mentre giunse solo nel corsodell’Ottocento ad Alagna (p. 50).
35 Tra i documenti del Cinquecento: stuva nelle case di Martino Salino di Pe-delegno nel 1541 (SID, b. 16, d. 322); del padre del notaio Gaspare de Gaspo di Ala-gna nel 1555 (d. 351), di Alberto Ecclesia nel 1556 (d. 353); del padre del notaioJohannes Baptista Minoya nel 1574 e nel 1578 (dd. 370, 372).
36 Un’altra convenzione per la costruzione di una casa a Riva Valdobbia(Pietre Gemelle) ad opera dei maestri Pietro Ghiger e Giacomo Igonetto nel1574 è documentata negli atti del notaio Romolo Chiarino di Varallo (ASVa,FNV, b. 9814).
37 Un caso ugualmete emblematico di un’altra valle alpina è fornito dall’acco-stamento di due case parallele a Blatt inferiore (fotografia in Valsesia, 1999), cheadottano le stesse soluzioni e materiali: quella datata 1620 presenta due piani; quel-la datata 1775 tre piani.
38 In un documento del 1565 a Carcoforo si trova una truna posita subtus do-mum … cum porticu … ubi dicitur ad truna prope torbam (ASPCa, b. 122, c. 6).
39 Nei palazzi varallesi le case dei notai avevano anche uno studio attrezza-to con una catedra (casa del notaio Bernardino Baldo di Varallo nel 1530; ASVa,FdA, b. 6).
40 L’Inventario della parrocchia di Rimasco del 1723 ci decrive la casa in cuiabitava il curato: casa con due stanze di sotto due di sopra due cantinette una stuffaun dispensilino di sopra coperto tutto di piode una stalla et un tetto da fieno copertoa piode con giardino. Nella casa si trovava una cardenza con tirabutti una cathenada fuocho con dodeci anelli un tondino d’abete vecchio una lettera due bottoli dibrente ... e doi d’una forma l’uno (b. 8984).
A Carcoforo il parroco Allegra, entrato in possesso della cura di Carcoforo, ri-strutturò la casa parrocchiale, dedicando particolare attenzione al giardino. Il 20marzo 1739 acquistò per 24 lire da Maria Maddalena del fu Francesco Zuccalla diCampo Ragozzi, moglie di Bartolomeo Pensa de valle Sogna, pastore abitante aCampo Ragozzi, un porticus alias domus cum lobbia confinante con la casa par-rocchiale (ASPCa, b. 121, c. 62). Il risultato dei lavori è descritto nell’Inventario del-la parrocchiale del 30 agosto 1749 (d. 13;ASPCa, b. 114, c. 10) e negli Atti di Visitadel 1760 (d. 15; ASDN, AVi, v. 313/II, ff. 888r-920v): Casa parochiale murata e co-perta a piode con stuffa annessa da una parte e la cantina dall’altra in piano di terra,a due camere di sopra ristaurate di nove finestre, una nella sala et li altra nella sua ca-mera a proprie spese del presente Rdo Sig. Curato Allegra, e luogo comune e cortile incui vi è dentro un canvello fatto a proprie spese dal sudto Rdo Sig Cuto con ivi annes-se un ben comodo giardino ridotto con gran spese dal proprio Sig Cuto che ha ven-duto quello lontano dalla casa parochiale (a Tetto Minocco) per 100 lire e con que-sto si è comprato il fondo del presente giardino. Probabilmente al termine della ri-strutturazione fece dipingere sopra la porta di accesso al giardino della casa par-rocchiale la scena arcadica con il motto NON HABEMUS HIC CIVITATEM MA-NENTEM SED FUTURAM tuttora presente, facendo riportare il suo nome e l’an-no di immissione in possesso della cura della parrocchia (1734 A… 16 R.P.P Alle-gra) (Fantoni, 2000).
41 V. nota 19.
107
dopo aver scontato una pena di sei mesi nel carcere di Varallo. Il fuoco bruciò com-pletamente una ventina di costruzioni (Monte Rosa, 1 e 8 gennaio 1864; Dionisot-ti, 1871, p. 33; Manni, 1980, f. IV, p. 238; Dematteis, 1984, p. 18; G.M., 1989; Fontana,1994, p. 133).
21 Nella Parochia di Carcofforo ha portato via N 33 case nella “Memoria dellainnondazione seguita nella vale sesia in detto anno come sopra 1755 ed alli 14 8brestesa da Giovanni Battista Regozio” (giunta conservata in copia del 2 giugno 1854di Carlo Zamboni del Molino di Ferrate (Fontana, 1994, p. 91). Sull’alluvione del1755 cfr. Fantoni (2000).
22 Manni (1980, f. IV, p. 242) riteneva che la località fosse posta alla confluenzatra Egua e Trasinera e che le costruzioni fossero state abbattute dall’alluvione del1755.
23 L’impiego di un tronco ricurvo è diffuso anche nelle case in legno della ValVogna.
24 Sei date sono comprese tra 1500 e 1550, venticinque tra 1550-1600, tren-totto tra 1600-1650, trenta tra 1650-1700, trentaquattro tra 700-1750, quindicitra 1750-1800, trentadue tra 1800-1850, ventitre tra 1850-1900 e sette nel Nove-cento.
25 La cognizione di un percorso evolutivo simile a quello descritto da Casaccia(1898) rimane anche nella memoria storica della generazione più anziana. Alcunetestimonianze raccolte ripropongono una storia simile e la convinzione che le casein legno fossero la casa tradizionale in tempi antichi è radicata in buona parte del-la popolazione più anziana.
26 Cfr. f. 56 p. 21 in Dematteis (1996) per il fuoco in una casa al Ronco supe-riore di Alagna.
27 firhus (letteralmente casa da fuoco) nel dialetto walser; Ca da focho nel dia-letto valsesiano.
28 L’evoluzione intuita da Casaccia è ripresa anche nella letteratura specializ-zata (Ciribini, 1943, p. 66).
29 Gli sfiati a muro sono ancora ben conservati in numerose costruzioni, in in-sediamenti permanenti e in alpeggi, in Val Cavaione.
30 Per un maggior dettaglio sulla distribuzione geografica e sulle variazioni tem-porali dell’uso del fuoco nelle case alpine si rimanda a Dematteis (1996).
31 In Mirici Cappa (1997) il locale a fianco della cucina (firhus) viene identifi-cato come stube a Macugnaga (p. 52) e in Val Formazza (p. 56) e come stand ad Ala-gna (p. 48); Giordani (1891) indicava invece per Alagna una generica corrispon-denza tra la voce stuba e la camera, dettagliando con haitstuba la camera con for-nello (p. 172).
32 Sull’efficienza di questo tipo di stufa si rimanda a Pedrotti (1994), citato inMirici cappa (1997, p. 35).
33 Sulla cultura della stufa, oltre al capitolo relativo contenuto in Dematteis(1996), si rimanda a Rizzi (1996).
34 Secondo Dematteis la sua diffusione a larga scala si verificò nelle Alpi cen-tro-orientali nel corso del Cinquecento (Dematteis, 1996, p. 42) quando comparve
106
renti nella macro (Ca Ravotti) e micro-toponomastica (campus de la ravera allaCarvaccia, 1571, b. 10620).
Tra le coltivazioni non destinate a scopi alimentari va segnalata quella della ca-napa. La sua coltivazione, grazie alla facilità di adattamento al clima alpino e allarapidità di crescita, si diffuse rapidamente in tutto l’arco alpino. La semina avveni-va nel mese di maggio e a settembre le piante erano pronte per poter essere rac-colte. Dopo l’essiccamento al sole gli steli erano messi a macerare in apposite poz-ze d’acqua (borri). Una volte asciugati al sole gli steli erano sottoposti a strigliatu-ra, con separazione delle fibre, che venivano pestate e pettinate.
54 Nel territorio di Varallo nella gestione dell’attività mulinaria era coin-volta anche la famiglia Scarognini, che nel Quattrocento e Cinquecento posse-deva molti mulini che venivano concessi in enfiteusi. Nel 1463 acquistarono daBartolomeo di Giacomo della Barattina la metà dei diritti di un mulino “allaRiva”; in documenti successivi il mulino è detto “vicino al ponte” e “sotto ilponte” (Inventario...). Altri mulini gli Scarognini avevano a Valmaggia (1540), aDoccio (1498, 1561) e alla Bagnola (1585; Inventario…). Nel catasto di Varallodel 1536 (ASVa) figurano i diversi mulini che gli eredi di Milano Scarogninipossedevano sotto la Riva del T. Mastallone, alla Scarpiola, alla Riva del Bosco(Cesa, 1997, p. 42).
55 Numerosi documenti sui mulini nel territorio di Pietre Gemelle si trovanonelle carte del fondo Carestia (SID), ove sono citati i mulini del Gabbio (1518, p.246), di Ca Verno (1525, p. 280), a Sulla Riva (1531, p. 296) a Vogna (1691, b. 17, dd.161, 162, 164). Nel 1437 è documentato un mulino ubi dicitur in gulla Vogna infe-riori (b. 15, p. 74); nel 1518 è citato un pratus molendini al Gabbio di Riva (b. 16, d.246; nel 1523 citato come prato apud molendinum, d. 268); nel 1525 un mulino a CaVerno (d. 280); nel 1531 un mulino semidistrutto alla ripa baranzanis alla Rusa diAlagna (d. 297); nel 1691 due mulini a Vogna (SID, b. 17, dd. 161-162, 164). Per i mu-lini presenti in Val Vogne cfr. Bellosta e Bellosta (1988); per quelli presenti nel ter-ritorio di Campertogno cfr. Molino (1985).
56 Zanolus filius quondam Petri notari de Battico de Bozoleto.57 In altra parte del documento la località è indicata come loco de Molino sive
ad Rabiosum.58 L’edificio ospitava anche, in due stanze, il primo ufficio postale della valle,
attivo in questa località ancora a metà Novecento. In fronte a questa costruzionesono ancora presenti i resti di mura perimetrali di un edificio (5105) che ospitavauna fabbrica di cappelli di mezzalana di proprietà di Battista Alberti, che trasmisealla discendenza, ancora presente a Rossa, il nome di Capleit.
59 Il Cruzzio (voce dialettale per burbero) era cavatore di pietra per fornelli.Venne travolto da una valanga mentre estraeva materiale nella cava della Gula,lungo il T. Egua alle spalle del paese.
60 In legno duro erano anche i chiodi e i cardini (conservati negli edifici del Tet-to in Val Cavaione).Altre essenze erano utilizzate per mobili o suppellettili. L’ace-ro si usava per scodelle e posate, il tiglio per zangole e rastrelli; la corteccia di be-tulla per le zangole per la ricotta.
61 Sulle caratteristiche tecniche e sui processi produttivi di questi materiali sirimanda a Mirici Cappa (1997, schede B4-B6, pp. 43-45). La scelta dei materiali nonsi limitava alla selezione delle essenze ma interessava anche altre caratteristiche
109
42 Questo fenomeno di parziale abbandono delle frazioni alte e di sviluppo dialcuni centri di fondovalle potrebbe essere all’origine di una teoria formulata dalCasaccia (1898) sulla fondazione delle frazioni di fondovalle da parte di coloni pro-venienti dalle frazioni alte. Il processo di filiazione verso il basso si manifestò an-che nel Cinquecento, con la fondazione di insediamenti attorno a strutture di ser-vizio (mulini) che sfruttavano le risorse idriche (ad esempio il Mulino della Car-vaccia). Ma in molte comunità caratterizzate da insediamenti sparsi la formazionedi un villaggio numericamente consistente attorno al centro parrocchiale, in prece-denza solo baricentro geografico della comunità, è un fenomento tardivo nello svi-luppo di questi territori. Il centro parrocchiale a Ferrate e a Rimasco, ricostruibileattraverso i documenti cinquecenteschi, poteva contare un numero veramente esi-guo di fuochi rispetto alla consistenza delle altre frazioni, che era paragonabile aquella attuale.
43 Casa Ragozzi è datata e siglata sotto la trave di colmo RC 1907.44 La riunione delle funzioni, nell’ambito dell’area walser, è comunemente ri-
tenuta una caratteristica peculiare solo delle costruzioni di Alagna e Gressoney (cfr.Mirici Cappa, 1997, p. 8).
45 Per una sintesi sulla Piccola Età glaciale si rimanda a Lamb (1977) e Grove(1988); per una bibliografia relativamente aggiornata a Bradley e Jones (1995).
46 Una corretta valutazione dell’impatto ambientale della Piccola Età Glacia-le deve essere comunque fondato su un’approfondita analisi di tutti i parametri cli-matici. Il deterioramento climatico di questo periodo, caratterizzato globalmentesoprattutto da una riduzione delle temperature, potrebbe non coincidere nell’areasudalpina con un aumento della piovosità nei mesi estivi.
47 Il foraggio viene trasportato direttamente dopo la fienagione nel luogo cen-trale ove sarebbe avvenuto il foraggiamento.
48 Il foraggio rimane temporaneamente sul luogo ove avviene la fienagione eviene portato in luogo centrale successivamente, generalmente nella stagione au-tunnale, quando l’allevatore dispone di maggior tempo.
49 Il foraggio rimane sul posto e il bestiame va presso i luoghi di sfalcio.50 Sembra quindi esservi una correlazione tra villaggi accentrati e gestione del
territorio con trasporto del foraggio; tra insediamenti sparsi e gestione del territo-rio con movimento del bestiame. La configurazione ad insediamenti sparsi nonavrebbe dunque una matrice etnica, come spesso affermato in letteratura, ma sa-rebbe prevalentemente legata ad un condizionamento ambientale.
51 In un documento del 1563 è citato tra i confini in fondo alle alpi del Mas-sero e del Fornetto il pasquerio de domo illorum de perachino (b. 10448), ove an-cora esiste una costruzione localmente nota come pasquà. Analogamente a Ri-ma sotto le alpi Lavazei e Vallè sono citati nel 1566 in fundo pasquera Rime (b.10448). Questi pasqueri, vicino a costruzioni adibite anche a residenze tempora-nee, erano citati negli atti come herbatici de domo (de domo illorum de perachi-no, b. 10448; herbatico de domo quod vocatur del Cugnolo, 1562, b. 10439, d. 82,Fantoni e Fantoni, 1995).
52 Un’altra costruzione un tempo presente nella stessa località è bruciata nel1975.
53 Nel Quattro-Cinquecento era diffusa anche la coltivazione delle rape, ricor-
108
struzione in luoghi diversi attribuendo a questa differenza spaziale effetti indot-ti invece dalla differenza temporale.
71 Il ricorso a tradizioni etniche è ancora recentemente invocato, e decisamen-te contrapposto ad un determinismo geografico, da Guichonnet per le costruzioniin legno della Savoia (1996, p. 142).
72 Analogamente alle valli Maggia e Verzasca, ove sono rispettivamente pre-senti ed assenti gli edifici in legno (Zanzi, 1986, p. 87). L’uso del legno in Val Mag-gia è progressivo: risalendo la valle si trovano prima case di sola pietra, poi casecon struttura portante in pietra e con riempimenti in fasciame di legno ad operaverticale, poi case con struttura portante il legno in opera orizzontale (Zanzi,1986, p. 79; 1996, p. 30).
73 Edifici in legno nell’area alpina non colonizzata da popolazioni walser sonoad esempio presenti a S. Bernolfo (1760 m) e, in minor misura in altre borgate del-la valle, alla testata del vallone di Bagni, valle laterale della valle della Stura di De-monte) (Castagno, 1996, p. 80, p. 87, nota 43). In questa località il sistema costrutti-vo a block-bau si sovrappone all’uso di coperture, oltre che in scandole, anche inpaglia (Molino, 1997, p. 89), analogamente a quanto documentato per l’area valse-siana alla frazione Dorca. L’uso fu probabilmente introdotto dalla vicina alta valledella Tinée, che corre parallela alla Valle Stura alle spalle di S. Bernolfo, ove le co-struzioni in legno sono ancora relativamente diffuse. Nella stessa area costruzioni inlegno si trovano nella valle del Lians (beiul-les-Launes), affluente del Var, paralle-lo alla valle del Tinèe (Castagno, 1996, p. 80, p. 87, nota 43).
Edifici in legno con tecnica a block-bau in aree in cui non è documentata lapresenza walser sono segnalati anche in insediamenti di versante della bassa vald’Aosta, sopra Saint Vincent (Demattes, 1984, pp. 70-71), in Valtournanche (a Tor-gnon, Chamois, La Magdaleine e Valtournanche; Dematteis, 1984, pp. 72-79); nellamedia Val d’Ayas (Dematteis, 1984, pp. 64-65); in alta Valpelline (Dematteis, 1984,pp. 86-87).
Nelle Alpi centrali edifici in legno sono segnalati in diverse località della Val-tellina; a S. Stino (Dematteis, 1987, pp. 116-117) e in Val Febbraro (pp. 24, 118-119;Benetti, 1996, pp. 317-318) in alta Val S. Giacomo (Valle del Liro); a Dalò (Demat-teis, 1987, pp. 18, 23) e in altre frazioni della bassa Val S. Giacomo sopra Chiavenna;a Bondeno e Avero nell’alta Val S.Giacomo (Dematteis, 1987, pp. 114-115); a Saro-gno (pp. 108-109) e Soglio (pp. 18, 112-113) nella bassa Val Bregaglia; in alta Val Tar-tano (sul versante orobico della Valtellina, p. 48-49); in Val Grosina (pp. 72-73), inValfurva (Dematteis, 1987, pp. 62-63; Benetti, 1996, pp. 317-318), a Fumero e in al-tre località della valle Rézzolo (Dematteis, 1987, pp. 58-59), ad Arroga, in Val Vio-la sopra a Bormio (p. 67); a Livigno (pp. 25, 33, 68-69; Benetti, 1996, pp. 317-318); aChiareggio. In Canton Ticino sono ancora presenti case in legno in alta val Leven-tina (Buzzi, 1996, p. 274) e in alcune valli laterali della valle di Blenio (Val Malva-glia), ove altre case erano documentate in passato anche sul fondovalle (Olivone)(Buzzi, 1996, pp. 263-266).
74 Gli incendi non risparmiarono, in condizioni sfavorevoli, pascoli e boschi. Nel1734 a Carcoforo il fuoco dato da Carlo Antonio Peracino ad un suo pascolo pernettarlo, a causa di un vento molto galiardo, si propagò a boschi ed altri pascoli. Di-versi abitanti di Carcoforo, accorsi per spegnere l’incendio, rimasero ustionati; nel-l’incendio perse la vita Margherita Zanolla, che cercò invano scampo alle fiammein un torrente (ASVa, FNV, b. 3004).
111
colturali; ad esempio, secondo una tradizione perdurata sino a tempi recenti, tra gliabeti si preferivano quelli che crescevano sui versanti esposti a sole, che diveniva-no più rossi e compatti. Era inoltre tradizione che le piante fossero tagliate in lunacalante (preferibilmente l’ultimo giorno del ciclo lunare) per impedire che tarlas-sero in autunno.
62 Sulle caratteristiche meccaniche e sui processi produttivi di questi materialisi rimanda a Mirici Cappa (1997, schede B1-B3, pp. 40-42).
63 La presenza di lastre al Seccio è segnalata anche in Tonetti (1911, p. 28).64 Una fornace è documentata nel 1494 a Rabernardo, quando i consorti del-
la squadra di Vagoti concedono per un anno ad Alberto di Ianno di Vogna il per-messo di cuocervi la calcina (SID, FCa, b. 15, p. 172). Una cava nel vallone del For-nale era cartografata nella Carta del 1759 (Peco, 1988). Una cava da calce era at-tiva ai Merletti inferiore ad Alagna. Il pozzo per la cottura della calce, lungo ilsentiero Merletti-Goreto, datato 1867, venne utilizzato per l’ultima volta nel 1922(Mirici Cappa, 1997, f. 43, p. 39; p. 50).A Rimella (a sud del Landwasser) era cen-sita una cava nella Carta del 1759 (Peco, 1988). In questo comune erano ancoravisibili sino agli anni Settanta tre fornaci di pietra a struttura tronco-conica (Si-billa, 1985, p. 139, nota 79).
65 Per la loro distribuzione (Maggiora,Valduggia, M. Fenera, Crevacuore e So-stegno) cfr. Fantoni e Fantoni (1991, fig. 1, p. 12).
66 La diffusione dei lavecc è documentata anche negli atti notarili. In un inven-tario di beni Peracino a Carcoforo nel 1568 compaiono lavezia lapidibus (ASVa,FNV, b. 8931).
67 Ad esempio un commercio di mole è documentato negli Statuta CommunisVercellarum (Ordano, 1956; in Chiappa Mauri, 1984, p. 168 nota 73) della fine delXII secolo, che impongono agli Eporediensi, ai signori di Montaldo e Sellino e alconte di Moriana il libero transito delle mole provenienti dalle alpi valdostane. LaValle Anzasca era un’altra grande produttrice di mole (Gruppo Archeologico diMergozzo, 1982; citato in Chiappa Mauri, 1984, p. 168, nota 75).
68 A Rimella negli atti di fine Cinquecento e inizio Seicento sono documenta-ti i mastri Rinoldi e Volpe, i Calcina, i Caneparo (Pizzetta, 1996). Maestri costrut-tori erano attivi anche a Riva (cfr. ad esempio, un documento del 1574 in ASVa,FNV, b. 9814).
69 Per una rassegna della letteratura sulle case nelle diverse aree a popola-mento walser nell’area alpina si rimanda a Carlen (1986, 1996); per un aggiorna-mento sull’analisi delle diverse tipologie costruttive in diverse aree walser si ri-manda ai contributi in AA.VV. (1986).
70 Le diversità tra i diversi tipi di casa illustrati in letteratura non sono impu-tabili solo a variazioni esclusivamente spaziali. L’analisi delle costruzioni nell’a-rea valsesiana ha evidenziato la forte variabilità temporale delle soluzioni adot-tate. È dunque necessario analizzare le tipologie costruttive su solide basi crono-logiche ed eseguire studi comparativi sulla variabilità spaziale delle case walser(e non) basandosi su esempi realmente riconosciuti come isocroni. Spesso, per as-senza di alcuni livelli stratigrafici (per incendi, calamità naturali, massicce ristrut-turazioni) non è possibile effettuare una completa seriazione. In assenza di precisiriferimenti cronologici, talvolta sono stati probabilmente confrontati tipi di co-
110
75 Per prevenire gli incendi il Consiglio comunale, il 10 febbraio 1821, aveva nelfrattempo stabilito che era vietato portare combustibile acceso da casa a casa, am-massare in cucina e nella camera da fuoco canapa, foglie, canelli, paglia, fieno odaltro materiale facilmente combustibile; obbligava gli abitanti a scopare la stradaper tenerla pulita da materiale infiammabile, a tenere presso casa un recipiented’acqua della capacità di almeno una brenta, a permettere i controlli agli agenti in-caricati di entrare nelle case per verificare il rispetto delle norme (ASVa, Vicein-tendenza, b. 192).
76 Nel limitrofo Biellese sono indicati come teggie.
112