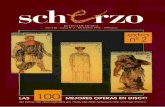Verdino Lo Scherzo leopardiano
Transcript of Verdino Lo Scherzo leopardiano
Sommario
Tabula gratulatoria p. 7Premessa (G.I.) » 9
PER ELIO GIOANOLASaba e Papini (da Autobiografia a Storia e cronistoria
del Canzoniere) (ANDREA AVETO) » 13Pascoli e i simboli della poesia (GIORGIO BÁRBERI SQUAROTTI) » 29Per Fernando Bandini (GIAN LUIGI BECCARIA) » 41Alfieri, Racine, Manzoni (ALBERTO BENISCELLI) » 57Il lupo e il somaro nelle Favole di Gadda (GIORGIO BERTONE) » 79Cesare Viviani. Lo sguardo dell’infanzia (DANIELA BISAGNO) » 89Il silenzio di Francesco Biamonti (VITTORIO COLETTI) » 115Caproni ’45: Genova, i libri, i giornali (FRANCO CONTORBIA) » 123Un episodio del dantismo novecentesco:
l’interpretazione “gioachimita” del veltro (SERGIO CRISTALDI) » 127Al di qua di Metello: requiem di Vittorini per il neorealismo
(FRANCESCO DE NICOLA) » 151O di uno o di nessuno, ovvero un’inconfessata unione di fatto
(PIETRO FRASSICA) » 161Due lettere inedite di Cesare Pavese
(MARZIANO GUGLIELMINETTI) » 175La “grande guerra” di Pirandello (GIOVANNA IOLI) » 177Appunti per una metafisica del “segno” in Savinio
(IDA LI VIGNI) » 187La “traversata” di Paolo Murialdi (ancora sulla Resistenza
nell’Oltrepò Pavese montano, con un’intervista al comandante Maino) (QUINTO MARINI) » 199
Padre. La figura del padre nella cerchia degli affetti di Adriano Sansa (STEFANIA MARTINI) » 241
La «valigia pesante» di Montale prosatore in viaggio da Firenze a Genova (FEDERICA MERLANTI) » 253
Ritratti, oggetti e vite evanescenti (Commento a Io e te che sorridiamo dalla foto di Dondero di Giovanni Giudici) (SIMONA MORANDO) p. 277
Amore e Morte in Tomasi di Lampedusa(FRANCESCO OLIVARI) » 299
Letteratura e multidisciplinarità: dalla psicoanalisi alle neuroscienze (LAURA SALMON) » 371
Tracce leopardiane nell’opera di Caproni: primi appunti(LUIGI SURDICH) » 391
Aspetti linguistici e testuali delle Città invisibili di Calvino(ENRICO TESTA) » 409
Bianco come il silenzio. Strutture tipografiche e interpuntive nei romanzi di Francesco Biamonti (ELISA TONANI) » 423
Il travestimento pirandelliano di Edoardo Sanguineti: Sei personaggi.com (FRANCO VAZZOLER) » 443
Lo “scherzo” leopardiano (STEFANO VERDINO) » 463
STEFANO VERDINO
Lo “scherzo” leopardiano*
Nonostante la sterminatezza della critica leopardiana, lo Scherzo del 15febbraio 1828 «ultimo Venerdì di carnevale», rubricato con il numeroXXXVI dei Canti, non ha finora attirato molta attenzione su di sé, rima-nendo tra i testi marginali e non cruciali. Anche il recente e importante to-mo della Lettura leopardiana edita da Marsilio nel 2003 non gli porge giu-stizia, anzi consente un certo arbitrio conglobandolo – nella lettura mono-grafica di Frattini – alla poesia immediatamente successiva e prima dei“frammenti” (vale a dire Odi, Melisso), forse per la natura dialogica di en-trambi i testi; ma al di là dell’arduo assortimento cronologico (un decenniodi scarto), va anche ricordato che dopo lo Scherzo Leopardi volle, nell’edi-zione Starita (e nella sua copia con correzioni autografe, base per il testodefinitivo dell’edizione Ranieri),1 lo stacco della sezione Frammenti, indi-cando pertanto un altro passo di lettura.
Anzi, il Leopardi ultimo tiene tanto a questa piccola poesia (da lui stes-so precedentemente trascurata) e alla sua posizione, che nella citata copiaStarita corretta, non esita a farla slittare di due posizioni (per l’inserzionedi Il tramonto della luna e La ginestra), in modo da computarla semprequale ultimo dei “canti” e significativo congedo con la messa in scena – avoce sfasata – dell’io d’altri tempi e del suo scambio di battuta con L’una diquelle Muse.
L’unico studio assai attento allo Scherzo si deve a Giuseppe Sangirardi,che riprende il rapporto con la possibile fonte, il n. XXXIII degli Scherzi diGherardo De Rossi, rubricato come epigramma e intitolato La fucina d’A-more, già a suo tempo segnalata dal Binni, e si svolge con un fitto rimandointertestuale, soprattutto in dialogo con alcune Operette morali (Parini, Lascommessa di Prometeo) e testi poetici di passo prosaico come gli sciolti Alconte Carlo Pepoli. Conclude Sangirardi:
Lo Scherzo, insomma, è un divertimento libresco. E tuttavia di tale divertimento sembranodover far le spese non solo la poesia recente, come viene dichiarato, ma sotto sotto tutta laletteratura precedente. Ne fanno le spese in nome di una nuova poesia che si annuncia, ben-ché segretamente, perfino in questo testo, nelle istanze del canto e della narrazione esempla-re che tra poco avranno piena e diversissima voce.2
463
Molto vi è qui da sottoscrivere, ma non sono d’accordo sulla portata ri-dotta di questo «divertimento libresco». Sangirardi limita lo spicco del te-sto a quel tardo inverno del ’28, a quell’essere sintomo (quanto mai anti-frastico) della stagione nuova che si avvierà a primavera. Indubbiamente ènota la concomitanza della stessa data, il 15 febbraio «ultimo Venerdì diCarnevale», con Zibaldone 4302, sul piacere della «rimembranza, il riflet-tere sopra quello ch’io fui, e paragonarmi meco medesimo», ma il «quan-do fanciullo» ch’avvia lo Scherzo per ora deve accontentarsi di un ironicofalsetto, dove il gioco memoriale è del tutto marginale (ovvero citatorio enon personale come nel coevo zibaldonesco appunto),3 mentre il più con-gruo riferimento è piuttosto con la chiusa di 4301: «Oramai si può dire converità, massime in Italia, che sono più di numero gli scrittori che i lettori(giacché gran parte degli scrittori non legge, o legge men che non iscrive)».A sua volta questo passo richiama la testimonianza contemporanea del Ro-sini (edita dal Pacella e ripresa dalla Ceragioli curatrice del catalogo Leo-pardi a Pisa, alle pp. 62-63):
Si passeggiava insieme col Leopardi (sono or ora compiuti 25 anni) e precisamente sullaPiazza de’ Cavalieri dirimpetto a quella brutta facciata della Chiesa dell’Ordine, e colla Tor-re dove morì Ugolino in faccia. Eravamo stati a visitar la Chiesa di Sant’Andrea per veder setraccia restava della sepoltura di Pier delle Vigne; e si era parlato dell’ingenuo stile di Dantenella narrazione della sua morte; e di cosa in cosa, e dopo la conferma che Virgilio più cheOmero avea dato al suo stile quella tinta di verità, che tanti pochi possedono, e venuti quin-di a considerare come andavano le cose letterarie d’Italia a quel tempo, si soffermò presso laFonte, e dopo un momento di silenzio: «Quanti credi», mi domandò, «che siano adesso inItalia capaci di ben comprendere il magistero di quel mirabile stile?» […]. Volea risponder iopochi più di cento, ma m’interruppe dicendo: «Amico mio, né pur venti». Si deve notare chequi Leopardi si riferisce specificamente allo stile di Virgilio.4
Allora infatti Leopardi leggeva Virgilio vestito dal Caro, mentre trangu-giava versi italiani classici per la Crestomazia e chiosava di reperti lessicali ilsuo Zibaldone: solo nel citato 4301 Chiabrera, Magalotti, Pulci, il Bernidell’Innamorato. Elio Gioanola ci ha opportunamente ricordato che questoè «l’ultimo vero impegno da studioso a cui Leopardi attende, impedito persempre in seguito, dal precipitare della salute, di dedicarsi ad opere di qual-che impegno».5 Anche dall’Epistolario emerge, in quell’inverno, proprio aridosso dello Scherzo un Leopardi eminentemente lettore; scrive infatti adAntonietta Tommasini, il 31 gennaio: «De’ miei studj non saprei che mi di-re, se non che io non istudio punto: solamente leggo per passatempo qual-che poco» (L 1215). Vi è anche una pausa nella corrispondenza, come haosservato la Ceragioli, da questo 31 gennaio alle quattro lettere del 25 feb-braio, che «rivelano ciò che è avvenuto in quel periodo di silenzio epistola-re». La studiosa ha ben messo in luce la riaccensione creativa tra febbraio e
464
aprile, osservando minutamente le linee interne dell’officina leopardiana,ma è assai utile tratteggiare un riscontro per così dire esterno, ovvero con laletteratura altrui attraverso la lettura fattane da Leopardi.
Gli Elenchi di letture di quell’inverno 1827-28 rubricano solo classici estranieri (dominante D’Alembert);6 si segnala il Saggio sullo stato attualedella letteratura italiana dell’Hobhouse (alias Ugo Foscolo), che lo provocòa un disegno affine «da contrapporsi».7 Le Memorie e disegni letterari diquel ’28 assortiscono progetti più diversi, dalle traduzioni ai lavori filologi-ci alla critica militante a prove di poesie quanto mai diverse da «Inni Cri-stiani» a «Scherzi anacreontici, catulliani ecc. filosofici, satirici ecc. al mododel De Rossi». In ogni caso è evidente, per quanto riguarda i versi, una do-minante ironica o tutt’al più un misurarsi con l’unico interlocutore di ri-spetto, per quanto opposto, vale a dire il Manzoni di cui a novembre avevaletto I promessi sposi, dandone plauso proprio in febbraio al Papadopoli(«Ho veduto il romanzo del Manzoni, il quale, non ostante molti difetti, mipiace assai, ed è certamente opera d’un grande ingegno», L 1224), mentrein aprile ’28 ne avrebbe letto gli Inni sacri e il Cinque maggio.8 Ma la scenaitaliana era davvero ingombra di una fitta serie di letteratura minore, incre-mentata dal trabocco definitivo del nuovo romantico, chiusa l’ultima parti-ta sulla mitologia, nelle discussioni sul Sermone montiano, tra ’25 e ’26.9
Una poesia come Scherzo non può che avere motivazioni contingenti,«sulla mancanza del labor limae nei poeti contemporanei»;10 e anche le suetestimonianze contestuali addotte fanno riferimento ad un radicale distac-co dallo «stato attuale della letteratura italiana», subita in carne e carta vi-va, sul discrimine di quel 1827, di tante significative concomitanze (la mor-te di Foscolo, il varo di Manzoni e Leopardi prosatori), su cui Dionisottiscrisse una pagina memorabile.11 Inoltre il «Facciam senza» «lima» registrail repentino sopravvento di una versificazione trascurata nella marea dineopoemi epici, romanzi e novelle in versi, traduzioni dal tedesco e dal-l’inglese, che da un biennio vanno tracimando. Infine in quell’inverno pi-sano Leopardi poteva misurare da un lato la clamorosa udienza del Man-zoni e la fredda accoglienza alle sue Operette morali,12 a rinforzo e definiti-va verifica dell’altra concomitanza editoriale del ’26, tra I lombardi e i suoiVersi bolognesi.13 Per due volte Leopardi verifica disattenzione nell’udien-za, anche in fondo tra gli amici toscani:14 basti pensare in quell’epoca al di-verso spicco dato dal Vieusseux nel Bollettino bibliografico alle Operettemorali, solo registrate a luglio ’27, e ai Promessi sposi, la cui rubricazionenel successivo settembre si accompagna a due mezze colonnine di fervore;per non dire delle vaste e tempestive escussioni di Tommaseo a parzialepro del Grossi (su cui infuriava la polemica) nell’aprile e nell’ottobre ’26 e
465
con più devozione a pro del Manzoni, nell’ottobre ’27 (uscì in ritardo neldicembre),15 rispetto ai più tardi plausi al Leopardi firmati dal Montani(per i Versi, a un anno dalla stampa, sul fascicolo di novembre-dicembre’27, che Leopardi lesse in Pisa portatogli dal Cioni a fine gennaio ’28;16 perle Operette in quello del febbraio ’28). Ed il poemone del Grossi, di buonsuccesso editoriale, era davvero tale da fargli scuotere la testa, se mai losorseggiò; ne vide di certo le zeppe segnalate da Tommaseo, nella soprac-citata recensione, dove tra l’altro l’ispido Dalmata per due volte rileva lamancanza della «lima» («Al forte fecondo ingegno del Grossi non dee cer-to pesare la rima. Piuttosto la lima»;17 «se non curando né le ingiurie dei vi-li né l’inetta sentenziosità de’ maligni, vorrà egli esercitare nel suo lavorolunga ed infaticabile l’opera della lima, egli potrà certo condurre, se non laparte inventiva, almen quella della esecuzione ad una eccellenza invidiabi-le»),18 la «lima», vedi un po’, proprio parola chiave dello Scherzo.
La corrente pochezza stilistica, unita alla quantità di produzione lette-raria, Leopardi l’aveva sempre davanti agli occhi per il tramite di gazzettee riviste. C’è solo l’imbarazzo della scelta. Ci soccorre un rendiconto tra lesue letture, documentate e possibili, in quell’inverno pisano, nel contestodi quello che usciva dai torchi e di cui il momentaneo pisano poteva averenotizia diretta o indiretta. Al di là delle letture rintracciabili nell’Epistola-rio,19 giova ricordare come per via dell’allestimento della Crestomazia poe-tica bazzicasse e richiedesse varie antologie, certamente manualistiche egeneraliste (come quella apprezzata del Brancia), ma è evidente, da una let-tera allo Stella del ’23 novembre, la conoscenza di vari florilegi anche pre-sumibilmente di viventi:
la Crestomazia di prosa non aveva altra opera italiana con cui gareggiare; ma una Crestoma-zia poetica dovrà contendere con quella del Brancia, che pure è molto passabile; dovrà con-tendere con qualche centinaio o migliaio di Parnasi, di Raccolte, di Scelte poetiche d’ogni ge-nere, tra le quali ve ne sono pur molte per lo meno mediocri.
Leopardi non cita titoli a caso: nel marzo ’26 aveva letto sull’“Antolo-gia” la segnalazione del Montani della Scelta di poesie romantiche, una col-lana («finora tomi 4») edita a Firenze da Magheri nel 1825-26 e compren-siva, in ordine di apparizione dei Sepolcri, della Pia del Sestini, della Fug-gitiva e dell’Ildegonda del Grossi, di Carmagnola e Adelchi. Anche il riferi-mento ai Parnasi non può essere casuale e non alludere tra l’altro a un re-cente Parnaso italiano novissimo, in corso di stampa a Napoli, presso laStamperia Francese, a cura di Carlo Mele, e segnalatogli dal Pucinotti nelfebbraio ’27 (L 1047). Al momento ne erano usciti quattro tometti, tra1826 e ’27, includenti anche Leopardi (nel secondo), esemplato da quattro
466
canzoni (Alla primavera, Ultimo canto di Saffo, Inno ai patriarchi, Alla suadonna), tratte dall’edizione del ’24.20 Il compilatore arruola classici e ro-mantici, dà credito a Leopardi per via della protezione dell’autorevolissi-mo Giordani:
Giacomo Leopardi da Recanati. Egli sembra piacersi di uno stile sparso di artificiose tenebre.A noi non riuscì replicare pe’ nostri tipi le sue più pregiate canzoni. Gode l’onorata amiciziadi Pietro Giordani, il quale in una famosa sua lettera gli dà la magnifica lode di stupendo in-gegno. Egli ha pubblicato non [h]a guari un nuovo commento al Canzoniere di Petrarca, etutti sperano da sì nobile pianta maggiori frutti (pp. 136-137).21
Ma premia, nella sostanza, nettamente la novella in versi, dando spiccoa Sestini e a Grossi, pur denunciando la trascuratezza stilistica del primo,privo di «quella tarda e paziente lima che affina le opere de’ poeti».22
Questo Parnaso è recensito con plauso nell’“Antologia” del luglio 1827,che riprende la licenza dell’editore napoletano nel IV tomo («mirar tantisacri ingegni sposare unanimemente alle corde gli utili dettati della religio-ne della morale e della filosofia», IV, p. XV) per una poesia eticamente mo-tivata contro residui arcadico-libertini. Inoltre il recensore, a prescinderedal Parnaso, riflette sul nesso tra poesia e lingua ed è generoso di una pre-cisa ricetta:
l’imitazione del naturale e del vero e degli esemplari migliori de’ due secoli veramente italia-ni del trecento e del cinquecento, curandosi meno di quel che fanno delle pratiche dellescuole o delle accademie da una parte, dall’altra delle gazzette e di libricciuoli stranieri, i qua-li, ci pensiamo, non sieno per recarci gran profitto nel fatto della letteratura nostra (p. 106).
La partita tra invadenza di libri tradotti e questione dello stile, come sisa, è in corso. L’ultimo fascicolo del ’27 della “Biblioteca italiana” non a ca-so è solo un fascicolo di «sola Bibliografia italiana», a causa della «sovrab-bondanza delle opere quest’anno pubblicate». È il fascicolo, quello di di-cembre, che reca anche una limitativa recensione al Petrarca leopardianodi Stella, cui si preferisce l’edizione del Carrer uscita a Padova «pei tipidella Minerva». Poche pagine dopo Leopardi poteva leggere (e disgustar-si) del “saggio” «dello stile della signora Saluzzo», con il fiammante «ro-manzo in versi» Ipazia,23 ovvero le prove di traduzione del Maffei e del Sig.Troilo Malipiero24 da La Tunisiade di monsignor Pyrker, patriarca di Vene-zia (che ebbe anche i cimenti traduttori del Monti e, sul “Nuovo ricoglito-re”, del Tommaseo). Il poema, dopo l’esempio dei Lombardi del Grossi,nel 1826, prolifera e la “Biblioteca italiana” segnala Semifonte conquistatae distrutta dai Fiorentini, nel 1202 di Giacomo Mini, il Rodolfo di Hasburgper la «sposizione» di Pietro Mocenigo all’Accademia di Padova. Tra le al-
467
tre traduzioni le Odi, sermoni e prose di Cristiano Temidio Gellert, «ver-sione dal tedesco di Camillo De’ Tonelli» oppure Il Compianto, ossia pen-sieri della notte su la vita, la morte e l’immortalità «poema di OdoardoYoung», tradotto da Gaetano Gargnani. Anche sull’“Antologia”, del mag-gio 1827, Leopardi aveva già notato una sfilza di prove poetiche,25 conse-gnate dallo stesso recensore alla fretta, giacché come alla “Musa” delloScherzo «il tempo manca»:
Dirò ora delle poesie varie, ma con maggiore brevità che delle prose, e perché sento che iltempo mi stringe, e perché so che il gusto odierno degli uomini non è molto inclinato alle co-se poetiche (p. 87).
Se poi i suoi poveri occhi si posavano sul “Nuovo ricoglitore”,26 che nel’25 e ’26 aveva pubblicato i suoi “Idilli” con un titolo di contraffazione an-tichizzante (Idilli e volgarizzamenti di alcuni versi morali dal greco), potevain quella stagione scorrere l’Algiso, «novella in quattro canti» di CesareCantù: i primi due canti si leggono rispettivamente nei fascicoli di ottobree novembre 1827; il terzo in quello di questo febbraio 1828; qui, ad esem-pio, si legge:
Nella sua stanza corre, e là si getta D’un suo devoto crocifisso ai piedi; E piange, e sclama: oh madre mia diletta, Perché a darmi ristor perché non riedi?
D’altra parte, oltre al romanticume mélo e trash, non meno moleste glidovevano apparire le crescenti storpiature del Manzoni sacro innografo, dicui proprio sul locale “Nuovo giornale de’ letterati”, XV (1827), 36, pp.233-234 di Pisa poteva gustare esempio con l’inno Alla religione di Monsi-gnor Carlo Emanuele Muzzarelli, memore anche del Cinque maggio e con-cluso con uno sgraziatissimo verso:
E come or sciolgo un cantico Figlio del mio pensiero, Lo sciolga il dì che scorrere Potrò le vie del vero, Dove immortal melode Canta di Dio la lode Dove più l’uom’ non muor.
L’avrà letto scoraggiato pensando alla sua buona amicizia con il Muzza-relli, che pochi anni prima nel ’24 aveva scritto dei versi (sempre brutti, co-munque) per lui autore delle Canzoni («O Tu, che la tua patria in suono ar-dito / Togliesti all’ozio indegno»).27 Era, in effetti, in atto anche una ricon-
468
versione di vari classicisti verso moduli manzoniani, che lasciava semprepiù solo e isolato Leopardi.
A questo punto a intender l’animo di quel Leopardi ci soccorre un pas-so di una lettera che il Giordani scrisse a Pietro Brighenti l’11 ottobre1839:
egli che avrebbe (diceva) sopportato le percosse, non sopportava la non curanza: ed era in ciòmolto meno filosofo di me. E non doveva capire che la sua troppa grandezza lo sottraeva al-la fama perché lo sottraeva alla misura?28
È superfluo ogni commento a una frase tanto acuta quanto limpida, nelmettere a fuoco il profondo disagio leopardiano nel non avere udienza.29
Questo è quanto sta nel contesto “esterno” dello Scherzo, la cui prosa-sticità non è però mimetica del «facciam senza» contemporaneo, ma èsempre esempio di un magistero consuetamente impressionante, di quella«disciplina» appresa da «fanciullo». Ma a questo punto occorre, propriosull’avvio del testo, sul «quando fanciullo», soffermarci ancora sulla soglia:non sfuggirà che il degrado poetico, che è nel contesto contemporaneo, neltesto viene arretrato agli esordi poetici del «fanciullo», quindi ai primi del-l’Ottocento, o al 1816, nella stagione della prima «disciplina» di poesia, fi-niti i puerilia. Vi è un preciso riscontro autobiografico nel nesso di «fan-ciullo» e «disciplina», che segna il controtempo radicale della propria scel-ta di poesia e coincide con l’avvento del Romanticismo. Ne deriva l’autoi-ronia, che guida la propria mano nella tessitura dei versi.
A livello del ’28, nel tempo della composizione, l’autoironia si esercitanell’esibizione del proprio lungo sodalizio musaico e della sua inadegua-tezza originaria. Inoltre il parlare alla Musa vale nella lingua dei Canti solocome movenza di autoironia, in quanto le precedenti allocuzioni su regi-stro serie, sono confinate solo nella variantistica d’autografo dell’Inno aipatriarchi e furono tutte accuratamente rimosse in sede di stampa, quasiparola ormai tabù, sul versante serio, negli anni venti.
Il personaggio dell’io poetico, infine, è parodiato nella duplice moven-za di «mirava e chiedea», da sempre canonici al verso leopardiano. Il fattoche «mirava» si dia in correzione (ma quando?), sul più neutro «guarda-va», indica una determinazione autoironica assai decisa, ma ancora pocolessicalmente derivata. Sempre l’altra correzione del «soggiungea», benfrequentato nelle poche prove di dialogo in versi (ante ’28 Il sogno; post’28 Consalvo), conferma l’intento correttorio di porre per così dire “in re-te” il testo, soprattutto sul margine del Pepoli.
La gamma degli intarsi è quanto mai mossa e deve forse il suo alto tas-so alla farcitura di prosa e verso italiano del Leopardi crestomante. Così
469
«l’officina» musaica, oltre che autocitazione dal Pepoli, come già osservato,può essere citazione ironica dell’allocuzione alla «Mitica Dea» del Sermonemontiano («E qual bizzarro / Consiglio di Maron chiude e d’Omero / A tela scuola, e ti consente poi / Libera entrar d’Apelle e di Lisippo / Nell’of-ficina?»), esibendo una meccanicità lavorativa anche per l’arte del verso ediminuendo la rilevanza della deità interlocutrice («L’una di quelle»); iltempo del soggiorno esibisce un formulario tipico del poema cavalleresco(nella cadenza a fine verso di tutto quel giorno in rima con intorno o d’in-torno; cfr. Orlando innamorato I, XIX, 33: Orlando furioso XXII, 15), men-tre il gesto di esser «pigliato» e non petrarchescamente preso per mano ciavvisa di un livello non elevato e tendenzialmente prosastico. La condu-zione «per mano pigliò» verso la «curia» d’Apollo, ad opera del Berni, sitrova nei Ragguagli di Parnaso (Centuria Seconda, Raggionamento 14), maa un barocco decisamente più grato ci conducono «gli strumenti dell’arte»;infatti in La ricreazione del savio il Bartoli, spiegandoci la «maraviglia» del-l’arte usa la metafora della «spelonca d’un fabbro», con tanto di confusi at-trezzi: «Quegli dunque dover essere strumenti e ingegni adatti ad alcun la-voro dell’arte» (libro 2, capo 10). Un puntuale riferimento al «lavoro deiversi» ci conduce a un altro maestro leopardiano, l’Alfieri in prosa della Vi-ta (Epoca 4, 4, 3), a cui probabilmente fa anche riferimento l’essenziale eoraziano riferimento alla «lima» («Però fine / non il numero, ma la lima /fa ricchezza ne’ carmi, / ed il tacersi a tempo indi è virtude», Rime 389b).Infine il finale ha l’esibito peso d’eloquenza dell’«hassi» da Leopardi usa-to altrimenti solo in prosa e con richiamo alla sua giovanile dottrina (infat-ti si trova quattro volte nella Storia dell’astronomia) – anche se non esclu-derei un certo sentore parodico con l’«havvi» di esuberante presenza nel-la coeva prosa gazzettistica del Tommaseo; mentre l’altrettanto prosaico «iltempo manca» è sì in calco da Zibaldone 4507, come osservò De Robertisjunior, ma nel gioco di rima con stanca non può non avere riferimento pa-rodico a un testo a Leopardi ben presente come il Rogo amoroso (313-4),con possibile espansione a Rime 1587 («il tempo or manca»), mutilato delsuo interrogativo esistenziale e abbassato come espressione finale e sbriga-tiva di una «Dea», che nelle sue due battute poco si è concessa ad un mu-saico parlare, di tono un poco più basso del poeta fanciullo interlocutore.
La centonazione citatoria, in questo caso, non è solo l’inevitabile fruttodell’esegeta abusante della LIZ, ma credo una strategia autoriale che sicombina con i propri rinvii intertestuali (osservati da Sangirardi) e fa inqualche modo sistema, per una poesia congegnata quanto mai con gli«strumenti dell’arte», in pieno rispetto verso il suo titolo di Scherzo. Lespie raccolte di echi e allusioni vanno configurando un doppio campo di
470
slittamento: da una parte verso frammenti d’eloquenza in prosa o mimesidi linguaggio formulare, dall’altro verso una costante diminuzione in dis-sonanza e degrado del possibile eco dotto in versi (così si è visto con Mon-ti e con Tasso). È quanto disegna lo “scherzo”, esercitato a tutto campo,naturalmente anche su se stesso, nel fuori tempo originario della proprianascita di poeta. E su questo versante ho più di un sospetto che in gioco visia anche un ammicco ironico verso il proprio supremo protettore, cioè ilGiordani, e segnatamente al suo celebre pubblico elogio del ’25, che logratifica di «ingegno immenso e stupendo», «studi fortissimi», «gioventùpromettitrice credibile di cose straordinarie». L’elogio, come si sa, è all’in-terno di un assai discusso (all’epoca) saggio, la Scelta di prosatori italiani,30
tesa a una «messianica aspettazione dello Stile», a detta del Dionisotti;31
quel saggio già nel ’25 non era sottoscritto da Leopardi, come per certi ver-si attesta il coevo epistolario,32 ma soprattutto di lì a poco il montaggio dellibro dei Versi del ’26 dichiarerà un dispettoso criterio antigiordaniano, co-me ha messo in luce Giovannuzzi.33 Ora, oltre un anno dopo, la distanza diGiacomino dall’auratico maestro si è incrementata: il saggio delle Operet-te sull’“Antologia” (voluto dal Giordani) non è stato di gradimento34 e su-bito è stato rimpiazzato dalla nuova più consistente stampa sul “Nuovo ri-coglitore”; la comune frequentazione a Firenze non è priva di una certa in-sofferenza da parte di Leopardi,35 che tra l’altro sarà scandalizzato dalcomportamento dell’intemperante amico nell’incontro con il Manzoni, il 3settembre.36 Altro atto di antigiordanismo sono le Crestomazie;37 le accom-pagnano i silenzi pisani (rimproverati dal sollecito Giordani)38 e infine l’e-clatante divario tra la celeberrima e ridente lettera a Paolina del 2 maggio’28 («ho fatto dei versi quest’Aprile; ma versi veramente all’antica, e conquel mio cuore d’una volta») e quella desolatissima al Giordani di tre gior-ni dopo: «la mia vita è noia e pena: pochissimo posso studiare, e quel po-chissimo è noia medesimamente: se negli studi potessi seguire ancora ilmio genio, veduta la qualità dei giudizi di questo secolo, non mi darebbepiù il cuore di logorarmi in far cose che mi contentassero».39
I toni così difformi spesso si spiegano, nell’epistolario leopardiano, conun frequente gioco mimetico e di sintonizzazione verso l’interlocutore,spinto anche fino alla menzogna a pro dell’amante compagnia (le lettere ci-tate al Pepoli e a Paolina di pochi mesi prima). Ma qui mi pare non pocacosa tacere al Giordani, proprio a lui, l’avvenuto risorgimento festosamen-te comunicato a Paolina. L’omissione del risorto poeta dei “versi” (e nondelle “canzoni” predilette dal Pigmalione)40 si accompagna, nel basso con-tinuo desolato, ad un’amara sconfessione – stante i «giudizi di questo se-colo» – di quell’immagine di perfezione, che in lui aveva massimamente
471
coltivato il Giordani. In altre parole il “secolo” è quello che è nella sua tri-vialità di lingua, ma anche il progetto di perfezione stilistica, sanziona Leo-pardi, è scaduto davvero. Come velatamente dice questo al suo mentore,così d’altra parte gli tace la nascita della propria nuova poesia, che impostasu basi nuove la partita con la lingua, diversa tanto dalla corrività romanti-ca, quanto dall’utopismo stilistico del Giordani. E la rottura della «lima»,per tornare al nostro Scherzo, se da un parte irride alla trascuratezza deicoetanei, dall’altra più sottilmente adombra anche l’irrimediabile fine del-la sintesi stilistica del maestro, tanto più che i nuovi versi «all’antica» degliimminenti Grandi Idilli configureranno un nesso del tutto inedito con gli«antichissimi», secondo quanto recentemente sostiene Lonardi.41
Ma qui dobbiamo osservare un curioso fenomeno, che spiega forse l’af-fezione, nel tempo, dell’autore a questa poesia trascurata. Lo Scherzo èpoesia di natura quanto mai ancipite, che scritta per liquidare il passato, sitrova invece ad essere il primo avvio, non testuale, ma lessicale del nuovotempo. Voglio dire che in Scherzo la volontà d’autore tende alla liquidazio-ne del verso (che latita da un triennio), mentre il lessico principia a trova-re nuove vie. Si registra nel corpo del testo quella forbice tra i due contiguipensieri dello Zibaldone, del 5 e 15 febbraio, sopra citati. Il lessico si aprealla stagione dei grandi idilli, solo in termini di molecola o di atomi, al di lào al di qua dell’aggregazione testuale. Così il «Quando fanciullo» d’avvio,che precedentemente ha in Leopardi solo prosastiche frequenze zibaldo-nesche, si ritroverà nelle Ricordanze in altro contesto; il «s’adopra» avrànuova e fragrante vita nel Sabato; anche la metafora della «disciplina», fuo-ri d’ironia, si troverà in Amore e morte, come rilevato da Gavazzeni e Lom-bardi.42 Ma soprattutto nuovo è quell’intreccio di “mostrare” “mirare” e“chiedere” che farà lo spicco dei Grandi idilli, in cui tali termini, tutti ori-ginari e presenti da sempre nella sua poesia, ma non finora interagenti, sivanno riverberando l’un l’altro, in una precisa dinamica, che vede da unaparte il disvelamento, il “mostrare”, atroce o comunque negativo dopo laverità delle Operette, dall’altra parte il “mirare” il mostrato con esatta de-terminazione e infine il vano chiedere nel silenzio dell’alterità.43 Qui laMusa ovviamente risponde, ma – torno a dire – m’intriga registrare solocerte primizie del lessico, che presto avranno ben altro spicco.
Ora questa germinalità di punti nevralgici del lessico della propria grandestagione è quanto retrospettivamente, sette anni dopo, nella Napoli del ’35,fece probabilmente agio a Leopardi in una ripresa tanto significativa di que-sta poesia, rimasta finora nel cassetto. Non solo vara il testo, ma lo inserisce alfondo del suo libro, portandolo assai in avanti rispetto alla positura cronolo-gica, che lo vedrebbe dopo il Pepoli. In questo caso Leopardi si comporta in
472
modo opposto al Passero e a Consalvo, che invece arretra. Nel ’35, nella faseultima, liquidatoria, anche verso se stesso, come insegna il Tristano, all’autoreche si rilegge, quel suo Scherzo di sette anni prima gli si offre come anticipatacertificazione del proprio forfait, ora irreversibile, anche per scelta geografica(Napoli contro Milano e Firenze), e vissuto con amarezza e aggressività neiconfronti dei diversi “nuovi credenti”,44 tanto da rendere inservibile la dedi-ca agli “amici di Toscana”. Il reclamato «disprezzo» anche per sé (A se stesso)si invera qui nella materialità del testo dove Leopardi può intendere – in virtùdella nuova ultima posizione tra i Canti – quei barbagli espressivi del lessicodei Grandi idilli, non più come annunci, bensì come relitti, soffocati dallo“scherzo”. La stessa scelta di finire il libro di versi in minore è significativa de-nuncia: già nel ’26, chiudendo con il Pepoli seguito dalle prove di traduzionisatiriche, aveva dato una simile indicazione di deliberata uscita d’autore dalproprio testo; non così nel ’24, dove l’a solo di Alla sua donna si dichiaravacome “inno” ed anche nel ’31, chiudendo con Il sabato e il reticente saluto al«garzoncello scherzoso». Nel ’35 si torna alla conclusione “bassa”, come nel’26, con una significativa diramazione: dopo l’epigrafica poesia A se stesso,Leopardi allinea una nuova «lettera in versi» quale può essere Aspasia, in ter-mini certo più sofferti e rivendicativi, che non la chiacchierata col Pepoli.Non senza malizia (e cattiveria), ad Aspasia, alla poesia per l’unica donna dicarne (anche se non assaggiata) di Leopardi, seguono le due sepolcrali, met-tendo in chiaro quale soglia interessi al Leopardi; infine con movimento anti-frastico ecco il rovesciamento della Palinodia, terza lettera in versi, di caratte-re pubblico, laddove Aspasia era più intima ed i due brevi stacchi di Imita-zione e Scherzo, in un territorio non giurisdizionale, poesie diversamente sfa-sate ed entrambe non frontalmente espresse dall’io, che abbiamo lasciato conl’interrogare le giovani donne morte e prendere in giro il candido Gino. Laprima, Imitazione, all’insegna dell’eleganza e della prodigiosa capacità di ri-creazione stilistica,45 l’altra, come sappiamo, tutta giocata in negativa falset-tante ed ora, non solo liquidatoria di classici e romantici, ma anche, in questaposizione, congedo di tutto il libro che si è andato consumando, con un gio-co finale che non sarebbe dispiaciuto al Montale ultimo, satiro, come si sa, an-che di se stesso. E la prova di tanta risignificazione di questo piccolo testo stanel fatto che nemmeno l’ultimissima stagione, di La ginestra e Il tramonto del-la luna, viene a cambiare i termini della questione. Per quanto nuovi e di-rompenti questi ultimi testi, fu volontà ulteriore di Leopardi, o per lo menocosì intese l’amanuense Ranieri, di non mutare la duplice conclusione in mi-nore e fuori dell’io poetante, calando gli ultimi capolavori non come conclu-sione, ma subito dopo la Palinodia, in una posizione forse un po’ assortita(tanto da non potersi intendere come pienamente definitiva).46
473
* Per le citazioni da Leopardi si fa riferimento alla più recente edizione di Tutte le prose e tutte le poe-sie, a cura di L. Felici e E. Trevi, Newton Compton, Roma 1997 e all’Epistolario, a cura di F. Brioschi eP. Landi, Bollati Boringhieri, Torino 1998 (sigla L per Lettera e numero d’ordine). Per i testi di altri au-tori italiani si fa riferimento alla LIZ, salvo diversa indicazione.
1 Su questo esemplare cfr. D. DE ROBERTIS, Le ultime volontà di Leopardi: la Starita con correzioni au-tografe, in “Italianistica”, XVI (1987), pp. 381-390.
2 G. SANGIRARDI, L’officina dello “Scherzo”, in Leopardi a Pisa, a cura di F. Ceragioli, Electa, Milano1997, p. 111 (a questo volume si rimanda per il contesto pisano del soggiorno).
3 Per questo giustamente Fiorenza Ceragioli ha sottolineato che «il passo è assolutamente lontano dal-l’epigramma» (F. CERAGIOLI, Il percorso segreto della poesia, in F. CERAGIOLI, M. ANDRIA, ll percorso del-la poesia. Giacomo Leopardi a Pisa (1827-1828), ETS, Pisa 2005, p. 16), ma non può – mi pare – non es-serci “relazione”: in comune vi è una voglia di poesia, nella prosa e nel verso, dove ancor prevale il let-terato falsettante delle Operette; e d’altra parte il pieno autoriconoscimento da poeta dello Zibaldone4302 scatta proprio nel quadro della mediocrità denunciata dallo Scherzo e da altre pagine zibaldone-sche. Anzi quel giorno di metà febbraio segna una fenditura che sarà sempre più approfondita, a partireda questa doppia matrice di disgusto del poetese corrente (e un po’ anche della tradizione) concomitan-te con il ritrovamento della voce; Leopardi ne ha voluto dare un segno ben netto con la giunta del 15aprile al pensiero del 15 febbraio, una giunta, non a caso, giocata sul pieno nesso tra il ritrovato io poe-tico e l’altrui letteratura: «e di commuover me stesso in rileggerli, come spesso mi accade, e meglio chein leggere poesie d’altri» (cfr. la riproduzione fotografica di Zibaldone di Pensieri, a cura di E. Peruzzi,Scuola Normale Superiore, Pisa 1989-94, p. 4302).
4 Peraltro anche il Rosini non era senza colpe, allora impegnato nella sua farraginosa Monaca di Mon-za, come è noto rivista in quell’inverno e oltre proprio da Leopardi, che in giugno confiderà a Monaldo:«sarà una cosa che varrà poco; e mi dispiace il dirlo, perché l’autore è mio amico […] e mi costringe a ri-veder la sua opera, pagina per pagina: ma io non so che ci fare» (L 1282). Su Rosini e Leopardi e sul-l’ambiente pisano frequentato da Leopardi cfr. anche L. BLASUCCI, Leopardi a Pisa [1987], in I titoli dei“Canti” e altri studi leopardiani, Morano, Napoli 1989.
5 E. GIOANOLA, Leopardi, la malinconia, Jaca Book, Milano 1995, p. 420.6 Ma vedi anche i vari libri italiani «novità del mercato librario» di un elenco inedito e attribuibile a
questo periodo in M. ANDRIA, Le tracce della lettura. Un elenco inedito dalle carte napoletane, in “I Qua-derni della Biblioteca Nazionale di Napoli”, IX (2000), 2, pp. 12-21.
7 Il Saggio sullo stato attuale della letteratura italiana di Giovanni Hobhouse tradotto dall’inglese da M.Pegna era apparso nel 1825. Come è noto Foscolo scrivendo nel 1818 sull’ultimo cinquantennio lettera-rio rilevò sei scrittori «il cui influsso può dal più al meno considerarsi aver contribuito alla formazionedello stile e del gusto di oggi», vale a dire Cesarotti, Parini, Alfieri, Pindemonte, Monti e Foscolo, in unasintomatica sequenza. Ben nota la conclusione del saggio, che suonò come staffilata ai nuovi romantici esuscitò le reazioni di Di Breme, nonché una lunga lettera di Foscolo al Pellico.
8 Sul rapporto tra Manzoni e Leopardi in questa stagione cfr. E. GHIDETTI, Firenze, Leopardi e Man-zoni, in Leopardi a Firenze, Atti del convegno di studi (Firenze 3-6 giugno 1998), a cura di L. Melosi, Ol-schki, Firenze 2002, pp. 113-130, cui si rinvia per la precedente bibliografia.
9 E anche, conseguentemente, l’avvento di una egemonia editoriale milanese, che va spiccando (comeattesta il celebre libro Intellettuali e librai nella Milano della Restaurazione di Berengo) e ben avvertita,negativamente, dallo stesso Leopardi provvisoriamente milanese, secondo quanto scrive al Brighenti l’8agosto 1825: «Qui non si sa nulla di Bologna. Non puoi credere quanta sia l’ignoranza dei Milanesi cir-ca la letteratura del mezzogiorno d’Italia. […] Ciò non può provenire se non da negligenza dei librai dicostà, perché alla fine Bologna in numero e in merito di letterati, vale assolutamente più di Milano inquesto momento. Eppure i libri di Milano sono subito conosciuti nell’Italia inferiore, e quelli dell’Italiainferiore non si conoscono a Milano o tardi o non mai» (L 716).
10 L. BLASUCCI, Leopardi a Pisa, p. 122.11 C. DIONISOTTI, Fortuna di Leopardi, in ID., Appunti sui moderni, il Mulino, Bologna 1988, pp. 212-213.12 Del resto lo stesso editore Stella era consapevole della difficile udienza delle Operette, scrivendone
a Leopardi il 1° agosto, e comunicandogli uno stralcio di una lettera dura del Tommaseo, al riguardo:«Delle sue Operette morali sento a dir bene da tutti, quantunque l’Italia non sia ancora accostumata aquel genere di lettura. Sentiremo che cosa ne diranno i giornali. Quasi come squarcio di giornale le fotrascriver qui appresso ciò che mi scrive un letterato. Il fo perché Ella è un autore che sa valutare il be-ne e il male che ne’ giudizi letterari se ne può dire. Amerei sentire che cosa Ella ne pensa di esso lettera-to, e qual risposta gli darebbe» (L 1115).
Ed ecco Tommaseo: «Ho letto il libro del Conte Leopardi: mi parve il libro meglio scritto del secolonostro; ma i principii, tutti negativi, non fondati a ragione, ma solo a qualche osservazione parziale,diffondono e nelle immagini e nello stile una freddezza che fa ribrezzo, una desolante amarezza» (G.
474
LEOPARDI, Epistolario, p. 2275).Nella citata lettera di Stella non manca il riferimento al boom dei Promessi sposi: «Il romanzo del
Manzoni, lo ha Ella letto? Sentirei volentieri il suo parere. Ora si sta attendendo quello di autore anoni-mo, che debbo pubblicar io; il quale però per quanto merito abbia non potrà mai sperare la fortuna delromanzo del Manzoni la cui edizione in un mese o poco più è stata affatto esaurita». Nell’insieme la let-tera dello Stella è assai interessante per mostrarci la sua strategia editoriale, in qualche modo duplice,pronta a inseguire l’onda del successo manzoniano, sfornando romanzi storici, ma anche desiderosa diopere editorialmente d’avanguardia, come lui reputava le Operette. Nel caso specifico segnalo un pro-babile errore del Moroncini, passato nell’edizione Brioschi dell’Epistolario. Per l’«autore anonimo» en-trambi gli annotatori fanno il nome di Il falco della rupe o la Guerra di Musso di G.B. Bazzoni, che sag-giato a puntate sul “Nuovo ricoglitore” da marzo ’28 sarà poi stampato da Stella nel 1829. Ma ciò fa con-trasto tra l’imminenza cui allude la lettera e la diluita edizione su periodico, di nessuna competizione conManzoni. In realtà credo che qui lo Stella faccia riferimento a Sibilla Odaleta. Episodio delle guerre d’I-talia alla fine del XV secolo, romanzo storico d’un italiano, ovvero Carlo Varese, che uscì nella consoli-data collana Biblioteca amena, dove l’anno prima uscirono il Petrarca leopardiano e il Dell’urbanità diTommaseo. Sempre del ’27 è anche l’altra “sperimentazione” di narrativa storica edita da Stella: Il ca-stello di Trezzo, novella storica del detto Bazzoni.
A Stella comunque Leopardi risponde il 23 agosto: «Del romanzo di Manzoni (del quale io ho sola-mente sentito leggere alcune pagine) le dirò in confidenza che qui le persone di gusto lo trovano moltoinferiore all’aspettazione. Gli altri generalmente lo lodano. Circa il giudizio sopra le Operette morali, cheElla mi comunica, che vuol ch’io le dica? Dirò solo che non mi riesce impreveduto. Che i miei principisieno tutti negativi, io non me ne avveggo; ma ciò non mi farebbe gran maraviglia, perché mi ricordo diquel detto di Bayle; che in metafisica e in morale, la ragione non può edificare, ma solo distruggere. Chepoi le mie osservazioni non sieno fondate a ragione ma a qualche osservazione parziale, desidero che siavero» (L 1127).
13 I subito discussi Lombardi ebbero nell’immediato un certo successo (quattro edizioni tra 1826 e’28); inoltre, segnala Baldacci, «è considerevole la serie di quelle napoletane che dal 1836 al ’62 si ripe-terono con insistenza» (Poeti minori dell’Ottocento, a cura di L. Baldacci e G. Innamorati, Ricciardi, Mi-lano-Napoli 1963, t. II, p. 235).
14 Sulla questione vedi ora i contributi di L. MELOSI, Leopardi e le mediazioni giordaniane nel carteggioVieusseux; E. BENUCCI, Vieusseux e la diffusione delle opere di Leopardi; W. SPAGGIARI, La mancata colla-borazione di Leopardi all’“Antologia”, in Leopardi a Firenze. Sulla scarsa comprensione in un ambientecomunque amico trovo emblematico un passaggio della ben nota lettera del generale Colletta al Cappo-ni di quel 1827: «Leggerò i dialoghi del Leopardi, ma sembrami impossibile che mi piacciano in stampa,se mi dispiacquero in scrittura. Sono di moltissimo inferiori a lui. Non so che fare per rallegrarlo: e qua-si credo che gli è necessaria l’infelicità» (citato in N. BELLUCCI, Giacomo Leopardi e i contemporanei,Ponte alle Grazie, Firenze 1996, p. 108).
15 Cfr lettera del Vieusseux a Leopardi di fine novembre (L 1180): «Tommaseo in questo frattempo hapartorito del Manzoni e di 4 fogli di riviste – questi non li ho letti; il Manzoni, temo dell’esito – Vera-mente sono il Direttore in angustie». In privato il Tommaseo era anche critico sui Promessi sposi, comein fulminanti righe scritte al Rosmini, nel febbraio 1828 all’indomani di questa recensione: «in quel libro,a dirla tra noi, c’è un veleno nascosto, e voi m’intendete quale; ce n’è uno palese dopo il primo tomo: lanoja. Di qui a quarant’anni non si potrà più leggere, sebbene sia, tutto compreso un libro ammirabile»(N. TOMMASEO, A. ROSMINI, Carteggio edito e inedito, a cura di V. Missori, vol. II (1827-1855), Marzo-rati, Milano 1967, lettera 160).
16 «Porto questa mattina al Conte Leopardi i due fascicoli 83, 84 e i vostri saluti», Gaetano Cioni a Gio-van Pietro Vieusseux, 30 gennaio 1828, in Leopardi nel Carteggio Vieusseux. Opinioni e giudizi dei con-temporanei 1823-1837, a cura di E. Benucci, L. Melosi, D. Pulci, Olschki, Firenze 2001, p. 117. Su quel fa-scicolo, nella stessa pagina 273 della recensione ai Versi Leopardi leggeva anche, sempre a firma del Mon-tani, una recensione ad Alcune poesie dell’Arici, i cui poemetti sono valutati con un criterio di utilità, inparticolare il Camposanto di Brescia, «soggetto degno di pietosi versi, che muovessero a visitarlo».
17 In “Antologia”, XXII (1826), 64, aprile, p. 72, dove si legge un campionario di stecche: «Quasi unvelo / Di pietre e dardi ricoperse il Cielo» (con esclamativa del Tommaseo: «Un velo di pietre!»); «Escorgendo i Francigeni, e la bianca / Insegna il capo al ponte ir sventolando» («Scorgendo ir sventolan-do!»); «L’altera fronte un bel palagio estolle / Fra boschi ameni sovra l’erba molle» («Un palazzo chesurge sull’erba?»); «Gran Dio, se il pianto degli afflitti piega / Alla clemenza il tuo voler sacrato» («Il sa-crato voler di Dio?»); «Di Pirro seguitato, per vaganti / sentier con tutto l’impeto si caccia», chiosandoancora «I sentieri vaganti? – E così dicasi del fragor muto, dell’uscio rude, della portatrice novella, e si-mili» (p. 73).
18 In “Antologia”, XXIV (1826), 70, ottobre, pp. 28-29.
475
19 Per la poesia contemporanea Leopardi riceve in dicembre da Giordani, tramite Vieusseux, Rime eprose di Giovanni Marchetti (L 1194 e 1197); verso fine febbraio gli pervengono versi da Pepoli (L 1213,L 1225), cui risponde con parole di stima («ho letto e riletto con piacer grande», L 1225; «il poemetto miè piaciuto anche di più», L 1233), mentre a Paolina giorni dopo dice: «Ho qui un altro libro del Pepolidiretto a me, più lungo ma non più bello. Non ve lo mando, perché credo che vi seccherebbe, comeavrebbe fatto a me se l’avessi letto». Il 25 febbraio, nella citata lettera di plauso manzoniano, riscontraPapadopoli (del 10 febbraio): «Ho veduto il poema della Malvezzi. Povera donna! Aveva veduto già ilmanoscritto». Si tratta di La cacciata del tiranno Gualtieri (Firenze 1827), ben noto a Leopardi dal ’26 (L958), in cui tra sgangherati versi riscontriamo con un lieve sobbalzo un tipico calco aggettivale montia-no-leopardiano («odorate»), che però è anche un nitido anticipo: «Era dell’anno / La stagion prima, equindi i calli e i campi / Splenean dipinti di mille colori, / Quasi nembi di fior parean le piante, / Rin-verdiva ogni stelo, e di fragranze / L’odorate ginestre empivan l’aria» (è quanto del canto III si riprodu-ce a pp. 152-153 nella recensione di Bagnoli sul “Nuovo giornale de Letterati”, XV (1828), pp. 150-157,di nuovo sotto gli occhi di Leopardi).
20 Cfr. Bibliografia leopardiana. Parte I, a cura di G. Mazzatinti e M. Menghini, Olschki, Firenze 1931,p. 132, e Parnaso italiano novissimo, per cura di U.E., Stamperia francese, Napoli 1826. Questo Parnasosi dichiara alla moderna, nel Dialogo introduttivo tra l’Editore e un Geometra refrattario alla poesia,identificata con la tradizione: «Io vo che voi mi diciate la maggior villania del mondo – replica l’Editore– se troverete nel Parnaso novissimo un madrigale o un sonetto». Questo l’impianto dell’opera: Tomo 1,1826: Il campo-Santo di Brescia di Cesare Arici; Poesie varie di Alessandro Manzoni (In morte di Carlo Im-bonati – Urania – Inni sacri); Il Libano di Luigi Carrer; Sul Teseo che uccide il Centauro, opera di Canovad’Ippolito Pindemonte; La prigione del Tasso di Carlo Pepoli; Alle viole di Giulio Perticari. Tomo 2,1826: Poesie recenti del cav. Vincenzo Monti; Quattro canzoni del conte Giacomo Leopardi; L’inno a Gio-ve e La felicita coniugale di Paolo Costa; Un sollievo nell’infermità del conte Francesco Benedetti Fore-stieri; Un’ode di Andea Mustoxidi; La Pia, leggenda romantica, di Bartolomeo Sestini. Tomo 3, 1826 (ma1827) Ildegonda e La fuggitiva di Tommaso Grossi; Manfredi re, stanze inedite. Tomo 4, 1826 (ma 1827):Sermoni di Teresa Albarelli Vordoni; Alcune poesie di Andrea Maffei; In morte di Ferdinando III, di Giu-seppe Borghi; Nastagio degli Onesti di Dionigi Strocchi; Tre epistole di Pier Alessandro Paravia; Due epi-stole di un poeta napoletano; Al Cavalier Monti in morte di Giulio Perticari di Felice Bellotti.
21 Il Parnaso napoletano avrà una continuazione, con altri quattro volumetti tra 1828 e ’29, che conten-gono: Tomo 5, 1828: Il corsaro di Byron; la Bucolica di Virgilio, resi in versi italiani da G. Niccolini. Tomo6 Versi di alquanti valorosi poeti moderni, 1828: Pindemonte, Monti, Paolo Costa, Francesco Cassi, Tom-maso Gargallo, Cesare Arici, Carlo Pepoli, Luigi Dragonetti, Michele Baldacchini, Giuseppe Campagna.Tomo 7, 1829: Costanza Monti, Teresa Albarelli Vordoni (traduzione da Pope), Teresa Malvezzi, Cateri-na Franceschi, Diodata Saluzzo Roero, Giuseppa Guacci. Tomo 8, 1829: Poesie del Guadagnoli.
22 Entrambi di strepitoso successo editoriale: la Pia del Sestini ha sei edizioni tra il ’22 e il ’27; l’Ilde-gonda, sette tra il 1820 e il ’26.
23 «Per saggio dello stile» si citano, tra gli altri questi versi: «Frena il parlare, egli all’oprar si accinge;/ Per disagiata via grand’orme imprime; / Orror di notte senza luna il cinge» (p. 353).
24 A svantaggio di quest’ultimo; tra i versi al paragone una similitudine di schiacciamento formichescoforse registrata dal futuro autore di La ginestra, che suona nella versione Maffei: «Come una torma / Diprovvide formiche, ove la dura / Orma d’inopinato passeggero / Ne scommetta la bica entro il pineto /Brulica costernata» e in quella fantasiosa e micidiale del Malipiero: «Come nell’irto cespo, che s’imbosca/ Tra i vimini assiepati e i bronchi avvinti, / Se fia, che il noderoso del viandante / Grosso baston v’apraallargato isquarcio, / Sorte da’fessi, e fugge d’ogn’intorno / Di agitate formiche un brulichio» (p. 356).
25 Alcune traduzioni (A. LAMARTINE, La perdita dell’Anio, traduzione di L. Feroni; P. DE KOSTER, Sag-gio d’imitazioni e traduzioni dal tedesco) e altri in proprio: A. MOCHETTI, I monumenti; Le nozze e I be-nefizi; P. FERRARI, Versi; G.M. CALVINO, L’industria trapanese; A.M. RICCI, L’orologio di Flora (pp. 64-65).
26 A Stella, 28 gennaio: «Il raccoglitore che ella mi favorisce, ha cessato di comparire col fascicolo di ot-tobre, giacché non ho mai veduto né il novembre né il dicembre» (L 1214). Stella provvede subito e nechiederà notizia il 12 aprile (L 1242), a cui Leopardi risponde il 2 maggio: «Le spedizioni di Gennaio eFebbraio (delle quali ripeto i miei sinceri ringraziamenti) mi furono ricapitate dal sig. Nistri» (L 1247).
27 Citato in N. BELLUCCI, Giacomo Leopardi e i contemporanei, pp. 40-41. Il Muzzarelli fu in corri-spondenza con il Leopardi fino al 1832.
28 P. GIORDANI, Lettere, a cura di G. Ferretti, Laterza, Bari 1937, vol. II, lettera CCLXXXIV.29 Su questo aspetto cfr. lettera al Papadopoli del 6 marzo 1826: «De’ miei dialoghi hai già un saggio
nell’Antologia di Gennaio, e mi sarebbe pur caro d’intendere quello che se ne dica costì, se pur capita aNapoli l’Antologia» (L 857). Ma due anni dopo allo stesso Papadopoli scrive il 25 febbraio, dieci giornidopo lo Scherzo: «Studiare e lavorare sono cose che ho dimenticate, e dalle quali divengo alieno ognigiorno di più. Con questa razza di giudizio e di critica che si trova oggi in Italia, coglione chi si affatica a
476
pensare e a scrivere. Scrivere poi senza affaticarsi punto e senza pensare, va benissimo, e lo lodo molto,ma non fa per me e non ci riesco» (L 1224).
30 In “Antologia”, XVII (1825), gennaio. Su questo scritto cfr. L. MELOSI, In toga e in camicia. Scrittie carteggi di Pietro Giordani, Pacini Fazzi, Lucca 2002, pp. 51-72.
31 Cfr. C. DIONISOTTI, Leopardi e Compagnoni, in ID., Appunti sui moderni, p. 128; ma nello stesso vo-lume cfr. il saggio Pietro Giordani.
32 In merito al noto attacco di Compagnoni (sul “Nuovo ricoglitore”) alla Scelta del Giordani, Leo-pardi scrivendo a Luigi Stella sarà d’accordo su alcuni aspetti («Ha molta ragione in quello che dice del-la scarsezza e brevità degli scritti di Giordani, e della sua pigrizia allo scrivere», L 819), ma non sulle cri-tiche allo stile, bollate come «maligne scempiaggini» anche al Papadopoli (L 857).
33 G. LEOPARDI, Versi, a cura di S. Giovanuzzi, Società Editrice Fiorentina, Firenze 2002, p. LXV.34 Cfr. la lettera al Vieusseux del 4 marzo 1826 in cui si lamenta dei refusi e chiede una sospensiva di
ulteriori pubblicazioni, auspicate invece dal Giordani nel breve cappello introduttivo. Alla stampasull’“Antologia” mancò, come è noto, il saggio d’accompagnamento del Giordani che ora Laura Melosistampa nell’originale stesura del ’26 (e con in apparato le varianti del testo vulgato di vent’anni dopo) nelcitato In toga e in camicia. Si può osservare, da questo scritto, con il grande plauso, anche lo scarto, tra idue sodali, da parte del Giordani. In breve: per Giordani l’approdo delle Operette mostra un animo «im-mobile contemplatore della universale necessità», che è ben diversa cosa dalla «disperazione» con in«bocca un sorriso», di cui discorre Eleandro con Timandro. Rispetto al Leopardi Giordani sembra unpo’ come è stato detto volgarmente di Adorno: «felicemente installato nell’Hotel dell’Abisso». La mon-danità e la retorica (ovvero la fede nello stile) gli garantivano una consolazione, in questa data già irre-peribile per Leopardi, minata dalla sua ironia.
35 A Brighenti, il 3 luglio ’27: «Finché sono in Firenze, o non mi dar commissioni per Giordani, o scri-vi in modo che tutta la lettera sia ostensibile a lui. Perché appena Giordani sa che tu mi hai scritto, vuolvedere la lettera. Se io dico di non poterla mostrare, gli fo nascere mille sospetti» (L 1102).
36 Cfr. la nota lettera di Vieusseux a Capponi: «Giordani gâtait tout par l’intempérance de sa langue enmatière de religion, et Leopardi lui même! a été scandalisé de son peu de menagements pour les opinionsde Manzoni» (G. CAPPONI, G. VIEUSSEUX, Carteggio, vol I (1821-1833), a cura di A. Paletti, Le Monnier,Firenze 1994, p. 89).
37 Drastico con Puccinotti l’11 gennaio ’28 che gli aveva scritto (L 1199) pensando che la Crestomaziadi prosa fosse frutto del citato progetto di Scelta del Giordani: «La Crestomazia non ha a che fare colpensiero di Giordani» (L 1209).
38 La prima lettera superstite di Leopardi da Pisa (dove vi arriva a novembre ’27) a Giordani è quelladel 5 maggio 1828 che esordisce: «tu dimandasti di me a Vieusseux, mostrando meravigliarti del mio lun-go silenzio» (L 1249); invece Giordani gli scrive il 13 novembre 27 (L 1163) e alla fine dello stesso mese(L 1171) a riscontro di una «letterina» «per dio troppo breve» perduta. La rarefazione dei rapporti saràlamentela del Giordani, ad esempio il 15 giugno ’29: «Prendi qualche volta la fatica di scrivermi, perchéil tuo silenzio accresce la mia tristezza! (L 1476).
39 A questa lettera Giordani risponderà a stretto giro di posta, l’8 maggio, con le parole, quasi, di Plo-tino a Porfirio: «Giacomino mio, amiamoci, amiamoci; e procuriamo di tollerare questa veglia inutile esmaniosa, finché ce ne liberi il sonno eterno e desiderabile» (L 1251).
40 Cfr. lettera al Brighenti del 15 gennaio ’27: «negli Idillii ed altre poesie di Leopardi non negherò chesia forse alquanto dei difetti da voi notati: ma delle dieci canzoni, cinque mi paiono stupende» (P. GIOR-DANI, Lettere, pp. 249-250). Ma va pur detto che a Giordani non sfuggirà poi la «grandezza e schiettez-za nello stile» del «Pastore errante» (L 1679).
41 Lonardi documenta una testuale memoria leopardiana dell’arché della parola poetica, vagheggiatacon irrimediabile nostalgia, per cui nel «desiderare l’antico imitando alcuni comportamenti della formu-larità antichissima si tocca il massimo della diversità di questo Leopardi […] rispetto all’intero classici-smo italiano ed europeo» (G. LONARDI, L’oro di Omero. L’“Iliade”, Saffo: antichissimi di Leopardi, Mar-silio, Venezia 2005, p. 21; e vedi in questo volume il saggio “A Silvia”: un canto veramente all’antica).
42 G. LEOPARDI, Canti, a cura di F. Gavazzeni e M.M. Lombardi, Rizzoli, Milano 1998, p. 622.43 Sul “mirare” cfr. E. GIOANOLA, Leopardi, la malinconia, pp. 272-273.44 Rispetto alla situazione del ’28, gli anni trenta vedono un diffusissimo proliferare di innodia sacra,
di fonte manzoniana. Se costante è il successo degli Inni sacri originali (sei edizioni tra 1822-27 e tredicitra 1828-39), i diadochi, rari negli anni venti, contano ben ventidue stampe negli anni trenta. Tra gli imi-tatori oltre al parente Mamiani, anche l’amico Muzzarelli, come s’è visto; né va dimenticato il perfido eanche straziante scacco paterno, di Monaldo editore del Manzoni sacro, in Macerata già nel ’28, a giu-gno. L’occasione è una stampa nuziale, ma l’edizione ha una significativa premessa di Monaldo, che sem-bra scritta su misura per Giacomo, in un estremo tentativo di arruolamento cristiano, nei giorni di con-diviso dolore familiare per l’improvvisa morte del giovane Luigi, fratello minore di Giacomo. «Giacomo
477
mio salviamoci. Tutto il resto è vanità» gli aveva scritto il 16 maggio Monaldo annunciando la morte diLuigi (L 1256). Otto giorni dopo l’appello affettuoso di Giordani (cfr. sopra n.39), Leopardi ricevevaquest’altra simile e più difficile richiesta.
45 Cfr. la magistrale lettura di Gilberto Lonardi nel citato volume Lettura leopardiana.46 Anche in questa strategia testuale mi pare inverarsi la tesi di fondo di Gioanola sulla dominante ma-
linconica in Leopardi: «La malinconia è stata insieme viaggio nella morte e difesa contro di essa, resa aldiktat della ragione e rivolta contro il suo strapotere, nella riproposizione, in termini di creatività poeti-ca e filosofica, dei diritti della “natura” e della vita quando, nella realtà, il congedo da esse è ormai un da-to stabilito», E. GIOANOLA, Leopardi, la malinconia, p. 175.
478