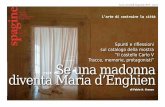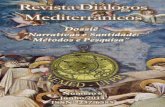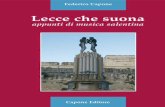Castello "Carlo V" di Lecce, recensione sul catalogo della mostra (e non solo)
Tra terra e mare: ricerche lungo la costa di San Cataldo (Lecce). Con un’Appendice...
-
Upload
unisalento -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Tra terra e mare: ricerche lungo la costa di San Cataldo (Lecce). Con un’Appendice...
Tra terra e mare: ricerche lungo la costa di San Cataldo (Lecce)
MARIANGELA SAMMARCO, SILVIA MARCHI*Con un’Appendice litostratigrafica di STEFANO MARGIOTTA**
Seppur già citato negli scritti di XVI secolo e noto a storici e cultori di antichitàsalentine1, le conoscenze sul porto antico di San Cataldo, presso Lecce (fig. 1), hannoprogredito in modo alquanto discontinuo e sono rimaste a lungo legate esclusivamen-te a segnalazioni di rinvenimenti fortuiti e ad interventi di recupero2 e all’edizione diantichi documenti relativi alle attività connesse al porto3.
L’esistenza di una struttura muraria riconosciuta come molo di un bacino portua-le antico era ben nota già nell’Ottocento; puntigliosamente scandagliato e disegnatodurante la lunga fase di progettazione per un nuovo approdo, il molo romano è bentracciato nella cartografia dell’epoca e i documenti d’archivio trasmettono ricche de-scrizioni dei resti antichi, testimoniando la notevole lunghezza e la sostanziale so-pravvivenza della struttura che fu parzialmente distrutta in fase di costruzione del-l’antemurale moderno. L’intervento di Cosimo De Giorgi, medico e scienziato salen-tino dedito a studi umanistici e geologici, all’epoca regio ispettore dei monumenti edegli scavi, evitò la completa distruzione del molo romano che sarebbe stato smantel-lato per ricavarne materiale da costruzione4.
Nel frattempo, a rendere più complessa la conoscenza delle strutture portuali,ampiamente devastate e depredate nel corso degli ultimi decenni, è intervenuto un ul-teriore avanzamento della linea di costa che, insieme a localizzati fenomeni di accu-mulo di sabbie marine e all’espansione urbana, ha drasticamente modificato l’aspettonaturale della baia.
Il sistema portuale antico di San Cataldo ha cominciato a rivelare le sue potenzia-lità ai fini della comprensione della topografia dell’area grazie alle possibilità offerteda un intervento diretto sui resti strutturali del molo antico5 che, nonostante la diffi-
JAT XXII (2012)
* Laboratorio di Topografia Antica e Fotogram-metria (LabTAF), Dipartimento di Beni Culturali– Università del Salento, via D. Birago 64, 73100Lecce, tel. 0832 295513; fax 0832 295506; e-mail:[email protected]
** Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biolo-giche e Ambientali – Università del Salento, S.P. 6,Lecce – Monteroni, 73100 Lecce, e-mail: [email protected]
1 DE FERRARIS GALATEO 1558, p. 120; MARCIA-NO 1855, p. 369; BERNARDINI 1955, pp. 34-35.
2 È alla lunga attività subacquea di Raffaele Con-gedo che si devono le prime conoscenze sui fondalidella rada e i primi recuperi di materiale archeolo-
gico. V. CONGEDO 1959; CONGEDO 1960; CONGE-DO 1984, ADIUTO PUTIGNANI, CONGEDO 1964.
3 COTA 1936; FOSCARINI 1984.4 DE GIORGI 1913.5 Questo contributo è il risultato di una ricerca
effettuata nell’ambito delle attività promosse dallecattedre di Topografia antica, Aerotopografia ar-cheologica e Rilievo e analisi tecnica dei monu-menti antichi dell’Università del Salento, ai cui ti-tolari professori Marcello Guaitoli, Giuseppe Ce-raudo e Carla Maria Amici va un sentito riconosci-mento. Un ringraziamento particolare è per Gian-franco Quarta che ha curato gli interventi subac-quei e la redazione del rilievo delle strutture som-
cile leggibilità dei resti archeologici oggetto di spoglio sistematico e continue distru-zioni, ha agevolato la comprensione delle caratteristiche edilizie e delle tecniche dicostruzione impiegate.
È stato realizzato il rilievo di dettaglio delle strutture a terra e dei poderosi restisommersi (fig. 2), e sono state condotte apposite ricognizioni aeree6 che hanno con-sentito la gestione di immagini oblique, opportunamente integrata con un analiticolavoro di fotointerpretazione su strisciate aeree storiche. Il confronto tra i dati strut-turali così ottenuti e l’abbondante materiale storico-iconografico derivato da ap-profondite ricerche d’archivio ha consentito di acquisire nuove informazioni sull’im-pianto portuale, sulle caratteristiche strutturali e di messa in opera del molo antico esulle distruttive operazioni di smantellamento finalizzate al reperimento di materialeedilizio da reimpiegare, nonché di definire la relazione topografica tra la nuova diga eil tratto superstite del molo d’età romana.
L’ampia disponibilità di cartografia storica e di levate aeree storiche ha, poi, resoparticolarmente interessante ai fini della ricerca una loro applicazione in ambito GIS,attraverso il corretto processo di adattamento su basi cartografiche digitali contem-poranee. Ciò ha agevolato l’analisi di dettaglio delle imponenti trasformazioni subitedal paesaggio costiero e legate a fenomeni di varia natura, fra cui le opere di bonificache hanno sensibilmente modificato ampi settori della fascia costiera e retrocostieradi San Cataldo, l’espansione dell’area urbana, causa della parziale distruzione del mo-lo romano e di altri edifici storici, le variazioni della linea di costa che hanno avuto unsignificativo ruolo nella lunga vicenda storica del porto antico.
Ancora in corso è, infine, l’analisi topografica del territorio compreso tra il portodi San Cataldo e il centro interno di Lecce. La ricerca si basa sulla ricognizione siste-matica capillare di un ampio comprensorio territoriale, replicata ed integrata in rela-zione alla visibilità di superficie che in alcune zone risulta continuativamente nonbuona: esistono infatti larghe porzioni di territorio coperte da fitta vegetazione spon-tanea e soprattutto grandi aree lagunari lungo la costa. Le lavorazioni agricole sonorisultate causa dell’alto livello di usura del materiale ceramico rinvenuto in superficie,che rende spesso difficile una datazione precisa, limitata in molti casi all’epoca di per-tinenza piuttosto che al secolo; spesso, poi, non è stato possibile stabilire il naturalerapporto tra abitato/insediamento e necropoli. Nonostante ciò l’esplorazione siste-matica ha portato finora all’acquisizione di un elevato numero di presenze archeolo-giche non conosciute, alla corretta valutazione di numerose altre già note e ha per-messo di chiarire alcuni fenomeni insediativi e situazioni d’area in precedenza soloparzialmente analizzati. La ricerca territoriale, una volta portata a conclusione, ten-terà di evidenziare come l’esistenza e la funzionalità della struttura portuale di SanCataldo siano state sempre fermamente collegate ad alcuni presupposti ben precisi,ovvero la capacità produttiva e ricettiva dell’entroterra, la presenza di una popolazio-ne locale dotata di una organizzazione politica ed economica e capace di creare unluogo di approdo e di garantirne il funzionamento, la possibilità di fruire di una reteviaria che consentisse un’ampia e rapida circolazione delle merci.
M.S.
108 MARIANGELA SAMMARCO, SILVIA MARCHI
merse. È infine d’obbligo ringraziare il dott. Ar-cangelo Alessio della Soprintendenza per i BeniArcheologici della Puglia, il quale ha costantemen-te dimostrato completa fiducia nell’avallare la ri-cerca. Le immagini con l’indicazione ASL sonoutilizzate su concessione del Ministero per i Beni ele Attività Culturali – Archivio di Stato di Lecce.
6 Le attività di ricognizione aerea rientrano nel-l’ambito del Progetto europeo Culture 2000. Eu-ropean Landscapes: Past, Present and Future a cuil’Università del Salento ha preso parte con il coin-volgimento del Laboratorio di Topografia Anticae Fotogrammetria (LabTAF) e del Laboratorio diArcheologia Medievale.
TRA TERRA E MARE: RICERCHE LUNGO LA COSTA DI SAN CATALDO (LECCE) 109
Fig. 1 - Presenze archeologiche nel terri-torio tra Lupiae e San Cataldo rilevate nelcorso dell’indagine sul terreno in relazio-ne alla viabilità di collegamento con ilporto e allo schema della centuriazione(base cartografica: IGM 204 III SE, II SO,II SE).
Fig. 2 - Planimetria generale delle struttu-re portuali di San Cataldo (rilievo G.Quarta).
Considerazioni sulla geomorfologia costiera del litorale di San Cataldo
L’ampia baia sabbiosa di San Cataldo si sviluppa lungo la costa adriatica immedia-tamente a Sud del breve promontorio dove sorge il faro, interessata direttamente daiventi dei quadranti orientali con prevalenza della corrente di Scirocco.
Le batimetrie, allontanandosi dalla linea di riva, segnano un andamento regolarefino ai m 100, per poi approfondirsi rapidamente; il fondale è caratterizzato dalla pre-senza di sabbia organogena a granulometria fine, e quindi di facile sospensione, spes-so interrotta dall’affioramento di bancate rocciose7.
La spiaggia, che è caratterizzata nella parte emersa dalla presenza di sabbie scured’origine vulcanica8, ha un’ampiezza estremamente variabile, legata principalmente alfenomeno della marea e alla sua escursione giornaliera, ma anche alla presenza dei re-sti strutturali dei moli diruti che trattengono sul lato esposto alle correnti marine no-tevoli quantitativi di sabbia e alghe che, dopo un periodo di accumulo, finiscono conl’aggirare l’ostacolo artificiale costituito dalle murature in crollo, depositandosi lungola riva.
L’aspetto attuale dell’area è il risultato di una combinazione di fenomeni di carat-tere naturale, a cui sono sopravvenute drastiche modifiche di origine antropica.
Una radicale modificazione del paesaggio costiero è stata determinata dalla risalitaolocenica del livello del mare. Pur non esistendo una curva di variazione del livellomarino su scala regionale9, gli studi attualmente disponibili per la costa adriatica pu-gliese propongono l’ipotesi che «in epoca greco-romana» il mare abbia raggiunto, inseguito a più oscillazioni, un livello più basso di circa m 3 rispetto alla sua posizioneattuale10. Un innalzamento del livello marino così stimato parrebbe confermato dalleevidenze archeologiche sommerse e semisommerse esistenti lungo la costa a Sud diSan Cataldo, in località San Giovanni, dove alcuni allineamenti di blocchi interpretaticome resti di una probabile peschiera si trovano ad una profondità compresa tra m1,5 e 3 ed un gruppo di vasche scavate nella roccia, utili probabilmente per la raccoltadel sale, sono poste invece a livello del mare11.
Nell’area compresa tra l’imponente molo in opera cementizia e un moletto di re-cente costruzione (fig. 3), localizzati fenomeni di insabbiamento dovuti all’azionedelle correnti marine e agevolati dalla presenza degli stessi resti murari, fanno sì che ledue bitte d’ormeggio del paramento meridionale del molo romano si trovino in unsettore della struttura ormai a terra. Il litorale sabbioso che si sviluppa oltre, in dire-zione Sud/Sud-Est, è invece interessato da costanti fenomeni di erosione, evidentetendenza evolutiva che interessa, con grande incidenza e diffusione, l’intera fascia co-stiera adriatica.
Parallelamente alla linea di riva si sviluppavano dei cordoni litorali di dune12 for-matisi a seguito delle più recenti oscillazioni del livello marino (avvenute probabil-mente dopo le ultime fasi glaciali quaternarie) che hanno favorito l’accumulo lungo la
110 MARIANGELA SAMMARCO, SILVIA MARCHI
7 Pochi metri a largo del faro affioramenti roc-ciosi costituiscono una lunga e pericolosa secca.Qui il Congedo localizzava, infondatamente, i re-sti della torre costiera di San Cataldo (CONGEDO1984, p. 54).
8 Sulla provenienza delle sabbie nere di San Ca-taldo dai depositi vulcanici del Monte Vulture,portate al mare dal fiume Ofanto e distribuite lun-go la costa dal ramo discendente della correnteadriatica v. DE GIORGI 1913; ALVINO 1974, in par-ticolare p. 19; MASTRONUZZI, PALMENTOLA, SAN-SÒ 1989, p. 255.
9 Per una sintesi dei dati disponibili sulle varia-zioni della linea di costa adriatica pugliese si ri-manda a AURIEMMA 2004a, pp. 22-30.
10 MASTRONUZZI, SANSÒ 2002, p. 54.11 Sulle evidenze di località San Giovanni v. CE-
RAUDO, ESPOSITO 1997.12 Dal punto di vista litologico i depositi di sab-
bia sovrastano una formazione rocciosa di tipocalcarenitico di età plio-pleistocenica (ALVINO1974, p. 6; BOSSIO, FORESI, MARGIOTTA, MAZZEI,MONTEFORTI, SALVATORINI 1999).
riva di depositi sabbiosi e, nell’ampia piana pericostiera, tabulare e poco elevata sul li-vello del mare, la formazione di stagni costieri più o meno ampi; il progressivo accre-scimento delle fasce dunari, dovuto ad un accumulo prevalentemente eolico, ed ilcontemporaneo interrimento degli stagni costieri, unitamente ad una leggera trasgres-sione che ha portato il mare al livello attuale, hanno agevolato la formazione nelle zo-ne paralitoranee di ampie manifestazioni palustri di retroduna13, oggi inattive perchébonificate.
Attualmente il cordone dunare, sebbene molto modesto in spessore e in altezza, siconserva solo lungo la fascia costiera a Nord della punta, dove sono ben leggibili gliinterventi di bonifica e di sistemazione idraulica effettuati in momenti diversi per ilrisanamento dell’area e dove, in tempi recenti, è stato realizzato un sistema di difesadel litorale costituito da pennelli frangiflutti perpendicolari alla linea di riva. I pesantiinterventi di cementificazione della costa effettuati nel corso del secolo scorso hannoinvece del tutto cancellato le dune costiere che si sviluppavano fino a pochi decenni falungo l’intera baia, modificando radicalmente le caratteristiche geo-ambientali di que-sto tratto di litorale.
Descrizioni letterarie e materiale d’archivio documentano la presenza, almeno apartire dal 1500, di ampie paludi nella marina leccese (fig. 4) che hanno costituito persecoli un grosso impedimento allo sviluppo delle attività agricole e di vasti settori del-la fascia costiera resi repulsivi dalla malaria.
Le prime azioni di bonifica e rimboschimento ai fini del risanamento territorialefurono intraprese alla metà del XIX secolo, quando tra 1855 e 1856 furono colmate
TRA TERRA E MARE: RICERCHE LUNGO LA COSTA DI SAN CATALDO (LECCE) 111
13 Per una descrizione dei fenomeni geomorfo-logici costieri v. PALMENTOLA 1989.
Fig. 3 - Fenomeni differenziati di accumulo e di erosione in corrispondenza dei ruderi del moloantico (Archivio LabTAF).
alcune conche localizzate vicino al porto e al posto doganale di San Cataldo. A segui-to di uno studio condotto dalla Commissione per la bonifica dei terreni paludosi, l’e-stensione della palude di San Cataldo, classificata come «palude di prima categoria»,fu stimata di 250 ettari; successivamente iniziarono le prime attività sistematiche dibonifica14: nel biennio 1884-1885 la palude che si trovava presso la «punta adrianea»,ampia circa 4 ettari, fu colmata manualmente con sabbia; tra 1890 e 1891 furono col-mate altre zone malsane che si estendevano tra la strada comunale e il mare e conte-stualmente si iniziò il rimboschimento15 di un’area demaniale ampia 20 ettari che siestendeva alle spalle della rada.
M.S.
Il porto di San Cataldo nella documentazione d’archivio
Nello specchio d’acqua antistante l’attuale Piazza Adriano, a Sud-Est del faro, ab-bondante documentazione d’epoca16 segnala la presenza dei ruderi di una imponentestruttura muraria, indicata come l’«antico molo» del Porto Adriano.
Nelle planimetrie ottocentesche relative alle opere di bonifica ed alla costruzionedi un nuovo molo che permettesse la ripresa delle attività marittime nella baia17, i restisemi-insabbiati del molo sono caratterizzati come un paramento di blocchi squadratidi grandi dimensioni e si protendono con andamento semilunato verso il mare, for-mando nel settore in acqua (la parte maggiormente esposta all’urto delle onde) unammasso di pietrame irregolare (figg. 5-6)
Dalle osservazioni dell’autore della bella «Pianta della Palude di San Cataldo»18
(fig. 7) si ricava la notizia che nel 1860 il molo era lungo 400 palmi, per metà distrutto
112 MARIANGELA SAMMARCO, SILVIA MARCHI
14 Sui primi interventi di bonifica v. MAINARDI1988; MAINARDI 1997.
15 Sulla questione del rimboschimento dei terre-ni prospicienti la rada di San Cataldo v. MAINARDI1989.
16 Le piante sono conservate presso l’Archiviodi Stato di Lecce (ASL) e l’Archivio Storico Co-munale di Lecce (ACL).
17 Furono elaborati ben cinque differenti pro-getti (nel 1863, nel 1865, nel 1878, nel 1881 e nel1889) che per motivi di natura economica o perinadeguatezza delle soluzioni strutturali propostenon furono approvati. Per una ricostruzione dellevicende v. SAMMARCO, MARCHI 2008.
18 Architetto I. Bernardini; la pianta è datata al 25febbraio 1860; ASL, Provincia, II dep., b. 18, f. 179.
Fig. 4 - L’estesa palu-de di San Cataldo nel-l’Atlante del RizziZannoni (1874).
TRA TERRA E MARE: RICERCHE LUNGO LA COSTA DI SAN CATALDO (LECCE) 113
Fig. 5 - Particolare della«Planimetria del Porto S.Cataldo (di rifugio e ap-prodo)» (ing. F. Pinto, giu-gno 1866; scala 1:2000);ASL.
Fig. 6 - Particolare della«Carta in scala 1:1000 del-l’area del molo di S. Catal-do» (ing. E. Fany, 1881);Biblioteca Provinciale diLecce.
dal mare, mentre l’altra metà risultava già all’epoca «inutilizzata» per l’avanzamentodella linea di riva. Di grande interesse nello scritto è la descrizione di un particolarestrutturale sfuggito ai successivi progettisti: nella «parte convessa» del molo, ovverolungo il paramento settentrionale, era visibile all’epoca «una scogliera» addossata allastruttura, realizzata con una tecnica non difforme dal cementizio antico. Lo spogliodel monumento per il recupero di materiale di riutilizzo avvenuto durante la costru-zione della nuova diga, ha causato la cancellazione di gran parte del paramento inblocchi, e conseguentemente dell’evidenza segnalata nella nota di progetto; pertanto alivello di pura ipotesi si potrebbe pensare di interpretare l’ulteriore barriera come unpossibile risarcimento o rifacimento della struttura effettuato in un momento nonprecisabile del lungo utilizzo del molo.
Un’interessante descrizione della struttura antica, ampiamente rovinata dalle ma-reggiate, è nella «Relazione relativa al progetto di nuovo ancoraggio da eseguirsi aSan Cataldo presso Lecce» redatta dall’ingegnere livornese Augusto Pazzi nel 30 lu-glio 1865, in cui si legge che l’antico molo «(…) in origine aveva la lunghezza di oltrecentocinquanta metri, il quale oggi è interrito internamente per circa due terzi edogni rimanente è stato distrutto dall’impeto delle onde, non restando di quest’ultimoche il solo imbasamento che si scorge a fior d’acqua». Il testo procede poi con la de-scrizione della parte basale su cui poggiava la struttura, formata da «un getto di pic-coli scogli naturali che si elevano fino presso il livello delle acque », preziosa informa-zione che, in assenza di dati di scavo, permette ora di ipotizzare per la struttura in ce-mentizio una fondazione su roccia.
Particolarmente dettagliata è la resa grafica della «Planimetria della zona demania-le consegnata all’amministrazione forestale per rimboschimenti presso la spiaggia diSan Cataldo»19 (fig. 8), dove spicca la presenza nella muratura di due elementi circola-ri interpretabili come colonne, a fronte della sola bitta che attualmente si conserva20.
114 MARIANGELA SAMMARCO, SILVIA MARCHI
19 Redatta dagli ingegneri E. Dragonetti e I.Sammartino nel 1890, in scala 1:1000; ACL.
20 La presenza di ben 3 colonne nel molo di San
Cataldo, utilizzate per l’attracco delle imbarcazio-ni, è testimoniata in DE SIMONE, 1874, p. 297 e DEGIORGI 1888, p. 383.
Fig. 7 - Particolare della «Pianta della Palude di San Cataldo» (ing. I. Bernardini, febbraio 1860);ASL.
In una veduta fotografica della fine dell’Ottocento (fig. 9) sono chiaramente identifi-cabili due colonne aggettanti dalla struttura emersa, oltre la quale un basso allinea-mento di massi sciolti si protende verso il mare. È verosimile pensare che la bitta piùinterna sia andata perduta quando è stata realizzato, forse per scopi bellici, un ampiotaglio nel paramento meridionale.
Di grande effetto sono la pianta acquerellata relativa al progetto del 189821 (fig.10), e quella di poco successiva (1901)22 che ne riprende gli elementi grafici principali.
TRA TERRA E MARE: RICERCHE LUNGO LA COSTA DI SAN CATALDO (LECCE) 115
21 «Planimetria del Progetto di massima per lasistemazione del Porto di San Cataldo presso Lec-ce», ing. A. Somma, 1898, scala 1:1000, ACL.
22 «Progetto per la sistemazione del Porto di SanCataldo presso Lecce», ing. V. Fiorentino, 1901,scala 1:500, ACL.
Fig. 8 - Particolare della «Planimetria della zona demaniale consegnata all’amministrazione fore-stale per rimboschimenti presso la spiaggia di San Cataldo» (ing. E. Dragonetti, I. Sammartino,1890; scala 1:1000); ACL.
Fig. 9 - I ruderi del molo di San Cataldo in un’immagine di fine Ottocento (da Laudisa 1995).
Come da progetto esecutivo23 a San Cataldo tra l’8 maggio 1901, giorno della posadella prima pietra, e il 15 luglio 1908, momento del collaudo della struttura24, fu rea-lizzata una nuova diga che, «spiccandosi dalla radice del diruto molo», si spingeva inmare in due tratti rettilinei raccordati da una curva, per una lunghezza complessiva dicirca m 190; nella parte interna il molo era affiancato da una banchina transitabileconnessa alla via rotabile che si innestava nella strada per Lecce. Il primo braccio siestendeva in direzione Sud-Est e sarebbe dovuto essere costruito con blocchi di pie-tra ricavati dai ruderi del molo Adriano messi in opera in aggetto l’uno sull’altro;quando si fosse esaurita la pietra di spoglio dai ruderi del molo, si sarebbe procedutoa fabbricare blocchi in calcestruzzo. Il secondo tratto era rivolto verso libeccio e pre-sentava il fianco esposto alle correnti rivestito di massi di pietra di cava25. Sui blocchiinsisteva una berma in muratura di pietrame che si elevava per 0,52 m, al di sopra del-la quale era collocato il muraglione alto m 3.50 (fig. 11).
Il molo antico non fu completamente distrutto per ricavarne materiale da costru-zione grazie all’intervento del De Giorgi26 in seguito al quale fu stabilito di sacrificare
116 MARIANGELA SAMMARCO, SILVIA MARCHI
23 Il progetto esecutivo fu presentato il 26 agosto1900 (ASL, Genio Civile, b. 260 f. 1296, «Progetto(26-8-1900) per la sistemazione del porto di S. Ca-taldo») a firma dell’ingegnere capo dell’Ufficiod’Arte del Municipio di Lecce Andrea Gatto ed ap-provato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubbli-ci nell’adunanza del 28 dicembre 1900 (ASL, GenioCivile, b. 260 f. 1294, Consiglio Superiore dei La-vori Pubblici, adunanza del 28 dicembre 1900).
24 ASL, Genio Civile, b. 260 f. 1297, Verbale divisita di collaudo, Impresa Reale Vito fu Egidio,15 luglio 1908.
25 I blocchi avevano dimensioni: m 2 di base e m1 di altezza. Riguardo la tipologia del materiale dacostruzione del nuovo molo, nella sezione relativaall’analisi dei prezzi viene specificato che i massinaturali da impiegarsi nella muratura sommersa sa-rebbero stati cavati da una «località adiacente ai la-vori, dal sito denominato Masseria Le Palazze»(cfr. la relazione allegata al «Progetto per la siste-mazione del porto di S. Cataldo presso Lecce» del26 agosto 1900; ASL, Genio Civile, b. 260 f. 1296).
26 Cfr. la «Lettera al Direttore dell’Ufficio re-gionale dei monumenti per le province meridiona-
Fig. 10 - Particolare della «Planimetria del Progetto di massima per la sistemazione del Porto diSan Cataldo presso Lecce», ing. A. Somma, 1898, scala 1:1000, ACL.
solo quella porzione del molo antico su cui si sovrapponeva il tracciato della nuovadiga, rispettando la parte restante. Come conseguenza di ciò fu redatta una periziasuppletiva27 con la quale si giustificava il costo maggiore previsto per la realizzazionedel primo tratto della diga, data la necessità di rimpiazzare i massi che si sarebberodovuti ricavare dal molo Adriano con nuovo materiale artificiale28.
Nelle cartografie di progetto il molo romano è, dunque, ben rappresentato grafica-mente, talvolta con interessanti caratterizzazioni, cui si aggiungono gli utili dati per laricostruzione della topografia generale dell’area. L’analisi dell’abbondante documenta-zione cartografica storica ha difatti permesso di identificare l’edificio in rovina dise-gnato nelle carte immediatamente a Nord del molo in cementizio, il cosiddetto castel-lum, con la torre costiera costruita tra la fine del XIV e gli inizi del secolo successivo,oggetto di una successiva sistemazione edilizia promossa dalla regina angioina Mariad’Enghien, la quale non intervenne dunque (come erroneamente ritenuto) sul molo,ma sulla fortificazione costiera29. Una localizzazione certa può anche essere propostaper la cappella intitolata a San Cataldo, di cui non si conosce finora la data di fonda-zione, ma che alla metà dell’Ottocento risultava in stato di abbandono e che fu abbat-tuta durante le più recenti sistemazioni urbanistiche del piazzale antistante il faro.
M.S.
TRA TERRA E MARE: RICERCHE LUNGO LA COSTA DI SAN CATALDO (LECCE) 117
li in Napoli, 10 maggio 1901» (Biblioteca Provin-ciale N. Bernardini, Manoscritti, vol. 147 f. 32).
27 ASL, Genio Civile, b. 260 f. 1297, «Lavorisuppletivi per la sistemazione del porto di S. Ca-taldo eseguiti a cura del Comune di Lecce consussidio dello Stato. Corrispondenza (1900-1913).Perizia suppletiva per aumento di spesa nelle ope-re di rivestimento della scogliera nel primo tratto
della diga (20 luglio 1901)»28 Nella parte sommersa del rivestimento, ai
blocchi di spoglio si sostituirono quelli artificialidi calcestruzzo, delle dimensioni di m2.00x1.00x0.85, per un volume risultante di unmetro cubo e settanta.
29 Per un approfondimento si rimanda a SAM-MARCO, MARCHI 2008.
Fig. 11 - «Progetto per la sistemazione del Porto di San Cataldo presso Lecce», ing. V. Fiorentino,1901, scala 1:500, ACL. Sezioni.
Analisi strutturale del molo romano
La struttura antica è articolata in due segmenti: il primo spicca dal muretto mo-derno che delimita Piazza Adriano e si protende lungo la spiaggia verso il mare peruno sviluppo complessivo di m 5130; il secondo tratto, lungo m 10, si trova sulla batti-gia, rasato sotto l’antemurale del molo novecentesco e non è sempre visibile a causadei rapidi insabbiamenti cui è soggetta l’intera baia (fig. 12).
Il molo, che presenta una struttura compatta e coerente, è costituito da un para-mento in opera quadrata in blocchi di calcarenite locale31 e da un nucleo in opus cae-menticium composto da pietrame di varia pezzatura frammisto a malta di calce contritume testaceo. Setti ortogonali e paralleli alle cortine esterne ripartiscono lo spaziointerno nella zona di maggiore larghezza della struttura (m 15), per irrobustirla e di-stribuire in maniera ottimale le spinte del materiale di riempimento e imbrigliare legettate effettuate per stati successivi.
Il complesso, piegando in direzione Sud-Est, disegna una leggera curvatura a par-tire dal settore centrale, con evidente deviazione del paramento meridionale. La su-perficie calpestabile non è uniforme ma si presenta fortemente erosa dagli agenti at-mosferici e pesantemente manomessa dagli interventi antropici. Nella parte a mare sisono conservate due catene ortogonali ai paramenti esterni e collegate fra loro da duespine parallele, realizzate con conci di lunghezza fra m 1.60 e 2.90 e con uno spessoreoriginario apprezzabile solo per alcuni di essi (cm 45÷50); molti, infatti, sono cosìusurati da essersi ridotti a lastrine sottili anche cm 10-15.
L’estremità verso mare è la parte più alta della struttura: infatti, una gettata diconglomerato (cm 50÷60) non conservata nel resto della fabbrica ma visibile nellefoto storiche (fig. 13), fa presumere la presenza in origine di almeno un filare diblocchi in più rispetto alla situazione attuale. Sempre in questo settore è collocatauna bitta d’ormeggio di forma cilindrica in marmo bianco venato, conservatasi perun’altezza ed un diametro di cm 40 (fig. 14). A breve distanza, nella parte centraledel molo, un’altra bitta è stata eseguita con una tecnica differente: uno dei blocchidel paramento meridionale, infatti, è stato sagomato all’estremità in modo da ottene-
118 MARIANGELA SAMMARCO, SILVIA MARCHI
30 La realizzazione della piazza ha obliterato la ra-dice del molo che, secondo la documentazione d’ar-chivio, era più lungo dell’attuale di almeno m 40.
31 Per le caratteristiche litologiche dei blocchi v.infra, Appendice.
Fig. 12 - Planimetria e sezioni prospettiche del molo antico (rilievo S. Marchi).
re una sporgenza, funzionale allo scopo32. La datazione delle bitte resta incerta, ma èinteressante notare che i tagli operati nei blocchi per l’alloggiamento della bitta dimarmo comprovano che la sua messa in opera non era prevista nella progettazioneiniziale; inoltre, il fatto che il piano di posa della colonna si trovi ad una quota infe-riore per due filari di blocchi rispetto all’ipotetico livello originario della struttura fapensare ad una realizzazione della bitta quando il complesso era già mutilo dellaparte superiore.
Nel settore centrale il molo è disturbato dalla presenza di un moderno pavimentoin piastrelle (m 4.84x4.00) e di ampi tagli nel paramento meridionale posti ad unaquota più bassa che costituiscono i resti di un’abitazione realizzata negli anni Trenta,raffigurata in una foto d’epoca (fig. 15) ed ancora in piedi negli anni Sessanta, munitadi accesso diretto a mare: in questo senso si deve, infatti, interpretare il taglio di ca. m3.50 operato nel settore di conglomerato di fronte all’abitazione. Sono, invece, proba-
TRA TERRA E MARE: RICERCHE LUNGO LA COSTA DI SAN CATALDO (LECCE) 119
32 Il tipo di bitta, realizzata però nel banco roc-cioso, è attestata lungo il perimetro del porto di
Ventotene (ANZIDEI, BENINI, LAMBECK, ANTO-NIOLI, ESPOSITO, SURACE 2004, p. 119, fig. 1.)
Fig. 13 - Il settore meridiona-le del molo in una foto ante-cedente la seconda guerramondiale. Al centro, la bittain marmo bianco venato. (Fo-toteca Provinciale “G. Palum-bo” di Lecce).
Fig. 14 - La bitta in marmocome si presenta attualmente.
bilmente pertinenti alle cabine ancora in esercizio negli anni Sessanta33 i quattro mu-retti realizzati in cemento e in blocchetti che con andamento parallelo attraversano ilmolo a partire dalla radice per una lunghezza massima di m 15.50.
Per tutto il suo sviluppo orizzontale, inoltre, la superficie presenta dei tagliprofondi da cm 10 a 60 che, probabilmente, ricalcano il tracciato dei camminamentiche servivano le casematte impiantate sulla struttura nel corso della seconda guerramondiale: si tratta di tre postazioni a pianta circolare, foderate di cemento e delimita-te da un filare di pietre.
Il paramento settentrionale è stato oggetto di uno spoglio sistematico derivatodall’impiego dei blocchi per la realizzazione dell’ancoraggio novecentesco (fig. 16). Ilprospetto si presenta conservato in elevato per m 2.30; i blocchi rimasti, spesso ridottia sottili lastre aderenti al nucleo di cementizio, testimoniano la presenza di almeno seifilari di conci. Il paramento, tuttavia, è caratterizzato da tessitura differente nel tratto
120 MARIANGELA SAMMARCO, SILVIA MARCHI
33 Per l’attestazione delle cabine sul molo Adria-no, si veda CARTELLI 1981, figg. 18-19.
Fig. 15 - L’edificio moderno realizzato nel settore centrale in una foto degli anni Trenta. (FototecaProvinciale “G. Palumbo” di Lecce).
Fig. 16 - La cortina settentrionale, oggetto di uno spoglio sistematico per la realizzazione dell’an-coraggio novecentesco.
iniziale rispetto a quello finale, dovuta alla necessità di adattare l’impianto ad un ter-reno non omogeneo, che non presentava giacitura perfettamente orizzontale ma unalieve pendenza verso il mare.
Meglio conservato e con uno sviluppo maggiore rispetto a quello settentrionale, ilparamento meridionale si conserva per un’altezza che varia da m 1.30 a 2.60 e presen-ta, conservati non in maniera costante, quattro corsi di blocchi. Del quinto filare, se-polto sotto la sabbia, si riesce ad individuare, in alcuni punti, il filo superiore. Il trattomeglio conservato parte dal centro ed aggetta verso il mare: i blocchi presentano unalunghezza che varia da m 1.80 a 2.90 ed uno spessore da cm 45 a 60, sono messi inopera per la maggior parte di taglio e risultano intervallati da blocchi di testa, dellalarghezza compresa fra cm 90 e 110. Ad una distanza di m 13.50 dalla testata meridio-nale, è stato effettuato un taglio nel paramento, probabilmente per consentire l’acces-so ai camminamenti di servizio alle casematte presenti sul piano di calpestio; i bloc-chi, in quel tratto, risultano fortemente danneggiati.
Da questo punto fino alla radice, il paramento appare molto meno conservato dalmomento che, per la parte visibile, è stato obliterato dall’abitazione moderna che vi siè addossata ed è stato massicciamente spogliato in prossimità dell’origine, forse perl’approvvigionamento di materiale da costruzione.
Lungo tutto lo sviluppo del paramento meridionale è evidente come i conci, solosbozzati e spesso non perfettamente levigati sulla faccia inferiore, siano stati messi inopera gli uni sugli altri mediante l’uso di zeppe e di malta che serviva a regolarizzarela superficie di contatto.
Il prospetto della struttura lungo il lato breve, per il suo carattere accidentale enon artificiale, consente di osservare la tessitura interna della muratura e di trarrequalche conclusione sulla messa in opera delle catene trasversali. Le cinque assise diblocchi visibili presentano orditura grossomodo corrispondente a quella del fiancosettentrionale e del fianco meridionale, pur se con minime variazioni di quota. Tutti iconci presentano le tracce lasciate dagli attrezzi utilizzati per la messa in forma. Sullafacciavista si riconoscono i segni ravvicinati dell’ascia martello; la superficie di contat-to, invece, è stata levigata mediante l’uso di uno scalpello a taglio liscio, che ha lascia-to solchi più larghi e regolari34. I blocchi di testa collocati alla base della punta estre-ma del molo sono collassati sotto la spinta della muratura soprastante: la stabilità del-la struttura è sicuramente stata menomata, in questo settore, dalla costruzione dellecasematte, che ha accresciuto la compressione esercitata dal riempimento, ed è com-promessa dalla continua azione erosiva del mare.
Già nelle fonti d’archivio ottocentesche si fa riferimento alla presenza di «barre diferro» utilizzate per rendere solidali i blocchi del molo antico. Oggi, del sistema difissaggio rimangono sei grappe messe in opera per vincolare i blocchi sulla stessa assi-sa, e due perni impiegati per legare blocchi sovrapposti. Le grappe, quattro delle qualia doppia T e due assimilabili al tipo a pi greco35 (fig. 17) presentano una lunghezza dicm 55÷60. Soltanto una è utilizzata per vincolare due blocchi del paramento meridio-nale; negli altri casi le grappe sono impiegate per fissare gli elementi delle catene tra-sversali36.
TRA TERRA E MARE: RICERCHE LUNGO LA COSTA DI SAN CATALDO (LECCE) 121
34 ROCKWELL 1989, pp. 27-28 e p. 39.35 GINOUVÈS, MARTIN 1985, p. 109, tav. 28;
ADAM 1990, pp. 56-58.36 Su uno dei blocchi visibili nella sezione occiden-
tale, non più in posto, una grappa a doppia T è statarealizzata su uno dei lati lunghi, mentre una mortasa
è stata solo abbozzata sul lato contiguo, senza peròche la grappa vi venisse alloggiata; anche in un altrocaso, la grappa è stata realizzata in una posizioneleggermente differente da quella prevista in origine, atestimonianza di un aggiustamento continuo in fasedi assemblaggio delle operazioni in progetto.
Il settore del molo antico sulla battigia si trova ad una quota inferiore di circa 2metri rispetto al primo tratto ed è stato rasato per la realizzazione del porto novecen-tesco; il segmento che emerge dalla sabbia è lungo ca. m 10 ed è costituito da un alli-neamento di blocchi che testimonia l’andamento chiaramente semilunato della strut-tura. Si tratta, sostanzialmente, di una spina trasversale di due conci e di un corso diblocchi posti per il lungo, ai quali si addossa il riempimento in conglomerato. I bloc-chi sono stati spezzati e livellati; inoltre al conglomerato antico, di cui si osservano la-certi anche ad una distanza di m 15 dall’origine dell’allineamento di conci, si è addos-sato il calcestruzzo moderno.
Rispetto alle tecniche di costruzione portuale descritte da Vitruvio (V, 12), la solu-zione edilizia adoperata per il molo di San Cataldo può essere ricondotta alla tipolo-gia a cassaforma, anche se l’assenza di malta idraulica esclude il ricorso alla stagnatu-ra. Si tratta quindi di una struttura a fondazione continua, realizzata con filari diblocchi disposti a vespaio37 che isolano degli spazi vuoti poi riempiti con gettate diopera cementizia (fig. 18). Tale metodo costruttivo può essere riconosciuto nel «siste-ma dell’émplekton»38 impiegato su vasta scala in numerose strutture del bacino medi-terraneo di diverse epoche; già in età classica, infatti, cassoni litici che contengono unriempimento di pietrame e terra sono impiegati nel porto del Lechaion39, presso Co-rinto, e nei porti greci di Larymna e Leukai40; ad una tipologia affine si possono assi-
122 MARIANGELA SAMMARCO, SILVIA MARCHI
37 FELICI 2001, pp. 167-168.38 ESPOSITO, FELICI, GIANFROTTA, SCOGNAMI-
GLIO 2002, p. 29.
39 PARIS 1915.40 LEHMANN HARTLEBEN 1923, p. 105.
Fig. 17 - Grappa a pi greco lungo il paramento settentrionale.
milare i porti fenici di Tiro41 e di Sidone42, dove le strutture superstiti sono datate frala fine dell’età ellenistica e la prima età romana. Strutture «a compartimenti» in operaquadrata con un nucleo di pietrame di varia pezzatura sono impiegate nei porti istria-ni di età romana datati tra il I ed il II sec. d.C.43; analogie costruttive presenta anche ilporto di Kyme Eolica attivo fin dall’età classica e forse risistemato nella prima metàdel I sec. d.C.44, dove accanto alla tecnica della gettata in cassaforma lignea sono atte-state casseforme di pietra con riempimento costituito da pietrame e terra o da un nu-cleo in cementizio. In età più tarda, un’analoga struttura a cassoni si trova impiegataanche sulla banchina meridionale del porto di Antedone45, in Grecia, datata fra la finedel V e l’inizio del VII sec. d.C., in cui, però, l’opera cementizia è realizzata con l’im-piego di malta idraulica.
Per quanto riguarda l’ancoraggio novecentesco, il cui andamento a L è perfetta-mente leggibile nelle immagini aeree (fig. 19), sulla battigia si conserva un segmentodella banchina del primo tratto che in origine doveva trovarsi cm 70 più in alto rispet-to al livello del mare ed ora si trova insabbiato. A m 5 di distanza, l’antemurale moder-no è diviso in due tronconi (fig. 2), il primo lungo m 15 ed il secondo, ormai in fase dicrollo, di m 2.50; il muraglione è realizzato con una doppia cortina di blocchetti messiin opera su filari a giunti alternati, posti di taglio, con una serie di blocchi per testa chepenetrano a coda nella muratura. Il paramento verso il mare ed il coronamento, chequi non si è conservato, sono realizzati in calcarenite, mentre il paramento interno è dipietra calcarea compatta. Il muro poggia, come da progetto, su una berma di lastre incalcestruzzo, che in origine era almeno m 1.20 più alta rispetto al livello del mare, ad-dossata ad un gradonato di blocchi di grandi dimensioni, di cui si vedono, sott’acqua,almeno due filari. La difficoltà di riconoscere un modulo fisso per i grossi blocchisommersi (la larghezza varia da cm 80 a 120, la lunghezza da un minimo di m 1.90
TRA TERRA E MARE: RICERCHE LUNGO LA COSTA DI SAN CATALDO (LECCE) 123
41 POIDEBARD 1951, pp. 36-43.42 POIDEBARD 1951.43 DE GRASSI 1955; AURIEMMA 2004b.
44 ESPOSITO, FELICI, GIANFROTTA, SCOGNAMI-GLIO 2002.
45 SCHLÄGER, BLACKMAN, SCHÄFER 1968.
Fig. 18 - Schema ricostruttivo tridi-mensionale dell’articolazione strut-turale del molo romano. In alto, vi-sta da Nord-Est; in basso, vista daSud-Ovest. Elaborazione S. Mar-chi.
oscilla fino a m 3.00) fa pensare che si tratti di materiale di reimpiego, derivato conogni probabilità dallo spoglio del molo antico. Il rilievo delle strutture sommerse,inoltre, ha consentito di appurare la presenza di un allineamento di blocchi lungo ladirettrice che costituisce l’ideale prosecuzione del paramento settentrionale. Il filare,collocato m 1.50 sotto il l.d.m., visibile soltanto nelle giornate di maestrale e leggibilein foto aerea (fig. 19), disegna una leggera curva e presenta diciannove blocchi di lun-ghezza compresa fra m 2.10 e m 3, con larghezza costante di m 1.10 e spessore massi-mo di ca. cm 0.50. Un blocco collocato di testa dopo i primi cinque di taglio potrebbeattestare la conservazione di un’eventuale catena trasversale. Tuttavia, la pertinenza diquesto allineamento all’originaria struttura del molo è solo ipotizzabile.
Lungo il secondo tratto si osserva che la scarpata di blocchi, su cui si doveva im-postare l’antemurale, risulta scompaginata dalle sollecitazioni del moto ondoso ed at-tualmente si presenta come una serie di cinque corsi di blocchi di grandi dimensionifortemente sbandierati gli uni sugli altri. Il muraglione moderno, conservato alla testae fino al coronamento, si imposta su una platea di grandi blocchi giustapposti, vinco-lati in senso verticale da perni metallici. I blocchi presentano un modulo abbastanzaregolare, di m 1.80÷2.00x0.80x0.50, a conferma del fatto che sono stati confezionatiex novo per l’impiego nel nuovo molo.
S.M.
Osservazioni conclusive
La situazione attuale del molo di San Cataldo è, come si è visto, il residuo di in-tense vicissitudini, alcune delle quali di carattere naturale, sopravvenute alla program-matica opera di distruzione effettuata a più riprese in età moderna.
124 MARIANGELA SAMMARCO, SILVIA MARCHI
Fig. 19 - Immagine aereadell’area portuale. Il moloantico spicca dalla modernaPiazza Adriano e si proten-de in mare; sott’acqua sonoben evidenti i resti del pode-roso ancoraggio novecente-sco con il profilo a L (Archi-vio LabTAF).
La continuità d’uso dell’approdo fino ad oggi ha poi comportato la perdita di de-posito archeologico sui fondali anche a causa dei numerosi dragaggi effettuati per larealizzazione e manutenzione del nuovo porto; inoltre l’assenza totale di attività discavo, non solo dell’imponente molo romano ma dell’intera area portuale, ha provo-cato l’irreparabile cancellazione di informazioni relative a monumenti di epoche dif-ferenti.
Dall’indagine effettuata, finalizzata principalmente all’acquisizione di una com-pleta documentazione di quanto in passato non esaurientemente analizzato, non deri-vano direttamente elementi utili alla definizione di una cronologia assoluta del moloin opera cementizia. La definizione cronologica delle evidenze strutturali deriva es-senzialmente dal dato fornito dalle fonti (Paus. VI, 19, 9), che collocano in età adria-nea la sistemazione infrastrutturale del porto.
La recente proposta di datare ad età augustea l’organizzazione della città romanadi Lupiae e degli interventi edilizi di carattere monumentale46 potrebbe suggerire unasimile datazione anche per la strutturazione dell’impianto portuale, nell’ambito di uncomplesso programma di pianificazione urbana e territoriale. Inoltre, finora è stataacriticamente accettata l’esistenza di analogie strutturali tra il molo di San Cataldo el’anfiteatro di Lecce47 che ha conseguentemente portato ad associare la cronologia deidue monumenti; in realtà esiste una differenza sostanziale nell’impiego dei materiali,essendo stata riscontrata la presenza di pozzolana d’importazione nel nucleo dell’o-pera cementizia dell’edificio leccese48, evidentemente assente nel molo, come hannodimostrato le analisi effettuate su un campione di materiale49.
Ciò naturalmente non esclude la possibilità che i due edifici siano coevi, ma è pro-babile che si tratti di opere costruite da maestranze di formazione e tradizioni co-struttive differenti.
Come è stato evidenziato50, proporre una datazione in età augustea sulla base diqueste considerazioni è ipotesi assai suggestiva: la città romana nascerebbe con la suaarea pubblica, le aree di necropoli, la cinta muraria e il suo approdo. In realtà, la solapossibilità per accertare questa presunta unitarietà ed accettare una retrodatazione dioltre un secolo rispetto al dato offerto dalle fonti può derivare solo dallo scavo strati-grafico dei resti del molo.
Difatti il dato che proviene dall’ampio ambito cronologico in cui si collocano glielementi di confronto considerati non sembra poter confermare o scoraggiare la pro-posta di assegnare la struttura di San Cataldo alla prima metà del II sec. d.C. La solu-zione edilizia adoperata a San Cataldo, riconosciuta su vasta scala in numerose strut-ture del bacino mediterraneo riconducibili ad epoche diverse e che si discosta dai ca-noni vitruviani, deve essere stata fortemente condizionata dall’ampia disponibilità di
TRA TERRA E MARE: RICERCHE LUNGO LA COSTA DI SAN CATALDO (LECCE) 125
46 Sulle trasformazioni urbanistiche di Lecce v.GIARDINO 1994, GIARDINO et al. 2000, D’ANDRIA2004.
47 In assenza di una datazione assoluta, l’edificioda spettacolo è stato variamente datato tra l’età re-pubblicana e la metà del II secolo d. C. sulla basedi caratteristiche tecniche o per la presenza di ele-menti decorativi. Per l’analisi strutturale del mo-numento v. AMICI 1997.
48 Ibidem, p. 195.49 L’analisi delle sezioni sottili della malta impie-
gata nel molo in cementizio è stata effettuate daldott. Guido Ventura, dell’Istituto Nazionale diGeofisica e Vulcanologia di Roma, al quale si ri-
volge un sentito ringraziamento per la collabora-zione. I componenti della malta sono risultati dinatura molto eterogenea, con prevalenza di granu-li di rocce calcaree fossilifere, frammenti malaco-logici e granuli di quarzo e di minerali vulcanici(clinopirosseni) che presentano un elevato gradodi rimaneggiamento e arrotondamento, caratteri-stica che fa ipotizzare un lungo processo di tra-sporto fluviale. Si può ipotizzare che nell’impastosia stata utilizzata sabbia reperita in loco che, co-me gia evidenziato (v. infra), ha origine vulcanicaed ha subito processi di trasporto fluviale prima diraggiungere l’Adriatico.
50 AURIEMMA 2004a, p. 171.
pietra da taglio ed alla facilità di estrazione e di lavorazione del materiale lapideo, cheè risultato appartenere a litotipi locali reperibili in località prossime alla fascia costiera(v. Appendice).
Sebbene resti ancora aperta la definizione cronologica dell’organizzazione del si-stema portuale, appare invece chiaro che con l’intervento imperiale, attuato per assi-curare la protezione dai venti dei quadranti settentrionali ed orientali, e stimolare an-che i traffici «privati» con l’inserimento nelle rotte di cabotaggio delle produzioni lo-cali, l’insenatura sabbiosa fu dotata di un molo in muratura innestato nell’estremitàsettentrionale nella terraferma, a chiudere uno specchio d’acqua adeguato per le ma-novre di carico e scarico di imbarcazioni di piccolo tonnellaggio.
Dall’analisi strutturale, tuttavia, emerge l’unitarietà progettuale dell’impianto che,seppur non si possa escludere sia andato incontro a ristrutturazioni nel corso del tem-po, non sembra aver subito rimaneggiamenti sostanziali o modifiche radicali nellaconcezione complessiva. Hanno invece pesantemente danneggiato il molo antico gliinterventi attuati nei primi anni del Novecento per la realizzazione del nuovo anco-raggio: oggetto di spoglio sistematico sono stati i paramenti del molo antico, in parti-colare quello settentrionale, i cui blocchi sono stati reimpiegati nelle opere novecen-tesche.
Nell’ampia serie di interventi che si deve supporre abbiano avuto luogo nella radadi San Cataldo, la realizzazione dell’ancoraggio novecentesco costituisce soltantol’atto più recente e meglio documentato; tuttavia è quello che ha maggiormente in-fluito sulla ridefinizione topografica dell’intera area portuale e inciso sulla situazioneambientale di questo tratto di costa. Le opere per il nuovo porto, infatti, mai resofunzionante e ridotto presto allo stato di rudere51, hanno comportato la distruzionedi gran parte del molo antico senza, per altro, mai assolvere allo scopo per cui eranostate progettate. In seguito, la costruzione negli anni Trenta di cabine per bagnanti ela realizzazione a scopo bellico di bunker e di camminamenti di servizio hanno ulte-riormente contribuito a danneggiare la struttura antica, già di per sé particolarmenteesposta agli agenti eolici e sottoposta, nella parte a mare, ad un continuo processo dierosione dovuto all’azione marina.
La funzionalità del porto leccese nei secoli dell’antichità, come accennato, deveessere stata fortemente legata ad alcuni fattori, quali la capacità produttiva e ricettivadell’entroterra e la distribuzione degli insediamenti in stretto rapporto spaziale con lafascia costiera e con la viabilità a lunga percorrenza.
Il territorio compreso tra il porto antico e il centro interno di Lupiae è caratteriz-zato da una morfologia piatta ed omogenea interrotta solo da rialzi rocciosi isolatiche raggiungono appena i 44 m. s.l.m.
Alla luce dei dati che derivano da un’analisi preliminare dei dati nostro possesso,sembra che si vada delineando un quadro insediativo complesso ed articolato della si-tuazione storica del territorio, considerato nel suo sviluppo diacronico (fig. 1).
La documentazione relativa all’età preistorica non è molto consistente e riguardarinvenimenti sporadici di strumenti litici verosimilmente riferibili a momenti diversidel Paleolitico. Più ricca risulta invece la documentazione relativa all’età del Bronzo,periodo a cui risalgono alcuni insediamenti aperti di dimensioni piuttosto modeste,individuati in corrispondenza di limitati rilievi rocciosi. È interessante notare comeconsistenti aree di materiali a impasto siano state localizzate in toponimo Specchia
126 MARIANGELA SAMMARCO, SILVIA MARCHI
51 Nel 1906, in seguito ad un ingente fenomenodi accumulo di alghe imputato alla presenza dellanuova struttura muraria, evento che causò la chiu-sura durante la stagione balneare dello stabilimen-
to realizzato nell’anno precedente, parte del moloappena realizzato fu abbattuta intenzionalmenteproprio per incentivare il deflusso delle alghe ma-rine (PASIMENI 1989, p. 33).
dell’Alto e in toponimo Specchia Mezzana, dove però non si conserva traccia dei pos-sibili tumuli funerari in spezzoni di calcare localmente definiti “specchie”, segnalatiin letteratura52.
Mancano dati relativi all’età del Ferro e all’età Arcaica; in questo periodo l’inse-diamento più importante doveva essere quello di Lecce dove sono documentati pic-coli nuclei di capanne di VIII-VII sec. a.C.53.
Due sole aree (presso Masseria Ramanno e in loc. San Ligorio) erano probabil-mente occupate da piccoli insediamenti rurali di epoca messapica caratterizzati da unacontinuità d’occupazione nel corso della prima età repubblicana. Significativo perquesta fase è il rinvenimento di materiali riferibili ad impianti produttivi di anforebrindisine individuati presso Masseria Ramanno54, appena 2,5 km a O del porto anti-co e localizzati lungo il percorso viario di collegamento con la città.
É tra I sec. a.C. e I sec. d.C. che si registra un primo incremento nel numero degliinsediamenti che comincia a popolare l’ampia fascia di territorio limitrofo al centroantico di Lecce che si sviluppa verso est e nord-est, in direzione della costa adriatica.Si tratta di insediamenti in prevalenza di piccole dimensioni nei quali l’attività pro-duttiva sembra rivestire maggior rilievo. Nella gran parte degli insediamenti agricolidi prima età imperiale è stata registrata una ininterrotta continuità di vita fino all’etàtardo antica, e per alcuni di essi anche oltre, in età bizantina ed altomedievale, indi-cando dunque una certa vitalità agricola del territorio anche nei primi secoli del Me-dioevo. Come già nelle epoche precedenti, anche per l’età tardo antica si tratta di sitinon molto grandi, alcuni dei quali non sembrano raggiungere l’ettaro. Tra questi perdimensioni spicca quello nei pressi di Erchie, nel quale è documentata una continuitàdi occupazione dalla prima età imperiale fino ai secoli centrali del Medioevo, la cuiestensione complessiva supererebbe i 10 ettari.
Le carte diacroniche mostrano una fascia costiera e retrocostiera scarsamente po-polata, ad eccezione delle evidenze tardorepubblicane di loc. San Giovanni e dell’im-pianto portuale di San Cataldo; ampi settori di campagna privi di insediamenti che inetà romana dovettero restare incolti se non addirittura inutilizzati, si alternavanodunque ad aree assai fittamente popolate55.
Per quanto riguarda la viabilità antica, la ricostruzione di alcuni tracciati si basanosul rinvenimento di tratti di carraie, di incerta cronologia, e sul percorso dei vecchiassi stradali riportati nella cartografia ottocentesca56. Nell’area indagata si registra co-munque una generale continuità d’uso dei percorsi, profondamente legata alla morfo-logia del territorio, ed è pertanto verosimile che molte delle strade presenti nella pri-ma levata IGM del 1874 per la maggior parte oggi in disuso e ridotti a percorsi dicampagna, ricalchino assi viari antichi, essendo spesso in stretto rapporto con le evi-denze archeologiche. Il principale asse stradale che attraversava il territorio, del qualesono state riconosciute ampie tracce, è la via di collegamento tra l’abitato di Lecce e
TRA TERRA E MARE: RICERCHE LUNGO LA COSTA DI SAN CATALDO (LECCE) 127
52 DE GIORGI 190553 GIARDINO et al. 200054 VALCHERA, ZAMPOLINI FAUSTINI 1997, pp.
151-15455 Allo stato attuale delle conoscenze, per il ter-
ritorio salentino risulterebbe una eccessiva forza-tura proporre una ricostruzione del paesaggio inetà romana, sebbene non sia difficile immaginareil territorio caratterizzato principalmente da pian-tagioni olearie e vinarie e, forse in maniera nonpoco consistente, dal pascolo. La poche fonti di-sponibili sono concordi nell’indicare almeno a
partire dal basso Medioevo la presenza di acqui-trini nella fascia retrocostiera, sfruttati per la pescae la raccolta di piante erbacee.
56 La difficoltà nell’individuazione degli assi via-ri antichi costituisce un problema generale pertutto il Salento, considerate anche le caratteristi-che costruttive di questi tracciati; essi, infatti, ge-neralmente non erano lastricati, ma in terra battu-ta oppure utilizzavano come fondo il banco roc-cioso affiorante, dove i solchi prodotti dal passag-gio dei carri non sono oggi sempre visibili.
lo scalo costiero di San Cataldo. Altri percorsi stradali si diramavano a raggiera dal-l’abitato antico, uscendo dalle porte aperte lungo la cinta muraria, mentre vari trac-ciati si sviluppavano in direzione SE per raggiungere la costa e la laguna delle Cesine.
In età medievale prosegue l’utilizzo dello scalo portuale di San Cataldo, testimo-niata dal ritrovamento di anfore medievali57, e di un’iscrizione funeraria di XIII-XIVsecolo58; ad oggi non possediamo chiare testimonianze archeologiche di un rafforza-mento o di un suo possibile sviluppo in età bizantina e sotto i Normanni, mentre nel-le fonti cartografiche e nei portolani medievali San Cataldo è indicato come uno deipunti d’approdo della costa leccese, ma non doveva essere dotato di rilevanti infra-strutture portuali, come testimoniano fonti documentarie d’età angioina: in un docu-mento del re Roberto d’Angiò datato al 1339 viene specificato che San Cataldo «nonera un porto ma una piccola rada»59; la sua funzionalità è attestata ancora in un Liberperegrinationis in cui si narra dello sbarco nel porto di San Cataldo avvenuto nel 1395da parte di un gruppo di pellegrini di ritorno dalla Terra Santa60. Fu probabilmentetra la fine del XIV e gli inizi del secolo successivo che lavori di riadattamento del lito-rale e l’edificazione di una torre61 determinarono una nuova fase di sviluppo per ilporto, conseguenza dell’incremento demografico della città di Lecce e della riorga-nizzazione economica del territorio62.
M.S. S.M.
Appendice litostratigrafica
Sono stati analizzati dal punto di vista litologico i blocchi costituenti il molo di SanCataldo. Essi sono risultati tutti attribuibili all’unità miocenica della Pietra leccese.
Questa unità affiora ampiamente, con andamento NW-SE, nei settori centro-occi-dentale e meridionale dell’area di Lecce, dove attualmente è molto estesa l’urbanizza-zione. Con lo stesso andamento ma di entità più limitata, sono gli affioramenti delsettore sud – orientale; quello più esteso di questi è messo a nudo dall’erosione delleCalcareniti di Andrano nell’anticlinale di Acaia63.
Nella sua tipica e più diffusa espressione, la Pietra leccese si presenta come unabiomicrite a prevalenti foraminiferi planctonici, più o meno compatta e friabile, a gra-na fine, talora marnosa, di colore giallo-paglierino. La stratificazione, mal definibile,appare in banchi che superano il metro di spessore; solo eccezionalmente essa è benmarcata per la presenza di livelli meno competenti e più o meno marnosi, spessi da 20a 30 cm. I fossili (in prevalenza pettinidi ed echinoidei) sono ricorrenti anche se spar-si; talvolta risultano frequenti le bioturbazioni a prevalente andamento orizzontale.
Nei 5-6 metri inferiori la Pietra leccese è molto compatta, tenace, di aspetto cri-stallino, di colore variabile dall’avana chiaro all’avana scuro o al grigio-nocciola, con
128 MARIANGELA SAMMARCO, SILVIA MARCHI
57 AURIEMMA 2004a, pp. 61-62 n. 6458 GUILLOU 1996, p. 173 n. 16059 MASSARO 1993, p. 251 e nota 360 MASSARO 2006, p. 14761 Risulta erronea la notizia, perdurata a lungo
negli scritti sul porto antico, di un intervento edi-lizio promosso dalla regina angioina Maria d’En-ghien per la realizzazione di una «ingentem mo-lem longis iunctam lapidibus miro opere» cheavrebbe inglobato la struttura romana. Nella do-cumentazione d’archivio a noi nota non comparealcuna menzione della costruzione di un nuovo
molo né esistono riferimenti relativi ad una possi-bile sistemazione di quello preesistente, operazio-ne che avrebbe comportato una ingente spesa didenaro di cui sarebbe sicuramente rimasta traccianei registri angioini. l’impresa di Maria d’Enghiennon deve dunque aver riguardato la costruzione diun molo bensì il restauro del «castello guarnito dimonitioni», con cui si indicava la torre costierapreesistente distrutta da una mina inglese agli inizidel XIX secolo.
62 MASSARO 1993, p. 257.).63 BOSSIO et al., 2006
tonalità spesso rosate o verdastre; essa mostra inoltre, per i primi 20-30 cm, sparsi no-duletti fosfatici e, talora, balanidi, pettinidi e piccoli denti di pesci. Nella porzione su-periore la formazione assume un contenuto leggermente glauconitico e, per alcunimetri, conserva un colore giallo ma con “picchiettature” verdi scure; diviene quindibruscamente ed estremamente ricca di granuli di glauconite, assumendo di conse-guenza una colorazione verde intenso, oltrechè una manifesta friabilità (questa varietàprende il nome di “piromafo”). Il contatto tra il sedimento intensamente glauconiticoe quello sottostante “picchiettato” ha un andamento irregolare e ondulato; questo an-damento è accentuato dallo sviluppo verso il basso di infiltrazioni più o meno estese,le quali appaiono come tasche o plaghe verdi nelle sezioni verticali. Oltre a numerosinoduletti fosfatici di dimensioni millimetriche fino a 2-3 cm, al contatto si rinvengo-no frequenti fossili (in particolare Neopycnodonte, Amusium, Flabellipecten; presen-ti anche modelli fosfatizzati di gasteropodi, pteropodi, bivalvi, brachiopodi e resti divertebrati). La loro concentrazione costituisce un caratteristico livello, spesso da 10 a50 cm, indicato dai locali cavatori come “linea delle cozze”. L’intervallo molto riccoin glauconite è spesso circa 2 m; al suo interno i fossili si rarefanno sempre più versol’alto.
Nelle aree della fascia orientale della Penisola Salentina, da Otranto a S. Mariadi Leuca, con le biomicriti glauconitiche termina la Pietra leccese; direttamente suqueste ultime, infatti, giacciono le Calcareniti di Andrano64. Nell’area di Lecce que-sta situazione è osservabile dalla periferia settentrionale dell’abitato verso Nord enella fascia più orientale (ad esempio, negli affioramenti di Mass. Ospedale a Norde di Acaia e Struda a Est). Nel settore meridionale, invece, al di sopra dei sedimentiglauconitici è presente un deposito (con strati di 20 – 30 cm di spessore) solo ini-zialmente simile alla tipica Pietra leccese. In esso la litologia diviene gradualmenteverso l’alto a grana media, passando da un colore avana chiaro (con locali concen-trazioni di Neopycnodonte, Amusium, Chlamys, Flabellipecten, nonchè con rarebioturbazioni e sparsi granuli di glauconite), ad uno giallo-ocra (ricca in bivalvi, ge-neralmente modelli, diversi da quelli del sottostante intervallo). Sulla base delle os-servazioni di superficie e del sottosuolo, lo spessore massimo della Pietra leccesenon supera gli 80 m.
Le varietà sopra descritte sono ben documentabili anche dall’analisi dei blocchiimpiegati nella struttura del molo di San Cataldo. Sono state analizzate le caratteristi-che litologiche di 119 blocchi. Quelli costituenti la base della struttura sono caratte-rizzati da una biomicrite compatta di colore giallastro con sparsi fossili (in prevalenzalamellibranchi e rari granuli di glauconite). Questi blocchi (costituiscono il 37% deiblocchi analizzati) sono coperti da altri (13% del totale) che sono composti da calca-reniti bianco-verdastre per la presenza di glauconite. I fossili sono comuni e disposticasualmente. I blocchi che costituiscono la parte superiore del molo sono invece ca-ratterizzati da una calcarenite verdastra (denominata piromafo e costituente quindi il50% dei blocchi analizzati) per la presenza di abbondante glauconite: i granuli sonoin più luoghi concentrati in lenti che così assumono colorazione più scura. I fossilisono frequenti a luoghi a costituire veri e propri livelli (tra questi molto frequenti i la-mellibranchi già descritti e che comunemente caratterizzano questo intervallo). Sonostate osservate anche buioturbazioni.
È evidente che i blocchi di roccia provengono dagli affioramenti di Pietra leccesepresenti nelle aree limitrofe il molo. Analisi biostratigrafiche integrate con altre ar-cheologiche sono in corso per stabilire l’esatta provenienza dei blocchi stessi.
TRA TERRA E MARE: RICERCHE LUNGO LA COSTA DI SAN CATALDO (LECCE) 129
64 BOSSIO et al., 1989, 1991, 1994, 1997.
Per quanto riguarda l’opus caementicium, questo è costituito da calcari detriticipiù o meno friabili, con grana da fine a grossolana, di colore grigio fino al giallo chia-ro con ricorrenti fossili (soprattutto pettinidi e ostreidi) e da calcari compatti micriticidi colore scuro. Queste litologie sono chiaramente attribuibili all’unità della Forma-zione di Uggiano La Chiesa di Bossio et al. (2006)65 ed affiorano diffusamente nelleimmediate vicinanze del molo costituendone peraltro il basamento litologico.
St.M.
BIBLIOGRAFIA
J.P. ADAM, L’arte di costruire presso i Romani, Milano 1990.L. ALVINO, Rilevamento costiero ed interpretazione idrodinamica dei sedimenti recenti lungo
un tratto del litorale di S. Cataldo di Lecce, in “Terra d’Otranto”, XVIII, 7-12, 1974, pp. 1-44.
C. AMICI, Iter progettuale e problemi architettonici dell’anfiteatro di Lecce, in “Metodologiedi catalogazione dei beni archeologici, in Beni Archeologici Conoscenze e TecnologieCNR-Università di Lecce, Quaderno 1.2”, Lecce-Bari 1997, pp. 181-198.
M. ANZIDEI, A. BENINI, K. LAMBECK, F. ANTONIOLI, A. ESPOSITO, L. SURACE, Siti archeolo-gici costieri di età romana come indicatori del livello del mare: un’applicazione al mare tir-reno (Italia centrale), in “Evolución paleoambiental de los puertos y fondeaderos antiguosen el Mediterráneo occidental, I seminario” (Alicante 14-15 novembre 2003), Soveria Man-nelli 2004, pp. 115-126.
R. AURIEMMA, Salentum a Salo. Porti, approdi, rotte e scambi lungo la costa adriatica salenti-na, Galatina 2004.
R. AURIEMMA, I porti romani dell’Istria. Una nuova ricerca a 50 anni dagli studi di AttilioDegrassi, in “L’archeologo subacqueo”, X, 2 (29), Maggio – Agosto 2004, pp. 8-14.
M. BERNARDINI, Panorama archeologico dell’estremo Salento, Trani 1955.A. BOSSIO, F. GUELFI, R. MAZZEI, B. MONTEFORTI, G. SALVATORINI, Studi sul Neogene e
Quaternario della Penisola Salentina. III - Stratigrafia del Pozzo Poggiardo (N. 54, PS1490/3), in “Atti del Convegno di Studi sulle conoscenze geologiche del territorio salenti-no”. Quaderni Centro Studi di Geotecnologie d’Ingegneria, 11, Lecce 1989, pp. 55-88.
A. BOSSIO, F. GUELFI, R. MAZZEI, B. MONTEFORTI, G. SALVATORINI, Note geologiche e strati-grafiche sull’area di Palmariggi (Lecce, Puglia), in “Rivista Italiana di Paleontologia e Stra-tigrafia”, 97 (2), 1991, pp. 175-234.
A. BOSSIO, F. GUELFI, R. MAZZEI, B. MONTEFORTI, G. SALVATORINI, La successione miocenicadell’area tipo delle Calcareniti di Andrano (Puglia, Italia Meridionale), in “Bollettino dellaSocietà Paleontologica Italiana”, 33 (2), 1994, pp. 249-255.
A. BOSSIO, L. FORESI, S. MARGIOTTA, R. MAZZEI, B. MONTEFORTI, G. SALVATORINI, Cartageologica del settore nord-orientale della Provincia di Lecce, Lecce 1999.
A. BOSSIO, L. FORESI, S. MARGIOTTA, R. MAZZEI, B. MONTEFORTI, G. SALVATORINI, , F. DO-NIA,. Stratigrafia neogenico-quaternaria del settore nord – orientale della Provincia di Lec-ce (con rilevamento geologico in scala 1:25.000), in “Geologica Romana”, 39, 2006, pp. 16-29.
F. CARTELLI, S. Cataldo di Lecce 1833-1981, Novoli 1981.G. CERAUDO, F. ESPOSITO, Strutture sommerse a San Cataldo (Le), in “Atti del Convegno
nazionale di archeologia subacquea” (Anzio 30-31 maggio e 1 giugno1996), Bari 1997, pp.241-244.
R. CONGEDO, Mare, pesca e archeologia, in “La Zagaglia”, 1959, pp. 47-50.
130 MARIANGELA SAMMARCO, SILVIA MARCHI
65 BOSSIO et al 2006.
R. CONGEDO, Le vicende storiche nel mare di Lecce attraverso l’archeologia sottomarina, in“La Zagaglia”, 1960, pp. 42-53.
R. CONGEDO, Salento scrigno d’acqua, Martina Franca 1984.G. COTA, L’antico porto di S. Cataldo. Studio tratto da atti e documenti, Lecce 1936.F. D’ANDRIA, Una nuova “lettura” di Lecce: il contributo delle recenti ricerche, in M. DI STE-
FANO (ed.), Lecce. Riqualificazione e valorizzazione ambientale architettonica e archeologi-ca del centro storico, Roma 2004, pp. 57-62.
A. DE FERRARIS GALATEO, Liber de Situ Iapygiae, Basilea 1558 (ristampa Galatina 1974).C. DE GIORGI, La Provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio, II, Lecce 1888 (ristampa Galatina
1975).C. DE GIORGI, Le specchie in Terra d’Otranto, in “Rivista Storica Salentina”, II, 7-8 e 11,
1905, pp. 313-334 e 481-513.C. DE GIORGI, La voce del mare: poche parole dette agli alunni della II classe dell’Istituto
Tecnico di Lecce sulla spiaggia di S. Cataldo sull’Adriatico il 17 maggio 1913, Lecce 1913.A. DE GRASSI, I porti romani dell’Istria, in “Anthemon. Scritti in onore di C. Anti”, Firenze
1955, pp. 119-169.L.G. DE SIMONE, Lecce e i suoi monumenti, I, Lecce 1874 (ristampa Lecce 1964).F. ESPOSITO, E. FELICI, P.A. GIANFROTTA, E. SCOGNAMIGLIO, Il porto di Kyme, in “ASu-
bacq”, III, Roma 2002, pp. 1-37.E. FELICI, Costruire nell’acqua: i porti antichi, in M. Giacobelli (ed.), Lezioni Fabio Faccenna.
Conferenze di archeologia subacquea (I e II ciclo), Bari 2001, 161-178.A.E. FOSCARINI, San Cataldo «Porto et maritima» di Lecce, Lecce 1984.L. GIARDINO, Per una definizione delle trasformazioni urbanistiche di un centro antico attra-
verso lo studio delle necropoli: il caso di Lupiae, in “StAnt”, 7, 1994, pp. 137-203.L. GIARDINO, P. ARTHUR, G.P. CIONGOLI, Lecce. Frammenti di storia urbana. Tesori archeo-
logici sotto la banca d’Italia, Bari 2000.A. GUILLOU, Recueil des inscriptions greques médiévales d’Italie, Roma 1996.R. GINOUVÈS, R. MARTIN, Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romaine, I,
Parigi 1985. I. LAUDISA, Ritratto di una città. Storia della fotografia leccese dell’Ottocento, Manduria
1995.K. LEHMANN HARTLEBEN, Die antiken Hafenanlagen des Mittelmeeres, in „Klio Beiheft“,
XIV, Leipzig 1923.M. MAINARDI, L’Acqua marcia. Le paludi nel Salento tra Ottocento e Novecento, Lecce 1988.M. MAINARDI, Un progetto di rimboschimento per S. Cataldo: da un carteggio di Cosimo De
Giorgi (1898), in M. MAINARDI (ed.), I boschi nel Salento. Spazi e storia, Lecce 1989, pp.57-65.
M. MAINARDI, Prime progettualità depaludistiche in Terra d’Otranto. La bonifica di S. Catal-do (1855-1861), in “Annali del Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofiche e Geografichedell’Università di Lecce, Studi in onore di D. Novembre”, IX-XII, 1992-1993, 1995-1996,Manduria 1997, pp. 807-846.
G. MARCIANO, Descrizione, Origini e Successi della Provincia d’Otranto, Napoli 1855.C. MASSARO, Territorio, società e potere, in B. VETERE (a cura di), Storia di Lecce. Dai Bizan-
tini agli Aragonesi, Bari 1993, pp. 251-344.C. MASSARO, Economia e società in una «quasi città» del Mezzogiorno tardomedievale: San
Pietro in Galatina, in A. CASSIANO, B. VETERE (a cura di), Dal Giglio all’Orso. I Principid’Angiò e Orsini del Balzo nel Salento, Galatina 2006, pp. 147-193.
G. MASTRONUZZI, G. PALMENTOLA, P. SANSÒ, Osservazioni sulle caratteristiche fisiografichedei litorali del Salento meridionale, in “Atti del Convegno sulle conoscenze geologiche delterritorio salentino”. Quaderni Centro Studi di Geotecnologie d’Ingegneria, 11, Lecce1989, pp. 223-241.
G. MASTRONUZZI, P. SANSÒ, L’evoluzione costiera dell’area di Torre Canne – T. S. Leonardo,in G. MASTRONUZZI, P. SANSÒ (eds.), Variazioni tardo-quaternarie del livello del mare edevoluzione della fascia costiera. Atti del Workshop (Ostuni 30-31 maggio 2002), Bari 2002,pp. 53-59.
G. PALMENTOLA, Lineamenti geologici e morfologici del Salento leccese, in “Atti del Conve-
TRA TERRA E MARE: RICERCHE LUNGO LA COSTA DI SAN CATALDO (LECCE) 131
gno sulle conoscenze geologiche del territorio salentino”. Quaderni Centro Studi di Geo-tecnologie d’Ingegneria, 11, Lecce 1989, pp. 7-23.
J. PARIS, Contribution à l’étude des ports antiques du mond grec. Notes su Lechaion, in BCH,39, 1915, pp. 5-16.
C. PASIMENI, Il tram del mare, Lecce 1998.A. POIDEBARD, Sidon. Aménagements antiques du port de Saida. Étude aérienne, au sol, et
sous-marine, 1946-1950, Beyrouth 1951.P. A. PUTIGNANI, R. CONGEDO, Carta archeologica sottomarina del Salento, Manduria 1964.P. ROCKWELL, Lavorare la pietra, Roma 1989.M. SAMMARCO, S. MARCHI, Il porto antico di San Cataldo (Lecce): indagini tradizionali e
nuove metodologie per uno studio topografico, in Archeologia Aerea. Studi di Aerotopogra-fia archeologica, III, 2008, pp. 147-176.
H. SCHLÄGER, D. J. BLACKMAN, J. SCHÄFER, Der Hafen von Anthedon, in AA, I, 1968, pp.21-98.
A. VALCHERA, S. ZAMPOLINI FAUSTINI, Documenti per una carta archeologica della Pugliameridionale, in Metodologie di catalogazione dei beni archeologici. Beni Archeologici Co-noscenze e Tecnologie CNR-Università di Lecce, Quaderno 1.2, Lecce-Bari 1997, pp. 103-158.
132 MARIANGELA SAMMARCO, SILVIA MARCHI