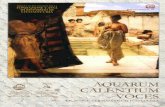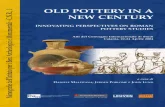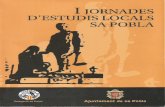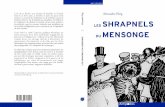Rev. F. Bourriot, Kalos Kagathos - Kalokagathia. D'un terme de propagande de Sophistes à une notion...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Rev. F. Bourriot, Kalos Kagathos - Kalokagathia. D'un terme de propagande de Sophistes à une notion...
Volume 126 1998, fascicolo 3
RIVISTA DI FILOLOGIAE DI ISTRUZIONE CLASSICA
e. bello doppoil morire vivere.
ancbora.:
1998LOESCHER EDITORE
TORINO
314 RECENSIONI
infatti spesso «sono proprio le comari quelle che intervengono come aiu-tanti della madre in travaglio» (333), oppure di volta in volta quello di'zia', 'cugina', 'nuora', 'cognata' (si pensi al greco yaÀ.'ij, affine yaÀ.Olç,con cui si designava la 'sorella del marito'), tutte figure femminili com-pagne abituali della sposa (338 sgg.); in qualche caso la donnola vienechiamata 'zitella', con chiara allusione alla figura della levatrice che indiverse culture «si connotava come donna nubile" (329). E quale 'sposamancata' la donnola è ora compatita e derisa, ora temuta «come unaparente vergine e inacidita, quando in casa c'è una ragazza che si spo-sa e i doni sono ammucchiati nella stanza» (328). A confermarlo sonoalcune curiose canzoncine dialettali italiane con funzione propiziato-ria, con cui si promette alla donnola un marito se risparmierà le gal-line del pollaio (327): un ulteriore tratto dell'ambiguità che contraddi-stingue l'animale (gli stessi nomignoli con cui viene designatopotrebbero essere del resto altrettante spie del timore che si nutre perquesto come per altri animali nocivi, 235 sg.).
In questo straordinario universo B. si addentra coniugando filo lo-gia e antropologia, storia naturale e folclore, sempre con la capacità diavvincere chi legge, di guidarlo con mano sapiente alla scoperta di nonsospettate relazioni fra cose ed eventi. È una storia lunga quella nar-rata da B. (e di necessità sacrificata in questo rapido resoconto), lungama non prolissa: non c'è nulla che si vorrebbe togliere come non c'ènulla che si sarebbe in grado di aggiungere. Una sola nota di lettura,per concludere. A proposito dell'umanizzazione o 'disnificazione' deglianimali è senz'altro vero che oggi va di moda imporre nomi «dichiara-tamente umani» agli animali di casa, ma forse non è altrettanto sicuroche si tratti di una «pratica che sarebbe risultata bizzarra o addirittu-ra censurabile fino a qualche decennio fa» (220). Mi viene in mente, p.es., tanto per non uscire dall'ambito della letteratura, che il gatto dicasa Raquin si chiamava François.
PIERGIORGIO PARRONI
FÉLIX BOURRIOT, Kalos Kagathos - Kalokagathia. D'un terme de pro-pagande de Sophistes à une notion sociale et philosophique. Étu-de d'Histoire athénienne. L Texte, II. Notes (Spudasmata, Bd. 58).Hildesheim - Zùrich - New York, Georg Olms Verlag 1995, pp. VI,
654,626.
Questa poderosa monografia è dedicata all'analisi della questionedell' origine e del significato della ben nota espressione greca KaÀ.ÒçKàyae6ç, la quale, contrariamente a quel che si potrebbe ritenere, nonè stata in realtà oggetto di molti e approfonditi studi, pur essendo spes-so citata dagli antichisti. Il primo lavoro monografico risale infatti al1930, ad opera di J. J'ùthner (Kalokagathia, in Charisteria A. Rzach,Reichenberg 1930, 99-119), seguito da un articolo di J. Berlage (De vi
BOURRIOT : COLESANTI 315
et usu vocum IWÀÒç K:àya(}6ç, K:aÀoK:àya(}{a, «Mnemosyne» n. sr. 60, 1933,20-40); di grande importanza, tra gli altri poco numerosi saggi dedica-ti alla questione, è la dissertazione di H. Wankel (Kalos kai agathos,Diss. Wiirzburg 1961, ried. New York 1979), che ha avuto il merito disegnalare, in un apposito indice (135-147), un grandissimo numero dipassi in cui ricorre questa espressione, da Omero fino al IV sec. a. C.;gli ultimi lavori di rilievo sono stati un saggio di W. Donlan (The Ori-gin of mÀòç K:àya(}6ç, «Am. Journ. Phil.» 94, 1973,365-374) e uno di K.J. Dover (Greek Popular Morality in the Time of Platon and Aristo-tle, Oxford 1974, 41-45: The Expression kalos kagathos).
Il lavoro di B. si può dividere in quattro sezioni ben precise. In unaprima parte (13-96), dopo aver introdotto brevemente il problema e averricordato i pochi studi precedenti (1-11), egli ci presenta una rassegnastoriografica, molto ben curata e pregevole, nella quale ricorda i varimodi in cui KaA.òçKàyae6ç è stato inteso, a partire dal mondo romanodel I sec. a. C. fino all'attuale XX secolo, riconoscendo tre fasi in que-sto lungo lasso di tempo. Innanzitutto c'è stato il passaggio del termi-ne dal mondo ellenistico a quello romano, dove è stato tradotto soltan-to con bonus, e non anche con pulcher, cosi come farà anche EnricoStefano (1572); la spiegazione di B., non molto convincente, è che i Ro-mani avrebbero soppresso KaÀ.6çperché non avevano della bellezza lastessa alta opinione dei Greci, preferendole la forza (14; 94). Una se-conda fase si ha invece nel XIX secolo, in cui si recupera KaÀ.6ç,e l'e-spressione KaA.òçKàyae6ç viene intesa come una delle tante definizionidei nobili. La terza fase si ha invece tra il XIX e il XX secolo, constudi appositamente dedicati al KaÀòçKàyae6ç, siano essi brevi sezionidi vaste opere, o piuttosto lavori monografici.
In quest'ultimo periodo si evidenziano due posizioni sull'antichitào meno di questa espressione: all'antica teoria dell'esistenza della de-finizione nobiliare di KaÀoìKàyaeol già in Omero, condivisa fino a quelmomento da tutti, e fatta propria in seguito anche da Wankel, si op-pone ora Jiithner, che nota come il nesso sia attestato per la prima vol-ta soltanto intorno alla metà del V secolo a. C., e afferma che solo daquesta data in poi, più o meno, si deve parlare di KaA.òçKàyae6ç.In precedenza, infatti, a partire da Omero, era solo e soltanto àyae6çil termine che designava il nobile; ad un certo punto, però, per imutamenti avvenuti nella società greca, il prestigio dei nobili si sa-rebbe trovato in declino, e il termine àyae6ç non sarebbe stato più ingrado di indicare compiutamente l'eccellenza della classe nobiliare; inobili allora vi avrebbero aggiunto KaÀ.6çcreando per sé, appunto, lanuova definizione di KaA.òçKàyae6ç, che conferiva loro nuovo prestigio,indicandone la supremazia fisica e morale. Donlan, che riprende que-sta teoria, precisa che le condizioni per il cambiamento del titolo no-biliare vi sarebbero già state verso la fine del VI secolo (la prova sa-rebbe Theogn. 933 sg., in cui si parla di àpE't'Ì]Kaì KUÀÀoç),e chel'aggiunta ad àyae6ç proprio di KaÀ.6ç,invece di un qualsiasi altro ter-
316 RECENSIONI
mine, dipenderebbe dal fatto che la bellezza era un privilegio deinobili.
B., come ci dice nella seconda sezione del suo lavoro (97-111), nellaquale discute di questioni preliminari, ritiene anch'egli che si debbaparlare di KaAòçKàyae6ç soltanto a partire dalla metà del V secoloa. C., perché a quel periodo, piti o meno, risalgono le più antiche atte-stazioni (104). Wankel aveva segnalato dei casi di unione di àyae6ç eKaÀ6çal comparativo e superlativo in Omero, Tirteo e Semonide amor-gino, ma B. vede in essi delle semplici unioni dei due aggettivi nel loroproprio significato, che non avrebbero niente a che fare con KaAòçKà-yae6ç (104 sg.). Per B., infatti, KaÀòçKàyae6ç costituisce una categoriaa parte, un'associazione irreversibile in cui KaÀ6çnecessariamente pre-cede, e àyae6ç deve seguire (101); questa affermazione viene sostenutasulla base di una testimonianza del grammatico di II secolo a. C. El-ladio (apud Phot. bibl. 529 b32-33), che sosteneva che gli Attici diconoKaÀòçKaì àyae6ç ma non àyaeòç Kaì KaÀ6ç. Questa per B. è la prova del-la particolarità di KaAòçKàyae6ç, che non sarebbe riconducibile alla sem-plice unione dei due normali aggettivi; i casi di àyaeòç Kaì KaÀ6çche siritrovano in Platone sono a suo dire la classica eccezione che confermala regola (ibid.). Inoltre, sulla base di quanto dice la Suda s. v. KaÀòçKàyae6ç (ÀÉyE'tatKa'tà cruvaÀot<j>11V,OÙXìKaAòçKaì àyae6ç), egli ritiene cheKaAòçKàyae6ç, in virtù della crasi, costituisca un nesso ben più saldodi un semplice accostamento di KaÀ6ç a àyae6ç (102), e arriva a fareesplicitamente una distinzione tra KaAòçKàyae6ç da una parte e KaAòçKaì àyae6ç dall'altra, sostenendo, sulla base delle ricorrenze delle dueforme (la prima sarebbe attestata sette volte di più dell'altra in riferi-mento agli uomini), che ogni espressione ha una sua propria coloritu-ra, e che l'impiego dell'una o dell'altra, cioè l'unione per crasi o perKai, non è indifferente (107-109).
Un altro punto che B. tiene a sottolineare è che KaAòçKàyae6ç nonsi potrebbe usare al femminile. La donna, infatti, sulla base delle no-stre attestazioni, viene definita KaÀ~Kàyaelj solo in contesti comici (Eup.109 K. - A., Canthar. 5 K. - A.), e non altrove, come ad es. nell'Econo-mico di Senofonte, dedicato a quello che deve essere il modello di KaÀòçKàyae6ç; questo fatto, a suo giudizio, non sarebbe casuale, ma vorreb-be dire, come l'eccezione della commedia confermerebbe, che la donnanon può essere definita KaÀ~Kàyael] appunto perché è una donna. L'ap-plicazione di KaAòçKàyae6ç al femminile, insomma, non suonerebbe benealle orecchie dei Greci (108 e n. 43; 346 sg.; 497). B. opera tra l'altrouna distinzione di uso tra gli aggettivi KaÀ6çe àyae6ç nel nesso con era-si riferito agli uomini, e gli stessi aggettivi riferiti alle cose, dove si do-vrebbe vedere soltanto il semplice accostamento di KaÀ6ça àyae6ç (107sg.), o anche la banalizzazione e lo svilimento del nesso KUAòçKàyae6ç(228; 349 sg.).
Nella terza sezione (113-252) B. enuncia la propria teoria sull'origi-ne e sul significato di KaÀòçKàyae6ç; qualunque sia il giudizio che ognu-
BOURRIOT : COLESANTI 317
no può darne, essa indubbiamente costituisce una novità nel campo de-gli studi su questa espressione.
Le più antiche attestazioni del nesso risalgono, a suo dire, al V se-colo, e sono Herodot. 1, 30, 4 KaÀ.oi'tEKàya80i(i figli di Tello); 2, 143,4 KaÀ.ÒçKàya86ç(il piromis dell'Egitto), e Aristoph. Dait. 1Cassio =205 K. - A., v. 8, in cui ricorre l'astratto KaÀ.oKàya8ia,attestato qui perla prima volta. B. si fonda su questo passo di Aristofane, in cui ci siriferisce ad Alcibiade come ad uno di coloro che praticano la KaÀ.oKà-ya8ia, per dire che proprio Alcibiade deve essere stato colui che ha lan-ciato ad Atene la moda di dire e di definirsi KaÀ.ÒçKàya86ç,subito imi-tato da altri giovani dell'epoca (214; 218). Alcibiade, però, avrebberipreso questo termine da Sparta, città con cui sia lui sia la sua fami-glia avevano stretti legami (215 sg.), secondo B., infatti, KaÀ.ÒçKàya86çsarebbe stato un termine militare spartano (178), come testimoniereb-be Thuc. 4, 40, 2 (172), applicato ai perieci dell' armata, secondo quan-to dice Xen. Hell. 5, 3, 8-9 (174 sg.). Una volta introdotto da Sparta adAtene intorno al 430 circa, ad opera di Alcibiade, KaÀ.ÒçKàya86çsarebbestato poi assunto dai sofisti, i quali ne avrebbero fatto un termine del-la loro propaganda: essi, cioè, si sarebbero definiti KaÀ.oìKàya8oi,e avreb-bero promesso ai loro allievi di renderli tali (219-223). La prova di que-sto sarebbe Aristoph. nub. 101, in cui vengono definiti appunto KaÀ.oìKàya80iSocrate e Cherefonte (219), che poi accolgono alla loro scuola ilKaÀ.òçKàya86ç(nub. 797) Fidippide (159). Insomma, KaÀ.ÒçKàya86çde-signerebbe un giovane allievo dei sofisti, ardito e carrierista come Al-cibiade, anzi amico di Alcibiade e suo sostenitore politico, all'internodi un gruppo di giovani, di varia estrazione, che aveva come obiettivola conquista del potere, e che si contrapponeva, come un terzo partito,agli schieramenti aristocratico e democratico (181 sg.; 184 sg.; 187); talisarebbero, ad es., i KaÀ.oìKàya80idi Aristoph. vesp. 1256, e ancora algruppo di Alcibiade apparterrebbero i KaÀ.oìKàya80idi Thuc. 8, 48, 6,come anche i Caristi KaÀ.oìKàya80idi Aristoph. Lys. 1059, assassini prez-zolati che avrebbero fiancheggiato Alcibiade e i suoi (190). Ma dopo il411 KaÀ.ÒçKàya86çperderebbe questo significato, per divenire una de-finizione dei nobili al posto del vecchio àya86ç. B. fa questa afferma-zione fondandosi su Xen. Hell. 2, 3, 19, dove, in un discorso tenuto daTeramene in occasione di una riunione dei Trenta nel 404, i ~ÉÀ.'tlcr'tOl'trov1tOÀ.l'troVvengono appunto definiti KaÀ.oìKàya80i(241); a detta di B.,infatti, dopo il 411 la 'prima generazione' di KaÀ.oìKàya80isarebbe qua-si scomparsa del tutto, e il termine, perduta la connotazione 'snob' chead esso conferivano Alcibiade e i suoi amici, si sarebbe ben prestato adindicare la classe nobiliare (228; 251).
Anche tralasciando le puntualizzazioni preliminari, opinabili in varipunti, questa teoria sull'origine dell'espressione non appare affatto con-vincente, sia per l'idea del nesso KaÀ.ÒçKàya86çfiglio di troppi padri,sia per la validità del metodo usato da B., il quale si appoggia unica-mente su una definizione di Alcibiade come KaÀ.òçKàya86ç,che natu-
318 RECENSIONI
ralmente non prova nulla, per attribuire a lui la responsabilità delladiffusione ateniese dell'espressione; e cosi nulla di certo può direi ilpasso senofonteo, di IV secolo, su una presunta origine spartana diKaA.òçKuya96çnel V secolo,tra l'altro non attestata altrove. Ugualmente,anche Thuc. 4, 40, 2 non prova affatto «l'incontestabilità dell'anterio-rità dell'uso spartano» di KaA.òçKuya96çrispetto all'uso ateniese (178),né ci assicura che tale termine, nel 425, era «corrente sulle bocche deisoldati peloponnesiaei» (177); tale passo, infatti, è stato scritto da unateniese, e inoltre, riferendosi ai fatti di Sfacteria (425 a. G.), risultasicuramente posteriore all'attestazione di KaÀoKùya9tanei Banchettan-ti aristofanei, rappresentati nel 427. Ancora, l'interpretazione di Thuc.8, 48, 6 roi»; KaÀoùçKuya90ùç6vollaSollÉvoUçcome «les soi-disant KaÀoìKuya9oi»(179; 185) credo che sia inaccettabile. Per i sofisti, faccio solonotare che è molto più verosimile che essi promettessero ai loro allievidi farli diventare uya9oi, o tutt'al più coeoì Kuya90i;per le Nuvole, poi,bisogna tener presente che Fidippide viene definito KaA.òçKuya96çp r i-m a di divenire allievo di Socrate. B. ha tenuto presente il Prota-gora platonico (che egli cita alle pp. 220 e 227), in cui effettivamenteProtagora afferma di essere KaÀòçKuya96çe di poter rendere KaÀoìKuya90ii propri allievi; ma questo dialogo è stato redatto nel IV se-colo, quando l'espressione KaÀòçKuya96çera usata già da molto tem-po. Anche gli altri passi sembrano iperinterpretati in base a questaidea che coinvolge Alcibiade e i sofisti; in particolare, in Thuc. 8,48, 6 i KaÀoìKuya90i sono sicuramente gli oligarchi, come ritenevaanche A. W. Gomme (The Interpretation of mÀ.oì ICara8o{ in Thu-cydides 4. 40. 2, «Class. Quart.» 47, 1953, 65-68), e non, come pen-sa B., il gruppo di Alcibiade opposto sia al oTilloçche agli oligarchi(Alcibiade, tra l'altro, aveva appena dichiarato di volere un regimeoligarchico, e dunque opposizione non potrebbe esserci in alcun caso);ugualmente, i Garisti di Aristoph. Lys. 1059 sg. sono al servizio deifautori del colpo di stato del 411, come leggiamo, senza possibilitàdi equivoco, in Thuc. 8, 69, 3, e non hanno rapporti con questo pre-sunto gruppo alcibiadico. Infine, l'ipotesi che i KaÀoìKuya90isi iden-tificassero con i nobili soltanto a partire dal 411 appare, sulla basedi quanto abbiamo, soltanto un'illazione.
Già in questa terza sezione, in riferimento al V secolo, B. ci rivelaquello che è il suo metodo, in realtà molto discutibile: analizzare tuttii personaggi definiti KaÀoìKuya90tdai vari scrittori, allo scopo di de-terminarne l'indole e lo status sociale, e trarre da tutto questo delle in-dicazioni per stabilire il significato di KaA.òçKuya96ç.In effetti, dalledefinizioni di Alcibiade, dei soldati spartani e del Socrate delle Nuvo-le come KaÀoìKuya90i,egli ha tratto la conclusione che il KaA.òçKùya96çè dunque Alcibiade o un tipo come lui, che è poi un soldato spartano,e infine che è un sofista o un allievo dei sofisti.
Nella quarta e più monumentale parte del suo lavoro (253-609), de-dicata al IV secolo, B. continua in questa sua indagine storica, oecu-
BOURRIOT , COLESANTI 319
pandosi ampiamente di tutti i personaggi detti lCUMìlCà'YuSoida Pla-tone, da Senofonte, dagli oratori attici e da Aristotele; l'inevitabile ri-sultato a cui si arriva percorrendo questa strada è il riconoscimento ditanti significati di lCUÀÒç;lCà'YuS6ç;quasi quanti sono i personaggi cosidefiniti, o, più in generale, quanti sono gli scrittori che usano questonesso, addirittura con alcune differenze di accezione all'interno dellostesso autore (ad es. Eschine, 447); insomma, il significato variava a se-conda di chi utilizzava questa espressione, come B. ci dice esplicita-mente (499). Nel corpus aristotelico, infine, lCUÀÒç;lCà'YuS6ç;viene usatoinsieme a lCUÀÒç;lCuìà'YuS6ç;per indicare lo stesso concetto (m, moro 1207b23-35); secondo B., allora, ci troveremmo di fronte alla fase finaledell'evoluzione dell'antico nesso, testimoniata appunto dal fatto chela crasi non sarebbe più apportatrice di una particolare tonalità (583sg.; 592),
Anche in questa quarta parte vi sono dei punti assai discuti bili,e non convincenti, tra i quali sceglierò solo pochi esempi: la tropposottile distinzione, all'interno del Menone platonico, tra le volte in cuiSocrate usa lCUÀÒç;lCà'YuS6ç;,che rifletterebbero una preferenza delSocrate storico, e le volte in cui passa al semplice à'YuS6ç;,nelle quali sidovrebbe vedere un intervento di Platone, a cui non piacerebbe l'altrotermine (284); la non condivisibile affermazione che lCUÀ.Òç;lCà'YuS6ç;elCUMlCà'YuSiunon ricoprirebbero lo stesso campo semantico: lCUÀ.OlCà'YuSiusarebbe usato in un'accezione più ristretta, in quanto attestato in rife-rimento soltanto a schiavi e donne, per i quali non si potrebbe usarela superiore definizione di lCUÀÒç;lCà'YuS6ç;(335 sg.; 346; 349); la sem-plice definizione di lCuÀ.oìlCà'YuSoiapplicata ai membri della 'YEpoucriue ai re di Sparta, in Aristot. polo 2, 1270b24 e 1271a23, conside-rata come una conferma della spartanità del nesso e dell' origine laco-nica della lCUÀ.OlCà'YuSiu,già in precedenza affermate (541; 547-549;569; 592).
Le conclusioni (611-629), in cui B. ribadisce con forza tutte le sueteorie, sono seguite da un indice dei personaggi lCuÀ.oìlCà'YuSoiesplici-tamente o implicitamente designati come tali (631 sg.), e poi da un uti-le indice dei passi in cui ricorrono lCUÀÒç;lCà'YuS6ç;e lCUÀ.OlCà'YuSiu(633-641), in riferimento ad esseri umani. Da questo secondo indice, adifferenza di quello fornito a suo tempo da Wankel, sono dunque esclu-si gli oggetti o comunque tutto ciò che non sia animato, secondo unascelta, a mio avviso, arbitraria; già in Omero, infatti, à'YuS6ç;veniva ri-ferito anche alle isole e ad altro (Od. 9, 27; 15, 507), e non c'è da stu-pirsi che lo stesso accada, nel V secolo, con lCUÀ.Òç;lCà'YuS6ç;.
È dunque ormai chiaro che B., più che uno studio sul terminelCUÀ.Òç;lCà'YuS6ç;,ha realizzato soprattutto uno studio storico su tutti ipersonaggi definiti lCuÀ.oìlCà'YuSoi,il che è cosa ben diversa. Tutto que-sto sforzo di indagine storica è certo encomiabile, e può costituire, diper sé, anche un interessante contributo; ma ciò risulta in realtà illimite della ricerca di B., perché, nel cercare di individuare chi fos-
320 RECENSIONI
sero storicamente tutti questi KUAOì Kàyueoi, inevitabilmente diversil'uno dall'altro, si finisce poi per rinunciare a determinare quelloche la formula KUAÒç Kàyue6ç doveva esprimere indifferentemente pertutti.
Tutto questo dipende, evidentemente, dall'idea che B. si è fattodell' espressione KUAÒç Kàyue6ç, che a suo dire prescinderebbe daisingoli valori dei due aggettivi: KUAOç e àyue6ç, infatti, grazie alla era-si che «sublima» il nesso (341), si unirebbero in modo ferreo e profon-do, perdendo in questo amplesso il loro originario significato, e crean-do una nuova definizione che indicherebbe semplicemente l'esseresuperiore (ibid.). Da quanto B. afferma, quindi, si deve ricavare che,paradossalmente, proprio nella definizione di KuAòç Kàyue6ç che quali-fica l'uomo come eccellente non vi sarebbe alcun elemento che possafar pensare a questo essere come ad un KUAOç e àyue6ç. Non si capisce,dunque, per quale motivo si sia dovuti ricorrere proprio a KUAOç e aàyue6ç per indicare l'eccellenza umana, dal momento che né l'uno nél'altro dei concetti espressi dai due aggettivi avrebbero un ruolo nelnuovo significato che, pure, proprio questi stessi aggettivi concorronoa creare.
Questa spiegazione, in realtà, non sembra spiegare nulla, e dunqueil problema di mAòç Kàyue6ç rimane ancora insoluto; se è chiaro, in-fatti, che questo nesso si riferisce all'uomo superiore, quel che non èchiaro, invece, è quale sia l'origine di questa connessione, e cioè perchésiano stati scelti proprio questi due aggettivi, e quali siano, se esisto-no, i rapporti che li legano. Il lavoro di B., anche accettando l'impro-babile origine spartano-sofistica del nesso, non risponde a questi in-terrogativi.
GIULIOCOLESANTI
L. IUNIMODERATICOLUMELLAERei rusticae liber decimus (Carmen decultu hortorum), a cura di FRANCESCABOLDRER(Testi e studi dicultura classica, 17). Pisa, Edizioni ETS 1996, pp. 401.
The alleged terminus ante quem of 62 A. D. for Columella's poemrests on the shaky argument that Col. refers at v. 135 to dulcis Pom-peia, which he «would not have done after the earthquake» (which isunlikely to have interfered much with market gardening), but the de-cade looks to be right, Silvinus, the dedicatee of the whole work, asalso specifically of bk. lO, is otherwise unknown, though if the Gallioof 3, 3, 3 is indeed Seneca's brother, it suggests that the poet (a nativeof Cadiz, v. 185) moved in distinguished circles. But he wrote his littlepoem pigre ... propter difficultatem operis (lO praef. 4) quite out oftime, as a devotee ot Virgil (so preface, proemium and eolophon); notas a contemporary of Petronius, Lucan and Seneca tragicus. The 436lines of text (and one page of preface) have now attracted four theses