Un riempimento fognario di età severiana dalle cosiddette “Terme di Elagabalo” a Roma
Transcript of Un riempimento fognario di età severiana dalle cosiddette “Terme di Elagabalo” a Roma
AMERICAN JOURNAL OF ANCIENT HISTORY
Editor, New Series: T. Corey Brennan, Rutgers University
Associate Editor: Christopher Mackay, University of Alberta
Assistant Editors: Dobrinka Chiekova, Bryn Mawr College; Debra Nousek, University of Western Ontario Editorial Advisory Board: W. Robert Connor, President, The Teagle Foundation, New York; Erich S. Gruen, University of California, Berkeley; Sabine MacCormack, University of Notre Dame; Stephen V. Tracy, The Ohio State University and Director, American School of Classical Studies, Athens.
Editorial assistant: Andrew G. Scott, Rutgers University
For Contributors: From New Series volume 1 (2002) the editorial office of the Journal is at The Department of Classics, Ruth Adams Building 007, Rutgers University, 131 George Street, New Brunswick, NJ 08901-1414, (USA), tel. 732.932.9493, fax 732.932.9246, email: [email protected]. For further information, please visit the journal website www.ajah.org. All editorial correspondence should be addressed to the Editor.
Typescripts intended for publication should be at least double-spaced (text and notes), with the notes numbered consecutively and following the text. Journals should be abbreviated as in L’Année philologique; modifications customary in English will be accepted. No indication of the author’s identity should appear on the typescript: the name and address should be on a separate page. References to the author’s own work should be in the same style as references to the work of others. Personal acknowledgments should not be included: they may be added after the article has been accepted for publication. Authors who want rejected articles returned should enclose postage.
For Subscriptions: From New Series volume 2.2 (2003) [2007] AJAH is published by Gorgias Press. All correspondence on business, subscription, advertising and permission matters should be addressed to Gorgias Press (AJAH), 954 River Road, Piscataway, NJ 08854 (USA), tel: 732-885-8900, email: [email protected]. Subscriptions are $85/vol. for individuals and institutions, plus shipping, handling and sales tax when appropriate. All prices are in USD and payments can be made by credit cards or checks drawn on US banks. Prepayment is required for shipment.
TH E R O MA N EMP IR E
D U R IN G
TH E S EV ER A N D Y N A S TY:
C A S E S TU D IES IN H IS TO RY,
A RT, A R C H ITEC TU R E, E CO N O MY
A N D LITER ATU R E
Edited by Eric C. De Sena (American Research Center in Sofia
and John Cabot University, Rome)
This volume is dedicated to the tens of millions of brave people
in North Africa and the Near East
(the homelands of Septimius Severus and Julia Domna)
who in 2011 and 2012 have risked and, even, lost their lives
in order to improve the conditions
of their countries and to achieve the unalienable rights of life,
liberty, justice and the pursuit of happiness.
Gorgias Press LLC, 954 River Road, Piscataway, NJ, 08854, USA
www.gorgiaspress.com
Copyright © by Gorgias Press LLC2013
All rights reserved under International and Pan-American CopyrightConventions. No part of this publication may be reproduced, stored in aretrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic,mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise without theprior written permission of Gorgias Press LLC.
Printed in the United States of America
2013 ܘ
9ISBN 978-1-59333-838-1 ISSN 0362-8914
v
TA B LE O F C O N TEN TS
Εditor’s Νote ................................................................................... ix Ιntroduction ..................................................................................... xi
SEVERAN HISTORY AND LITERATURE ...................................1
The Parthian Campaigns of Septimius Severus: Causes, and Roles in
Dynastic Legitimation ...............................................................3 Mark K. Gradoni
“Unitas ex Africa: Was Tertullian the Origo
of Imperial Unification?” ........................................................25 E.T. Walters
URBAN TRANSFORMATIONS
DURING THE SEVERAN PERIOD......................................67
La Gallia Mosellana nell’età dei Severi:
il caso del Vicus di Bliesbruck ................................................69 Jean-Paul Petit Sara Santoro
Water Works and Monuments in Gaul in the Severan Age:
Some Considerations...............................................................95 Alice Dazzi
More Water for Rome: Nothing New in the Eternal City?
Water-Related Monuments as Part
of the Severan Building Program .......................................... 117 Jens Koehler
A Note on the Architectural Decoration
of the Severan Period in Pamphylia and Cilicia .................... 151 Müjde Türkmen-Peker
vi THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
L’Attività edilizia a destinazione pubblica fra i Severi
e i Soldatenkaiser: continuità e trasformazioni ..................... 173 Simone Rambaldi
Il tempio di Serapide sul Quirinale:
note di archeologia e topografia tra Antichità e Medioevo. .. 207 Ottavio Bucarelli
Alcune osservazioni sulla Sicilia durante il periodo dei Severi .... 227 Giancarlo Germanà
Vestigia architettoniche del periodo di Settimio Severo
in Tunisia .............................................................................. 255 Paola Puppo
ASPECTS OF SOCIETY AND ECONOMY
DURING THE SEVERAN PERIOD.................................... 285
The Origo of the Thracian Praetorians in the Time of Severans ... 287 Ivo Topalilov
Un riempimento fognario di età Severiana dalle cosiddette
“Terme di Elagabalo” a Roma .............................................. 301 Edoardo Radaelli
La ceramica ad ingobbiatura nera di Treviri –
una merce costosa in Pannonia durante l’epoca Severiana ... 341 Eszter Harsányi
Baetican Oil and Septimius Severus ............................................. 361 Lúcia Afonso
Economic Growth in the Early and Middle Imperial Periods,
Pre-200 AD: an Economic Approach
from a Peripheral Hispanic Province, Lusitania ................... 377 José Carlos Quaresma
Economy and Trade of Sicily During Severan Period:
Highlights Between Archaeology and History...................... 415 Daniele Malfitana – Carmela Franco – Annarita Di Mauro Thematic Maps By G. Fragalà
TABLE OF CONTENTS vii
SEVERAN ART AND IDEOLOGY ............................................ 463
Between Tradition and Innovation –
the Visual Representation of Severan Emperors ................... 465 Florian Leitmeir
Ideological Messages and Local Preferences:
the Imagery of the Severan Arch at Lepcis Magna ............... 493 Stephan Faust
Elagabalo invictus sacerdos: l’imperatore fanciullo
e la centralizzazione del sacro attraverso
lo specchio delle monete ....................................................... 515 Andrea Gariboldi
The Arch of Septimius Severus in the Roman Forum:
a Re-Consideration ................................................................ 541 Maria Lloyd
301
U N R IEMP IMEN TO F O G N A R IO
D I ETÀ S EV ER IA N A
D A LLE C O S ID D ETTE
“ TER ME D I ELA G A B A LO ” A R O MA
Edoardo Radaelli (University of Southampton; Sapienza – Università di Roma)1
Gli anni ‘80 del XX secolo sono stati, per Roma, un periodo di grande
fermento per l’archeologia in generale e per l’archeologia urbana2 nello
1 Questo scritto, da un lato è una sintesi della Tesi in Metodologia e Tecnica
dello Scavo discussa nell’A.A. 2008–2009 per la Scuola di Specializzazione in
Beni Archeologici della “Sapienza” – Università di Roma, dall’altro è parte di un
lavoro in corso d’opera più vasto (MPhil/PhD presso the University of South-
ampton). Quest’ultimo, partendo dall’analisi completa della massa di dati cera-
mici provenienti dalle stratigrafie medio imperiali presso le “Terme di Elagaba-
lo”, intende affrontare, tramite confronti con siti editi (oltre a Roma, che soffre
della cronica mancanza di contesti ceramici editi e non soltanto di età severiana,
anche, ad esempio, Ostia), le implicazioni commerciali durante il II e l’inizio del
III secolo d.C., argomento che non è stato volontariamente trattato in questa sede.
Ringrazio sentitamente Clementina Panella che dirige lo scavo delle pendici N-E
del Palatino, Lucia Saguì responsabile dell’Area IV, A. Falcone per l’aiuto nella
prima fase di studio, G. Pardini per le informazioni numismatiche e B. Lepri per
le informazioni preliminari sul materiale vitreo oggetto della sua tesi di laurea.
302 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
specifico.Tra le indagini che hanno preso avvio in questo periodo, una tra
le più importanti3 è quella dell’area della Meta Sudans, diretta dalla
prof.ssa Clementina Panella, iniziata nel 1985 grazie agli stanziamenti
dovuti alla Legge Biasini (Legge Speciale del 23 Marzo 1981, n. 396) e
parzialmente conclusasi nel 2001 riportando alla luce le strutture della
fontana flavia,4 demolita definitivamente nel 1936, per la realizzazione
della Via dell’Impero voluta da Mussolini (Manacorda, Tamassia 1985,
192–194; Insolera, Perego 1983, 129; Nardoni 2005, 132).
Le indagini hanno, inoltre, permesso l’individuazione e l’analisi delle
strutture più antiche che essa obliterava, attribuite già dal Colini all’età
neroniana (Colini 1937). Gli scavi e lo studio dei materiali hanno confer-
mato entrambe le datazioni proposte in passato, ma hanno altresì posto
alcuni interrogativi di notevole interesse per la ricostruzione topografica
dell’area più occidentale della Valle del Colosseo e della prospiciente
area delle Pendici Nord-Orientali del Palatino, mai realmente interessata
da scavi o studi specifici.
Nell’autunno del 2001 è stata intrapresa l’indagine di quest’area
(fig. 1), volta alla risoluzione dei quesiti posti dalle precedenti campagne.
Le indagini, tuttora in corso, hanno permesso l’individuazione di una
complessa stratificazione collocabile tra la situazione preantropica e l’età
contemporanea (basti pensare ai servizi della città moderna). La superfi-
cie d’indagine è stata divisa dapprima in due aree (Area II, verso la valle
e Area I, ad Ovest di questa) separate fra loro da una struttura muraria
con andamento NE-SW5 presente almeno dall’età sillana e che ha deter-
2 Sul significato di questo termine cfr. ad esempio Brogiolo 2000.
3 Da non dimenticare le indagini presso la Crypta Balbi, importantissime per
l’archeologia post-antica e medievale, e quelle presso le pendici settentrionali del
Palatino. 4 Per il resoconto dettagliato dei ritrovamenti cfr. Panella 1990. La fontana
era nota dalle descrizioni delle fonti letterarie e si era a conoscenza del suo aspet-
to attraverso alcune monete antiche. I ruderi di questo monumento sono stati,
inoltre, tramandati attraverso numerose raffigurazioni della piazza. 5 Da qui in avanti le indicazioni di orientamento saranno semplificate con la
menzione dei soli punti cardinali.
UN RIEMPIMENTO FOGNARIO DI ETÀ SEVERIANA 303
minato sorti ed interventi edilizi di notevole differenza.6 Ad esse nel 2005
è stata aggiunta—verso Sud-Est—l’Area III.
Nel 2007 il cantiere di scavo è stato ampliato con l’apertura dell’Area
IV, situata ad Ovest della cd. Area I e comprendente l’edificio comune-
mente noto con il nome di “Terme di Elagabalo”.7 Questo complesso non
era stato mai seriamente, stratigraficamente ed estensivamente indagato
prima, se si eccettuano gli sterri della fine dell’Ottocento operati dal Rosa
(Rosa 1873, 80–82),8 lo studio architettonico operato dal Popescu negli
anni 20 del Novecento (Popescu 1930) e i quattro saggi operati dalla Es-
cuela Española de Arqueología degli anni 1989–1992 (parzialmente editi
in Arce, Mar 1990, Mar 2005, Mar 2006).
Nell’area delle “Terme di Elagabalo” le indagini hanno permesso
l’individuazione di un’articolata stratigrafia che soltanto dalla fase giulio-
claudia è stato finora possibile comprendere con maggiore chiarezza. Nel-
la porzione Est e lungo il lato Nord dell’area di scavo è stata individuata
la prosecuzione di strutture già indagate nel settore immediatamente a
Est, costituite da parti di un ambiente di una domus e del fronte strada di
questo isolato, con tabernae (fig. 2) Tutto il complesso, che vide numero-
si rifacimenti e restauri tra la tarda età repubblicana e l’età claudia (Saguì
2009, 239–243), fu interessato dall’incendio del 64 d.C. (di cui sono state
rinvenute cospicue tracce soprattutto in quei settori che sono stati chiama-
ti vani 3, 6, 7 ed 8) a cui seguì una completa obliterazione e un quasi to-
tale abbandono (Saguì 2009, 243–244). Sembra, infatti, che durante l’età
flavia quest’area fosse priva di edifici e che l’attività edilizia in questo
settore fu ripresa soltanto in età adrianea (Saguì 2009, 244–245).
All’età adrianea, quindi, è attribuibile un grande complesso edilizio,
costituito da stanze rettangolari allungate in senso N-S comunicanti fra
loro e pavimentate con opus spicatum, con una strada che ne delimitava il
6 Per le notizie riguardanti questi settori delle indagini cfr.: Panella 2001; Pa-
nella 2006; Ferrandes 2006; Carbonara 2006; Zeggio 2006; Panella et al. 2011. 7 Il nome “Terme” è parzialmente erroneo. Esso nasce dal ritrovamento già
nella fine del XIX secolo di un piccolo balneum retrostante la grande abside oc-
cidentale (indagato poi a partire dalla campagna estiva 2010, non pertinente però
all’impianto originario) che ha portato all’interpretazione come impianto termale
per l’intero complesso. 8 E’ noto anche un dettagliato rapporto del Pellegrini per il Ministero della
Pubblica Istruzione: cfr. Saguì 2009, 236 e nt. 4.
304 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
lato posteriore. Interpretato come un horreum, prevedeva ingressi a Nord,
Ovest, Est e Sud (Saguì 2009, 246–254; fig. 3, in grigio scuro).
I cospicui interventi edilizi databili all’età severiana, ebbero un pro-
fondo impatto non soltanto sulla sommità del colle (nell’area della Vigna
Barberini), ma anche sulle pendici nord-orientali, mettendo fine alla
breve vita delle strutture adrianee che si estendevano in questa zona.
L’horreum di età precedente fu, infatti, completamente raso al suolo e
con esso una parte delle sostruzioni palatine. Furono artificialmente in-
nalzati i livelli e su questi furono fondati l’esteso complesso delle cd.
“Terme di Elagabalo” e le nuove poderose sostruzioni palatine.
Rispetto a quanto è stato possibile sapere degli edifici precedenti, le
informazioni riguardanti il nuovo edificio sono piuttosto limitate, nonos-
tante il discreto stato di conservazione delle murature e la struttura plani-
metrica molto ben leggibile. L’edificio di età severiana è costituito (fig. 3,
in grigio chiaro) da una serie di ambienti che si sviluppano attorno ad una
corte centrale e che hanno dimensioni più ridotte e diversa articolazione
rispetto all’horreum precedente. Purtroppo, la perdita dei piani pavimen-
tali in tutti gli ambienti indagati, l’asportazione delle stratificazioni di età
imperiale in tutta la porzione occidentale del complesso e l’impossibilità
di indagare tutto il fronte settentrionale hanno privato l’analisi di dati es-
senziali alla ricostruzione delle funzioni e delle percorrenze nel
complesso, sebbene sia ipotizzabile la sua interpretazione come un altro
magazzino (per l’analisi di tutti i muri severiani indagati fino al 2009 cfr.
Saguì 2009, 254–262).
All’interno di quello che sarà il vano 4 del magazzino severiano (in
corrispondenza del secondo ambiente da Est dell’edificio adrianeo) è sta-
to rinvenuto un condotto fognario di servizio ad una piccola latrina, il cui
riempimento (fig. 3, cerchio nero; US 4194), oggetto di questo contributo,
è stato immediatamente riconosciuto come di particolare interesse per la
quantità e qualità di materiale ceramico. Non si conservano, in questo
vano, resti di strutture che possano aiutare l’identificazione d’uso (forse
realizzate in legno oppure rimosse completamente dai successivi inter-
venti severiani).
Il materiale esaminato ammonta complessivamente a 5232 frammenti
(fig. 4). Fra questi, quello che più ha colpito l’attenzione è stato il ritro-
UN RIEMPIMENTO FOGNARIO DI ETÀ SEVERIANA 305
vamento di numerosi esemplari integri o parzialmente integri,9 l’elevata
presenza di ceramica comune (cfr. infra) e la quasi totale assenza di resi-
dui (80 vasi in fase contro 11 oggetti residuali).10
Classi N. di frammenti Percentuale
Ceramiche fini 14 0,4%
Ceramiche comuni 2619 73,5%
Lucerne 321 9,0%
Anfore 608 17,1%
Totale 3562 100%
Sono state rinvenute anche 10 monete che, ad un primo esame, sembrano
quasi tutte circolanti nel periodo di utilizzo dell’ambiente adrianeo essen-
do attribuibili al massimo alla fine del II secolo d.C.11
Il materiale vitreo è
attualmente in corso di studio, ma una prima analisi ha permesso di indi-
viduare esemplari di piatti, coppe, bicchieri, balsamari ed un vago di col-
lana cronologicamente molto coerenti fra loro.12
Ceramiche fini da mensa. Sono presenti con soli 7 esemplari.13
9 Sono interi 3 esemplari di lucerne, 3 esemplari di ceramica comune da men-
sa e dispensa e 4 esemplari di ceramica da fuoco. 10
Nelle tabelle che seguono i materiali residui saranno contraddistinti da un
colore grigio chiaro, mentre i materiali datanti saranno evidenziati con un colore
grigio più scuro. 11
Si tratta di 4 monete repubblicane in pessimo stato di conservazione (resi-
due), 1 asse databile tra il I e il II sec. d.C., 1 asse di età antonina, 1 asse di Anto-
nino Pio, 2 sesterzi di Marco Aurelio e un asse molto probabilmente di Lucio
Vero. Ringrazio il Dott. Giacomo Pardini per le informazioni preliminari sul ma-
teriale numismatico in corso di studio. 12
Informazione personale di Barbara Lepri, che sta ultimando lo studio di tut-
to il materiale vitreo proveniente dall’Area IV. 13
Tre frammenti non sono identificabili: 1 esemplare di Sigillata orientale A
molto fluitato, 1 frammento di Sigillata italica ed 1 frammento di Sigillata africa-
na A. In Rizzo 2003b, 39 viene posto il dubbio che per le coppe del tipo Cons-
pectus 37.5=Rizzo 2003a, Tav. XXIII, 10=Rizzo 2003b, fig. 2,2=Patterson et al.
2003, fig. 5.5/6, 164–165, la produzione si prolunghi nel II secolo poiché è stata
306 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
Classe Forma Tipo Datazione n. es.
Sigillata
Orientale A
Non id. Non id. - 1
Sigillata
italica
Coppa Conspectus 37.5 =
Rizzo 2003a, Tav.
XXIII, 101= Rizzo
2003b, fig. 2,2 =
Patterson et al.
2003, fig. 5.5/6,
164–165
Età tiberiana
- fine I d.C.
1
Lamboglia 1 C =
Hayes 8 B = Boni-
fay 3, n. 5
III d.C. 1
Sigillata
africana A
Coppe Hayes 14b, 11 Prima metà
III d.C.
2
Hayes 14/17, 1 Seconda
metà II-
prima metà
III d.C.
1
Sigillata
africana A/C
Coperchio Salomonson XXII
(Hayes 146)
Prima metà
III d.C.
1
TOTALE 7
Notevolmente attestate sono, invece, le ceramiche comuni sia da mensa e
dispensa, sia da fuoco, tutte di produzione locale.14
Fra queste, inoltre, è
stato possibile notare una fortissima ricorrenza di medesime forme e stes-
si tipi.
rinvenuta una grande quantità di pezzi afferenti a questo stesso tipo in un contes-
to datato al 140–160 d.C. 14
Per 6 esemplari, riconducibili alle ceramiche comuni da mensa e dispensa
in base alle paste, e per 1 esemplare di ceramica comune da fuoco, non è stato
possibile identificare la forma funzionale poiché si trattava di pareti non diagnos-
tiche. Le datazioni che seguiranno, si riferiscono a cronologie di attestazione.
UN RIEMPIMENTO FOGNARIO DI ETÀ SEVERIANA 307
Ceramica comune da mensa. E’ presente 69 esemplari. Sono attestate
solamente 4 forme funzionali, fra cui ben 55 brocche.
Forma Figura Confronto Datazione con-
fronto
n. es.
tavv. I, 1;
V, 38
- - 26
tav. I, 2 Pavolini 2000,
nn. 33–34
Età flavia-età
adrianea
16
tavv. I, 3;
V, 41
Ostia II, 398 80–90 d.C. 4
tav. I, 4 Curia II, A573,
fig. 263, 209
Età dioclezi-
anea
4
Brocche tav. I, 5 Ostia II, 400 80–90 d.C. 2
tav. I, 6 Carta-Pohl-Zevi
1978, strato IV,
fig. 128, 201
Età traianea 1
tav. I, 7 Ostia I, 300 240–250 d.C. 1
tav. II, 8 Ostia III, 67 190–220/225
d.C.
1
- Non id. Non id. 4
Piattello tav. II, 9 - - 1
Bicchiere tav. II, 10 - - 2
Boccalino tav. II, 11 Duncan 1964,
fig. 12, form 28,
108
65–75 d.C. 1
Non id. - - - 6
TOTALE 69
308 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
Le più attestate fra le brocche (26 esemplari) sono quelle con orlo a tesa
orizzontale, corpo piriforme tendente al globulare con evidenti segni del
tornio, ansa a tortiglione impostata sull’orlo e sulla spalla e basso piede
ad anello (tavv. I, 1; V, 38).15
Il secondo tipo in ordine di attestazione
(16 esemplari) è quello con orlo a sezione triangolare, superiormente ar-
rotondato e versatoio, corpo piriforme e basso piede ad anello (tav. I, 2),
mentre altri 4 esemplari differiscono dai precedenti solamente per la parte
superiore dell’orlo che si presenta piana (tavv. I, 3; V, 41). Gli altri tipi di
brocche e il boccalino hanno confronti datati tra il I e il IV secolo d.C. I
bicchieri e il piattello non sembrano invece avere confronti con esemplari
editi.16
Ceramiche comuni per la conservazione dei cibi. E’ presente con
9 esemplari. Sono attestate solamente 3 forme funzionali, con una predo-
minanza delle olle.
15
Nonostante la sostanziale omogeneità, è stato possibile notare la presenza
di piccole varianti morfologiche che prevedono un corpo che varia dal piriforme
al globulare. Questa forma, della quale non si conoscevano finora pezzi interi,
presenta tuttavia forti similitudini con alcuni esemplari editi. Fra questi una broc-
ca utilizzata come segnacolo di una tomba, datata al II secolo a.C. (Diamadis
2006); una cd. anforetta rinvenuta all’interno della cisterna degli scavi della Villa
di Livia ad gallinas albas (Carrara 2001, n. 96, fig. 225, 189). Anse simili sono
edite anche in Ostia I, p. 103, figg. 511–512; Cabrera Carratalá et al. 1999, CP
135260, 138 e fig. 19, 144; Schucany et al. 1999, fig. A.8, 13, 16 (esemplare
differente per morfologia dell’orlo, datato al 25/20 a.C.-10/5 d.C.); Martin-
Kilcher 1994, 451–452, fig. 201, taf. 251, nn. 5670 (datato al 30–130 d.C.) e
5671 (datato al I–III sec. d.C.). Anse simili in ceramica comune ad ingobbio
bianco sono edite in Porcari 2008, fig. 2 a–d, fig. 7, 51, 237. 16
Il piattello (tav. II, 9) presenta un bordo ricurvo forse a formare una deco-
razione a foglie o petali; i bicchieri (tav. II, 10) hanno un orlo estroflesso, pareti
molto sottili con evidenti segni del tornio e basso piede a tromba.
UN RIEMPIMENTO FOGNARIO DI ETÀ SEVERIANA 309
Forma Figura Confronto Datazione
confronto
n. es.
tav. II, 12 Ostia IV, 230 225/230–
270/280 d.C.
3
tav. II, 13 Dyson 1976, LS
100
post 330–335
d.C.
1
Olle tav. II, 14 Curia II, A1141,
fig. 263, 68
80/90 d.C. 1
tav. III,
15
Duncan 1964, fig.
18, 223
65–75 d.C. 1
tav. III,
16
simile a Moltó
Poveda 1999, 168
e fig. 12, 171
Non indicata 1
Dolium di
piccole
dimensioni
tav. III,
17
simile a
Settefinestre, tav.
23, 1
oppure
simile ad olla in
impasto con orlo
sagomato Bul-
garelli, Torre
2009, 335–336,
fig. 3, 2.
Età tardo-
antica, medie-
vale e moder-
na
oppure
I–II/III secolo
d.C.
1
Coperchio tav. III,
18
Ostia IV, 422 190–200/225
d.C.
1
TOTALE 9
Ceramica comune per la preparazione dei cibi. In questo caso si tratta di
soli due frammenti: 1 esemplare di bacino con orlo a tesa pendente leg-
germente ingrossato e parete inclinata verso l’interno (tav. III, 19)17
e un
esemplare di mortarium.
17
Ostia IV, 96 (fine IV–inizi V secolo d.C.).
310 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
Ceramica comune da fuoco. E’ presente con 69 esemplari. Sono attes-
tate 6 forme funzionali, con netta predominanza di una forma di ciotola
(46 esemplari).
Forma Figura Confronto Datazione
confronto
n. es.
Ciotola tavv. III,
20; V, 40
- - 46
tav. III, 26 Olcese 2003, tav.
X, 3
II secolo d.C. 10
tav. III, 27 simile a
Settefinestre, tav.
30, 8
oppure Dyson
1976, 22II–11
oppure Ostia III,
186
Età severiana
oppure 40
d.C. circa
oppure 240–
250 d.C.
1
Olle tav. IV, 28 Ostia II, 487 80–90 d.C. 1
tav. IV, 29 Ostia III, 185 240–250 d.C. 1
tav III, 30 Dyson 1976, LS 9 Post 330–335
d.C.
1
tav. III, 31 simile a Carta-
Pohl-Zevi 1978,
str. IV, fig. 131,
271
età traianea 1
Casseruole tav. IV, 32 Settefinestre, tav.
24, 14
50/1 a.C.–IV
sec. d.C.
1
tav. IV, 33 Carta-Pohl-Zevi
1978, str. IV, fig.
131, 270 b
Età traianea 1
tav. IV, 34 Ostia II, 478 80–90 d.C. 1
Tegami tav. IV, 35 Zevi-Pohl 1970,
Strato IV B2, fig.
130, 75
Età claudia 1
UN RIEMPIMENTO FOGNARIO DI ETÀ SEVERIANA 311
Forma Figura Confronto Datazione
confronto
n. es.
Coperchi tav. IV, 36 Dyson 1976, LS
96
330–335 d.C. 1
tav. IV, 37 Carta-Pohl-Zevi
1978, str. IV, fig.
131, 255
Età traianea 1
Incensiere tav. V, 38 - - 1
Non id. - - - 1
TOTALE 69
Le ciotole, infatti, appartengono tutte allo stesso tipo caratterizzato da un
orlo distinto, ingrossato e ripiegato verso l’interno, una leggera carenatura
smussata che delimita l’orlo dal corpo, corpo a tronco di cono rovesciato,
due anse applicate sulla carenatura e schiacciate al centro fino ad aderire
all’orlo formando una sorta di W arrotondata e un basso piede ad anello
(tavv. III, 20, V, 40).18
Ben attestate sono anche le olle, soprattutto quelle
(10 esemplari) con breve orlo a tesa orizzontale, collo cilindrico e corpo
globulare e due anse impostate subito sotto l’orlo e sul corpo (tav. III,
18
Nonostante l’omogeneità di fondo degli esemplari di questa forma, è stato
possibile distinguere piccole variazioni nel profilo e nella dimensione dell’orlo
che hanno portato alla identificazione di 5 “varietà” (cfr. tav. III, 21–25) e alcune
irregolarità sia nella dimensione che nella circolarità dell’orlo: esso infatti varia
tra 19 e 23,6 cm e la circonferenza, il più delle volte circolare, in alcuni esemplari
tende maggiormente verso l’ovale mentre in altri è decisamente irregolare, forse
per difetti di fabbricazione o cottura. Questa forma, della quale non si conosceva-
no finora esemplari interi, è attestata in contesti inediti di Vigna Barberini datati
tra il 190 e il 240 d.C. (inf. di G. Rizzo) e presenta parziali somiglianze con alcu-
ni esemplari editi. Fra questi, orli con andamento simile sono editi in Dyson
1976, FG61–62, 48 (fine III–inizi II a.C.), CF7, 22 (I sec. a.C.–I sec. d.C.) ed
LS54, 147 (metà II–metà III secolo d.C.). Si veda anche l’esemplare edito in Del-
la Porta-Sfredda-Tassinari 1998, tav. CXL, 3, 211–213 e in Cortese 2005, tav. 1,
3, 328 (età augustea). Andamento dell’orlo e della parete ricordano i tegami con
orlo ingrossato prodotti nell’officina di San Biagio/Nepi editi in Patterson et al.
2003, 167 e fig. 9. 1–4, (fine I-inizio III secolo d.C.) e la casseruola tipo 16 di
Quercia 2008, 204 (età neroniano-flavia).
312 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
26). Gli altri tipi di olle e le altre forme funzionali hanno confronti attes-
tati tra il I e il IV secolo d.C.,19
ad eccezione dell’incensiere che non trova
confronti puntuali.20
Ceramica a vernice rossa interna. E’ presente con due tegami di pro-
duzione campana21
riferibili alla forma Chiosi 1996, fig. 3, 41= Goudi-
neau 1970, tav. II, 30–31, datata tra l’età claudia e gli inizi del III sec.
d.C.
Ceramica africana da cucina. Sono attestati 20 esemplari, dei quali
sono stati identificati i seguenti tipi:22
Forma Tipo Datazione n. es.
Casseruola Hayes 197=Ostia III,
267=Bonifay 10
Prima metà II-fine
IV/inizi V d.C.
6
Casseruola Non id. - 3
19
La casseruola tav. IV, 30 è un’imitazione locale della casseruola Hayes
197=Ostia III, 267=Bonifay Culinaire type 10 in ceramica africana da cucina. La
casseruola tav. III, 31 è un’imitazione locale della marmitta Ostia I, 271 in ce-
ramica africana da cucina. La casseruola tav. IV, 32 è confrontabile anche con
Guldager Bilde 2008, 113–114, Form 18d, pl. 48,7 (I–III sec. d.C.). Il tegame
tav. IV, 35 è confrontabile anche con Guldager Bilde 2008, Form 1, 99–101, pl.
35, 6 (I–III sec. d.C.). Il coperchio tav. IV, 36 è confrontabile anche con Guldager
Bilde 2008, 120, Form 27b, pl. 54, 6, (I–III sec. d.C.). 20
L’incensiere tav. V, 38 presenta un orlo superiormente piano e decorato da
ondulazioni realizzate con digitazioni, parete svasata con tre fasce di decora-
zione: le prime due realizzate con colpi di stecca a formare dei piccoli ovoli; infe-
riormente ad esse una fascia di decorazione ondulata a digitazioni impresse.
Frammenti più conservati e afferenti al medesimo tipo sono stati rinvenuti in uno
strato di età neroniana indagato all’interno del vano 6 durante la campagna 2011.
Per questa ragione il tipo può essere datato almeno a partire dall’età neroniana (e,
forse, il frammento qui analizzato si può considerare in giacitura secondaria). 21
La pasta presenta un’elevatissima quantità di augite e prodotti vulcanici, ti-
pici delle produzioni di quest’area. 22
Lo stato di conservazione dei frammenti di piatti/coperchi e la similitudine
fra questi tipi, non permettono un’identificazione più puntuale. Gli esemplari di
casseruola non id. sono costituiti solo da pareti.
UN RIEMPIMENTO FOGNARIO DI ETÀ SEVERIANA 313
Forma Tipo Datazione n. es.
Tegame Lamboglia 10
B=Hayes 23 A
Fine I-prima metà
del III (meno fre-
quente a fine
IV/inizi V d.C.)
7
Piatto/Coperchio Ostia II, 302 oppure
Ostia I, 18 oppure
Ostia III, 332=Hayes
196, n. 1
Fine I a.C.-prima
metà III d.C.
4
TOTALE 20
Suppellettile da illuminazione.23
Le lucerne sono rappresentate da 321
frammenti, corrispondenti a 76 esemplari, tutti di produzione italica, tra i
quali nettamente prevalenti sono i tipi Bailey P, P/Q e Q (40 esemplari),
in alcuni casi realizzati con le stesse matrici (37 esemplari di Bailey tipo
P/Q con la spalla decorata con tralci di vite e con due diversi bolli).24
23
Per lo scioglimento e le trascrizioni dei bolli sulle lucerne si seguono i cri-
teri di Panciera 1991. 24
Si tratta di due diversi bolli: 1) anepigrafo con due ovoli e un’immagine
d’ape; 2) onomastico con menzione del fabbricante. Gli ovoli del bollo anepigra-
fo sono attestati ad esempio in Bailey 1980, fig. 111, Q 1121, Q 1303, Q 1311;
l’ape invece sembra essere inedita. Non si può stabilire con certezza se l’ape sia
un semplice signum decorativo oppure un’indicazione del cognomen del fabbri-
cante. Non si può totalmente escludere, infatti, che l’assonanza Aprilis-apis
(come se fosse avvenuto un passaggio Aprilis – Apilis – apis) abbia dato luogo
alla rappresentazione figurata allusiva al cognomen (sulle immagini onomastiche
in età imperiale si vedano i riferimenti bibliografici in Saguì 2009, 252–253, nota
39). Il bollo onomastico è edito in CIL XV, 6412 c. Questo bollo è attestato ad
esempio in una lucerna conservata nel museo archeologico di Verona, edita in
Larese-Sgreva 1996, n. 309, 189. Forse può essere identificato con il Sex(ti)
Eg((n))(ati) Apr(ilis) di CIL XV, 6412 a (ma anche CIL V, 8114, 43), sebbene
esistano altri bolli di lucerna recanti Aprilis editi ad esempio in CIL XV, 6308 e
CIL V, 8114, 9.
314 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
Tipo (Bailey 1980) Bollo Datazione n. es.
C, Q 992, 198, pl. 25. - Fine I-primo
terzo II d.C.
1
M, Group II - Terzo quarto I-
200 d.C.
1
N - I–IV d.C. 1
P, Q 1279, 324, pl. 67
(tav. V, 42)
((ovulum)) ((apis))
((ovulum))
90–140 d.C. 1
P, Q 1307, 329, pl. 70,
97
- Prima metà II
d.C.
1
P/Q = Hellmann 1987,
82, pl. XL, 313 (tav.
VI, 45)
((ovulum)) ((apis))
((ovulum))
Fine I/prima
metà II-metà
II/metà III d.C.
6
P/Q = Hellmann 1987,
82, pl. XL, 313
- Fine I/prima
metà II-metà
II/metà III d.C.
24
P/Q = Hellmann 1987,
82, pl. XL, 313 (tav.
VI, 43)
EN APRILIS =
Sex(tus vel -ti)
E(g)n(atius – vel
ati) Aprilis
Fine I/prima
metà II-metà
II/metà III d.C.
7
P/Q = Deneauve 1969,
192, pl. LXXXII, 905
(tav. VI, 47 A-B)
[LU]C FORT =
[Lu]c(i) Fort(is)
Fine II o inizi III
sec. d.C.
1
Q, Q 1329, 341, pl. 73 - Metà II d.C. 1
Non id. con becco tri-
angolare senza volute
- - 2
Bilicne con becchi tri-
angolari
(tav. VI, 46)
- - 2
Non id. C IUL NICEF = C.
Iul(ius vel -i)
Nicef(orus vel -ori)
Età di Traiano-
età di Antonino
Pio
1
Non id. con ariete sul
disco
- - 1
UN RIEMPIMENTO FOGNARIO DI ETÀ SEVERIANA 315
Tipo (Bailey 1980) Bollo Datazione n. es.
Non id. con fiera sul
disco
(tav. VI, 44)
- - 1
Non id. - - 25
TOTALE 76
La lucerna bilicne sembra inedita e senza decorazione.25
Gli altri due bolli
attestati sono databili tra l’età traianea e forse gli inizi del III secolo d.C.26
Anfore. Le anfore sono rappresentate soltanto da 30 esemplari, così
distinti:
Produzione Italica27
Tipo Confronto Datazione n. es.
Dressel 2–4 tirrenica Martin-Kilcher
1994, 2108
70/60 a.C.-prima
metà II d.C.
1
Dressel 2–4 tirrenica Martin-Kilcher
1994, 2053
50–70 d.C. 1
Dressel 2–4 campana - 70/60 a.C.-prima
metà II d.C.
1
25
Presenta una somiglianza per la forma (ma non per la presa o la decora-
zione) con Deneauve 1969, pl. XCVIII, 1070, 216 e con Rosenthal-Sivan 1978,
60, n. 241. 26
Per il bollo mutilo l’integrazione è possibile grazie a quello attestato in
Larese-Sgreva 1996, n. 307, 189 che dà come riferimenti bibliografici Bernasconi
1865, n. 309, Balil 1968, 58 e CIL V, 8114, 82. Il bollo C. Iul Nicef. è edito in
Bailey 1980, 97 e, come suggerito in Balil 1968, 48, potrebbe rientrare nella
famiglia dei bolli Iuli Nicef(ori) di CIL XV, 6495. 27
La produzione campana della Dressel 2–4 (di cui si conserva il puntale) è
identificabile per il tipo di pasta; le c.d. Anfore di Spello (fondi e anse) sono
identificabili per il tipo di pasta; l’esemplare non id. è riconducibile a quest’area
di produzione per il tipo di pasta, ma è costituito solamente da frammenti di pare-
ti e da un frammento di ansa.
316 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
Tipo Confronto Datazione n. es.
Ostia II, 521/Ostia
III, 369–370
Ostia II, 521 Età tiberi-
ano/claudia-fine II
d.C.
3
Non id. - - 1
TOTALE 7
Produzione Gallica. E’ presente 1 solo esemplare riferibile alla
produzione della Gallia Narbonensis, sebbene non attribuibile ad alcun
tipo.
Produzione Iberica (Baetica)28
Tipo Confronto Datazione n. es.
Dressel 20 - Età augustea-III
sec. d.C.
1
Dressel 14 A Martin-Kilcher
1994, 5356
I–II d.C. 1
Beltrán II A =
Pélichet 46
Étienne-Mayet
2002, fig. 34, 2
25 d.C.-seconda
metà II d.C.
1
Dressel 28 tarda - Fine I-metà III d.C. 1
Baetica da garum
non id.
- - 1
Non id. - - 1
TOTALE 6
28
La Dressel 20 è datata genericamente poiché si tratta di soli 3 piccoli
frammenti di ansa e da 1 puntale; alla Dressel 28 tarda, prodotta in Baetica, sono
attribuibili gli orli Ostia I, 549; Ostia III, 391; Ostia IV, 290–291; l’esemplare di
Baetica da garum non id. è stato identificato per il tipo di pasta e trattandosi di un
frammento di ansa con solco centrale, ma non è stato possibile individuarne il
tipo; l’esemplare non id. è costituito da frammenti di pareti attribuibili a
quest’area produttiva per la pasta, ma non identificabili con le altre anfore qui
attestate.
UN RIEMPIMENTO FOGNARIO DI ETÀ SEVERIANA 317
Produzione Nord-Africana29
Tipo Confronto Datazione n. es.
Africana IA Keay 1984, fig. 37,
8
Metà II/fine II-
inizi III d.C.
1
Africana IA Keay 1984, fig. 37,
2
Metà II/fine II-
inizi III d.C.
1
Africana IB Keay 1984, fig. 38,
6
Metà II-metà III
d.C.
1
Non id. - - 3
Tripolitana non id. - - 1
TOTALE 7
Produzione Egeo-Orientale30
29
Gli esemplari non id. sono costituiti da sole pareti. 30
L’Agora F65/66 è costituita da pareti e per questo la datazione rimane ge-
nerica. L’anticipo della datazione delle Kapitän I o II è dovuto ad attestazioni
precedenti alla cronologia tradizionale presso le recenti indagini del Nuovo Mer-
cato di Testaccio (Coletti, Lorenzetti 2010, 156). L’indicazione Kapitan I/II è
dovuta alla presenza di sole pareti, che non permettono una distinzione fra i due
tipi. Il dubbio tra Cretese 2 e 3 è, invece, dovuto alla presenza di un’ansa che
morfologicamente si situa tra la variante b del tipo Cretese 2 e il tipo Cretese 3.
La Cretese generica è attestata da sole pareti. La Zeest 80 è databile, secondo
Dyczek 2001, 159, da fine I al III secolo d.C., mentre per Swan 2010, 112–115 la
sua produzione arriva fino alla fine del V, sebbene dal IV secolo d.C. il tipo abbia
una diffusione solamente orientale e cambi la morfologia dell’orlo; per Coletti,
Lorenzetti 2010, 160 quest’anfora proverrebbe dalla Pamphilia, per Krapivina
2010, 70, invece, avrebbe un’origine nel Bosforo; anfore Zeest 80 sono attestate a
Roma in un argine datato alla fine del II–inizi del III secolo d.C. di via P. Blaser-
na (Cianfriglia, Francini 2008, 398–402 e fig. 314, 3) ed in strati adrianei di Tes-
taccio (scavi SAR – Nuovo Mercato) datati al 110–140 d.C. (Coletti, Lorenzetti
2010, 160). La datazione della Kingsholm 117 o simile è presa da Rizzo 2003a,
154–155. L’anfora non id. è attestata solo da pareti.
318 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
Tipo Origine Confronto Datazione n. es.
Agora F 65/66 Valle del
Meandro
- Fine I a.C.-III
d.C.
1
Kapitän I Area egeo-
microasiatica
Ostia IV,
439
Primo quarto II-
fine III d.C.
1
Kapitän I/II Area egeo-
microasiatica
- Primo quarto II-
fine III d.C.
1
Cretese 2/3 Creta - 50 d.C.-fine II
d.C. (AC2)/27
a.C.-inizi III d.C.
(AC3)
1
Cretese non id. Creta - - 1
Zeest
80=Bengazi
MR5=Dyczeck
21
Pamphilia?
Bosforo?
- I-fine V d.C. 1
Kingsholm
117 o simile
Palestina - I-III d.C. 1
Non id. Non id. - - 1
TOTALE 8
Produzioni non id. Per 2 esemplari non è stato possibile proporre
un’identificazione né formulare un’ipotesi sull’area di provenienza.
Ossi Lavorati31
Tra gli ossi lavorati sono presenti:
- 13 aghi crinali interi e 15 frammentari (tav. VII, 49): asta a sezione
circolare e affusolata, estremità superiore appuntita a cono. Un solo ago
ha una capocchia con decorazione tendente al triangolare (tav. VII, 48).
31
Per alcuni manufatti in osso d’età imperiale rinvenuti a Roma si veda, a ti-
tolo esemplificativo, Moroni 2008 (con bibliografia precedente).
UN RIEMPIMENTO FOGNARIO DI ETÀ SEVERIANA 319
- 3 aghi da cucito interi e 4 frammentari (tav. VII, 50): asta a sezione
circolare con estremità superiore appuntita e cruna costituita da due fori
circolari contigui.
- 1 dado di forma cubica irregolare con facce che misurano tra 0,77 e
0,80 cm. Le indicazioni numerali sono realizzate con un puntino circon-
dato da due piccoli cerchi concentrici. (tav. VII, 51 A–F).
Dall’analisi dei materiali ceramici, gli esemplari “residui”32
(11) sono:
Classe Forma Tipo Datazione n. es.
Sigillata
italica
Coppa Conspectus 37.5 = Riz-
zo 2003a, Tav. XXIII,
101= Rizzo 2003b, fig.
2,2 = Patterson et al.
2003, fig. 5.5/6, 164–
165
Età tiberi-
ana - fine I
d.C.
1
Non
id.
Non id. Primo
quarto I
a.C.-fine I
d.C.
1
Sigillata Ori-
entale A
Non
id.
Non id. - 1
Bailey 1980, C, Q 992 Fine I-
primo ter-
zo II d.C.
1
32
Non vi è generale accordo da parte degli studiosi su cosa si intenda col ter-
mine “residuo”. Spesso si intende “residuo” un manufatto rinvenuto in contesti
databili almeno una generazione dopo il termine della sua produzione. Questo
perché un oggetto circolava e/o veniva usato anche successivamente al momento
in cui si finiva di produrlo. Tuttavia, nonostante spesso questa definizione sia
appropriata per molti reperti, in questo caso specifico essa sembra abbastanza
impropria, poiché questo criterio di una generazione, stabilito a tavolino, è labile.
Gli oggetti qui definiti come “residui” in realtà erano in uso e/o circolavano nel
momento in cui l’ambiente adrianeo fu distrutto ed entrarono a far parte di questo
nuovo contesto di poco più tardo. Per questo motivo i materiali possono even-
tualmente definirsi in modo migliore come “falsi-residui”.
320 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
Classe Forma Tipo Datazione n. es.
Bailey 1980, P, Q 1279 90–140
d.C.
1
Lucerne Non id. con bollo C. Iul.
Nicef.
Età Traia-
no-età
Antonino
Pio
1
Bailey 1980, P, Q 1307 Prima me-
tà II d.C.
1
Bailey 1980, Q, Q 1329 Metà II
d.C.
1
Dressel 2–4, Martin-
Kilcher 1994, 2108
70/60 a.C.-
prima
metà II
d.C.
1
Anfore Dressel 2–4, Martin-
Kilcher 1994, 2053
50–70 d.C. 1
Dressel 2–4 campana
non id.
70/60 a.C.-
prima
metà II
d.C.
1
TOTALE 11
Fra gli esemplari identificabili come in fase (80), invece, sono stati enu-
cleati i tipi la cui produzione si colloca nell’orizzonte cronologico più
tardo. Si tratta di soli 5 esemplari che sono più precisamente datanti:
Classe Tipo Cronologia N.
es.
Sigillata Afri-
cana A
Lamboglia 1 C= Hayes 8 B
= Bonifay 3, n. 5
III secolo d.C. 1
Hayes 14b, 11 Prima metà III
secolo d.C.
2
Sigillata Afri-
cana A/C
Salomonson XXII (Hayes
146)
Prima metà III
secolo d.C.
1
UN RIEMPIMENTO FOGNARIO DI ETÀ SEVERIANA 321
Classe Tipo Cronologia N.
es.
Lucerne Bailey 1980, P/Q, bollo
[Lu]c. Fort.
Fine II o inizi III
sec. d.C.
1
TOTALE 5
L’analisi dei materiali ha permesso di inquadrare la formazione del de-
posito originario nella fase di vita dell’ambiente, collocabile nel corso del
II secolo d.C., poco prima, quindi, del riempimento del condotto fognario.
Gli esemplari datanti, infatti, permettono di inquadrare questo intervento
nell’età severiana e verosimilmente agli inizi del III secolo d.C., sebbene
non sia attestato alcun esemplare di Sigillata africana C che prende avvio
proprio dagli inizi del III secolo d.C. (Atlante I, 14; Gandolfi 2004, 133–
135; Gandolfi 2005, 203–207), né di anfore Africana II, le cui varianti più
antiche IIA1 e IIA2 sono datate alla metà/seconda metà del II-prima metà
del III secolo d.C. (Bonifay 2004, 111).
In questo momento fu completamente interrata la fogna di età adria-
nea che costituiva un vuoto strutturalmente pericoloso in vista della rea-
lizzazione del nuovo edificio severiano. Per colmare la fogna è molto
probabile che siano stati utilizzati materiali provenienti proprio
dall’ambiente in cui essi si trovavano ed in cui erano in uso nel momento
in cui fu distrutto, come lasciano ipotizzare da una parte le datazioni dei
materiali definiti “residui” che si situano in un range cronologico che
sembra concentrarsi proprio nel corso del II secolo d.C., dall’altra anche
le datazioni della maggior parte degli elementi in fase di questo contesto.
Manufatti analoghi a quelli attestati in questo riempimento sono stati
rinvenuti in alcuni strati di distruzione in questo ed in altri ambienti
dell’horreum adrianeo, permettendo, quindi, di confermare questa ipotesi.
Le ceramiche analizzate facevano quasi sicuramente parte di uno degli
ambienti dell’horreum adrianeo33
che precede l’impianto di età severiana.
Non è noto l’utilizzo specifico per il quale questi contenitori furono rea-
lizzati, ma si possono avanzare delle proposte riguardo ciò che brocche e
ciotole avrebbero potuto contenere. Le caratteristiche macroscopiche del-
la pasta delle ciotole (per le quali sembrano essere state utilizzate materie
33
Per la descrizione e l’articolazione dell’horreum adrianeo cfr.: Saguì 2009,
246–254.
322 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
prime di non eccellente qualità) e lo stato di conservazione degli esempla-
ri sembrano indicare l’inadeguatezza di questi recipienti per il posiziona-
mento sul fuoco diretto. Per le lucerne, invece, non vi possono essere
dubbi circa il loro utilizzo, ma vale la pena sottolineare che esse sono
tutte annerite attorno al foro d’illuminazione e quindi devono essere state
utilizzate.
Le ipotesi che si possono formulare sono le seguenti e, sebbene molto
distanti fra loro, sono entrambe verosimili:
1. Le brocche con ansa a tortiglione contenevano acqua poiché il
diametro dell’orlo e la sua forma avrebbero causato una certa
perdita di vino nell’atto di versarlo. Le altre brocche, soprattutto
(ma non solo) quelle con versatoio, avrebbero invece contenuto
vino. Le ciotole in ceramica da fuoco potrebbero aver contenuto
cibi solidi, liquidi o semiliquidi.
2. Tutte le brocche erano destinate a contenere acqua, mentre le
ciotole potrebbero essere dei contenitori per l’acqua versata dalle
brocche stesse34
.
Prendendo spunto da queste due ipotesi, se ne possono avanzare altre ri-
guardanti la destinazione d’uso dell’ambiente dal quale i materiali pro-
vengono. La presenza di tante forme tutte uguali sia in ceramica comune
da mensa (brocche con orlo a tesa e anse a torciglione, ma anche brocche
con orlo a sezione triangolare) sia in ceramica da fuoco (ciotole con orlo
distinto ed ingrossato e olle con piccolo orlo a tesa orizzontale) sia di lu-
cerne (Bailey 1980, tipo P/Q) può far pensare ad una bottega in cui questi
oggetti erano venduti al pubblico. Non è, infatti, possibile escludere to-
talmente l’identificazione di questo ambiente come la bottega di un
rivenditore di ceramiche (quale che fosse il loro utilizzo) in cui si svolge-
va l’attività commerciale anche nelle ore di poca luce (per l’annerimento
delle lucerne).
Più verosimile sembrerebbe, invece, l’identificazione dell’ambiente di
provenienza originaria come una piccola popina, un’osteria o trattoria, in
cui era stato acquistato uno stock di oggetti in ceramica tutti uguali, per-
34
Per fare un esempio più contemporaneo poteva trattarsi di un abbinamento
“da toilette” personale per il lavaggio delle mani o del viso, come accadeva nelle
dimore aristocratiche fino all’arrivo dell’acqua corrente.
UN RIEMPIMENTO FOGNARIO DI ETÀ SEVERIANA 323
ché funzionali a servire cibi e bevande. Si tratterebbe di una popina
comunque ben organizzata poiché fornita di una latrina per le necessità
degli avventori. Alcuni frammenti di argilla rinvenuti all’interno del
riempimento fognario in esame potrebbero essere quello che resta di un
bancone. Questi frammenti presentano, infatti, una serie di concavità che
sembrano combaciare quasi perfettamente con le ciotole rinvenute in
questo riempimento (tav. VII, 52).
A partire da Tiberio furono emanati editti imperiali sempre più severi
e restrittivi sulla possibilità di somministrazione dei cibi nelle popinae.35
Le testimonianze offerte da Ostia mostrano, tuttavia, resti molto usurati di
banconi in edifici “per la ristorazione” appartenenti al II secolo d.C., tanto
da far pensare che alla morte di Vespasiano gli editti emanati in pre-
cedenza abbiano cessato di essere applicati e già sotto Domiziano essi
non esistessero più.36
La datazione proposta per i materiali analizzati po-
trebbe, quindi, farli rientrare cronologicamente in questo periodo di
nuova floridezza delle popinae.
Rimane aperta la questione sul tipo di cibi che venissero somministrati
in questa popina. Il contenuto delle brocche potrebbe essere quello pros-
pettato nell’ipotesi precedentemente esposta (cfr. supra, n. 1), fermo res-
tando che i romani non erano soliti bere il vino puro (cfr. ad esempio Sal-
za Prina Ricotti 1987, 75), mentre rimane più difficile identificare il con-
tenuto delle ciotole. Esse potrebbero esser state usate come una specie di
piatti/zuppiere da portata che, vista la loro manifattura, avrebbero mante-
nuto caldi sia cibi liquidi o semiliquidi,37
sia le carni38
(come sembra at-
35
Tiberio per primo proibì che fossero venduti dolci nelle osterie (Suet., Tib.,
34); sotto Claudio invece gli edili vietarono la possibilità di offrire carni cotte o
acqua calda per allungare le bevande (Cass. Dio., 60–67; Suet., Claud., 38);
Nerone e Vespasiano permisero la sola somministrazione di ceci cotti e vino.
Questi ‘regolamenti commerciali’ determinarono un profondo cambiamento in
questi esercizi che fino ad allora erano considerati come luoghi in cui mangiar
bene, tanto che Orazio le chiamava le unctae popinae (Hor., Epist., I, 14, 21). 36
Salza Prina Ricotti 1987, 122. Già Marziale (Mart., I, 41, 9–10) menziona
le tiepide osterie nelle quali il rauco cuoco vendeva salsicce fumanti ed anche
Giovenale (Iuv., XI, 78–81; VIII, 172–178) ne dà un quadro molto vivace. 37
In via di semplici ipotesi, si può pensare ad esempio: alla alicia, un semoli-
no/polenta di grano o farro, talvolta con alcune aggiunte (nota in diverse realizza-
zioni in base alla finezza della macinazione: André 1981, 58–59; Salza Prina
324 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
testare la grande quantità di reperti osteologici e la malacofauna: cfr. su-
pra, fig. 4) forse accompagnate da qualche salsa39
più o meno speziata.40
A prescindere, tuttavia, dalla funzione che queste ceramiche comuni
potevano aver avuto nell’ambiente da cui provengono ed in cui erano uti-
lizzate fino a tutto il II secolo d.C., i rinvenimenti di questo riempimento
fognario, visti nella loro totalità, ci offrono un esempio di una parte dei
materiali che circolavano a Roma tra la fine del II e gli inizi del III secolo
d.C., nei primi anni quindi del Principato di Settimio Severo.
Ricotti 1987, 72; Baun 1995, 37; White 1995, 39–40); alla polenta, una zuppa
d’orzo liquida, tuttavia poco usata dai romani (André 1981, 61); ad una zuppa di
legumi e verdure in cui erano presenti anche la bieta (Apic., III, 2, 1) e forse gli
spinaci (André 1981, 28); ad una minestra di legumi con ceci, orzo, lenticchie e
piselli (Apic., IV, 4, 2; V, 5, 2); alla tisana, un decotto o bevanda a base di orzo
mondato (Plin., N.H., XVIII, 75: essa era così tanto diffusa che Plinio non ritenne
necessario darne la ricetta; André 1981, 62 che menziona altre fonti); al tragus,
una specie di polenta a base di grano mondato ed essiccato (Plin., N.H., VIII, 76);
alla puls, una sorta di polenta a base d’acqua o latte, farina di grano (André 1981,
pp. 60–61) o farro (Braun 1995, 35–36), talvolta con aggiunta di formaggio,
miele e uova (la puls punica di Cato, Agr., 85; Olcese 2003, 38). 38
Per le specie note e le ricette a base di volatili vd. ad esempio André 1981,
127–133; Salza Prina Ricotti 1987, 95–101; per le specie note e le ricette a base
di pesci vd. ad esempio André 1981, 96–103 e 107–113; Salza Prina Ricotti
1987, 101, 103–105; Wilkins-Hill 1995, 430; per le specie note e le ricette a base
di molluschi vd. ad esempio André 1981, 103–107 e 125–126; Salza Prina Ricotti
1987, 101–103 e 106–107; per le specie note e le ricette a base di animali di me-
dia taglia vd. ad esempio André 1981, 114–125 e 134–148; Salza Prina Ricotti
1987, 89–91, 92–95 e 106. E’ nota l’attività di un commerciante di carni, come
riportato nella sua epigrafe funeraria, “de Sacra Via” (Frayn 1995, 110 e biblio-
grafia precedente). 39
Le salse menzionate da Apicio sono molto numerose. Per una visione
d’insieme su queste cfr. Solomon 1995. 40
Fra le spezie si può citare ad esempio il pepe (piper monoxylis: Plin., N.H.,
VI, 105) che fu molto richiesto in età imperiale e che proveniva, trasportato via
mare attraverso le tratte dell’oceano indiano, dall’India: su questa tratta cfr. Daf-
finà 1995.
UN RIEMPIMENTO FOGNARIO DI ETÀ SEVERIANA 325
ABBREVIAZIONI
Agora = Robinson H. S., Pottery of the roman Period. Chronology. The
Athenaian Agora V (1959).
Atlante I = AA. VV., EAA, Atlante delle forme Ceramiche I, Ceramica
fine romana nel bacino Mediterraneo (medio e tardo impero) (1981).
Bengazi = Riley, J.A., The Coarse Pottery from Bernice. In Excavations
at Sidi Khrebish, Benghazi (Berenice) II, «Libya Antiqua», Suppl. 5,2,
Lloyd, J.A. (ed) (1979) 91-467.
Conspectus 1990 = Ettlinger E. et al., Conspectus formarum terrae sigil-
latae italico modo confectae (1990).
Cretese = Marangou-Lerat A., Le vin et les amphores de Créte: de
l’époque classique ò l’époque imperiale, Études Crétoises 30 (1995).
Curia II = Morselli C., Tortorici E. (eds.), Curia, Forum Iulium, Forum
Transitorium, II, «Lavori e studi di archeologia» 14 (1990).
Food in antiquity 1995 = Wilikins J., Harvey D., Dobson M.(eds.), Food
in antiquity (1995).
Kingsholm = Hurst H. R., Kingsholm. Excavations at Kingsholm Close
and Other Sites with a Discussion of the Archeology of the Area
(1985).
Ostia I = AA.VV., Ostia I, «Studi miscellanei. Seminario di archeologia e
storia dell’arte greca e romana dell’università di Roma» 13 (1968).
Ostia II = AA. VV., Ostia II, «Studi miscellanei. Seminario di archeolo-
gia e storia dell’arte greca e romana dell’università di Roma»16
(1970).
Ostia III = AA. VV., Ostia III, «Studi miscellanei. Seminario di archeo-
logia e storia dell’arte greca e romana dell’università di Roma»21
(1973).
Ostia IV = AA. VV., Ostia IV, «Studi miscellanei. Seminario di archeo-
logia e storia dell’arte greca e romana dell’università di Roma»23
(1977).
Patabs I 2010 = Kassab Tezgör D., Inaishvili N. (eds.), Patabs I, Produc-
tion and Trade of amphorae in the Black Sea, «Varia Anatolica» XXI
(2010).
Settefinestre = Ricci A. (ed.), Settefinestre. Una villa schiavistica
nell’Etruria romana, III. La villa e i suoi reperti (1985).
326 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
BIBLIOGRAFIA
André J., L’alimentation et la cuisine à Rome (1981).
Arce J., Mar R., Monumento presso l’Arco di Tito nel Foro Romano:
Campagna 1989, «Quaderni di Archeologia Etrusco-Italica» 19 («Ar-
cheologia Laziale» X) (1990) 43–51.
Bailey D. M., A Catalogue of the Lamps in the British Museum, II, Ro-
man Lamps made in Italy (1980).
Balil A., Lucernae Singulares, «Collection Latomus», vol. XCIII (1968).
Beltrán Lloris M., Las ánforas romanas en España (1970).
Bernasconi C., Catalogo descrittivo degli oggetti d’arte e di antichità del
civico museo di Verona (1865).
Bonifay M., Études sur la céramique tardive d’Afrique (2004).
Braun T., Barley cakes and Emmer bread, in Food in antiquity (1995)
25–37.
Brogiolo G., s.v. Urbana, Archeologia, in R. Francovich - D. Manacorda
(eds.), Dizionario di Archeologia: temi, concetti e metodi (2000) 350-
355.
Bulgarelli F., Torre E., Produzione e commercio di alcune classi di cera-
mica comune nel territorio di Vado Ligure (SV) (I–III sec. d.C.). Pri-
mi dati archeologici ed archeometrici integrati: Parte I, in Les céra-
miques communes d’Italie et Narbonnaise. Structures de production,
typologies et contextes inérits, IIe s. av. J.-C.–IIIe s. apr. J.-C., Pas-
qualini M. (ed.) (2009) 331–341.
Cabrera Carratalá L., Jiménez Martínez E., Pérez Coloma Á., Rico Cáno-
vas E., Ros Berenguer s., La Ceramica comune, in La villa di Plinio il
Giovane a San Giustino, Primi risultati di una ricerca in corso, Bra-
coni P., Uroz Sáez J. (eds.) (1999) 135–147.
Carbonara V., Domus e tabernae lungo la via verso il Foro, «Scienze
dell’antichità» 13 (2006) 15–35.
Carrara M., C. Materiali dalla cisterna, in Messineo G. (ed.), Ad Gallinas
Albas, Villa di Livia, «Bullettino della Commissione archeologica
comunale di Roma» Suppl. 8 (2001) 165–200.
Carta M., Pohl I., Zevi F., La taberna dell’Invidioso. Piazzale delle Cor-
porazioni, Portico Ovest: saggi sotto i mosaici, «Notizie degli scavi di
antichità» 32 Suppl., 1978 (1987).
Chiosi E., Cuma: una produzione di ceramica a vernice rossa interna, in
Les céramiques communes de Campanie et Narbonnaise (Ier s. av.
J.-C. – IIe s. ap. J.-C.). La vaisselle de cuisine et de table, Actes des
UN RIEMPIMENTO FOGNARIO DI ETÀ SEVERIANA 327
Journées d’étude organisées par le Centre Jean Bérard et la Soprin-
tendenza Archeologica per le Province di Napoli e Caserta, Naples,
27–28 mai 1994, Bats M. (ed.) (1996) 225–233.
Cianfriglia L., Francini S., Via Portuense, Via P. Blaserna. Area fu-
neraria e infrastrutture agricole (municipio XV), « Bullettino della
Commissione archeologica comunale di Roma » CIX (2008) 388–402.
Coletti F., Lorenzetti E. G., Anfore orientali a Roma. Nuovi dati dagli
scavi della Soprintendenza Archeologica di Roma nell’area del Tes-
taccio, «Rei Cretariae Romanae Fautorum acta» 41 (2010) 155–164.
Colini A. M., Meta Sudans, «Atti della Pontificia accademia romana di
archeologia. Rendiconti» XIII (1937) 15–39.
Daffinà P., Le relazioni tra Roma e l’India alla luce delle più recenti in-
dagini, «Conferenze IsMEO» 7 (1995).
Della Porta C., Sfredda N., Tassinari G., Ceramiche comuni, in Olcese G.
(ed.), Ceramiche in Lombardia tra II secolo a.C. e VII sec. d.C., Rac-
colta dei dati editi, Documenti di Archeologia 16 (1998) 133–230.
Deneauve J., Lampes de Carthage (1969).
Diamadis N., II. 323, Brocca di grandi dimensioni, Via Vertumno, Loca-
lità Pietralata (Municipio V), Tomba ipogea, in Tomei (2006) 260.
Dressel H., CIL XV, 1, I, tab. II.
Duncan G. C., A Roman Pottery near Sutri, «Papers of the British School
at Rome» 30 (1964) 38–88.
Dyczek P., Roman amphorae of the 1st–3rd centuries AD found on the
Lower Danube: typology (2001).
Dyson S. L., Cosa: the Utilitarian Pottery, «Memoirs of the American
Academy in Rome» XXXIII (1976).
Étienne R., Mayet F., Salaisons et sauces de poisson hispaniques (2002).
Ferrandes A. F., Tra valle e collina: il sistema sostruttivo neroniano e le
sue trasformazioni, in «Scienze dell’antichità» 13 (2006) 37–59.
Filippi F. (ed.) Horti et Sordes, Uno scavo alle falde del Gianicolo
(2008).
Frain J., The roman meat trade, in Food in antiquity (1995) 107–114.
Gandolfi D., La produzione ceramica africana di età medio e tardo impe-
riale: terra sigillata chiara e ceramica da cucina, in Lusuardi Siena S.
(ed.), Ad mensam, Manufatti d’uso da contesti archeologici fra tarda
antichità e medioevo (1994) 127–156.
Gandolfi D., Sigillate e ceramiche da cucina africane, in Gandolfi D.
(ed.), La ceramica e i materiali di età romana, classi, produzioni,
commerci e consumi (2005) 195–232.
328 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
Goudineau C., Note sur la céramique à engobe interne rouge-pompéien
(Pompejanisch-Roten Platten), «Mélanges de l'Ecole française de
Rome. Antiquité» 82 (1970) 159–186.
Guldager Bilde P., Cooking Ware, in Guldager Bilde, Poulse et al. (2008)
95–124.
Guldager Bilde P., Poulse B., Sande s., Vaag E. L., et al., The Temple of
Castor And Pollux II.1, «Occasional Papers of the Nordic Institutes in
Rome» 3 (2008).
Hayes J. W., Late Roman Pottery (1974).
Hellmann M.-C., Lampes Antiques de la bibliothèque Nationale II, Fonds
general: Lampes pré-romaines et romaines (1987).
Insolera I., Perego F., Archeologia e città. Storia moderna dei fori impe-
riali (1983).
Kapitän G., Le anfore del relitto romano di Capo Ognina (Siracusa), in
Baldacci P. et al. (eds.), Recherches sur les amphores romaines, «Col-
lection de l'École Française de Rome» 10 (1972) 243–252.
Keay S. J., Late Roman Amphorae in the Western Mediterranean. A ty-
pology and economic study: The Catalan evidence, «British archaeo-
logical reports. International series» 196 (1984).
Krapivina V. V., Amphorae of the 3rd
–4th
centuries A.D. in Olbia Pontica,
in Patabs I (2010) 63–73.
Lamboglia N., Gli scavi di Albintimilium e la cronologia della ceramica
romana (parte prima: campagna di scavo 1938–1940) (1950).
Larese A., Sgreva D., Le lucerne fittili del museo archeologico di Verona
I (1996).
Manacorda D., Tamassia R., Il Piccone del Regime (1985).
Mar R., El Palatí. La formació dels palaus imperials a Roma (2005).
Mar R., Contribución a la topografía de los palacios imperiales en Roma
(Escavaciones Españolas junto el Arco de Tito), «Scienze
dell’antichità» 13 (2006) 157–198.
Martin-Kilcher S., Die römischen Amphoren aus Augst und Kaiseraugst.
Ein Beitrag zur römischen Handels-und Kulturgeschicte, 2–3 (1994).
Moroni M. T., L’Instrumentum in osso e metallo, in Filippi (2008) 387–
405.
Nardoni T., s.v. Meta Sudans, in C. Calci (ed.), Roma archeologica. Le
scoperte più recenti della città antica e della sua area suburbana
(2005) 132–134.
UN RIEMPIMENTO FOGNARIO DI ETÀ SEVERIANA 329
Olcese G., Ceramiche comuni a Roma e in area romana: produzione,
circolazione e tecnologia (tarda età repubblicana-prima età impe-
riale) (2003).
Panciera S., Struttura dei supplementi e segni diacritici dieci anni dopo,
in Supplementa Italica 8 (1991) 9–21.
Panella C., La valle del Colosseo nell’antichità, «Bollettino di archeo-
logia» 1–2 (=2) (1990) 35–88.
Panella C., La Valle del Colosseo prima del Colosseo e la Meta Sudans,
in La Regina A. (ed.), Sangue e Arena (2001) 49–67.
Panella C., Il Palatino Nord-Orientale: nuove conoscenze, nuove
riflessioni, «Scienze dell’antichità» 13 (2006) 265–299.
Panella C., Saguì L., Zeggio S., Ferrandes A. F., Pardini G., Lo Scavo
Archeologico tra ricerca e trasmissione della Memoria, «Forma Ur-
bis, Itinerari nascosti di Roma Antica», Anno XVI, n. 4 (2011) 4–18.
Patterson H., Bousquet A., Di Giuseppe H., Le produzioni ceramiche nel-
la media valle del Tevere tra l’età repubblicana e tardo antica, «Rei
Cretariae Romanae Fautorum acta» 38 (2003) 161–170.
Pavolini C., Scavi di Ostia, XII, La ceramica comune, Le forme in argilla
depurata dell’antiquarium (2000).
Pélichet E., A propos des amphores romaines trouvées à Nyon, in
«Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte» 8
(1946) 189–209.
Popescu I. A., Le cosiddette Terme di Eliogabalo in via Sacra. Rilievo e
considerazioni architettoniche sopra un gruppo di rovine situate sulla
via Sacra ai Pendici del Palatino, finora spiegate quali terme di
Eliogabalo, Larare, lavacro, etc…, «Ephemeris Dacoromana» IV
(1930) 1–28.
Porcaro B., La ceramica comune a ingobbio bianco, in Filippi (2008)
233–246.
Quercia A., Le ceramiche comuni di età romana, in Filippi (2008) 197–
232.
Rizzo G., Instrumenta urbis I. Ceramiche fini da mensa, lucerne ed an-
fore a Roma nei primi due secoli dell’impero (2003).
Rizzo G., Roma e le ultime produzioni “Tardo-Italiche” di vasi in Terra
Sigillata, «Rei Cretariae Romanae Fautorum acta» 38 (2003) 35–42.
Rosa P., Sulle scoperte archeologiche della città e provincia di Roma
negli anni 1871–1872 (1873).
330 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
Rosenthal R., Sivan R., Ancient Lamps in the Schloessinger Collection,
(QUEDEM, Monographs of the Institute of Archaeology, The Hebrew
University of Jerusalem, 8) (1978).
Saguì L., Pendici Nord-orientali del Palatino: le “Terme di Elagabalo”.
Indagini archeologiche e prime riflessioni, «Archeologia Classica»
LX (2009) 235–274.
Salomonson J. W., Etude sur la céramique romaine d’Afrique sigillée
claire et céramique comune de Henchir el Ouiba (Raqqada), en Tuni-
sine Centrale, «Bulletin antieke beschaving» XLIII (1968) 80–141.
Salza Prina Ricotti E., Alimentazione, cibi, tavola e cucine nell’età impe-
riale, in L’alimentazione nel mondo antico. I Romani-età imperiale
(Catalogo della mostra per la Giornata mondiale dell’alimentazione
16/10/1987) (1987) 71–130.
C. Schucany C., Martin-Kilcher S., Bergen L., Paunier D., Römische
Keramik in der Schweiz (1999).
Solomon J., The Apician sauce, ius apicianum, in Food in antiquity
(1995) 115–131.
Swan V. G., Dichin (Bulgaria): the destruction deposits and the dating of
Black Sea amphorae in the fifth and sixth centuries A.D., in Patabs I
(2010) 107–118.
Tomei M. A. (ed.), Roma. Memorie dal sottosuolo. Ritrovamenti archeo-
logici 1980/2006 (2006).
White K. D., Cereals, bread and milling in the roman world, in Food in
antiquity (1995) 39–43.
Wilkins J., Hill S., The sources and sauces of Atheneaus, in Food in an-
tiquity (1995) 429–438.
Zeest I. B., Keramičeskaja Tara Bospora, «Materialy i issledovanija po
archeologii SSSR» 8 (1960).
Zeggio S., Dall'indagine alla città. Un settore del centro monumentale e la
sua viabilità dalle origini all’età neroniana, «Scienze dell’antichità» 13
(2006) 61–122.
Zevi F., Pohl I., Ostia (Roma). Casa delle Pareti Gialle, salone centrale.
Scavo del pavimento a mosaico, «Notizie degli scavi di antichità»
Suppl. I (1970) 43–244
UN RIEMPIMENTO FOGNARIO DI ETÀ SEVERIANA 331
FIGURES
Fig. 1: La porzione occidentale della valle del Colosseo.
La freccia indica l’area delle indagini
(rielaborazione da PANELLA ET AL. 2011, fig. a p. 4).
332 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
Fig. 2: Sovrapposizione planimetrica della fase severiana (in grigio chiaro) e della domus con tabernae di età claudia
(grigio scuro) alle “Terme di Elagabalo” (da SAGUI 2009, fig. 7).
Fig. 3: “Terme di Elagabalo”. Sovrapposizione planimetrica
delle fasi adrianee (in grigio scuro) e severiane (in grigio chiaro)
con la numerazione dei vani. Il cerchio nero nel vano 4
indica la posizione del riempimento fognario in esame
(rielaborazione da SAGUÌ 2009, fig. 8).
UN RIEMPIMENTO FOGNARIO DI ETÀ SEVERIANA 333
Fig. 4: Quantificazione dei materiali attestati
in numero di frammenti e percentuali.
336 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
Tav. III: (15–19 e 26–27, scala 1:3; 20–25, scala 1:2); 21: varietà 1;
22: varietà 2; 23: varietà 3; 24: varietà 4; 25: varietà 5.
338 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
Tav. V: 38 Incensiere; 39: Brocche con ansa a tortiglione in ceramica
comune: visione di profilo; 40: Ciotola biansata in ceramica da fuoco:
visione di profilo; 41: Brocca con orlo triangolare e versatoio in ceramica
comune: visione di profilo; 42: Lucerna BAILEY 1980, Tipo P, Q 1279.
UN RIEMPIMENTO FOGNARIO DI ETÀ SEVERIANA 339
Tav. VI: 43: Lucerna BAILEY 1980, P/Q con bollo En. Aprilis;
44: Lucerna non id. con fiera; 45: Lucerna BAILEY 1980, P/Q con bollo
((ovulum)) ((apis)) ((ovulum)); 46: Lucerna bilicne non id. con becchi
triangolari; 47: Lucerna BAILEY 1980, Tipo P/Q = DENEAUVE 1969,
pl. LXXXII, 905, p. 192: A) Disco e spalla decorati, B) fondo con bollo
[Lu]c. Fort.
340 THE ROMAN EMPIRE DURING THE SEVERAN DYNASTY
Tav. VII: 48: Ago crinale in osso decorato: visione di profilo;
49: Visione d’insieme degli aghi crinali; 50: Visione d’insieme degli aghi
da cucito; 51: Dado in osso (A–F visione delle varie facce);
52: Ciotole in ceramica da fuoco parzialmente combacianti con le tracce
presenti sui frammenti di piano d’argilla.
















































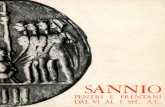










![Maranello e il suo territorio dalle origini all’alto Medioevo: due secoli di scoperte archeologiche, Milano 1996 [Donato Labate]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631f8d9663ac2c35640add5e/maranello-e-il-suo-territorio-dalle-origini-allalto-medioevo-due-secoli-di-scoperte.jpg)








