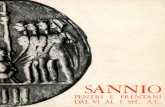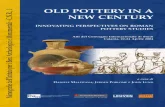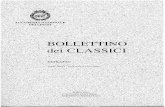Sannio. Pentri e Frentani: dalle guerre sannitiche alla romanizzazione, 1980
Spigolature dalle carte agostiniane viterbesi, in «Analecta Augustiniana», 76 (2013), pp. 17-57
Transcript of Spigolature dalle carte agostiniane viterbesi, in «Analecta Augustiniana», 76 (2013), pp. 17-57
SPIGOLATURE DALLE CARTE AGOSTINIANE VITERBESI
ANTONELLA MAZZON
ABSTRACT
The object of this work is a presentation of an edition of the most ancientdocuments related to the Augustinian priory of Viterbo. It concerns a totalof 154 documental pieces, covering the years between 1216 and 1399. The es-say is introduced by a brief history of the archive and of the priory itself.Some particular and meaningful wills are specifically studied and presentedon a deeper level.
SPIGOLATURE DALLE CARTE AGOSTINIANE VITERBESI*
In questo contributo si presentano i primi esiti di un progetto ditrascrizione ed edizione delle più antiche pergamene relative al con-vento agostiniano della SS. Trinità di Viterbo1, nato grazie alla colla-borazione tra il Centro culturale agostiniano di Roma e la comunitàagostiniana di Viterbo.
Le pergamene, inizialmente conservate presso l’archivio del con-vento, confluirono in seguito alle soppressioni napoleoniche nell’Ar-
* È con sincera e profonda gratitudine che ringrazio in queste poche righe p.Mario Mattei, parrocco della chiesa della SS. Trinità di Viterbo, nonché archivistadella Provincia Italiana, e p. Rocco Ronzani del Centro Culturale Agostiniano diRoma.
1 Sulla presenza agostiniana a Viterbo si rinvia a U. MARIANI, Gli Eremitani di S.Agostino in Viterbo, in «Bollettino storico agostiniano», 1 (marzo 1925), fasc. 3 pp. 73-77 e fasc. 4 pp. 118-122; U. MARIANI, De conventu nostri Ordinis Viterbiensis, in «Ana-lecta Augustiniana», 11 (1925-1926), pp. 227-235; R.L. DE PALMA, Agricoltura e lavorosalariato a Viterbo nel Quattrocento. Le terre del convento della S.ma Trinità, in A. LAN-CONELLI, R.L. DE PALMA, Terra, Acque e lavoro nella Viterbo medievale, Roma 1992(Nuovi Studi Storici, 15), pp. 73-230: 75, 78-79. M.L. POLIDORI, Il santuario della Tri-nità in Viterbo, in «Lunario romano», 21 (1992), pp. 359-369 (numero monografico,Santuari cristiani del Lazio, a cura di A. RAVAGLIOLI); M. MATTEI, Gli Agostiniani a Vi-terbo: le origini eremitche e l’inizio del santuario mariano, in «Analecta Augustiniana»,72 (2009), pp. 405-442; M. MATTEI, L’ordine agostiniano a Viterbo al tempo del beatoGiacomo, in Giacomo da Viterbo al tempo di Bonifacio VIII. Studi per il VII centenariodella morte, a cura di P. GIUSTINIANI, G. TAVOLARO, Roma 2011, pp. 129-172. Il proget-to andrebbe integrato e completato, oltre che con l’edizione dell’intero fondo diplo-matico relativo alla chiesa e convento della Trinità conservato presso la Biblioteca de-gli Ardenti di Viterbo, con lo studio dell’eventuale documentazione trasmessa nei pro-tocolli notarili custoditi presso l’Archivio di Stato di Viterbo e considerando anchequanto contenuto nella Miscellanea II G I 23 della Biblioteca degli Ardenti, e con lacronaca del codice 28 della Biblioteca Capitolare sempre di Viterbo (fonti queste ul-time consultate a suo tempo da G. SIGNORELLI, Viterbo nella storia della Chiesa, 3 voll.,Viterbo 1907-1908).
chivio storico del Comune di Viterbo2 dove, sul finire del XIX secolo,vennero inventariate, come testimonia una nota recante la data del16 settembre 1886 apposta al termine dell’inventario: «Le pergame-ne descritte nel presente catalogo in numero di trecento dieci settepiù quattro documenti cartacei furono diligentemente bollati, nume-rati e collazionati dalla Commissione deputata dal Municipio al scar-dinamento dell’Archivio Storico Viterbese ed essendo detto catalogopienamente conforme all’altro compilato dal cav. prof. Ceccotti incarta di cotone fu deliberato di ritenerlo per originale»3. Nel riscon-tro fatto nel 1933-34 risultò mancante un solo documento cartaceo;un altro sarà segnalato come mancante successivamente. Poco primadella seconda guerra mondiale l’Archivio storico del Comune di Vi-terbo venne depositato presso la locale Biblioteca degli Ardenti4. Quile pergamene sciolte (secoli XI-XVIII) relative alla sezione “Corpora-zioni religiose soppresse di Viterbo” sono quasi 30005.
L’intero fondo relativo al convento della SS. Trinità conta dun-que un totale di 317 pezzi pergamenacei così suddivisi dal punto divista cronologico: 34 del XIII secolo, 120 del XIV, 107 del XV, 28 delXVI, 21 del XVII, 6 del XVIII e infine un documento degli inizi delXIX6. L’edizione qui presentata interesserà esclusivamente i primi154 pezzi (corrispondenti ai numeri di inventario 3512-3665), per unperiodo che corrisponde agli anni 1216-13997.
Antonella Mazzon20
2 Sull’Archivio in generale si rinvia a P. SAVIGNONI, L’archivio storico del comunedi Viterbo, in «Archivio della Società romana di storia patria», 18 (1895), pp. 5-50, 269-318; 19 (1896), pp. 5-42, 225-294; 20 (1897), pp. 5-43, 465-478.
3 Inventario che viene però giudicato dal Savignoni «con troppi errori cronologi-ci e troppo vago» (SAVIGNONI, L’archivio storico cit., 1895, p. 13).
4 E. TERENZONI, L’Archivio storico comunale di Viterbo. Ipotesi di riordinamento siste-matico, in Storia nazionale e storia locale: la tutela del patrimonio culturale: il patrimonio do-cumentario della Tuscia. Atti del XIX Congresso nazionale archivistico (Viterbo, 27-30 ot-tobre 1982), Roma 1984 (Fonti e studi di storia, legislazione e tecnica degli archivi moder-ni, 19), pp. 189-224: 191; G.B. SGUARIO, Fondi archivistici della Biblioteca degli Ardenti, inPresenze eterodosse nel Viterbese tra Quattro e Cinquecento, Atti del Convegno Internaziona-le (Viterbo, 2-3 dicembre 1996), a cura di U. DE CAPRIO, C. RANIERI, Roma 2000, pp. 3-7.
5 TERENZONI, L’archivio storico cit., p. 204; e come già affermava il Savignoni nel1895, ancora oggi, «le carte sciolte, divise secondo la provenienza, sono conservate inordine cronologico entro cassette di latta» (SAVIGNONI, L’archivio storico cit., p. 9).
6 Savignoni accenna poi ad altre cinquanta pergamene «dell’ex-convento dellaTrinità catalogate dall’avv. G. Oddi» relative agli anni 1102-1543, che allo stato attua-le non sono state prese in visione (L’archivio storico cit., 1895, p. 27).
7 Presso l’archivio della comunità della SS. Trinità di Viterbo si conservano le tra-scrizioni manoscritte realizzate qualche decennio fa da p. Raffaele Trani – storico, ar-cheologo, archivista-paleografo – le quali, seppure preziose, si sono rivelate parziali,in quanto il lavoro da lui compiuto ha riguardato solo la documentazione in cui veni-va esplicitamente citato il convento agostiniano.
Come in altri fondi relativi ad enti religiosi, anche in quello del-la fondazione eremitana viterbese si trovano documenti apparente-mente estranei8 all’ente stesso ma che possono trovare la loro ragio-ne d’essere ad esempio in quanto munimina, ossia documenti checomprovano la legittimità dei diritti acquisiti su dei beni attraversovendite, permute e donazioni; documenti questi che giungono nellemani dell’ultimo attore dell’azione giuridica insieme al bene oggettodella transazione, attore il cui nome naturalmente non appare indi-cato nel documento né come produttore né come destinatario. Altridocumenti invece possono essere confluiti all’interno del fondo degliEremitani semplicemente perché l’archivio religioso è ritenuto unluogo di conservazione più sicuro rispetto a quello personale o di fa-miglia o addirittura a quello comunale. Fatto per esempio riscontra-to da Renzo Nelli riguardo ai documenti agostiniani conservati a Pi-stoia, i quali costituiscono un vero e proprio archivio cittadino9.Un’altra motivazione è individuata da Antonella Ghignoli, riferendo-si in particolare agli eremitani del territorio senese: essi «possonoaver conservato documenti di laici non solo per l’acquisizione stabi-le dei loro beni, ma anche a causa di certi affari che spesso per loroconto (combinazioni di matrimoni o cause legate all’aredità) i frati-eremiti, specie quelli di città, conducono come procuratori»10. E nel-la casistica suggerita dalla Ghignoli rientrano per esempio le perga-mene 7 e 8 del fondo della Trinità, in cui nel novembre del 1261 il no-taio certifica che Gerardo Mancie riceve da Angelo Verçerie, a nomedella figlia Flordipisa, e futura sposa dello stesso Gerardo, una dotedi 60 libbre di denari senesi, lucchesi e pisani piccoli; lo stesso Ge-rardo poi obbliga una sua casa sita in hora San Luca; una dote cheverrà successivamente integrata il 1° marzo 1277 con l’aggiunta di unmantello di lana del valore di 10 libbre di denari paparini11. Oppure
Spigolature dalle carte agostiniane viterbesi 21
8 Sicuramente può apparire estraneo un documento come quello tramandato inuna pergamena del 1351-1352 (Viterbo, Biblioteca degli Ardenti, Fondo Trinità [d’orain poi BCArdenti, Trinità], pergg. 97/1-2) in cui vengono registrati i pagamenti per de-biti di usura da parte di Dera di S. Gimignano, debiti lasciati dal marito Carduccio Pel-legrini. Ma un documento successivo (BCArdenti, Trinità, perg. 97/3, 1356), fornisceuna risposta sicura nell’ottenimento del perdono da parte di Dera dell’eremitano Ago-stino Tinacci, vescovo di Narni, la cui famiglia a S. Gimignano nella chiesa di S. Ago-stino possedeva una cappella.
9 R. NELLI, Il convento agostiniano di San Lorenzo a Pistoia: un “Archivio” per lacittà, in «Bullettino Storico Pistoiese», a. CV, 3ª s., n. 38 (2003), pp. 87-100.
10 A. GHIGNOLI, Gli archivi degli eremiti di Siena, in Ermites de France et d’Italie(XIe-XVe siècles). Actes du colloque organisé par l’École française de Rome (Certosa diPontignano, 5-7 mai 2000), dir. A. VAUCHEZ, Rome 2003 (Collection de l’École françai-se de Rome, 313), pp. 255-276: 263.
11 BCArdenti, Trinità, pergg. 7 (18 novembre 1261) e 8 (1° marzo 1277).
la pergamena 17 con la quale Fulçerio Girardi riceve a titolo di doteda Letizia, figlia del fu Gregorio di Alberico, sua futura sposa, diver-si beni immobili, tra cui una casa posta in contrada Sant’Andrea, unoliveto in contrada Mole di San Martino, e una vigna in contrada Val-le di Rivo Secco12.
Singolare esempio di donazione viene offerto da un documentodel 6 aprile 1278 con cui Giovanni Insengne cede, riservandosenel’usufrutto sua vita natural durante, una vigna in contrada Plani deNuce, nei pressi di Viterbo, al figlio Nero con la condizione di tener-ne una metà pure libere per sé e l’altra metà pro indiviso per condivi-derla con il fratello Petruccio nel caso in cui questi faccia ritorno a Vi-terbo13. Tale documento viene registrato nel libro delle Quattro chiavi,in ottemperanza all’obbligo sancito da parte del Comune di registra-re i documenti con azioni con valore superiore ai cento soldi14.
Piuttosto varia si presenta, per quanto in linea con quanto nor-malmente conservato nei fondi archivistici conventuali15, la tipologiadocumentaria presente all’interno dell’archivio viterbese, in cui sicontano, oltre alle donazioni, anche testamenti e vendite.
Per quanto riguarda i testamenti, sui cui ci soffermeremo piùavanti, ne sono presenti circa una ventina, e in diversi di essi vieneespressamente citata la chiesa della SS. Trinità oppure un frate ere-mitano, in qualità di esecutore testamentario oppure di semplice te-stimone.
Differenziata risulta pure la natura dei testimoni istituzionali dimatrice sia religiosa (come nei documenti emanati dalla cancelleria
Antonella Mazzon22
12 BCArdenti, Trinità, perg. 15 (5 maggio 1286).13 BCArdenti, Trinità, pergg. 11 e 12. Lo stesso Giovanni Insegne e i suoi figli so-
no i protagonisti anche della perg. 9 (28 maggio 1269). Cfr. Il Liber quattuor claviumdel comune di Viterbo, a cura di C. BUZZI, Roma 1998 (Fonti per la storia dell’Italia me-dievale. Regesta chartarum, 46-47), pp. LXXVI, 523-525, nr. 427.
14 Ibid., pp. VII-VIII. 15 A. BARTOLI LANGELI, N. D’ACUNTO, I documenti degli ordini mendicanti, in Li-
bro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel Basso Medioevo, acura di G. AVARUCCI, R.M. BORRACINI VERDUCCI, G. BORRI, Spoleto 1999, pp. 381-415.In particolare Bartoli Langeli definisce l’archivio mendicante come un archivio di“relazione” in cui il convento può essere visto come il destinatario sia nei privilegiacontenuti nella documentazione pontificia di «altre isitutizioni ecclesiastiche di ri-ferimento» sia negli instrumenta, come ad esempio nei testamenti. Ma l’autore notacome sono invece «in minoranza … gli atti che vedono il convento e i frati assume-re formalmente l’iniziativa documentaria» (Ibid., p. 385). Piuttosto scarso risulta es-sere l’interesse dimostrato dai Mendicanti per la documentazione in generale, disin-teresse che secondo Bartoli Langeli va ricercato nel legame tra il convento e le suericchezze, ossia nel rapporto «tante proprietà altrettante attenzione ai munimina»(Ibid., p. 389).
pontificia o vescovile16) sia civile (rappresentati da riformanze o sin-gole rubriche poi confluite o non recepite negli statuti comunali, in-ventari di beni e delibere delle allora autorità civili e comunali17).
Ma la presenza di documenti “estranei” al convento trova ancheuna motivazione di natura prettamente istituzionale nella definizio-ne espressa nel Capitolo generale dell’Ordine del 1394 secondo laquale «il religioso che avesse ricevuto – o che ricevesse in futuro – daipropri genitori o benefattori dei beni mobili o immobili, ponesse ilrelativo documento nel “deposito comune”, lasciando al suo arbitrio,almeno in parte, l’usufrutto di tali beni fino alla morte, dopo la qua-le essi dovevano essere incorporati a quelli della comunità»18. E in ef-fetti questa disposizione ben legittima la presenza di diversi munimi-na all’interno dell’archivio agostiniano non altrimenti giustificabili erinconducibili, nella gran parte dei casi, a specifici soggetti.
In realtà nelle prime Costituzioni dell’Ordine, compilate a Rati-sbona nel 1290, non sono presenti disposizioni relative alla produzio-ne e conservazione della documentazione; si fa solo accenno agli in-ventari dei beni della sacrestia 19 ma non risulta contemplata né l’indi-viduazione di un luogo deputato come archivio, o meglio come depo-sito dei documenti, né la compilazione e/o realizzazione di un inventa-rio dei beni patrimoniali e dei documenti comprovanti tali proprietà.
Sicuramente i frati hanno maggiore interesse nel salvaguardaree conservare i libri,20 i quali risultano infatti essere tra i pochi ogget-
Spigolature dalle carte agostiniane viterbesi 23
16 Si vedano per esempio i documenti pontifici corrispondenti a BCArdenti, Tri-nità, pergg. 1-2, 4-5, 10, 25-26, 37-38, 75, 110 e 154; mentre per la documentazione ve-scovile si rinvia alle pergamene 18, 28 e 98.
17 Cfr. il testo corrispondente alle note 42-43 e inoltre quanto contenuto in BCAr-denti, Trinità, pergg. 69, 106-107, 145.
18 Citato da D. GUTIÉRREZ, Storia dell’Ordine di Sant’Agostino, I/2, Gli Agostinianinel medioevo 1357-1517, Roma 1987, p. 80.
19 Si veda ad esempio l’additio al cap. 29 (De modo electionis procuratoris et sacri-stiae et officio eorum) in cui si legge: «volumus etiam quod in singulis maioribus con-ventibus habeantur tria inventaria, in quaternis stabilibus, quorum de omnibus bonismovilibus et immovilibus unum teneat prior, aliud procurator, tertium unus bonusfrater de conventu. In minoribus vero conventibus sufficient duo»; cfr. I. ARAMBURU
CENDOYA, Las primitivas constituciones de los Augustinos (Ratisbonens del año 1290),in «Archivo Agustiniano» (Valladolid 1968), pp. 83-84.
20 Diverse sono infatti le disposizioni che riguardano questi particolari beni e chene regolano la gestione, specie in seguito alla morte dei confratelli che ne possedeva-no, e la loro tutela e conservazione. Era infatti previsto già dalle Costituzioni di Rati-sbona che nella sacrestia o in qualche parte del dormitorio fosse presente un «bonumet securum armarium» in cui andavano riposti i libri non utilizzati di frequente daparte del coro o nell’ufficio ecclesiastico (cfr. ARAMBURU CENDOYA, Las primitivas con-stituciones, p. 123).
ti concessi come “beni di possesso”, e proprio in occasione di un ca-pitolo provinciale svoltosi a Viterbo nel giugno del 1296 si stabilisceche «omnia quecumque bona fratrum defunctorum, sive in libris, si-ve in pecunia remanserint, devolvantur ad loca, que ipsos genueruntin Christo, ubicumque decedant, deductis tamen expensis factis ininfirmitate et exequiis, si contingat ipsos decedere extra dicta loca.Nec volumus quod ista diffinitio se extendat ad libros lectorum, quoshabuerunt a provincia. Bona vero fratrum qui fuerunt recepti in aliaprovincia, sint illius loci in quo decedunt»21. E proprio un illustre “fi-glio” della città di Viterbo, ossia Giacomo da Viterbo22, in occasionedel Capitolo Generale celebrato a Bologna nel 1306, ottiene l’appro-vazione di una convenzione grazie alla quale potrà tenersi i libri ac-quistati durante la sua carriera di studente e docente grazie ai finan-ziamenti dei confratelli pagando però nell’immediato 90 fiorini d’oroin favore dell’Ordine e disponendo che dopo la sua morte la bibliote-ca divenga di proprietà del convento di Viterbo23.
Qualche ulteriore informazione riguardo alla gestione e conser-vazione del patrimonio documentario è presente nei capitoli dellaProvincia Romana, alla quale il convento di Viterbo appartiene,24 e
Antonella Mazzon24
21 Sull’importanza dei libri si veda I. ARAMBURU CENDOYA, Las primitivas constitu-ciones cit., pp. 55, 113 e in particolare le pp. 122-123 relative al capitolo «de libris ha-bendis». Nel capitolo generale celebrato a Montpellier nel 1324 viene raccomandato diconservare in modo scrupoloso il patrimonio librario presente nei singoli conventi; cfr.Antiquiores quae exstant definitiones Capitulorum generalium Ordinis, in «Analecta Au-gustiniana», 3 (1909-1910), p. 468.
22 In generale sulla figura del beato Giacomo si rinvia al già citato Giacomo da Vi-terbo al tempo di Bonifacio VIII, e in particolare al saggio di P. VIAN, Giacomo da Viter-bo: vita e opere. Una rassegna bibliografica, in Ibid., pp. 11-26, da aggiornare con la vo-ce curata dallo stesso VIAN, Giacomo da Viterbo, in Dizionario Biografico degli Italiani,54, Roma 2000, pp. 243-246.
23 Antiquiores quae exstant definitiones Capitulorum generalium Ordinis, in «Ana-lecta Augustiniana», 3 (1909-1910), p. 56; D. GUTIÉRREZ, Storia dell’Ordine di Sant’Ago-stino, I/1, Gli Agostiniani nel medioevo 1256-1356, Roma 1986, pp. 283-284; MATTEI,L’Ordine agostiniano a Viterbo cit., p. 144. Nessun documento del fondo della Trinitàreca indicazioni di materiale librario.
Un altro importante legame tra la comunità di Viterbo e Giacomo è rappresenta-to dal vicino convento di Monte Razzano, da cui dovevano provenire i primi frati ar-rivati a Viterbo (cfr. MATTEI, L’ordine agostiniano a Viterbo cit., pp. 136-138, 140-141).Nel Capitolo Generale di Ratisbona del 1290 viene infatti proposta la vendita di taleluogo per poter sovvenzionare parte dei suoi studi «Item diffinimus quod si vendaturlocus de Monte Racçanensi frater Iacobus de Viterbio, baccellarius parisiensis, habe-at XXV fl. aureos», cfr. S. LOPEZ, Gli antichi Capitoli della Provincia Romana (1274-1339), in «Analecta Augustiniana», 2 (1907-1908), pp. 291-297: 292.
24 Cfr. S. LOPEZ, Gli antichi Capitoli della Provincia Romana (1274-1339), in «Ana-lecta Augustiniana», 2-4 (1907-1910), passim. Per questo periodo storico sono gli unici
all’interno della quale nell’arco di pochi decenni tale convento vienead assumere un ruolo significativo divenendo, con Roma, Orvieto ePerugia, uno dei quattro conventi de primo gradu25. Negli atti dei ca-pitoli provinciali si trovano infatti rinnovate le disposizioni relativealla necessità di compilare gli inventari dei beni posseduti26, mentreper esempio proprio in un Capitolo tenutosi a Viterbo nel 1335 vieneconfermata la “definizione” secondo la quale i frati non potevanomuoversi all’interno della propria provincia o recarsi in altri conven-ti dell’Ordine «sine licteris testimonialibus», ma nessun esemplare diquesta tipologia documentaria sembre essersi conservato.
Nel convento viterbese dovevano essere poi conservate tutte lelettere papali relative alla Provincia Romana, assurgendo così a sededell’Archivio provinciale27, una volta individuato un luogo sicuro do-
Spigolature dalle carte agostiniane viterbesi 25
capitoli che si siano conservati. Per una panoramica sulla legislazione riguardo la ge-stione e conservazione del materiale documentario si rinvia a A. MAZZON, Il più anticoinventario dei documenti (1431) del convento agostiniano romano di San Trifone - San-t’Agostino, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», 40 (2010) 77, pp. 15-64: 19-25.
25 In esso, ad esempio, doveva essere istituita una scuola di grammatica, in ot-temperanza al Capitolo Provinciale del 1297, frequentata da scolari viterbesi e daquelli provenienti dalle vicine Corneto, Toscanella, Montefiascone, Orvieto e Acqua-pendente.
26 Si citano a pure titoli esemplificativo il Capitolo provinciale celebrato a San-ta Maria del Popolo il 23 aprile 1327 in cui si parla di un registro in cui elencare i be-ni mobili e immobili, (cfr. LOPEZ, Gli antichi Capitoli della Provincia Romana cit., 4,pp. 36-38). Mentre ad Orte, il 29 giugno 1330, il Capitolo provinciale stabilisce chetutti i priori della Provincia Romana, prima che venga riunito il capitolo in cui ver-ranno eletti il vicario e il discreto, compilino un «inventarium de omnibus bonis lociet de utilitatibus factis pro illo anno vel de debito si, quod absit, contraheretur» (ibid.,IV, pp. 91-92). A Perugia (luglio 1332; cfr. ibid., pp. 132-134) si prescrive che il prioreprovinciale faccia rinnovare il «registrum de bonis omnium locorum provincie» epertanto si ordina che ciascun priore tenga un quaderno in cui registrare le entrate ele uscite. Nel 1334 a Montecimino i frati stabiliscono che il padre provinciale debba«videre omnia cartularia, et eodem modo debeat per sententiam excommunicationiscogere fratres ad ‹dandum› in scriptis omnia bona eis ad usum concessa, et ponan-tur in registro contra omnia bona locorum» (ibid., pp. 137-138); definizione confer-mata nel Capitolo provinciale di Viterbo (24 luglio 1335) in cui inoltre si stabilisceche nessun frate possa andare in giro solo e senza lettere testimoniali (ibid., pp. 155-158). Infine nel Capitolo del 1337 celebrato a Montefiascone si ordina a tutti i prioridi compilare un «inventarium omnium rerum et utilitatum locorum, ita quod in car-ta ubi tale inventarium factum fuerit sit lectera electionis prioris, discreti ac vicarii,ita quod in eodem folio sive in eadem carta contineantur omnia, scilicet, inventa-rium, utilitates et electio prioris, discreti ac vicarii», prima di recarsi al capitolo pro-vinciale (ibid., pp. 160-161).
27 «Diffinimus quod lictere papales ad nostram provinciam pertinentes reducan-tur ad conventum nostrum de Viterbio, et ibi in aliquo loco tuto, arca vel scrineo re-ponantur et conserventur sub duabus clavibus, cum hoc ex diffinitione Capituli Gene-
ve conservare la documentazione, o meglio un vero e proprio conte-nitore dove tenerla chiusa sotto chiave («lictere papales ad nostraprovinciam pertinentes reducantur ad conventum nostrum de Viter-bo, et ibi in aliquo loco tuto, arca vel scrineo reponantur et conser-ventur sub duabus clavibus»).
Solamente durante il Capitolo provinciale svoltosi a Maglianonel maggio 1323 verrà deciso che le «lictere prioratus fiant in pro-priis locis», e soprattutto che «quilibet prior teneatur facere in locoin quo est prior unum cartolarium bonum et magnum, in quo debe-at scribere diligenter omnes introitus et expensas loci, et omnes ressacristie, pannos loci et alias massaritias loci predicti nullo diminu-to, ita quod priores qui post eum venerint omnia in dicto cartularioinveniant scripta». Finalmente si ha dunque notizia di un cartolario,che deve essere di buona fattura e di sostenute dimensioni, volumein cui in realtà devono essere registrate le entrate e le uscite relativeal convento e i beni posseduti, ma nel quale non è prevista alcunamenzione/registrazione esplicita di instrumenta o chartae28.
Se fino alla fine del XIII secolo l’unica indicazione rintracciatanelle disposizioni capitolari provinciali riguarda la registrazione deibeni presenti nella sacrestia, nel corso del XIV secolo gli Eremitani,per lo meno quelli della Provincia Romana, sembrano preoccuparsidi riporre in un luogo sicuro e sotto chiave i documenti. Anche senon si dimostrano particolarmente ligi, confrontando le prescrizioniprovenienti dal “governo centrale” e secondo quanto disposto nei re-gistri del generale Bartolomeo Veneto29, il quale, nel gennaio del1389, si trova costretto a richiamare tutti i priori e i rettori dei con-venti della Provincia Romana, i quali, sotto pena di scomunica e dicarcere, dovranno entro due mesi «omnia registra fecisse integralitercopiari, aliud registrum de quibuscumque bonis dicti conventus no-viter faciendo, si hoc anno non fecerit, copiandoque similiter»30.
Generalmente i frati eremitani e le loro comunità non possiedo-no beni e proprietà immobiliari tali da rendere necessario un depo-sito di documenti a loro salvaguardia31, considerando pure che, nelle
Antonella Mazzon26
ralis quelibet provincia facere teneatur, et hoc facere teneatur per procuratores pro-vincia infra festum beati Michaelis, alioquin eos vestimentorum provisine privamus»,cfr. LOPEZ, Gli antichi Capitoli della Provincia Romana cit., 2, pp. 298-301.
28 LOPEZ, Gli antichi Capitoli della Provincia Romana cit., 3, pp. 317-318.29 Bartholomaei Veneti O.S.A. Registrum generalatus, II, 1387-1389, cur. A. HARTMANN,
Roma 1998 (Registra Priorum Generalium, 4).30 Ibid., pp. 362-363, nr. 1104.31 In generale sulla documentazione di natura contabile conservata negli archivi
mendicanti si veda A. BARTOLI LANGELI, G.P. BUSTREO, I documenti di contenuto econo-mico negli archivi conventuali dei Minori e dei Predicatori nel XIII e XIV secolo, in L’eco-
Costituzioni di Ratisbona32, si era stabilito che nell’arco di un trien-nio fossero vendute tutte le case fino ad allora possedute. Ma «quel-la disposizione non arrivò in pratica a essere realizzata, sebbene mo-strasse chiaramente l’orientamento preso dagli Agostiniani in mate-ria di povertà»33, e da essa dipendesse la necessità di conservare ladocumentazione comprovante tali proprietà34.
Quindi l’individuazione delle reali proprietà del convento all’in-terno della città ma anche nel territorio circostante è un compitoche, nel caso specifico della comunità stanziata a Viterbo, potrebbepresentarsi più complicato a causa della mancanza di fonti di altranatura archivistica, specie i libri delle entrate e delle uscite e altri re-gistri di carattere amministrativo per tutti i secoli XIII e XIV35.
Spigolature dalle carte agostiniane viterbesi 27
nomia dei conventi dei frati minori e predicatori fino alla metà del Trecento. Atti delXXXI Convegno internazionale (Assisi, 9-11 ottobre 2003), Spoleto 2004 (Atti dei con-vegni della Società internazionale di studi francescani e del Centro interuniversitariodi studi francescani, nuova serie, 14), pp. 119-150; G.P. BUSTREO, Écrits conventuels,écrits urbains. La documentation des mendiants de Trévise aux XIVe et XVe siècles, inÉconomie et religion. L’expérience des ordres mediants (XIIIe-XVe siècles), sous la direc-tion de N. BÈRIOU – J. CHIFFOLEAU, Lyon 2009 (Collection d’histoire et d’archéologiemédiévales, 21), pp. 39-61.
32 Secondo quanto stabilito dalle Costituzioni compilate a Ratisbona nel 1290 ilprocuratore di ciascun convento doveva far scrivere «in libros» ogni bene spettante alconvento e annotare tutte le spese sostenute, spese di cui doveva dar conto una voltaal mese dinnanzi all’intera comunità conventuale (cfr. ARAMBURU CENDOYA, Las primi-tivas constituciones cit., p. 82). Purtroppo la contabilità relativa al convento viterbesesi è conservata soltanto a partire dal secolo XV, cfr. R.L. DE PALMA, Lavori edili nelladocumentazione contabile del convento della S.ma Trinità di Viterbo (sec. XV), in «Ar-chivio della Società romana di storia patria», 110 (1987), pp. 177-196: 177.
33 L. MARÍN, La storia. Dalla morte di s. Agostino al 1244-1256, in V. GROSSI, L. MA-RÍN, G. CIOLINI, Gli Agostiniani: radici, storia, prospettive, Palermo 1993, pp. 79-188: 177.
34 «La magna unio del 1256 … voluta, anche questa, e sancita da Roma con la ca-nonica sequela di litterae fondanti, e col crisma dato al compromesso cercato da quel-le diverse anime dell’unione sul problema della povertà: sussiste una “causa iusta etrationabilils” affinché i frati dimoranti “in locis eremitis vel a populorum frequentiaremotis” abbiano possessiones senza venir meno al voto di povertà, dal momento che,a differenza dei frati che dimoravano nei moderni loci, cioé nei conventi di città, nonpossono vivere delle elemosine dei fedeli. La mirabile formulazione sembra precorre-re quella visione duplice che poi, nel Trecento, i frati eremiti avranno della propriaesperienza di ordo, e questa figura quasi a chiasmo – possessiones nei deserti loci / pau-pertas nelle civitates – sembra già modulare quel motivo del locus desertus che si espri-merà al meglio nel secolo successivo, ora come mito delle origini, ora come cifra di-stintiva del frate agostiniano, frate della città che ‘manifesta’ di portare, nella propriastoria, la conoscenza del deserto e, nel proprio habitus, la possibilità sempre aperta diritornarvi» (GHIGNOLI, Gli archivi degli eremiti di Siena cit., pp. 256-257).
35 La serie della Riformanze, conservata a Viterbo presso la Biblioteca comunaledegli Ardenti, è costituita da 172 volumi e riguarda gli anni 1403-1870, cfr. P. MASCIO-
A complicare le cose ha sicuramente contribuito l’incendio del142236, durante il quale non sappiamo però quanto e quale materialesia andato realmente perduto. Non essendosi poi conservato alcuninventario relativo alla documentazione non è neppure possibile sti-mare quale potesse essere il patrimonio documentario di epoca me-dievale presente o per lo meno relativo al convento37.
Tra l’altro la comunità viterbese non stava passando un buonmomento già da qualche tempo, infatti nel novembre del 1419 il ge-nerale Agostino Favaroni «occasione ruine cellarii, dormitorii et aliisofficinis multum necessariis, ut reparari possint ne ex morosa dila-tione maius dampnum consequeretur» concedeva al convento di Vi-terbo di vendere e alienare le proprietà meno utili al convento finoad un valore di 300 ducati per mano dei venerabili cittadini e mae-stri Onofrio, Giovanni sarto e Ruffino Merichelli nonché un frate chedoveva essere scelto tra quelli del convento38.
***
L’edizione del fondo diplomatico relativo al convento viterbesepotrà rivelarsi un utile strumento per lo studio delle diverse intera-zioni realizzatesi tra l’ordine religioso e le istituzioni civili, per rico-struire quali siano state le dinamiche di penetrazione nella strutturaurbana e fra gli ampi strati del laicato urbano, cercando di seguire ilprocesso di organizzazione e di gestione economica del patrimonioimmobiliare urbano ed extra urbano che il nuovo convento andavaformando e consolidando già dalla metà del secolo XIII.
Antonella Mazzon28
LI, Le riformanze del Comune di Viterbo, in Storie a confronto. Le riformanze dei comu-ni della Tuscia alla metà del Quattrocento, Manziana - Roma 1995, pp. 109-127.
36 Per sostenere le spese necessarie al restauro dei danni subiti poiché «dicta do-mus sit casualiter igne combusta» interviene Martino V il quale il 26 luglio 1422 inviadue brevi: il primo diretto al vescovo cittadino affinché vengano dati 150 fiorini d’oroal convento eremitano presi dai beni spettanti alla Santa Sede per la «reparatione si-ve fabrica» del convento; l’altro è invece rivolto ai fedeli che vengono invitati a parte-cipare al restauro della casa eremitana ottenendo in cambio per un triennio l’indul-genza di quattro anni e quattro quarantene (BCArdenti, Trinità, pergg. 179 e 180; Alon-so, Regesta, III, p. 25 nr. 38).
37 Per esempio per il “vicino” convento di S. Agostino di Roma il più antico in-ventario relativo ai documenti risale al 1431-1432 ed è ora edito in MAZZON, Il più an-tico inventario dei documenti cit.
38 Dal registro del generale Favaroni, cfr. Roma, Archivio della Curia Generalizia[d’ora in poi AGA], Dd 4, f. 2r; ed. in «Analecta Augustiniana», 7 (1917-1918), pp. 216-217, sub data Siena, 21 novembre 1419. Dalla stessa fonte sappiamo poi che la setti-mana successiva viene nominato come priore del convento viterbese fr. Agostino diGiovanni, lector de Senis.
Il più antico documento che attesta la presenza agostiniana nel-la cittadina della Tuscia, attraverso l’esplicita menzione di un «locusfratrum Heremitanorum Ordinis Sancti Augustini in Viterbio», risa-le al 1256 e riguarda la vendita da parte di Raniero Altadonne a frateGiacomo, loro procuratore, di un pezzo di terra «cum cantonibusmuratis et inmuratis et lapidibus», posto fuori porta del Bove, «iux-ta carbonarias civitatis Novas et Veteres», e confinante con un altropezzo di terra già posseduto dagli stessi Agostiniani39. Si può pertan-to supporre che questo nucleo territoriale abbia costituito la prima“base” di insediamento e sia stato, se non il luogo in cui gli Eremita-ni hanno iniziato a costruire la loro chiesa, a partire dai muri e dal-le pietre già presenti nel terreno acquistato da frate Giacomo, per lomeno un loro spazio nei pressi della primigenia fondazione, ancheperché le zone limitrofe al convento eremitano, secondo quanto sug-gerito dalla documentazione due-trecentesca, risultano essere scar-samente urbanizzate40 e pertanto libere da altri “vincoli politico-ar-chitettonici”, come la distanza minima da rispettare nella costruzio-ne di due conventi mendicanti all’interno di uno stesso luogo.
La presenza dei frati eremitani in Viterbo, già attestata negli an-ni centrali del XIII secolo41, viene ufficializzata nel 1258 quando lachiesa agostiniana, o meglio l’altare maggiore, viene consacrato daOttone di Châteauroux, cardinale di Tuscolo, su incarico di Alessan-dro IV, e poi per mano dello stesso pontefice (il quale «fecit consecra-ri ecclesiam Sancte Trinitatis de Viterbio, ubi morantur fratres ere-mitarum ordinis Sancti Augustini per dominum Otonem, Dei gratiaTusculanum episcopum cardinalem, et sequenti mane ipse persona-liter, assistentibus sibi suis fratribus dominis cardinalibus et multisepiscopis, more debito paratis, sollempniter consecravit altare maiusdicte ecclesie»)42. Il papa concederà poi un’indulgenza a quanti
Spigolature dalle carte agostiniane viterbesi 29
39 BCArdenti, Trinità, perg. 6 (18 ottobre 1256); cfr. SIGNORELLI, Viterbo nella sto-ria della Chiesa, I, Viterbo 1907, p. 230 nota 20; MATTEI, L’Ordine agostiniano a Viterbocit., pp. 141-142.
40 Cfr. a tal proposito A. CORTONESI, Il lavoro del contadino. Uomini, tecniche, col-ture nella Tuscia tardomedievale, Bologna 1988 (Biblioteca di storia agraria medievale,5), p. 5 e nota 10.
41 Inizialmente i frati erano stanziati sul Monte Razzano (Monte Ragonese) e ilpapa Gregorio IX il 5 maggio del 1236 aveva concesso ai fedeli che si sarebbero reca-ti in visita alla loro chiesa dedicata a S. Maria nel giorno anniversario della sua con-sacrazione cento giorni di indulgenza (BCArdenti, Trinità, perg. 6). L’arrivo dei frati aViterbo dovette quindi seguire di poco all’acquisto del terreno di Raniero Altadonnaavvenuto il 18 ottobre del 1256. Cfr. supra nota 23.
42 Cfr. Viterbo, Biblioteca degli Ardenti, Fondo Comune, perg. 246 (anno 1291);MATTEI, L’Ordine agostiniano a Viterbo, pp. 145-146.
avrebbero visitato o sovvenzionato la chiesa dal giorno della dedica-zione, il 2 giugno, alla festa della natività della Madonna, ossia l’8settembre43. E nella cronaca di frate Francesco di Andrea da Viterbocosì viene ricordato l’evento: «Anno Domini 1257. Fu facta la chiesade la Ternità de Viterbo, et fu facto el muro al piede de Faule, cioè dale mura de la rupe de la porta de Buove insino a la porta del castel-lo, puosta sotto ad S.to Chimente»44.
Tra i documenti più interessanti per la storia dell’Ordine eremi-tano a Viterbo si possono sicuramente mettere in evidenza quelli re-lativi all’edificazione della cappella dedicata a sant’Anna, realizzatagrazie al generoso lascito del noto matematico, astronomo e cappel-lano pontificio Giovanni Campano45. Nella stessa cappella si radune-
Antonella Mazzon30
43 Cfr. SIGNORELLI, Viterbo nella storia della Chiesa cit., I, pp. 229-230 nota 20; A.CAROSI, Le epigrafi medievali di Viterbo, secoli V-XV, Viterbo 1986, p. 52 nr. 15; MATTEI,L’Ordine agostiniano a Viterbo cit., p. 145.
44 Cronaca inedita di fra Francesco di Andrea da Vitebo dei Minori, trascritta dalmanoscritto originale della biblioteca Angelica di Roma e pubblicata dal conte cav. F.Cristofori, Foligno 1888, p. 49.
45 Originario di Novara (dove nasce intorno al 1220), appartiene ad una fami-glia di notai. Fu cappellano di Urbano IV e medico personale di Bonifacio VIII.Muore tra il 9 e il 17 settembre 1296 a Viterbo e viene sepolto nella chiesa della SS.Trinità (cfr. A. PARAVICINI BAGLIANI, G.J. TOOMER, Campano da Novara, in DizionarioBiografico degli Italiani, XVII, Roma 1974, pp. 420-424; A. PARAVICINI BAGLIANI, Me-dicina e scienze della natura alla corte di Bonifacio VIII, in Roma anno 1300. Atti del-la IV settimana di studi di Storia dell’arte medievale dell’Università degli studi di Ro-ma “La Sapienza” (19-24 maggio 1980), a cura di A.M. ROMANINI, Roma 1983, pp.773-797: 775-779; T. BOESPFLUG, La curie au temps de Boniface VIII. Étude prosopo-graphique, Roma 2005 (Bonifaciana, 1), pp. 114-115, nr. 164). Il 10 giugno 1288 Nic-colò IV gli concede la facoltà di poter testare liberamente (BCArdenti, Trinità, perg.13) e Campano farà testamento il 9 settembre 1296 (BCArdenti, Trinità, perg. 22; ildoc. è stato edito da A. BONANNI, Il santuario della Madonna Liberatrice in Viterbo.Memorie storiche e documenti in gran parte inediti, Viterbo 1901, pp. 77-78, doc. I(ed. parziale), e da A. PARAVICINI BAGLIANI, Un matematico nella corte papale del seco-lo XIII: C. da N. († 1296), in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», XXVII (1973),pp. 98-129: 124-127 doc. 4; cfr. MATTEI, L’Ordine agostiniano a Viterbo cit. pp. 148-150). Successivamente Bonifacio VIII, il 27 gennaio 1302, confermerà al priore e aifrati eremitani di Viterbo la donazione a loro fatta, come da legato testamentario diCampano da Novara, di alcuni beni nella città e nel distretto di Viterbo (BCArdenti,Trinità, perg. 25; BONANNI, Il santuario della Madonna cit., pp.78-79, doc. II) e nel set-tembre del 1319 i frati eremitani prenderanno pieno possesso dei beni dotali desti-nati alla cappella di S. Anna (BCArdenti, Trinità, perg. 41; BONANNI, Il santuario del-la Madonna Liberatrice cit., pp. 79-80, doc. III); il 15 novembre del 1322 viene rila-sciata la quietanza per l’acquisizione da parte del vescovo di Viterbo, Angelo Tigno-si della quarta canonica (BCArdenti, Trinità, perg. 45).
rà il 28 maggio del 1320 l’intera cittadinanza – spaventata, secondole cronache del tempo46, da un violento uragano in cui erano stateidentificate schiere di demoni e altri infernali immagini – a seguitodelle indicazioni dell’immagine della Vergine che aveva invitato a re-carsi in preghiera nella chiesa della SS. Trinità chiedendo la prote-zione della Madonna lì dipinta. Sprofondati i demoni nel Bullicame,grazie all’intervento della Vergine e della sua miracolosa immagine,la cappella divenne luogo privilegiato per il culto mariano viterbeseprendendo da allora il nome di Maria «Liberatrice»47. Ancora oggi ta-le avvenimento viene celebrato con una processione solenne che tro-va la sua più antica testimonianza in un altro “frammento statutario”del 30 maggio 1344 anch’esso conservato nel fondo della Trinità48.
Fin da subito buoni dovettero poi essere i rapporti tra i frati delconvento e le locali istituzioni civiche come sembra suggerire la do-cumentazione relativa alla costruzione di una fontana in ottempe-ranza alla precisa e specifica regolamentazione di natura “statutaria”sulle acque49. E così sembrano essere nel corso del XIV secolo quan-
Spigolature dalle carte agostiniane viterbesi 31
46 Cfr. Miracolo della Madonna della santissima Trinità di Viterbo, Viterbo 1577;Maria vergine liberatrice dell’illustrissima città di Viterbo. Relazione del prodigioso con-flitto, e vittoria contro i demonij visibili, & inuisibili per mezzo della sua miracoloza im-magine ..., del P. baccellier Fr. Giovanni Agostino MANICCHI, Ronciglione 1662; I. CIAM-PI, Cronache e statuti della città di Viterbo, Firenze 1872, p. 33; Cronaca inedita di fraFrancesco di Andrea, p. 52; SIGNORELLI, Viterbo nella storia della Chiesa cit., I, pp. 397-398 note 30 e 31; MATTEI, L’Ordine agostiniano a Viterbo cit., p. 151.
47 Nella cappella della Madonna troverà sepoltura nel 1369 il cardinale Saragoz-za, morto a Viterbo il 4 di ottobre (Cronaca inedita di fra Francesco di Andrea cit., p.56: «Adì 4 de octobre morse in Viterbo el cardinale de Cesarea Augusta, et fu seppelli-to ne la chiesa de la Ternità ne la cappella della Madonna»). Si tratta di Guillaumed’Aigrefeuille il Vecchio (Lafont, 1326-Viterbo, 4 ottobre 1369); i suoi resti mortali fu-rono trasferiti in seguito a Limoges.
48 BCArdenti, Trinità, perg. 69 (copia del 30 aprile 1345); già edito da BONANNI, Ilsantuario della Madonna cit., pp. 80-82, doc. IV; cfr. SIGNORELLI, Viterbo nella storia del-la Chiesa cit., I, pp. 397-398 note 30 e 31, poi ripreso nella rubrica 146 del lib. IV dellostatuto del 1469 (Lo Statuto del comune di Viterbo del 1469, a cura di C. BUZZI, Roma2004 (Fonti per la storia dell’Itali medievale. Antiquitates, 24), pp. 360-361); MATTEI,L’Ordine agostiniano a Viterbo cit., pp. 151-153. Infine Urbano V nel 1369 concederà inperpetuo la processione, ottava e commemorazione annuale da farsi nella chiesa dellaSS. Trinità la seconda domenica di Pentecoste (BCArdenti, Trinità, perg. 110, 16 aprile1369; cfr. Urbain V, Lettres communes analysées d’aprés les registres dits d’Avignon et duVatican, VIII, a cura di M. HAYEZ, A.-M. HAYEZ, Rome 1982, p. 358 nr. 24585).
49 A. MAZZON, Ducere aquam et facere fontem. Una disposizione statutaria viterbe-se a favore degli Eremitani della Santissima Trinità, in Sit liber gratus, quem servulusest operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90°compleanno, a cura di P.CHERUBINI, G. NICOLAJ, Città del Vaticano 2012 (Littera antiqua, 19), pp. 463-473.
do per esempio viene siglato un accordo tramite una permuta, graziealla quale il convento, in cambio di diverse migliaia di blocchi di pe-perino dati al Comune, in quel momento in difficoltà economiche ri-spetto alla necessità di riparare le mura cittadine, otterrà un terrenoe un tratto di strada che va dalla chiesa della SS. Trinità alla porta diBove. Nel perfezionare l’accordo il consiglio comunale dei sedici bo-ni viri chiederà poi agli Agostiniani anche la costruzione di due nuo-ve porte per poter permettere un continuo e sicuro controllo die etnocte delle mura stesse50. Successivamente le due porte verranno rea-lizzate e le chiavi dovranno stare «continue penes priores et confalo-nerium ipsius civitatis»51. Mentre nell’estate del 1404 gli Agostinianiotterranno un altro campo, posto in una zona adiacente alla lorochiesa, «iuxta muros comunis, in contrata Turris Bovis» in cambiodella celebrazione quotidiana di una messa nella cappella del palaz-zo comunale52.
Interessanti spunti offrono i documenti relativi ad oblazioni53 etestamenti utili per analizzare alcuni aspetti devozionali e i rappor-ti che legavano i fedeli alla chiesa e al convento della SS. Trinità,ma anche come vedremo fonti insostituibili, ad esempio, per noti-zie sulla struttura architettonica della chiesa e del convento e suifrati in essi presenti. Per la prima tipologia documentaria accennosolo al caso di Francesca figlia del fu maestro Rainerio medico, evedova di Giovanni Brache della contrada di San Giovanni in Petradi Viterbo, la quale, «volens pro Christi amore et beate Marie sem-per virginis et anime sue salute in sancta religione Ordinis beati Au-gustini sub iure hobedientie se artare et residuum vite sue infraquantum sibi possibile erit regulari subicere discipline et Deo et
Antonella Mazzon32
50 La prima porta sarà «in muro prope portam et turrim Bovis, et aliam muroveteri dicti comunis, iuxta domum Angelutii Accursini de contrata Sancti Fausti-ni».
51 BCArdenti, Trinità, perg. 106; MARIANI, De conventu cit., pp. 230-232 nota 5.52 BCArdenti, Trinità, perg. 160 (1° luglio 1404).53 Si vedano ad esempio le oblazioni di Bartholutius Bonifatii domini Morvelli di
Viterbo (BCArdenti, Trinità, perg. 51; 5 dicembre 1329; Appendice documentaria, nr.3), e di Therio Tucii Egidii, macellaio, e della moglie Petruccia (BCArdenti, Trinità,perg. 90; 27 novembre 1351; Appendice documentaria, nr. 7).
Dell’oblata Grazia da Viterbo troviamo invece notizia nel registro del generaleBartolomeo Veneto, il quale nell’estate del 1387 le concede di recarsi a Roma per vi-sitare S. Pietro e altri luoghi santi (cfr. Bartholomaei Veneti O.S.A. Registrum genera-latus cit., II, p. 119 doc. 314, citato da A. CZORTEK, L’oblazione dei laici presso i fratieremiti di sant’Agostino nei secoli XIII e XIV, in «Analecta Augustiniana», 65 [2002],pp. 7-40: 20).
beate Marie virgini et beato Augustino perpetuo deservire», genu-flessa di fronte all’altare maggiore della S. Trinitatà «obtulit perso-nam suam Deo omnipotenti et beate Marie semper virgini et beatoAugustino» e ai due rappresentanti terreni dell’ordine ossia a fraPaolo di Pavia, provinciale della Provincia Romana, e Agostino Lel-li di Viterbo, priore della S. Trinità, cui la donna dona due vigneti eun appezzamento di terra54.
Passiamo in breve rassegna alcuni testamenti.Nel 1316 Beniventa, moglie di Gugliemo Plenerii Mangiavacche,
dispone di essere sepolta nella chiesa della SS. Trinità cui destina unavigna posta in contrada Rispalgi, lasciandone però l’usufrutto al ma-rito e, dopo che sarà anche lui morto, il fructus dovrà essere impiega-to per luminarie e ornamenti per la stessa chiesa agostiniana55. Beni-venta destina a fr. Iacoppo 100 soldi di denari paparini, e nel caso cheegli dovesse premorirgli tale cifrà andrà a colui che in quel tempo sa-rà il priore del convento eremitano. Allo stesso Iacoppo, che viene poinominato tra i suoi tre esecutori testamentari, dovranno essere dateanche 5 libbre di denari paparini. Il legame con il convento viene poisuggellato dall’indicazione del luogo in cui viene rogato l’atto, ossianel capitolo della Trinità, e alla presenza di ben nove frati56.
I frati della Trinità saranno invece nominati eredi dei beni siamobili sia immobili nel 1318 da Miglore, figlia di Giovanni Lori diVetralla, ma non li potrannno vendere, pena l’esclusione dall’ereditàche andrà in favore del vescovado viterbese — fatti salvi i legati a fa-
Spigolature dalle carte agostiniane viterbesi 33
54 BCArdenti, Trinità, perg. 149; 22 marzo 1394 e 11 settembre 1399 (Appen-dice documentaria, nr. 8). Cinque anni dopo frate Agostino, provinciale della Pro-vincia Romana e procuratore ed economo del convento della SS. Trinità, prende ilpieno possesso delle vigne e della terra lasciata a detta chiesa dall’oblata France-sca.
55 La vigna viene donata ai frati con l’obbligo di non venderla, sub pena di far-la pervenire all’ospedale di S. Spirito di Viterbo e del vescovado viterbese. I lascitipro anima e per la celebrazioni di diversi anniversari e messe riguardano diversechiese viterbesi. Alla chiesa di S. Faustino 20 soldi di paparini, a quella di Santa Ma-ria ad Gradus «pro anima sua et suorum peccatorum remissione» tre libbre di dena-ri di paparini, la stessa cifra viene destinata a quella di San Francesco «pro missiscantandis pro anima sua et suorum peccatorum remissione», mentre le chiese diSan Pietro de Castaneo e di S. Maria de Veritate «pro missis cantandis» dovrannoavere 40 soldi di paparini (BCArdenti, Trinità, perg. 36; 1° settembre 1316; Appendi-ce documentaria, nr. 1).
56 Si tratta dei seguenti frati, tutti appartenenti all’ordine degli eremiti di S. Ago-stino: Francesco in Città della Pieve, Bartolomeo di Viterbo, Tommaso di Montefiasco-ne, Tomaso subpriore, Bartolino di Viterbo, Nicola di Perugia, Giovanni di Castro, einfine Luca e Giovanni, entrambi di Viterbo.
vore dei frati Minori, dei Predicatori e dei suoi esecutori testamenta-ri57. Il documento viene rogato «in claustro Sancte Trinitatis infraduas portas», e quattro dei cinque testimoni sono dei frati dell’ordi-ne eremitano (si tratta di Mutio, Paulutio, Vanni di Viterbo e Pietrodi Orte).
Un altro testamento viene invece rogato, oltre vent’anni dopo,nell’orto della chiesa della Trinità, «qui ortus positus est post dictamecclesiam, iuxta muros communis Viterbii», e a dare valore all’attogiuridico sono chiamati come di consueto sette testimoni, tutti fratiagostiniani58. A disporre le sue ultime volontà è Domenico condamNicole un tempo di San Gemini e ora abitante in Viterbo, il quale no-mina tra i suoi esecutori testamentari, nonché fideiussori, il prioredella SS.ma Trinità. Egli dispone la donazione di un terreno a favo-re della chiesa eremitana con l’obbligo di utilizzare i frutti ricavati datale appezzamento per la costruzione di una cappella all’interno del-la stessa chiesa, dove egli dovrà essere sepolto e in cui dovrà esseresempre presente un religioso che celebri la Messa per l’anima sua eper quella dei suoi genitori.
Il temibile anno della peste nera registra due testamenti. Nelprimo Mutius Clementis, Dei spiritu agitatus, dona a fra Giacomo,maestro economo e procuratore e vicario generale dell’Ordine degliEremitani di S. Agostino, diversi beni immobiliari alla chiesa dellaTrinità affinché venga edificata una cappella, nella medesima chie-sa e simile a quella del maestro Campana («cum altitudine cappelledomini Campane et amplitudine dicte cappelle domini Campanepost tribunam»); e nello stesso giorno Cecco domini Paltoni, an-ch’egli Dei spiritu agitatus, dona – per la costruzione della stessacappella – un orto di sua proprietà pro anima sua et remissione pec-catorum59. L’atto viene rogato «in claustro secundo, sub porticu ca-stri ecclesie Sancte Ternitatis».
Di poco successivo è il testamento dell’orefice Iacobutio del fuTuccio di Viterbo della contrada di San Simeone60. Ai frati egli lasciauna casa posta nella sua contrada e un appezzamento in contrada
Antonella Mazzon34
57 Cfr. il codicillo testamentario in BCArdenti, Trinità, perg. 40 (15 dicembre 1318;Appendice documentaria, nr. 2).
58 Si tratta di Pietro Landi, Angelo Tucii Grassis, Iacobutio di Orte, Angelo, Gio-vanni e Marco entrambi di Corneto, e infine Salvato di Amelia; BCArdenti, Trinità,perg. 35 (27 marzo 1341; Appendice documentaria, nr. 4).
59 Entrambi gli atti sono in BCArdenti, Trinità, perg. 79 (7 maggio 1348; qui in Ap-pendice documentaria, nr. 5).
60 BCArdenti, Trinità, perg. 82 (27 luglio 1348; qui in Appendice documentaria, nr.6). Il convento entrerà in possesso della casa diverso tempo dopo, ossia con la morte
Vallis Mortis affinché costruiscano una capella in cui celebrare dicontinuo la messa e gli altri uffici divini da parte di un cappellanoscelto tra gli stessi frati (in caso di mancato rispetto di quanto da luidisposto sarebbero dovuti subentrare prima i frati della chiesa di SanFrancesco e poi l’episcopato cittadino). Iacobutio dispone inoltre lavendita di alcuni beni appartenuti alla defunta moglie Petruccia per-ché con il ricavato venga realizzato un calice per l’altare di detta cap-pella e per adornare lo stesso dona poi una grande tovaglia e due to-vaglioli. Mentre il ricavato dalla vendita di altre vesti e di «omnia fer-ramenta sua ad artem aurificum pertinentia» verrà distribuito daisuoi esecutori testamentari, tra cui si registra anche l’agostiniano An-gelo Tucii, «pro male ablatis incertis».
***
Oltre alla schedatura sistematica, fatta possibilmente tramitela realizzazione di ampi regesti, del materiale del XV secolo, ci siauspica un proseguimento dei lavori attraverso una ricognizionedei fondi notarili viterbesi conservati presso il locale Archivio diStato61 e l’edizione dei fondi pergamenacei più antichi relativi ad al-tri conventi sorti e gestiti dagli agostiniani nella Sabina e nella Tu-scia laziale. Infatti mentre le fondazioni del Lazio meridionale so-no state oggetto di diversi studi62, per quelle della parte centro set-tentrionale molto deve essere ancora fatto. In effetti manca a tut-
Spigolature dalle carte agostiniane viterbesi 35
di Odolina, moglie di Giacomo, un tempo sua erede universale (cfr. BCArdenti, Trini-tà, perg. 137, 29 giugno 1389; presa di possesso da parte di Bartolomeo Iacobi di Vi-terbo, sindaco, economo e procuratore del convento agostiniano).
61 TH. FRANK, Notai viterbesi del Trecento, in «Rivista storica del Lazio», 5 (1996),pp. 45-82.
62 Cfr. i recenti saggi di G. PESIRI, La presenza agostiniana a Cori nelle notitiedi padre Tommaso Bonasoli, in «Annali del Lazio Meridionale. Storia e storiogra-fia», 5/2 (2005), pp. 37-46; C. CIAMMARUCONI, Gli insediamenti agostiniani nella dio-cesi di Anagni e l’episcopato di frate Giovanni Pagnotta (1330-1341), in «Latium»,24 (2007), pp. 101-120; G. PESIRI, Documenti dell’archivio degli Agostiniani di Cori(1244-1503). Saggio di ricostruzione, in «Archivio della società romana di storiapatria», 131 (2008), 117-224; C. CIAMMARUCONI, Il primo insediamento eremitano aCori. Il locus di S. Agostino extra muros (1273-1467), in Il complesso monumenta-le di S. Oliva a Cori. L’età romana, medievale, rinascimentale e moderna, a cura diD. PALOMBI, P.F. PISTILLI, Tolentino 2008 (Monografie Storiche Agostiniane, NuovaSerie, 8), pp. 37-63; C. CIAMMARUCONI, Gli Eremitani di S. Agostino nel Lazio meri-dionale (XIII-XIV secolo), in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 63 (2009),pp. 379-408; C. CIAMMARUCONI, Il monastero di S. Margherita a Cori (1299-ante1451): la più antica fondazione agostiniana femminile a sud di Roma?, in «Analec-ta Agustiniana», 72 (2009), pp. 63-90.
t’oggi un rilevamento sistematico delle fondazioni mendicanti inrelazione alla documentazione ad essi relativa attualmente conser-vata63 e in generale uno sguardo d’insieme sulla presenza degli Or-dini Mendicanti nel Lazio64.
ANTONELLA MAZZON
Sapienza-Università di RomaVia di Monte del Gallo 14/10
00165 [email protected]
Antonella Mazzon36
63 Auspicabile il proseguimento del progetto del Centro Culturale Agostinianosulle fondazioni in Italia, specie le sezioni relative ai documenti e agli insediamenti.
64 Cfr. G. BARONE, Geografia ecclesiastica ed insediamenti monastici e conventuali,in Bonifacio VIII, i Caetani e la storia del Lazio, Roma 2004, pp. 133-140. Un primo eisolato tentativo venne avviato a metà degli anni ‘70 del secolo scorso, dai partecipan-ti a una tavola rotonda dedicata agli Ordini Mendicanti nei comuni dell’Italia centra-le (anni 1220-1348), ma il progetto diede solo risultati parziali, cfr. Les Ordres Men-diants et la Ville en Italie Centrale (v. 1220-1350), in «Mélanges de l’École Française deRome», 89 (1977), pp. 555-773. Sono poi seguiti studi relativi soprattutto all’architet-tura e all’urbanistica legata alle fondazioni religiose che hanno portato alla teorizza-zione della “città degli Ordini Mendicanti”, ma è mancato un approfondito e proficuodialogo con le fonti documentarie e statutarie.
APPENDICE DOCUMENTARIA
nr. 11316 settembre I, Viterbo
Testamento di Beniventa, moglie di Gugliemo Plenerii Mangna-vecchie, la quale dispone di essere sepolta nella chiesa della SS.maTrinità cui destina una vigna posta in contrada Rispalgi, lasciandoneperò l’usufrutto al marito e, dopo che sarà anche lui morto, il fructusverrà impiegato per luminarie e ornamenti per la stessa chiesa dellaS.Ma Trinità; la vigna viene donata con l’obbligo di non venderla conla pena di farla pervenire all’ospedale di S. Spirito di Viterbo e del ve-scovado viterbese.
Originale, Viterbo, Biblioteca degli Ardenti, SS. Trinità, pergamena 36(3547), [A]. Pergamena di mm 210 x 880.
Sul verso le annotazioni: «Testamentum domine Benvenute relinquentisecclesie nostre unam vineam» (sec. XV); «Testamento di d. Benvenute con cuilascia al convento una vigna detta Rispoglio, con onere che non si alieni sottopena che decada all’ospedale di S. Spirito di Viterbo» (sec. XIX); «Il nostro Ri-spoglio viene ascritto dal vecchio campione ad un frate, dunque forse questa la-scita non venne» (sec. XIX).
(S) In nomine Domini, amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo.CCC°XVI., Apostolica Sede pastore vacante per mortem dominiClementis pape quinti, indictione .XIIII., die primo mensis septem-bris. In presentia mei notarii et testium subscriptorum ad hec spe-cialiter vocatorum et rogatorum, domina Beniventa, uxor GuillelmiPlenerii Mangiavacche, sana mente et pura conscientia timens futuremortis periculum, nolens intestata decedere et nichil sit quod magisheredibus debeatur pro ut suppine mortis liber sit stilus et [...]ortumad quod iterum non redit arbitrium. Idcirco presens testamentumfecit et condidit quod a iure dicitur sine scriptis. In quo quidem testa-mento in primis reliquid episcopatui Viterbiensi pro anima sua etsuorum peccatorum remissione soldos .Vos. paparinorum. Item reliq-uit ecclesie Trinitatis de Viterbio apud quam sui corporis sepulturamelegit quandam suam vineam, positam in contrata Rispolgli, iuxtarem Vannis Karadonne, rem Petri Percolli et rem magistri IacobiCalçolarii et alios suos confines, reservato usufructu dicte vineeGuillelmo eius viro tempore vite sue tantum quem usufructum dictadomina reliquit Guillelmo viro suo predicto, post mortem autem dic-ti Guillelmi sui viri, fructus dicte vinee voluit et mandavit quod per-petuo convertatur in luminaribus et ornamentis ecclesie Sancte Trini-tatis predicte et pro vino divini sacrificii celebrandi in ecclesia supra-
Spigolature dalle carte agostiniane viterbesi 37
dicta(a). Item voluit et mandavit quod dicta vinea nullo tempore ven-datur vel distrahatur seu alienetur nec vendi, distrahi vel alienari pos-sit vel debeat per fratres ordinis Heremitarum Sancti Augustini et sivenderetur vel alienaretur dicta ecclesia Sancte Trinitatis cadat a iuresuo et perveniat ad hospitale Sancti Spiritus de Viterbio et episcopa-tum Viterbiensem. Item reliquid ecclesie Sancti Faustini65 soldos .XX.paparinorum. Item reliquid ecclesie Sancte Marie ad Gradus66 pro an-ima sua et suorum peccatorum remissione tres libras denariorum pa-parinorum. Item reliquid ecclesie Sancti Francisci67 pro missis can-tandis pro anima sua et suorum peccatorum remissione tres librasdenariorum paparinorum. Item reliquid ecclesie Sancti Petri de Cas-taneo pro missis cantandis pro anima sua et suorum peccatorum re-missione soldos .XL. paparinorum. Item reliquid ecclesie SancteMarie de Veritate68 pro missis cantandis pro anima sua et suorum pec-catorum remissione soldos .XL. paparinorum. Item reliquid ecclesieSancte Marie de Monte Carmelo decem libras denariorum paparino-rum quas iussit, voluit dictam ecclesiam debere habere infra unumannum a die mortis tueri proxime secute de hominis ipsius testatricisviro, de domo et terra cum oliveto relictis Iutio filio Marini subscrip-to inferius confinatis, volens etiam et mandans quod predictus Iutiusinfra dictum terminum solvere teneatur et debeat dicte ecclesie de re-lictu subscriptarum vinee et terre cum oliveto sibi facto dictas .X. li-bras paparinorum quas si dicta ecclesia non habuit infra terminumsupradictum liceat ex tunc dicte ecclesie sua auctoritate propria do-mum et terram cum oliveto subscriptis ipsi Iutio relictis intrare poses-sionem capere, vendere seque insolutum retinere sine pena legis etcurie denumptiandi et subastandi eidem ordinandi recessa remissa.Item reliquid Iutio filio Marini de Plano Scarlani suo nepoti iurelegati domum suam positam in contrata Sancti Nicolai de Plano Scar-lani iuxta rem Cinelli, viam publicam et alios suos confines. Itemreliquid Iutio Marini predicto iure legati quoddam suum petium terrecum oliveto positum in contrata Petre Late iuxta rem PetriBartholomei Petri Thosonis, rem Angeli Perse et viam publicam etalios suos confines quod tenent ab ea ad livellum heredes Leonar-ducii, salvo et reservato ecclesie Sancte Marie de Monte Carmelo iureet actione in dicto relicto .X. librarum quas voluit et mandavit dictam
Antonella Mazzon38
65 SILVESTRELLI, Città, castelli e terre della regione romana. Ricerche di storia medie-vale e moderna sino all’1800, (Città di Castello 1914), ed. Roma 19402, p. 655.
66 Per la storia del convento, nei suoi diversi aspetti, si veda Santa Maria in Gra-di, a cura di M. MIGLIO, Viterbo 1996.
67 SILVESTRELLI, Città, castelli e terre, p. 657.68 IBID, pp. 657-658.
ecclesiam debere habere et dictum Iutium solvere debere prout su-perius est expressum. Item reliquid religioso et honesto viro fratri Ia-coppo ordinis Heremitarum Sancti Augustini69 centum solidos denar-iorum paparinorum. Et si predictus frater Iacobus predecederet tes-tatrici predicte voluit et mandavit dictos .C. solidos dari et solvi prioriqui per tempora erit in ecclesia Sancte Trintatis predicte. Item reliq-uid Petrucio Bartholomei Petri Thosonis decem libras denariorumpaparinorum. Item reliquid Cecco Rubei decem libras denariorumpaparinorum. Item reliquid Brunelle, filie Mutii Ragni, decem librasdenariorum paparinorum, et si predicta Brunella premoriretur eidemtestatrici, voluit et mandavit dictas .X. libras dari et solvi aliis filiabusMutii supradicti. Item reliquid domine Pasane, uxori olim magistriAngeli, decem libras denariorum paparinorum. Item reliquid domineDyamante Martini quinque libras denariorum paparinorum in auxil-ium dotis filie sue maioris. Item reliquid Fytie domine Iohanne tres li-bras denariorum paparinorum. Item reliquid religioso et honesto vi-ro fratri Iacoppo predicto ultra et preter predictum relictum .C. soli-dos sibi factum quinque libras denariorum paparinorum. Item reliq-uid domine Iuliane Iacobi de Algero .XL. solidos paparinorum. Itemreliquid domine Vone, matri Iutii Vone, .XL. solidos paparinorum.Item reliquid Verdenoso, Pasque et Annese suis neptibus et filiabusBartholomei .XL. solidos paparinorum pro qualibet earum. Itemvoluit, mandavit et reliquid quod dos sua non petatur nec peti possita Guillelmo viro suo predicto in vita ipsius Guillelmi. Item reliquid,voluit et mandavit quod induantur de bonis suis quadraginta pau-peres in quorum cuiuslibet indumento dentur et expendantur .XXti.solidos denariorum paparinorum. Item voluit, reliquid et mandavitquod de bonis suis maritentur quatuor orfane secundum provi-sionem, beneplacitum et voluntatem executorum suorum infrascrip-torum. Item voluit, iussit et reliquid quod post mortem dicti Guillel-mi sui viri infrascripti sui executores et quilibet eorum possint et de-beant dotem suam predictam petere et recipere et ipsam dotem ex-pendere et distribuere pro anima sua et suorum peccatorum remis-sione prout ipsis executoribus melius et utilius videbitur et placebit.Item reliquid in opere cimiterii ecclesie Sancti Faustini tres librasdenariorum paparinorum dandas et solvendas quando fuerit dictumopus. Ad que omnia et singula supradicta exequenda et legata predic-ta solvenda et distribuenda fecit et reliquid suos executores et fide-icommissarios religiosum, providum et honestum virum fratrem Ia-coppum de Viterbio ordinis Heremitarum Sancti Augustini, Petrum
Spigolature dalle carte agostiniane viterbesi 39
69 Cfr. Capitula antiqua Provinciae Romanae, O.N., in «Analecta Augustiniana», 3(1909-1910), pp. 174-175, 249, 296, 317-320.
Bartholomei et Ceccum Rubei et quemlibet eorum, dans et concedenspredictis suis executoribus et eorum cuilibet licentiam et plenariampotestatem(b) bona sua omnia et singula tam mobilia quam immobil-ia pro predictis omnibus et singulis exequendis et legatibus predictissolvendis et distribuendis, vendendi, distrahendi et precium recipien-di prout ipsis executoribus placuerit et videbitur expedire. In omnibusautem aliis suis bonis mobilibus et immobilibus, iuribus et actionibuspresentibus et futuris sibi suos universales heredes instituit pauperesChristi. Et hec est ultima sua voluntas et suum ultimum testamentumquod et quam valere voluit iure testamenti, et si non valeret iure tes-tamenti valeret iure codicillorum et iure consuetudinario civitatisViterbii et omni modo et iure quibus melius potest. Cassans, irritanset anullans omne aliud testamentum, ultimam voluntatem seu codi-cillum per eam actenus factos, volens et mandans solum presensoctinere perpetaum firmitatem.
Actum fuit hoc Viterbii, in capitulo ecclesie Sancte Trinitatis,presentibus religiosis viris fratre Francisco de Castro Plebis, fratreBartholomeo de Viterbio70, fratre Thomaso de Monteflascone, fratreThoma subpriore, fratre Bartholino de Viterbio71, fratre Nicola de Pe-rusia72, fratre Iohanne de Castro, fratre Luca de Viterbio et fratre Io-hanne de Viterbio73 omnibus ordinis Heremitarum sancti Augustinitestibus ad hec specialiter vocatis et rogatis.
Et ego Laurentius olim Macthei Laurentii de Viterbio, alme Ur-bis prefecti auctoritate iudex ordinarius et notarius, predictis omni-bus et singulis interfui et rogatus ac etiam de mandato dicte testatri-cis scripsi et publicavi. Et supradictum additum silicet “pro vino di-vini sacrifici celebrandi in ecclesia supradicta” signavi in .XVIIa. li-nea et scriptum ante actum propria manu scripsi et signavi.
(a) da et pro vino a ecclesia supradicta, aggiunto con rinvio a fine docu-mento (b) segue -d- espunto
nr. 21318 dicembre 15, Viterbo
Codicillo testamentario di Miglore, figlia di Giovanni Lori di Ve-tralla, con cui dispone che eredi dei suoi beni mobili e immobili sia-
Antonella Mazzon40
70 Cfr. Capitula antiqua Provinciae Romanae, O.N., in «Analecta Augustiniana», 3(1909-1910), pp. 35, 38, 174.
71 Ibid., p. 248.72 Ibid., pp. 297-298.73 Ibid., p. 248.
no i frati Eremitani della S.ma Trinità di Viterbo, che non li potran-nno vendere, pena l’esclusione dall’eredità che andrà in favore del ve-scovado viterbese - fatti salvi i legati a favore dei frati Minori, dei Pre-dicatori e dei suoi esecutori testamentari.
Originale, Viterbo, Biblioteca degli Ardenti, SS. Trinità, pergamena 40(3551), [A]. Pergamena di mm 150 x 430.
Sul verso: «Codicellus d(omin)e Meioris de Vetralla» (sec. XV); «Codicil-lo di domina Migliore, figlia di Giovanni Lori di Vetralla che lasciò al nostroconvento tutti i suoi beni mobili e immobili. Ma non si specifica in che con-sistano questi beni» (sec. XVIII-XIX); «21 dic. 1318, codicillo» (sec. XIX).
(S) In nomine Domini, amem. Anno eiusdem nativitatis millesi-mo .CCC°XVIII., tempore domini Iohannis pape .XXII., mens(is) de-cembris die .XV., indictione .Ia. In presentia mei notarii et testiumsubscriptorum, cum domina Miglore filia olim Iannis Lori de Vetral-la fecerit testamentum scriptum manu mei notarii infrascripti, ip-sum testamentum ratificavit volens tamen aliqua de dicto testamen-to adere et minuere per presentem codicillum adidit et minuit inhunc modum, que domina Miglore voluit et mandavit quod omniabona sua mobilia et immobilia ad ipsam pertinentia vel spectantiaiure dominii vel quasi tempore mortis et ante sint et esse debeant fra-trum et conventus ecclesie Sancte Trinitatis de Viterbio et ad usumet comodum dictorum fratrum et conventus pro anima sua et paren-tum suorum perpetuo debeant remanere et in hiis bonis dicta domi-na dictos fratres et conventum sibi heredes instituit non obstante ali-quo relicto vel legato in dicto testamento contento et non obstanti-bus quibusdam aliis heredibus in dicto testamento expressis et etiamdeclaratis et quod dicta bona vel aliquid ipsorum per dictos fratresvel conventum vel aliam personam de cetero non possint vendi, per-mutari, impignorari, donari vel quoquomodo alienari, set semper vo-luit et mandavit permanere ad dictos fratres vel apud dictos fratreset conventum superius memoratum ad usum et alimenta et necessa-ria eorumdem et si acciderit aliquo tempore dicta bona vel aliquideorum per eos vel aliquem eorum vendi, obligari, permutari vel alie-nari vel inpingnorari voluit et mandavit quod statim ex nunc proutex tunc dicti fratres et conventus priventur a iure hereditatis predic-te et a dicta hereditate et succedat in dictis bonis et hereditate epi-scopatus civitatis Viterbii, salvis semper et reservatis relictis sive le-gatis factis fratribus Minoribus et Predicatoribus et executoribussuis. Et hec est ultima sua voluntas quam valere voluit iure codicil-lorum vel iure consuetudinario civitatis Viterbii vel iure cuiuscum-que alterius ultime voluntatis.
Spigolature dalle carte agostiniane viterbesi 41
Actum est hoc Viterbii, in claustro Sancte Trinitatis infra duasportas, presentibus fratre Mutio, fratre Paulutio et fratre Vanne deViterbio, fratre Petro de Orto74 Ordinis Sancti Agustini et MutioAngelutii testibus ad hoc specialiter a dicta domina vocatis et ro-gatis.
Et ego Bartholomeus olim domini Boncontis de Viterbio, aucto-ritate alme Urbis prefecti notarius, hiis omnibus interfui a dicta do-mina rogatus scripsi et publicavi.
nr. 31329 dicembre 5, Viterbo
Bartholutius Bonifatii domini Morvelli di Viterbo offre i suoi be-ni e se stesso come oblato alla chiesa della SS. Trinità.
Originale, Viterbo, Biblioteca degli Ardenti, SS. Trinità, pergamena 51(3562), [A]. Pergamena di mm 170 x 490.
Sul verso: «Obligatio Bartholutii … plura bona» (sec. XV, nota quasi deltutto abrasa); «5 dicembre 1329 obbligazione della chiesa della Trinità» (sec.XIX) e della stessa mano: «Nel 1329: Bartolomeo Bonifatii di Viterbo offer-se se stesso e molti de’ suoi beni a Dio e alla nostra chiesa della Trinità, li be-ni sono li seguenti: un pezzo di terra col prato posti nella contrada di Polizivicino al Conichio, il ius che ha sopra un casamento una volta di Corrado diPietro Mafeo posto nella contrada di S. Quirito. Il ius che ha sopra un ortouna volta di Mateuccio di Matia quale possiede Beralducio di maestro Pieroposto nella contrada di S. Michele. Il ius che ha sopra tre orticuli nel painodella Trinità. La mettà di una casa che ha pro indiviso con Tomaso Vanni a20 libbre di moneta di quei tempi che li dovevno li eredi di Piero Matheo daToscanella per una casa lasciatele da suo fratello»; «Cosa ci si raccapezza perqueste notizie?».
(S) In nomine Domini, amen. Anno eiusdem nativitatis.M°CCC°XXVIIII°., tempore domini Iohannis pape .XXII., indictio-ne .XIIa. mens(is) decembris die .V. intrante. In presentia mei nota-rii et testium subscriptorum, Bartholutius Bonifatii domini Morvel-li de Viterbio obtulit, tracstulit ‹sic› et mandavit se et bona sua in-frascripta et iura sua que habet in infrascriptis suis bonis scilicet ob-tulit unum summ petium terre cum prato positum in contrata Pala-tiorum, iuxta rem Cole domini Marci, a duabus partibus, iuxta Co-nichium et fossatum et iuxta viam publicam et rem heredum An-dreotii pecudarii et alios suos confines et ius quod habet in accasa-
Antonella Mazzon42
74 Ibid., pp. 250, 318.
mento olim Corradi Petri Maffei posito in contrata Sancti Quiriciiuxta rem magistri Mathei Mutii, rem ser Egidii ser Fatii et rem Ra-nucepti domine Beccarie et iuxta viam a duabus partibus et iusquod habet in quodam orto olim Mactheotii domine Mathee quempossidet Veraldutius magistri Petri et fratres eius, posito in contra-ta Sancti Mi‹cha›elis, iuxta rem heredum Sylvestri Gentilis Pasqua-lis, rem Nardi Ciaffarini et fossatum et viam publicam et ius quodhabet in tribus orticellis positis in Plano Trinitatis iuxta muros Com-munis, rem Portii magistri Rollandi, rem Thome Vannis Ciurianneet alios suos confines et medietatem unius casalini quod habet com-mune pro indiviso cum heredibus Thomai Vannis Ciurianne, iuxtarem Cole Iannis Canis et iuxta viam publicam a duabus partibus etalios suos confines et .XX. libras paparinorum quas habere debet abheredibus Petri Mathei de Tuscanella causa relicti sibi facti pro unocasalino ipsius Bartholutii fratris Deo et ecclesie Sancte Trinitatis deViterbio in manibus religiosi et honesti viri fratris Pauli de Peru-scio75 prioris ipsius ecclesie Ordinis Heremitarum Sancti Augustiniet ipsi fratri Paulo priori recipienti vice et nomine ipsius ecclesiequas possessiones et que bona promisit dictus Bartholutius eidemdomino priori recipienti pro ipsa ecclesia perpetuo defendere abomni persona in curia et extra et constituit se suo nomine posside-re donec possessionem intraverit corporalem quam intrandi propriaauctoritate et retinendi deinceps dictus Bartholutius eidem priorirecipienti pro ipsa ecclesia dedit et concessit licentiam et liberampotestatem et ex nunc ex pacto habito inter ipsum dominum prio-rem et Bartholutium concessit dictus Bartholutius eidem dominopriori recipienti pro ipsa ecclesia licentiam et liberam potestatemipsa bona et iura vendendi cui voluerit pro pretio quod convenirepoterit et pretium recipiendi et de eo faciendi quod voluerit. Queomnia et singula supra et infrascripta promisit dictus Bartholutiuseidem fratri Paulo priori recipienti et stipulanti iure et nomine dic-te ecclesie et iuravit ad sancta Dei Evangelia, tactis scripturis, per-petuo facere, actendere et observare et rata et firma habere et tene-re et contra oblationem predictam et presentis contractus tenoremaliquo tempore non facere vel venire ratione aliqua exceptione sivecausa et refectione dampni et expensarum litis et extra sub obliga-tione et ypotheca omnium bonorum suorum presentium et futuro-rum, mobilium et immobilium, et sub pena .CC. librarum paparino-rum inter eos legitime stipulata et promissa qua soluta vel non, ra-
Spigolature dalle carte agostiniane viterbesi 43
75 Cfr. Donatio quedam fr. Pauli de Perusio (Facta Perusii 23 augusti 1295), in«Analecta Augustiniana», 3 (1909-1910), pp. 87-88; Capitula antiqua Provinciae Roma-nae, O.N., in ibid., p. 174; 4 (1911-1912), p. 90.
to manente contractu, et ad maiorem cautelam dictus dominusprior recepit dictum Bartholutium ad obsculum pacis nomine vereoblationis et promisit bonum nomen in defensione dictarum rerumoblatarum Bartholutius antedictus.
Actum est hoc Viterbii, in loco capituli et etiam in capitulo eccle-sie Sancte Trinitatis, presentibus magistro Bartholomeo magistri Io-hannis, Dominico Petruccioli, fratre Dyonisio lectore, fratre Augusti-no lectore de Viterbio, fratre Bartholo lectore, fratre Stephano, fratrePetro Landi, fratre Paulo priore Tuscanelle ordinis HeremitarumSancti Augustini in capitulo congregatis et pluribus aliis testibus adhec vocatis et rogatis.
ET Ego Matheus magistri Iohannis Mathei Caçati notarii de Vi-terbio, auctoritate alme Urbis prefecti iudex ordinarius et notarius,predictis omnibus interfui et rogatus scripsi et publicavi.
nr. 41341 marzo 27, Viterbo
Domenico condam Nicole un tempo di San Gemini e ora abi-tante in Viterbo, fa testamento istituendo sua erede universale lamoglie Altovenuta; nomina suoi esecutori testamentari nonché fi-deiussori Giovanni, arciprete della chiesa Maggiore di Viterbo, e ilpriore della SS.ma Trinità sempre di Viterbo. Dispone la donazionedi un terreno a favore della chiesa della SS.ma Trinità con l’obbli-go di utilizzare i frutti ricavati da tale appezzamento per la costru-zione di una cappella all’interno della stessa chiesa, dove egli dovràessere sepolto.
Copia autentica, Viterbo, Biblioteca degli Ardenti, SS. Trinità, pergame-na 35 (3546), [B] del 26 maggio 1341. Pergamena di mm 180 x 565.
Sul verso: «come andò a finire?» (sec. XIX); «Testamentum […] Gemini[…] in cui lasciò al nostro convento della SS.ma Trinità di questa città unpezzo di terra in contrada Montaroni col peso di fare una cappella nella no-stra chiesa del fruttato del dette terreno e dirvi poi giornalmente la messa perl’anima sua e dei suoi genitori; rogò Fardo di Gentili, alli 27 marzo 1312»(sec. XIX); «27 marzo 1312, particola di testamento» e «1341» (mano moder-na a matita).
La copia è così introdotta: (S) In nomine Domini, amen. Hoc est exem-plum quarundam particularum cuiusdam testamenti publici scripti et publi-cati manu Sinibaldi magistri Bartholomei olim Petri Iannis Ricciuti notariide Viterbio quarum particularum tenor talis est: … Segue l’autenticazionecon le sottoscrizioni notarili: Lectum et ascultatum fuit hoc exemplum cumsuo originali auctentico instrumento testamenti predicti, non vitiato, non
Antonella Mazzon44
cancellato nec in aliqua parte sui corrupto vel leso, Viterbii in ecclesia San-cte Marie de Salute, presentibus, videntibus, legentibus et ascultantibus tamexemplar quam exemplum infrascriptis discretis viris licteratis videlicet serIacobo condam Petri Pauli iudice ordinario et notario et magistris MartinoGentilis et Martino olim magistri Laurentii notariis de Viterbio, testibus adpredicta omnia et singula vocatis et rogatis, cui abscultationi et lecture etomnibus et singulis supradictis dictus ser Iacobus iudex ordinarius suam or-dinariam auctoritatem interposui et decretum. Sub annis a nativitate Domi-ni .M°CCC°XLI°., indictione nona, tempore domini Benedicti pape .XII., die.XXVI. mensis maii.
(S) ET ego Martinus Gentilis de Viterbio, alme Urbis prefecti auctorita-te notarius et iudex ordinarius, predictis lecture auctoritatis et decreti inter-positioni una cum prefatis iudice ordinario et notariis interfui et quia dic-tum exemplum cum suo originali auctentico instrumento testamenti predic-ti concordare vidi, legi et inveni ideo me subscripsi in testem et meum con-suetum signum apposui.
(S) ET ego Martinus olim magistri Laurentii de Viterbio, auctoritate al-me Urbis prefecti notarius et iudex ordinarius, predictis lecture auctoritatiset decreti interpositioni una cum prefatis iudice ordinario et notariis inter-fui et quia dictum exemplum cum suo orriginali auctentico instrumento te-stamenti predicti concordare vidi, legi et inveni ideo me subscripsi in testemet meum consuetum signum apposui.
(S) Et ego Iacobus condam Petri magistri Pauli de Viterbio, auctoritatealme Urbis prefecti iudex ordinarius atque notarius, predictis lecture et as-scultationi una cum prefatis notariis interfui et quia dictum exemplum cumsuo originali instrumento predicto concordare vidi, legi et inveni ideo mesubscripsi et signum meum consuetum apposui ac meam ordinariam aucto-ritatem interposui et decretum.
Et ego Fardus condam Gentilis de Viterbio, alme Urbis prefecti auctori-tate ‹aggiunto nell’interlinea› notarius et iudex ordinarius, predictis lecture,ascultationi auctoritatis et decreti interpositioni una cum prefatis iudice or-dinario et notariis interfui et predictum exemplum prout inveni in suo origi-nali auctentico instrumento predicto ita hic de verbo ad verbum scripsi etexemplavi, nichil addens vel minuens quod mutaret substantiam veritatis etde mandato et auctoritate dicti iudicis ordinarii in hanc publicam formamreddegi.
In nomine Domini, amen. Anno Domini .M°CCC°XLI°., temporedomini Benedicti pape .XII., die .XXVII. mensis martii indictione no-na. In(a) presentia mei notarii et testium subscriptorum ad hec specia-liter vocatorum et rogatorum, Dominicus condam Nicole olim deSancto Gemino et nunc habitator civitatis Viterbii, sanus corpore etmente conscientia pura considerans tempus esse fragile et caducum
Spigolature dalle carte agostiniane viterbesi 45
et quod nemo in iudicio confidere potest volens saluti anime sue pro-videre cupiens quod bona sua secundum suam dispositionem libereremaneant(b) presens testamentum nuncupativum(c) quod a iure dici-tur sine scriptis per manus mei notarii infrascripti in hunc modumfacere procuravit. In primis reliquit venerabili patri et domino domi-no Angelo Viterbiensi et Tuscanensi episcopo76 quinque solidos papa-rinorum. Item reliquit, iussit et legavit ecclesie Sancte Trinitatis Or-dinis Sancti Agustini de Viterbio unum suum petium terre positumin pertinentiis Viterbii, in contrata Montaroni iuxta rem heredumdomini Peponis Gatti, iuxta rem heredum Nerii de Montealto, viampublicam et alios suos confines, cum hac conditione videlicet quodde fructibus ipsius petii terre fiat una capella scilicet in loco ubi eritsepultus dictus Dominicus et ipsa capella fiat in ecclesia supradictaSancte Trinitatis et quod in dicta capella continue serviat unus reli-giosus presbiter qui continue dicat missam pro anima sua, patris etmatris sue. Et quod fructus ipsius petii terre deveniant et sint presbi-teri qui in dicta cappella serviat. Et si fructus dicti petii terre essentplus pro vita dicti presbiteri illud plus perveniat ad manus cappella-ni dicte cappelle pro anima sua et dicat orationes apud quam eccle-siam elegit sibi sui corporis sepulturam. Item reliquit et legavit et ce-tera. Et ad predicta omnia et singula iudicia et legata solvenda et di-stribuenda prefatus Dominicus fecit, constituit et dimisit suos execu-tores et fideicommissarios venerabilem virum dominum Iohannemarchipresbiterum Maioris ecclesie Viterbiensis, religiosum virum . .priorem ecclesie Sancte Trinitatis de Ordine Sancti Agustini de Viter-bio, ut fideliter adimpleant votum suum testamenti presentis. In om-nibus aliis bonis suis mobilibus et immobilibus, presentibus et futu-ris, ubicumque sint et reperiri poterunt prefatam dominam Altave-nutam eius uxorem heredem universalem sibi instituit atque fecit. Ethec est ultima sua voluntas suumque ultimum testamentum et fina-les dispositiones, quam et quod dictus testator esse voluit et manda-vit valere iure testamenti et si iure testamenti non valeret, voluit iu-
Antonella Mazzon46
76 Angelo Tignosi, canonico lateranense, vescovo di Viterbo dal 19 marzo 1318.Nel 1319 è nominato rettore del Patrimonio e il 5 marzo 1322 è coadiutor del vicarioUrbis, mentre nel 1325 viene lui stesso nominato vicario Urbis. Muore il 18 dicembre1343; cfr. C. EUBEL, Hierarchia Catholica Medii Aevi sive summorum pontificum, s.r.E.cardinalium, ecclesiarum antistium serie ab anno 1198 usque ad annum 1431 perductae documentis tabularii praesertim Vaticani, I, Monasterii 19132, p. 532 e nota 7; M. AN-TONELLI, Di Angelo Tignosi vescovo di Viterbo e d’una sua relazione al pontefice in Avi-gnone, «Archivio della Società romana di storia patria», 51 (1928), pp. 1-14; E. PETRUC-CI, Vescovi e cura di anime nel Lazio, in Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà delXV secolo, Attti del VII Convegno di storia della Chiesa in Italia (Brescia, 21-25 settem-bre 1987), I, Roma 1990, pp. 429-546: 445-447, 463.
re codicillorum et cuiuslibet ultime voluntatis ac iure consuetudina-rio civitatis Viterbii et omni modo et iure quibus melius valere potest.Cassans et irritans omne aliud testamentum omnesque codicillos etcuiuslibet ultime voluntatis et finales dispositiones factas actenusper dictum testatorem que manu cuiscumque notarii apparerent. Ethoc tamen ultimum suum testamentum suamque ultimam voluntan-tem et finalem dispositionem esse asseruit, voluit et mandavit quodet quam dictus testator esse voluit et valere et tenere perpetuam fir-mitatem. Actum est hoc Viterbii in orto ecclesie Sancte Trinitatis deViterbio Ordinis Sancti Agustini, qui ortus positus est post dictam ec-clesiam, iuxta muros communis Viterbii; presentibus religiosis virisfratre Petro Landi, fratre Angelo Tucii Grassis, fratre Iacobutio deOrto, fratre Angelo, fratre Iohanne de Corneto, fratre Salvato deAmelia et fratre Marcho de Corneto de dicto ordine sancti Agustinitestibus ad hec specialiter vocatis et rogatis. Et ego Sinibaldus magi-stri Bartholomei olim Petri Iannis Ricciuti notarii de Viterbio, aucto-ritate alme Urbis prefecti notarius et iudex ordinarius, predictis om-nibus interfui, rogatus scribere scripsi et publicavi.
(a) B Im (b) re aggiunto nell’interlineo (c) B nunccupativum
nr. 51348 maggio 7, Viterbo
Mutius Clementis, Dei spiritu agitatus, dona a fra Giacomo, mae-stro economo e procuratore e vicario generale dell’Ordine degli Ere-mitani di S. Agostino, diversi beni immobiliari alla chiesa della Tri-nità perchè venga edificata una cappella, vicino e simile a quella delmaestro Campana, nella medesima chiesa.
Lo stesso giorno Cecco domini Paltoni, anch’egli Dei spiritu agi-tatus, dona – per la costruzione della stessa cappella – un orto di suaproprietà pro anima sua et remissione peccatorum.
Copia autentica, Viterbo, Biblioteca degli Ardenti, SS. Trinità, pergame-na 79 (3590), [B] del del 25 febbraio 1350 dai protocolli del notaio Nicolamagistri Petri Raynerii di Viterbo. Pergamena di mm 185 x 380.
Sul verso: «7 maggio 1348. Donazione alla echiesa della Trinità» (sec. XIX).La copia è così introdotta:
(S) In nomine Domini, amen. Hoc est exemplum quorumdam protocol-lorum repertorum in libro sive quaternutio protocollorum et inter alia pro-tocolla olim magistri Nicole magistri Petri Raynerii notarii iam defunctiquorum quidem protocollorum et libri tituli tenor talis est: … Segue l’auten-
Spigolature dalle carte agostiniane viterbesi 47
ticazione e sottoscrizione notarile: ET ego Iohannes magistri Petri condamVerardi notarii de Viterbio alme Urbis prefecti auctoritate notarius et iudexordinarius predicta omnia et singula prout inveni in dictis eorum orriginali-bus protocollis ita hic fideliter de verbo ad verbum nullo addito vel minutoper quod veritatis substantia mutaret fideliter scripsi et exemplavi et unacum discretis viris magistro Petro Verardi de Viterbio iudice ordinario et no-tario, ser Thoma eius filio et ser Antonio Cecconi notariis testibus de ipsisorriginalibus protocollis cum dictis exemplis seu copiis diligentem collatio-nem feci et quia utrumque concordare inveni, dictos exemplos seu copias demandato auctoritate et decreto discreti viri magistri Petri Verardi iudicis or-dinarii et notarii supradicti scripsi copiavi et exemplavi et in hanc formampublicam reddegi. Qui magister Petrus iudex ordinarius et notarius sedenspro tribunali in domo sua posita in civitate Viterbii, in premissis suam auc-toritatem interposuit et decretum, sub annis Domini millesimo .CCCL., tem-pore domini Clementis papa sexti, indictione tertia die .XXV. in mense fe-bruarii.
Cit. SIGNORELLI, Viterbo nella storia cit., p. 396 nota 28; MARIANI, De con-ventu nostri cit., p. 230, nota 4.
In nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo .CCCXLVIII°.tempore domini Clementis pape sexti, indictione prima, diebus etmensibus infrascriptis, infrascripta sunt protocolla seu contractusscripta et publicata manu mei Nicolai magistri Petri Raynerii notariide Viterbio, diebus et mensibus infrascriptis. Die .VII. mensis maii,actum est hoc Viterbii in claustro secundo, sub porticu castri eccle-sie Sancte Ternitatis, presentibus hiis testibus Iacobo domini Bocchi-sciani, Vanne Tucii Arnati et Torsulino magistri Tursi, magistro Io-hanne magistri Petri Raynerii, Mutius Clementis Dei spiritus agita-tus dedit, cessit, donavit et habere concessit reverendo viro dominofratri Iacobo magistro yconomo et procuratori et vicario generalisOrdinis Heremitarum Ordinis Sancti Agustini de Viterbio ibidempresenti et recipienti vice et nomine capituli et conventus dicte eccle-sie et pro dicta ecclesia Sancte Ternitatis de Viterbio pro quadamcappella fienda, edificanda in dicta ecclesia iuxta cappellam dominiCampane quod deahitur per ecclesiam Sancte Ternitatis cum altitu-dine cappelle domini Campane et amplitudine dicte cappelle dominiCampane, post tribunam huic ad .XVIII. menses proxime venturosexpensis dicti yconomis et procuratoris dicte ecclesie quatuor domossine orto dicti Cobutii simul medietas positas Viterbii, in contrataPlani Ternitatis, iuxta rem dicte ecclesie, iuxta rem dicti Cobutii, viaspublicas a duabus partibus et alios suos confines. Item unum cupel-larum, ortos et territoria simul iuncta iuxta rem dicte ecclesie et viaspublicas et alios suos confines. Item quamdam(a) domum discoper-
Antonella Mazzon48
tam positam in dicta contrata iuxta rem ecclesie predicte ‹et› viampublicam.
Eodem die, loco et testibus Ceccus domini Paltoni Dei spirituagitatus pro dicta cappella edificanda dedit, donavit et concessit dic-to procuratori et yconomo dicte ecclesie pro dicta ecclesia quemdamsuum ortum positum in dicta contrata iuxta rem ser Nini domini Ia-cobi, iuxta rem Cechini macellarii pro anima sua et remissione pec-catorum.
Et ego Nicolaus olim magistri Petri Raynerii notarii de Viterbio,alme Urbis prefecti auctoritate notarius et iudex ordinarius, predic-tis omnibus interfui rogatus scripsi et publicavi.
(a) quamdam scritto due volte
nr. 61348 luglio 27, Viterbo
Testamento dell’orefice Iacobutio del fu Tuccio di Viterbo dellacontrada di S. Simeone, il quale dispone che una casa e la terra e ilrelativo diritto ereditario su questi beni, che furono di sua moglie Pe-truccia, vadano prima alla di lei madre Aldiuda e dopo la sua mortealla chiesa della Trinità con l’obbligo di realizzare una cappella in cuiun prete dovrà celebrare in perpetuo messe e ufficini divini. Qualorain frati eremitani non ottemperassero a tale disposizione i beni pas-serrano alla chiesa di San Francesco di Viterbo, e in caso di negligen-za agli obblighi predispoti all’episcopato viterbese.
Originale, Viterbo, Biblioteca degli Ardenti, SS. Trinità, pergamena 82(3593), [A]. Pergamena di mm 180/185 x 735.
Sul verso: «27 luglio 1348. Testamento» (sec. XIX).Cit. SIGNORELLI, Viterbo nella storia cit., p. 396 nota 28; MARIANI, De con-
ventu nostri cit., p. 230, nota 4.
(S) In nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo.CCCXLVIII., tempore domini Clementis pape .VI., indictione pri-ma, die .XXVII. mens(is) iulii. In presentia mei notarii et testiumsubscriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum, Iacobu-tius olim Tucii aurifex de Viterbio et contrata Sancti Symeonis in-firmus corpore, sanus tamen mente et conscientia pura, timens fu-ture mortis periculum nolens decedere intestatus set volens bonasua disponere et anime sue salubriter providere presens nuncupa-tivum testamentum quod a iure dicitur sine scriptis per manus meinotarii infrascripti fieri et scribi facere procuravit. In quo quidem
Spigolature dalle carte agostiniane viterbesi 49
testamento in primis reliquid domino . . Viterbiensi episcopo duossoldos paparinorum. Item voluit et mandavit quod vendantur unasua roba de blada, una cotta sua, una roba de viridi olim dominePetrucie uxoris olim sue, videlicet tunica, guarnachia et pellis et depretio ipsarum rerum fiat unus calix altaris in ecclesia Trinitatis deViterbio pro infrascripta cappella. Item reliquid ecclesie Trinitatisde Viterbio pro altari infrascripte cappelle unam tobaliam man-gnam et duos tobaglolos mixtos ad sericum. Item voluit et manda-vit quod vendantur una sua guarnachia de viridi femminea etunum suum corectum et omnia ferramenta sua ad artem aurifi-cum pertinentia per infrascriptos suos executores et pretium ipsa-rum rerum distribuatur per infrascriptos suos executores pro ma-le ablatis incertis prout eis melius visum fuerit. Item reliquid ec-clesie Sancti Fortunati de Viterbio duodecim soldos paparinorumquos dixit se habuisse de bonis dicte ecclesie. Item reliquid eccle-sie Sancti Symeonis de Viterbio pro opere dicte ecclesie .XXti. sol-dos paparinorum. Item reliquid domine Aldiude uxori olim ColeTodini socere sue unum medialem grani et usumfructum in vitasua tantum omnium bonorum et hereditatis olim domine Petruciefilie olim ipsius domine Aldiude uxoris olim dicti testatoris in qui-bus bonis dicta domina Petrucia instituit sibi heredem dictum Ia-cobutium testatorem olim virum suum in suo ultimo testamentoscripto ut dicitur manu magistri Iohannis Sandri domini Cristofa-ri notarii. Post mortem vero ipsius domine Aldiude dicta bona ethereditas sint et deveniant ad ecclesiam Trinitatis de Viterbio procappella infrascripta. Item reliquid ecclesie Trinitatis de Viterbioquandam suam domum positam in civitate Viterbii in contrataSancti Symeonis, iuxta rem heredum Seppi Naldi, rem ecclesieSancti Systi, viam publicam et alios suos confines; et quoddam pe-tium terre positum in tenimento Viterbii in contrata Vallis Mortis,iuxta rem Colai Iutii Mangnani, rem Tucii Odutii de Fabuli, viamet alios suos confines; et ius quod habet in bonis et hereditate do-mine Petrucie olim sue uxoris pretextu et ex tenore successionis etinstitutionis ipsius domine Petrucie ex testamento ipsius dominePetrucie scripto ut dicitur manu magistri Iohannis Sandri dominiCristofari de Viterbio notarii videlicet post mortem domine Aldiu-de uxoris olim Cole Todini socere dicti testatoris de quibus domo,petio terre et iure dicte hereditatis voluit et mandavit quod in dic-ta ecclesia Trinitatis fiat una cappella in qua in perpetuum conti-nuo sit unus cappellanus ex fratribus dicti loci presbiter qui omnidie dicat et celebret missas et alia divina officia pro anima sua etparentum suorum et ipsam cappellam de dictis domo, petio terreet iure hereditatis dotavit. Et si dicta ecclesia Trinitatis et fratres
Antonella Mazzon50
dicte ecclesie fuerint negligentes facere fieri dictam cappellam etin ea tenere dictum cappellanum ad celebrandum missas et alia di-vina officia omni die, ut supra dictum est, quod dicte domus, ter-ra et ius dicte hereditatis sint ecclesie Sancti Francisci de Viterbiocum dicto onere dicte cappelle modo quo supra fiende. Et si dictaecclesia Sancti Francisci seu fratres dicte ecclesie cessaverint seufuerint negligentes ad predicta supra specificata quod dicta do-mus, terra et ius predictum sint episcopatus Viterbiensis cum one-re supra specificato de cappella predicta. Item fecit suos executo-res et fideicommissarios ad predicta exequenda magistrum Pe-trum Verardi notarium et Mutium magistri Iohannis Maltaglati etfratrem Angelum Tucii Ordinis Sancti Agustini. In omnibus autemaliis suis bonis mobilibus et immobilibus, iuribus et actionibus etin quadam vinea sua posita in tenimento Viterbii, in contrata San-cte Marie de Rifarinis, iuxta rem heredum Matharotii magistri Io-se, rem heredum magistri Pangni, viam publicam et alios suosconfines, sibi universalem heredem instituit dominam Odulinamsororem suam, uxorem Mutii magistri Iohannis Maltaglati et sidicta domina Odulina decesserit quandocumque sine legitimis fi-liis vel filiabus ex legitimo matrimonio ex se natis quod dicta vineaet omnia alia sua bona sint et esse debeant supradicte ecclesie Tri-nitatis pro dicta cappella vel eius ecclesie in qua dictam cappellamfieri contingerit. Et hec est ultima sua voluntas et suum ultimumtestamentum quod et quam valere voluit iure testamenti et si iuretestamenti non valeret voluit valere iure codicillorum et si iure co-dicillorum non valeret voluit valere iure consuetudinario civitatisViterbii et omni iure et modo quibus melius valere potest. Cap-sans, irritans et annullans omne aliud testamentum et ultimam vo-luntatem per eum hactenus factum vel factam manu cuiuscumquealterius notarii appareret et hoc presens testamentum et ultimamvoluntatem voluit omnibus aliis prevalere et obtinere perpetuo ple-nariam roboris firmitatem.
Actum est hoc Viterbii, in domo dicti testatoris, presentibus An-gelutio Herrigucii, Vannicello Petri Farracie, Vannicello Martini Im-bracti, Paulo Binnini, Dato Pucii, Cecchino Bucii et Menico Riccar-di dicto alias Toso, testibus ad predicta vocatis specialiter et rogatisa testatore predicto.
Et ego Petrus Cole domini Marci de Viterbio, auctoritate almeUrbis prefecti notarius et iudex ordinarius, predictis omnibus et sin-gulis interfui et ea omnia et singula rogatus a dicto testatore scribe-re scripsi et publicavi.
Spigolature dalle carte agostiniane viterbesi 51
nr. 71351 novembre 27, Viterbo
Therio Tucii Egidii, macellaio, e sua moglie Petruccia si leganospiritualmente agli agostiniani della SS. Trinità offrendo se stessi edi loro beni, riservandosene l’usufrutto prima per loro e poi per il lo-ro figlio Giovanni, al convento e ai frati che accettano, radunati incapitolo, sotto la presidenza del priore Bartolomeo da Orvieto.
Originale, Viterbo, Biblioteca degli Ardenti, SS. Trinità, pergamena 90(3601), [A]. Pergamena di mm 180 x 750.
Sul verso: «27 nov. 1351. Oblazione di due coniugi alla chiesa della Tri-nità» (sec. XIX; questa nota è stata scritta su una più antica parzialmenteabrasa e in parte leggibile con l’ausilio della lampada di Wood).
(S) In nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo tricen-tesimo quinquagesimo primo, tempore domini Clementis papesexti, indictione quarta die .XXVII. mensis novembris, in presen-tia mei notarii et testium subscriptorum. Convocato et congregatocapitulo loci fratrum, capituli et conventus ecclesie Sancte Trini-tatis de Viterbio Ordinis Heremitarum Beati Agustini ad sonumcampanelle in sacristia dicti loci de mandato religiosi et honestiviri fratris Bartholomei de Urbeveteri prioris dictorum loci,fratrum, capituli et conventus, dicto priore et infrascriptisfratribus conventualibus dicti loci presentibus et capitulum moresolito facientibus(a) constituti in dicto capitulo Therius Tucii Egidiimacellarius de Viterbio et domina Petrucia uxor dicti Therii, ipsoviro suo presente et volente, et uterque ipsorum cupientes Deo om-nipotenti, individue Trinitati ac beato Agustino confessori per-petuo famulari et huius vite naufragia evitare ac eorum bonadisponere et ordinare sponte et eorum bonis et liberis voluntatibusottulerunt sese cum eorum infrascriptis bonis et cum infrascriptispactis et reservationibus sollempni deliberatione prius prehabitadiligenti Deo omnipotenti, individue Trinitati ac beato Agustinoconfessori et supradictis fratri Bartholomeo et fratribus conventu-alibus dicti loci ecclesie Sancte Trinitatis de Viterbio Ordinissupradicti, presentibus et recipientibus nomine eorum et dicti locifratrum, capituli et conventus et pro eis hoc modo videlicet quoddicti Therius et domina Petrucia eius uxor reservaverunt eis et eo-rum alterutri et Iohanni eorum filio in eorum vita usumfructumdictorum et infrascriptorum bonorum suorum et alterutrius ipso-rum et eidem Iohanni reservatis omnibus iuribus et actionibus queet quas habet et habere sperat in bonis eorum predictisquocumque modo et quacumque de causa ac etiam eis et eorum
Antonella Mazzon52
alteri iure peritus reservato disponendi in vita eorum et ad ipso-rum voluntatem de supradictis et infrascriptis eorum bonis oblatisper eos. Et dicti prior et fratres nomine quo supra promiserunt etconvenerunt eisdem Therio et domine Petrucie eius uxori oblatispredictis presentibus et recipientibus propterea eos et eorum al-terum toto tempore vite ipsorum alere et gubernare, vestire et cal-ciare ac etiam(b) eis dare omnia necessaria ad victum et vestitumipsorum omnibus sumptibus et expensis dictorum loci, fratrum,capituli et conventus. Qui prior et fratres predicti cum pactis etreservationibus supradictis quo supra nomine dictos Therium etdominam Petruciam eius uxorem flexis genibus et manibus iunc-tis existentes coram eis in eorum et dictorum loci, capituli et con-ventus veros oblatos receperunt. Et ipsi dictis priori et fratribuspromiserunt obedientiam et reverentiam, quorum bonorum obla-torum et cuiuslibet ipsorum posessionem dicti Therius et dominaPetrucia eius uxor sese nomine dictorum loci, fratrum, capituli etconventus et pro eis amodo constituerunt possidere donec dictifratres nomine dictorum loci, capituli et conventus ipsorum bono-rum posessionem intraverint et acceperint corporalem quam in-trandi, accipiendi eius auctoritate propria et retinendi eisdem li-centiam dederunt et omnimodam potestatem sine pena legis etcurie et alicuius persone contradictione seu molestia. Quam qui-dem oblationem et omnia et singula supradicta promiserunt etconvenerunt dicti Therius et domina Petrucia oblati predicti ac eti-am iuraverunt ad sancta Dei evangelia, scripturis corporaliter tac-tis, dictis priori et supra et infrascriptis fratribus nomine quosupra presentibus et recipientibus ac etiam legitime stipulantibuset dicti prior et fratres quo supra nomine dictis Therio et dominePetrucie uxori eius presentibus et stipulantibus perpetuo et omnitempore attendere et observare et in nullo contra facere vel venireper se vel alium aliqua ratione, exceptione vel causa. Cum refec-tione dampnorum et expensarum litis et extra sub ypotheca etobligatione sui et omnium et singulorum bonorum suorum et al-terutrius ipsorum et bonorum omnium dictorum fratrum loci, ca-pituli et conventus predictorum mobilium et immobilium, presen-tium et futurorum que se unus nomine alterius et alter alterius etpro eo constituit possidere et pena centum librarum denariorumpaparinorum inter eos promissa et legitime stipulata, qua penacommissa, exacta, petita et soluta vel non predicta tamen omniaperpetuo rata maneant atque firma perdurent semper.
Nomina vero dictorum fratrum conventualium dicti loci sunthec scilicet frater Agustinus de Urbeveteri supprior77, fraterStephanus magistri Guillelmi, frater Erasmus et Simonellus de
Spigolature dalle carte agostiniane viterbesi 53
Viterbio, frater Donatus, frater Nicolaus, frater Iohannutius et fraterNerutius de Urbeveteri, frater Angelus de Tuscanella78, frater Fran-ciscus de Visso79, frater Thadeus de Aquapendenti et frater Iohannesde Criptis.
Bona autem per dictum Therium supra oblata sunt hec scilicet:quidam campus positus in tenimento civitatis Viterbii in contrataVallis Cerri, iuxta rem Vannicelli Petri Armildi, rem heredum Maro-tii domini Angeli, viam et alios suos confines.
Item unum petium vallis positum in tenimento Viterbii, in con-trata Acque Formicule iuxta rem.
Item quoddam petium terre positum in tenimento Viterbii, incontrata Plani Crepuli iuxta rem.
Item quedam domus posita in civitate Viterbii, in contrata Fabu-lis iuxta rem.
Bona vero dicte domine Petrucie uxor dicti Therii que supra ot-tulit sunt hec videlicet: terre cum valle et plano posite in tenimentocastri Vetralle80, in contrata Capacque, iuxta rem hospitalis SancteMarie de Furicasso81 de dicto castro, iuxta rem.
Actum est hoc in civitate Viterbii, in sacristia dicti loci ecclesieSancte Trintiatis, presentibus Cecco domini Paltoni de Viterbio, Cec-co Sanctucii de comitatu Aretii et Petro Iannis de Reate, testibus deViterbio ad hec vocatis et rogatis.
ET ego Iohannes magistri Petri condam Verardi notarii de Viter-bio, alme Urbis prefecti auctoritate iudex ordinarius atque notarius,predictis omnibus et singulis presens interfui et ea omnia et singulasupradicta rogatus scribere scripsi et publicavi.
(a) A facientientibus (b) segue eta cancellato
nr. 81394 marzo 22, Viterbo e 1399 settembre 11
Oblazione alla chiesa della SS. Trinità di Viterbo da parte diFrancesca figlia del fu maestro Rainerio medico e vedova di Gio-
Antonella Mazzon54
77 Cfr. Capitula antiqua Provinciae Romanae, O.N., in «Analecta Augustiniana», 3(1911-1912), p. 136.
78 Cfr. Notitiae ad Provinciae Romanae, O.N., historiam spectantes saec. XIV-XV, in«Analecta Augustiniana», 5 (1913-1914), pp. 291, 293, 399.
79 Ibid., pp. 248, 267.80 Per Vetralla cfr. SILVESTRELLI, Città, castelli e terre cit., II, pp. 719-723.81 Per la chiesa di S. Maria in Forcassi, nei pressi di Vetralla cfr. SILVESTRELLI, Cit-
tà, castelli e terre cit., II, p. 723.
vanni Brache della contrada di San Giovanni in Petra di Viterbo, laquale lascia a fra Paolo di Pavia, provinciale della Provincia Roma-na, e Agostino Lelli di Viterbo, priore dei frati, capitolo e conventodella S. Trinità, due vigneti e un appezzamento di terra. Cinque an-ni dopo frate Agostino, provinciale della Provincia Romana e il pro-curatore ed economo del convento della S. Trinità prendono il pie-no possesso delle vigne e della terra lasciata a detta chiesa dall’obla-ta Francesca.
Originale, Viterbo, Biblioteca degli Ardenti, SS. Trinità, pergamena 149(3660), [A]. Pergamena di mm 225 x 310.
(S) In nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo tricente-simo nonagesimo quarto, tempore domini Bonefatii(a) pape noni, in-dictione secunda, die vigesimo secundo mens(is) martii. In presentiamei notarii et testium subscriptorum, domina Francischa filia olimmagistri Rainerii medici et uxor condam Iohannis Brache de Viter-bio et contrata Sancti Iohannis in Petra, volens pro Christi amore etbeate Marie semper virginis et anime sue salute in sancta religioneOrdinis Beati Augustini sub iure hobedientie se artare et residuumvite sue infra quantum sibi possibile erit regulam subicere disciplineet Deo et beate Marie virgini et beato Augustino perpetuo deservire,constituta ac genuflessa coram reverendo patre domino fratre Paulode Papia82, provinciali fratruum Heremitarum Beati Augustini in Ro-mana Provincia pro domino nostro papa ac etiam coram venerabiliviro fratre Augustino Lelli de Viterbio priore fratuum, capituli et con-ventus ecclesie Sancte Trinitatis de Viterbio dicti Ordinis manus pli-citas habens inter manus predictorum domini fratris Pauli provin-cialis et fratris Augustini prioris, existens ante altare maius ipsius ec-clesie Sancte Trinitatis obtulit personam suam Deo omnipotenti etbeate Marie semper virgini et beato Augustino et dictis domino fra-tri Paulo et priori, recipientibus et stipulantibus vice et nomine fra-truum, capituli et conventus dicte ecclesie Sancte Trinitatis et pro eisdans, ponens necnon promictens et profitens stabilitatem et hobe-dientiam debitam secundum regulam Ordinis antedicti; et intentuomnipotentis Dei et beate Marie virginis ac etiam beati Augustini prosuorum parentium et eius remedio peccatorum obtulit, dedit et ha-bere concessit dictis domino fratri Paulo provinciali et fratri Augusti-no priori predicto presentibus et recipientibus et legitime stipulanti-
Spigolature dalle carte agostiniane viterbesi 55
82 Cfr. Notitiae ad Provinciae Romanae, O.N., historiam spectantes saeculis XIV-XV,in «Analecta Augustiniana», 5 (1913-1914), pp. 148, 313, 369-370, 397, 420-421; 6 (1915-1916), pp. 13, 63, 65.
bus nominibus quibus supra quandam suam vineam positam in te-nimento civitatis Viterbii in contrata Turris Matrigliane iuxta rem he-redum Paulutii et iuxta rem Telle(b), iuxta rem heredum Silvestri Gac-ti, iuxta viam publicam et alios suos confines. Et quandam aliamsuam vineam cum uno petio terre et pasuris dicte vinee iuntis et do-mo cum torcularibus in ea(c) existentibus, positam in dicto tenimen-to in contrata Fontane Agreste iuxta rem episcopatus Viterbiensis,rem Angeli Vannutii Pelacanis, iuxta rivum siccum et fossatum cur-rentem, viam publicam et alios suos confines, cum omnibus et sin-gulis que infra predictis continentur confinibus vel alios si qui forentet cum omnibus et singulis que dicte res supra oblate et utraque ea-rum habent, tenent et continent in se, intus et extra se in integrumomnique iure et actione, usu seu requisitione dictis rebus oblatis etutraque earum dicte domine pro eis modo aliquo pertinente et spec-tante de iure consuetudinario vel de facto ad habendum, tenendum,possidendum, vendendum, permutandum et quicquid dictis dominoprovinciali et priori ac fratribus, capitulo et conventui dicte ecclesieet eorum successoribus placuerit perpetuo faciendum. Cum hac ta-men conditione et onere quod prior, fratres, capitulum et conventusdicte ecclesie Sancte Trinitatis qui nunc sunt et per tempora eruntemant et emere teneantur et debeant de fructibus ipsarum vinearumpercipiendis per eos unum calicem et unum paramentum ad usumaltaris et divini cultus in dicta ecclesia perpetuo permansura, reser-vato tamen ipse domine et sibi remanentibus ad faciendum liberevelle suum omnibus aliis et singulis suis bonis mobilibus et immobi-libus, presentibus et futuris de quibus ex pacto et conventione habi-tis inter oblatam predictam et dictos recipientes prefata domina libe-re possit facere velle suum prout poterat ante oblationem predictam.Quam quidem oblationem dicti domini provincialis et prior recepe-runt et acceptaverunt pro dicta ecclesia Sancte Trinitatis et fratribus,capitulo et conventu ipsius ecclesie. Et insuper dicta domina oblatio-nem predictam et omnia et singula supradicta et infrascripta promi-sit et iuravit in manibus dictorum domini provincialis et prioris ipsisdominis provinciali et priori recipientibus et stipulantibus vice et no-mine dicte ecclesie et fratruum, capituli et conventus ipsius ecclesiequi nunc sunt et per tempora erunt et pro eis perpetuo rata, grata etfirma habere et tenere et contra non facere vel venire per se vel aliumaliqua ratione, exceptione vel causa. Et exhibere ipsis provinciali etpriori qui nunc sunt et per tempora erunt hobedientiam et reveren-tiam sub obligatione suorum bonorum, et refectione dampnorum etexepensarum litis et extra et ad penam et sub pena dupli valoris etextimationis dictarum vinearum. Et ad cautelam re[nuntians](d) pre-fata oblata beneficio Velleiani senatus consulti autentice si qua mu-
Antonella Mazzon56
lier iuri ypothecarum et omni alii legum et iuris auxilio, certiorataprimo per me ‹notarium› infrascriptum de dictis iuribus et beneficiisquid sint et quid dicant.
Actum est hoc Viterbii in dicta ecclesia Sancte Trinitatis ante al-tare predictum, presentibus Thomarotio Thomai et Paulo Vannis deBarbarano picçicarolo habitatore civitatis Viterbii et Valentino Pe-trucii Iacovoni de Viterbio testibus ad hec vocatis et rogatis.
In nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo tricentesimononagesimo nono tempore domini Bonefatii pape noni, indictioneseptima, die undecimo mens(is) septembris. In presentia mei notariiet testium subscriptorum supradictus dominus frater Augustinusprovincialis fratruum Heremitarum Beati Augustini in Romana Pro-vincia pro domino nostro papa ac etiam procurator et yconomusprioris, fratruum, capituli et conventus dicte ecclesie Sancte Trinita-tis yconomario et procuratorio nomine pro eis vigore dicte oblatio-nis et omnium et singulorum predictorum et omni modo, via, iure etforma quibus melius potest accedens una mecum notario infrascrip-to et testibus infrascriptis ad dictas vineas super infradicta oblationepositas et confinatas et utramque earum cepit et apprehendit tenu-tam et corporalem posessionem dictarum vinearum et terre et cuiu-slibet earum intrando ipsas vineas et terram et quamlibet earum etambulando et sedendo in eas et per eas et colligendo de herbis gre-bis terre, uvis et pampinis vitium et arborum in ipsis vineis et terriset qualibet earum existentibus in signum vere posessionis et dominiidicens se quibus supra nominibus a modo et deinceps velle dictas vi-neas et terram et quamlibet earum cum [omnibus] earum iuribuspro se et dictis fratribus, capitulo et conventu ipsius ecclesie et eo-rum in dicta ecclesia successoribus tenere et possidere nemine con-tradicente.
ET ego Quiricus condam Roberti Gemini de Viterbio, imperialiauctoritate notarius et iudex ordinarius, predictis omnibus et singu-lis interfui et ea rogatus scribere scripsi et publicavi.
(a) così A (b) segue uno spazio bianco corrispondente a circa 6 lettere (c)tra ea ed existentibus sembra esserci un segno probabilmente per et ma non dichiara lettura (d) parola coperta da macchia
Spigolature dalle carte agostiniane viterbesi 57