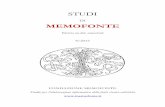« Pratiche umanistiche e riforma monastica. Gli epistolari camaldolesi latini nel Quattrocento »,...
-
Upload
univ-lyon2 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of « Pratiche umanistiche e riforma monastica. Gli epistolari camaldolesi latini nel Quattrocento »,...
PROGRAMMA DEL CONVEGNO III
I T A L I A B E N E D E T T I N ASTUDI E DOCUMENTI DI STORIA MONASTICA
a cura delCENTRO STORICO BENEDETTINO ITALIANO
39
00-Pagg.romane.indd 3 09/04/2015 14:34:00
CENTRO STORICO BENEDETTINO ITALIANO
CAMALDOLIE L’ORDINE CAMALDOLESE
DALLE ORIGINIALLA FINE DEL XV SECOLO
Atti del I Convegno internazionale di studi in occasione del millenario di Camaldoli (1012-2012)
Monastero di Camaldoli, 31 maggio - 2 giugno 2012
a cura di
CÉCILE CABY e PIERLUIGI LICCIARDELLO
CESENABADIA DI SANTA MARIA DEL MONTE
2014
00-Pagg.romane.indd 5 09/04/2015 14:34:01
Tutti i diritti riservati - All rights reserved
Copyright © 2014 by Centro Storico Benedettino Italiano, Cesena. Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, anche parziale o per estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo, effettuati, compresi la copia fotostatica, il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta del Centro
Storico Benedettino Italiano. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.
ISBN 978-88-98104-09-3
Congregazione O.S.B. CAM
Regione Toscana
Ente Cassa di Risparmio di Firenze
Il presente volume è stato pubblicato con il contributo di
00-Pagg.romane.indd 6 09/04/2015 14:34:01
CÉCILE CABY
PRATICHE UMANISTICHE E RIFORMA MONASTICA:GLI EPISTOLARI CAMALDOLESI LATINI
NEL QUATTROCENTO
Lo scopo di questo contributo è innanzitutto richiamare l’attenzione sulla circolazione nell’Ordine camaldolese durante il Quattrocento di una tipologia di scrittura molto specifica e emblematica dell’Umane-simo, ossia la scrittura epistolare, in particolare sotto forma di sillogi epistolari organiche. L’obiettivo è doppio: da un lato contribuire alla conoscenza delle logiche di affermazione e di successo al di fuori del suo ambiente di maggiore sviluppo (e addirittura in ambienti che sono spesso considerati come antagonisti all’Umanesimo, come gli ordini reli-giosi) di un genere letterario e di un tipo documentario caratteristico e addirittura caratterizzante dell’Umanesimo, nonché all’esplorazione dei suoi rapporti con altre tipologie epistolari precedenti e/o concorrenti, come le forme notarili e amministrative di scrittura epistolare; dall’altro indagare la penetrazione capillare delle pratiche culturali umanistiche nella cultura dell’Ordine camaldolese o di alcuni centri e individui di quest’Ordine.1
Altre spie – come per esempio la penetrazione dell’orazione epidit-tica – avrebbero permesso di mettere in luce l’influenza degli orienta-menti umanistici sempre più dominanti nel corso del Quattrocento sulle pratiche intellettuali e l’immagine in quanto letterati di un Traversari, ma anche di un Dolfin o di un Bernardino Gadolo e in generale di monaci che scelsero nel corso del Quattrocento di plasmare le loro pratiche culturali su quelle che erano dominanti negli ambienti so-ciali che essi frequentavano. Nel quadro problematico che ho appena delineato, tuttavia, la prassi epistolare mi è parsa un punto di partenza particolarmente pertinente e comodo, data l’importanza, negli ultimi trent’anni, degli studi sull’epistolografia umanistica e in particolare
1. Su questo tipo di approccio vedi CABY, De l’érémitisme, p. 599-662; EAD., L’huma-nisme au service de l’Observance: quelques pistes de recherche, in Humanisme et Église en Italie et en France, éd. P. GILLI, Rome 2004, p. 115-148; EAD., Al di là dell’ “Umanesimo religioso”. Umanisti e Chiesa nel Quattrocento, in Cultura e desiderio di Dio. L’Umanesi-mo e le Clarisse dell’Osservanza, Assisi 2009, p. 15-33; e infine il volume Les humanistes, clercs et laïcs dans l’Italie du XIIIe au début du XVIe siècle, dir. C. CABY - R. M. DESSÌ, Turnhout 2012 (Collection d’études médiévales de Nice, 13).
21-Caby.indd 523 09/04/2015 14:47:15
CÉCILE CABY524
sugli epistolari in quanto raccolte organiche.2 Vi si aggiunge, per quanto riguarda l’Ordine camaldolese, un dato quantitativo palese: nel secolo XV possiamo contare ben tre, o addirittura quattro, membri dell’Ordine che hanno curato la raccolta delle loro lettere all’interno di epistolari latini ordinati, pubblicizzati o addirittura pubblicati a stampa, nel corso della loro propria esistenza o poco dopo. Si tratta, nella prima metà del secolo, di Ambrogio Traversari e, negli ultimi decenni del secolo, quando ormai lo sviluppo umanistico del genere epistolare ha raggiunto i suoi massimi livelli, di Pietro Dolfin e Bernardino Gadolo (1463-1499).3 Avrei forse potuto aggiungere a questi tre – ma non l’ho fatto per questo contributo – il copialettere del monaco di origine toscana ed ex carmelitano Mauro Lapi, che raccolse a metà Quattrocento 31 risposte dei suoi corrispondenti, assieme ad 11 delle sue lettere in un carteggio composito, in parte latino, in parte volgare, attualmente conservato alla Biblioteca Marciana di Venezia e proveniente da S. Mattia di Murano, dove, dopo un percorso travagliato a Camaldoli, Mauro visse i suoi ultimi anni, in mezzo a non poche contraddizioni.4 Escludo invece da questa panoramica un altro discepolo del Traversari, Agostino da Por-tico di Romagna, le cui lettere volgari alle agostiniane di S. Marta di Siena, scoperte e studiate da Daniela Delcorno Branca, entrano a pieno in una tipologia di lettere spirituali erede di un ricco filone trecentesco.5
2. Sugli epistolari umanistici vedi A. PEROSA, Sulla pubblicazione degli epistolari degli umanisti, ora in ID., Studi di filologia umanistica, a cura di P. VITI, Roma 2000, III, p. 9-21; C. H. CLOUGH, The Cult of Antiquity: Letters and Letter Collections, in Cultural Aspects of the Italian Renaissance: Essays in Honour of Paul Oskar Kristeller, ed. C. H. CLOUGH, Manchester-New York 1976, p. 33-67; L. GUALDO ROSA, La pubblicazione degli epistolari umanistici: bilancio e prospettive, « Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano », 89 (1980-1981), p. 369-392; C. GRIGGIO, Dalla lettera all’epistolario. Aspetti retorico-formali dell’epistolografia umanistica, in Alla lettera. Teorie e pratiche epistolari dai Greci al Novecento, a cura di A. CHEMELLO, Milano 1998, p. 83-107; A. PETRUCCI, Scrivere lettere: una storia plurimillenaria, Roma-Bari 2008, p. 69-86 (con bibliografia alle p. 206-209); P. CHERUBINI, Introduzione a IACOPO AMMANATI PICCOLOMINI, Lettere (1444-1479), a cura di P. CHERUBINI, I-III, Roma 1997; I, p. 4 ss.; V. R. GIUSTINIANI, Lo scrittore e l’uomo nell’epistolario di Francesco Filelfo, in Francesco Filelfo nel quinto centenario della morte, Padova 1986 (Studi Maceratesi, 17), p. 249-274, C. REVEST, Au miroir des choses familières. Les correspondances humanistes au début du XVe siècle, « Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge », 119/2 (2007), p. 447-462.
3. Su questi tre autori si partirà dalla bibliografia e dall’elenco delle opere segna-lati in GUERRIERI, Clavis, p. 4-57 (Ambrosius Traversarius), 62-67 (Bernardinus Gadolus), 269-281 (Petrus Delphinus).
4. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. XIV. 295 (4348); cfr. CABY, De l’érémitisme, ad indicem; E. BARBIERI, Il libro nella storia. Tre percorsi, Milano 1999 e GUERRIERI, Maurus Lapi de Florentia, in EAD., Clavis, p. 132-146.
5. E. GUERRIERI, Agostinus de Porticu, in EAD., Clavis, p. 57-58; D. DELCORNO
21-Caby.indd 524 09/04/2015 14:47:16
GLI EPISTOLARI CAMALDOLESI LATINI NEL QUATTROCENTO 525
Questi ultimi due casi ci ricordano, se era necessario, che la prassi epistolare non è certo una invenzione dell’Umanesimo e che i monaci ne fecero nel corso del Medioevo un genere prediletto nelle sue numerose variazioni tipologiche. Anzi, proprio mentre Petrarca raccoglieva le sue lettere familiari e senili, nell’ambito di alcuni ordini religiosi si stava sviluppando un ricco filone di lettere di direzione spirituale in volgare, particolarmente vivace nell’Ordine agostiniano, ma anche domenicano o vallombrosano, e del quale sono stati recentemente forniti dei pano-rama molto stimolanti.6 Senza rottura netta e attraverso numerose zone di confine,7 dal Petrarca in poi, si sviluppa però una forma di lettera più coscientemente e programmaticamente ispirata ai modelli antichi, non solo patristici, ma anche classici, che implica, oltre ad un uso par-ticolare della lingua latina e della composizione retorica, una forma di condivisione di ideali culturali e sociali che si manifesta in particolar modo nell’uso di selezionare le proprie lettere per comporle all’interno di un’opera organica in grado di fornire un’immagine costruita dell’au-tore e del suo itinerario biografico e intellettuale: l’epistolario d’autore appunto.
I tre epistolari camaldolesi latini che intendo esaminare non sono certo terre incognite: ovviamente la raccolta del Traversari è di gran lunga quella che ha cristallizzato il maggior numero di studi, anche molto recentemente, mentre quella di Bernardino Gadolo è rimasta pra-
BRANCA, Notizie di manoscritti. Lettere di direzione spirituale di un discepolo del Traver-sari: Agostino di Portico di Romagna, « Lettere italiane », 53 (2001), p. 377-96, EAD., Un camaldolese alla festa di S. Giovanni. La processione del Battista descritta da Agostino di Portico, « Lettere Italiane », 55 (2003), p. 3-25, EAD., Istruzioni per monache: filigrane bibliche nelle lettere di direzione spirituale di Agostino di Portico, in Sotto il cielo delle Scritture. Bibbia, retorica e letteratura religiosa (secoli XIII-XVI), Firenze 2009, p. 101-114 e il contributo della stessa autrice in questi atti.
6. Si vedrà per es. Girolamo da Siena, Epistole, a cura di S. SERVENTI, Venezia 2004, cap. 2 (p. 35 ss.) e S. BRAMBILLA, ‘Padre mio dolce’. Lettere di religiosi a Francesco Datini. Antologia, Pisa 2010.
7. Seleziono nel mezzo di una bibliografia sterminata i seguenti titoli: P. O. KRI-STELLER, Renaissance Thought and Its Sources, a cura di P. MOONEY, New York 1979, p. 85-105; R. WITT, Medieval Ars dictaminis and the Beginnings of Humanism: A New Construction of the Problem, « Renaissance Quarterly », 35 (1982), p. 1-35; P. G. RICCI, Il Petrarca e l’epistolografia, in ID., Miscellanea Petrarchesca, a cura di M. BERTÉ, Roma 1999, p. 201-212; G. C. ALESSIO, Preistoria e storia dell’ars dictaminis, in Alla lettera, p. 33-49; infine F. DELLE DONNE, Epistolografia medievale ed epistolografia umanistica. Riflessioni in margine al manoscritto V F 37 della Biblioteca Nazionale di Napoli, in Parrhasiana II. Atti della seconda giornata sui manoscritti medievali e umanistici della Biblioteca Nazionale di Napoli, a cura di G. ABBAMONTE - L. GUALDO ROSA - L. MUNZI, Napoli 2002 (Annali dell’I.U.O - Dipartim. di Studi del Mondo Classico e del Mediter-raneo Antico, sez. filologico-letteraria, 24), p. 37-51.
21-Caby.indd 525 09/04/2015 14:47:16
CÉCILE CABY526
ticamente sconosciuta e quella di Pietro Dolfin quasi dimenticata dopo le importanti basi gettate da Schnitzer (1929) e da Soranzo e Picotti negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento.8 Ormai quasi quindici anni fa avevo fatto largo uso di queste lettere nell’ultima parte del mio libro dedicata alla storia quattrocentesca dell’Ordine camaldolese, sot-tolineando allora il drastico cambiamento tipologico creato nel corpus documentario relativo all’Ordine dalla loro presenza massiccia (più di 4000 lettere in circa sessant’anni per il Dolfin), nonché il modo in cui le corrispondenze quattrocentesche costruiscono una rappresentazione della cultura e dei rapporti sociali che ne condiziona fortemente la nostra percezione. Qui vorrei riprendere la questione non tanto del contenuto delle lettere, quanto delle raccolte epistolari in sé, per ognuno dei tre epistolari di Traversari, Dolfin e Gadolo, alla luce delle problematiche sopra enunciate.
LETTERE E RACCOLTE EPISTOLARI DI AMBROGIO TRAVERSARI: SCONFINAMENTI DI GENERE E DI TIPOLOGIA
L’epistolario del Traversari ha mobilitato, come ho già segnalato, alcuni fra i migliori studiosi dell’Umanesimo, da Mercati a Sottili, ed è stato recentemente riesaminato nel contesto di studi sulla corrisponden-za con Niccolò Niccoli da Anna Favi, su alcune lettere amministrative inedite da Simona Iaria o sulla scrittura latina e greca del Traversari (Marzia Pontone).9 È la ragione per la quale, forte delle acquisizioni di
8. Oltre ai riferimenti citati alla nota 3, rimando a J. SCHNITZER, Peter Delfin Ge-neral des Camaldulenserordens (1444-1525). Ein Beitrag zur Geschichte der Kirchenreform, Alexanders VI. und Savonarolas, München 1926; G. B. PICOTTI, La giovinezza di Leone X, Milano 1928 (rist. anast. Roma 1981); G. SORANZO, Pietro Dolfin, generale dei Camal-dolesi e il suo epistolario, « Rivista di storia della Chiesa in Italia », 13 (1959), p. 1-31; alle mie indicazioni in CABY, De l’érémitisme, p. 636-646 e 763-790 e ai lavori in corso di E. Guerrieri, in particolare il suo contributo in questo volume.
9. Oltre ai riferimenti citati alla nota 3, rimando a due contributi “classici”: G. MERCATI, Traversariana, in ID., Ultimi contributi alla storia degli umanisti, Città del Vaticano 1939, I, p. 1-96 e A. SOTTILI, Epistolografia fiorentina: Ambrogio Traversari e Kaspar Schlick, in Florenz in der Frührenaissance. Kunst-Literatur-Epistolographie in der Sphäre des Humanismus. Gedenkschrift für Paul Oskar Kristeller (1905-1999), a cura di J. MÜLLER HOFSTEDE, Rheinbach 2002, p. 181-216; nonché a C. L. STINGER, Humanism and the Church Fathers. Ambrogio Traversari (1386-1439) and Christian Antiquity in the Italian Renaissance, Albany 1977, p. XII-XV, e a quattro contributi recenti: A. FAVI, Note sulla trasmissione testuale dell’epistolario di Ambrogio Traver-sari, « Medioevo e Rinascimento », n.s., 12 (2001), p. 89-103; S. IARIA, Nuove testimo-nianze autografe di Ambrogio Traversari nell’Archivio di Stato di Firenze, in Margarita
21-Caby.indd 526 09/04/2015 14:47:16
GLI EPISTOLARI CAMALDOLESI LATINI NEL QUATTROCENTO 527
questi studi, potrò sorvolare su alcuni aspetti, fermandomi esclusivamente su alcune domande centrali nella prospettiva di questo contributo.
Benché non se ne conservi, a quanto pare, nessuna traccia mano-scritta certa, l’ideazione in vita della raccolta ordinata delle epistole è documentata dalle lettere stesse del Traversari. Le prime notizie risalgono agli anni 1432-1434, ossia ad una data alla quale Traversari è già priore generale. Fin dall’autunno 1432, il desiderio di un giovane monaco, tal Facino, di trascrivere le lettere scambiate fra Ambrogio e suo fratello Girolamo per raccoglierle assieme alle altre in un registro,10 invita Traversari a sperimentare una prassi ben documentata in seguito, come per esempio a partire dal 1434, quando si trattò, su suggerimento di Cristoforo da S. Marcello, di approntare una raccolta di tutte le lettere.11 Come è stato ben messo in evidenza da A. Sottili, Traversari procedette in realtà su due piani paralleli: « Da un canto raccoglieva e ordinava le missive per la sua edizione d’autore, dall’altro le diffondeva a gruppi », in un primo tempo Cristoforo da S. Marcello e in seguito Placido Pavanelli, ambedue stretti collaboratori del papa.12 Il progetto era impegnativo: prevedeva in primo luogo la raccolta delle lettere ori-ginali da parte del Traversari, poi la loro copia a cura del vescovo di Rimini, nonché la rifinitura del testo da parte dell’autore al momento di includerle in una raccolta ordinata.13 In numerose lettere, che testimo-niano questo lavoro, si coglie la totale partecipazione del Traversari ai valori e ai comportamenti della cultura umanistica. Egli, per esempio, si dimostra preoccupato di controllare la stesura del testo delle sue lettere prima che circolassero fra i lettori: una preoccupazione simile a quella
amicorum. Studi di cultura europea per Agostino Sottili, a cura di F. FORNER - C. M. MONTI - P. G. SCHMIDT, Milano 2005, II, p. 585-602; M. PONTONE, Ambrogio Traversari monaco e umanista fra scrittura latina e scrittura greca, Firenze-Torino 2010 e EAD., Lettere inedite di Ambrogio Traversari nel codice Trivulziano 1626, « Italia medioevale e umanistica », 52 (2011), p. 71-102. Cito le lettere di Traversari dall’edizione AMBROSII TRAVERSARII [...] latinae epistolae, ed. P. CANNETI - L. MEHUS, II, Firenze 1759 (rist. anast. Bologna 1968; da ora in poi TRAVERSARI, Epistolae: si cita per libro e episto-la, eventualmente colonna), con rinvio se necessario a F. P. LUISO, Riordinamento dell’epistolario di A. Traversari con lettere inedite e note storico-cronologiche, Firenze 1898-1903 (abbreviato LUISO).
10. « Litteras ad te meas Fazinus noster, iuvenis plane bonus et mihi in primis gratus, transcribere cum nostris caeteris cupit registrumque conficere », cit. e ed. in PONTONE, Lettere inedite di Ambrogio Traversari, p. 78 e App. II, Ep. 9, p. 99-100.
11. In part. TRAVERSARI, Epistolae, III 20 (Fontebuono, 22 nov. 1434), 21, 22, 23, col. 126-129.
12. Cfr. SOTTILI, Epistolografia fiorentina, p. 197-198.13. Come ben si legge per esempio nelle lettere TRAVERSARI, Epistolae, III 22, col. 128;
III 23, col. 128-129; III 30, col. 134-135; cfr. SOTTILI, Epistolografia fiorentina, p. 198-199.
21-Caby.indd 527 09/04/2015 14:47:16
CÉCILE CABY528
dei suoi contemporanei impegnati nell’allestimento del proprio epistolario. Le sue preoccupazioni riguardano anche la distribuzione delle lettere e la strutturazione della raccolta, che, secondo un uso condiviso nei primi esempi di epistolari umanistici, privilegia l’ordine per destinatario e gruppo di destinatari rispetto a quello cronologico (che tra l’altro lo avrebbe avvicinato di più ai modelli tradizionali di registri).14 Nel 1437 (aprile-agosto), Traversari impartisce così al suo discepolo fra Michele indicazioni molto precise sui particolari editoriali (scrittura, impagina-zione e ornamentazione) che avrebbe dovuto assumere la sua raccolta.15 In definitiva, il progetto è del tutto coerente con quelli che mettono in atto negli stessi anni altri umanisti fiorentini; è invece assai singolare nel contesto camaldolese e anche benedettino.
In realtà, a più riprese Traversari aveva espresso ai suoi corri-spondenti un senso di imbarazzo, o addirittura di vergogna, nei con-fronti delle contraddizioni fra il suo status monastico e alcuni aspetti dell’ope razione. Questi sentimenti nascono prima di tutto dal fatto che, non avendo conservato l’exemplar delle sue lettere, Traversari dovette richiederle ai suoi corrispondenti,16 come si evince molto chiaramente dalla lettera a Leonardo Giustiniani del 15 dicembre 1435, nella quale at-tribuisce ad altri magni viri il progetto che rende necessaria la fastidiosa raccolta delle sue missive presso i loro destinatari.17 Ma la preoccupa-zione è anche per le conseguenze sociali della circolazione pubblica che
14. Cfr. per esempio le lettere a Cristoforo da S. Marcello del dicembre 1434 (TRA-VERSARI, Epistolae, III 23-24, col. 128-129) o nel febbraio 1435 (ibidem, III 29, col. 132-133); a Placido Pavanelli, IV 26, col. 224-225; SOTTILI, Epistolografia fiorentina, p. 198-199.
15. TRAVERSARI, Epistolae, XIII 14 (= LUISO XIII 23), col. 622-623. Su questa lettera molto famosa, cfr. SOTTILI, Epistolografia fiorentina, p. 195 e S. IARIA, Un discepolo di Ambrogio Traversari: fra’ Michele di Giovanni Camaldolese, in « Italia Medioevale e Umanistica », 45 (2004), p. 243-294 (244).
16. Tale richiesta viene mandata a Francesco Sandelli, abate delle Carceri, il primo dicembre 1434 (TRAVERSARI, Epistolae, XX 15, col. 898-900 = LUISO XX 14) o a Mariotto Allegri il 10 nov. 1434 (TRAVERSARI, Epistolae, XV 32, col. 703-704 = LUISO XV 33) e di nuovo il 4 luglio 1436 (TRAVERSARI, Epistolae, XV 47, col. 718 = LUISO XV 45); cfr. SOT-TILI, Epistolografia fiorentina, p. 197-198.
17. TRAVERSARI, Epistolae, VI 38, col. 321-322 = LUISO VI 41: « Puto mirabere novam et propemodum verecundam postulationem meam. Instant apud me magni viri et quo-rum preces negligere nequaquam possum, ut epistolas meas illis scribendas tradam, et quum harum non esse penes me copiam respondeam, eas ut ex his ad quos scriptae sunt colligendas curem, postulare pergunt avidissime. Porro id quam sit verecundum non ignoras. Neque tamen vel hoc ipsum negare illis possum: ea sunt virorum insignium merita. Te oro si quae sunt apud te ex nostris (nam scripsisse pluries memini) eas omnes ad me mittas, ad te, quando transcriptae erunt, remeaturas, ignoscasque pudori meo qui nihil non licere mihi apud te existimavi ». Cfr. SOTTILI, Epistolografia fiorentina, p. 198, che cita anche altre lettere con la stessa richiesta.
21-Caby.indd 528 09/04/2015 14:47:16
GLI EPISTOLARI CAMALDOLESI LATINI NEL QUATTROCENTO 529
questo tipo di raccolta implicava, ben lontano dall’uso tradizionale degli ordini, per i quali la registrazione delle lettere era a uso esclusivamente interno, ma invece in totale conformità con l’uso fondante per la vita intellettuale e sociale dell’Umanesimo.
A questo punto è necessario affrontare l’articolazione fra l’attività del Traversari umanista, impegnato nella sua raccolta epistolare, e quella del Traversari priore generale camaldolese, impegnato nella riforma del suo Ordine e dei suoi vari componenti, attraverso la stesura di missi-ve di contenuto prevalentemente burocratico o amministrativo, alcune delle quali sono tuttora attestate in modo disperso negli archivi dei destinatari.18 Separare del tutto le due attività o non interrogare la loro articolazione sarebbe estremamente fuorviante: come è stato dimostrato da Charles Stinger e approfondito in seguito da altri a proposito del programma di traduzioni dal greco, Traversari non scinde quasi mai la sua prassi intellettuale dal suo impegno di riforma, né concepisce la riforma monastica al di fuori di una riappropriazione della letteratura antica, in particolare patristica.19 Per quanto riguarda le raccolte di lettere, sappiamo che, accanto alla raccolta promossa da Cristoforo di S. Marcello fin dal 1434, furono allestite alcune antologie. Una di queste, per esempio, è inviata il 24 giugno 1436 al cubicularius Placido Pavanel-li, e consiste nella selezione delle sue lettere « quae ad curam Ordinis mihi crediti magis pertinere videntur ». La lettera che annuncia l’invio di quest’antologia mi pare importante da vari punti di vista: da un lato, attesta uno stato avanzato della raccolta epistolare, ordinata in quattro libri alla richiesta di Cristoforo da S. Marcello (due ad Eugenio IV, a Cristoforo da S. Marcello e a suo fratello e due ad altri); dall’altro, met-te in evidenza la porosità fra pratica culturale umanistica, all’opera nella realizzazione della raccolta, e impegno riformatore, motivo dell’antologia sul governo dell’Ordine, non a caso mandato a un importante attore del progetto di riforma monastica di papa Eugenio IV.20 Allo stesso
18. Su questo tipo di lettere si veda ultimamente IARIA, Nuove testimoniaze au-tografe di Ambrogio Traversari e PONTONE, Ambrogio Traversari monaco e umanista, p. 205-215.
19. STINGER, Humanism and the Church Fathers; M. GIGANTE, Ambrogio Traversari interprete di Diogene Laerzio, in Ambrogio Traversari nel VI centenario della nascita. Atti del Convegno internazionale di studi, Camaldoli-Firenze 1986, a cura di G. C. GARFAGNINI, Firenze 1988, p. 406-411.
20. TRAVERSARI, Epistolae, IV 26, col. 224-225 = Luiso IV 25 et IV 27, col. 225-226; cfr. SOTTILI, Epistolografia fiorentina, p. 194. Su Placido Pavanelli si veda ormai F.G. TROLESE, Placido Pavanello, abate generale di Vallombrosa (1437-1454) e la riforma di Santa Giustina, in Arbor Ramosa. Studi per Antonio Rigon da allievi, amici, colleghi, a cura di L. BERTAZZO - D. GALLO - R. MICHETTI - A. TILATTI, Padova 2011, p. 621-642.
21-Caby.indd 529 09/04/2015 14:47:16
CÉCILE CABY530
modo, possiamo sottolineare che uno dei nuovi “clienti” che compaiono a favore dell’allestimento di un nuovo carteggio, in un momento in cui il primo e principale “cliente” della raccolta completa, Cristoforo da S. Marcello, sembra rinunciare progressivamente, è proprio l’abate della Badia fiorentina, Gomes,21 un altro personaggio chiave della riforma mo-nastica voluta da Eugenio IV,22 del quale conserviamo, se non un vero e proprio epistolario, almeno un copialettere composto dalle missive originali dei suoi corrispondenti.23 Il mondo monastico e specialmente quello della riforma sembra quindi manifestare un forte interesse per le lettere del Traversari e per la sua raccolta, un interesse che addirittura crebbe dopo la morte del monaco umanista.
Dopo il febbraio 1438, Traversari smise di parlare del suo epistolario nelle sue lettere e non si conserva nessuna traccia manoscritta certa del progetto che egli stesso aveva promosso fra il 1434 e il 1437.24 Ma que-sto faticoso lavoro preparatorio servì probabilmente di base per le due raccolte canoniche, realizzate dopo la morte del priore generale camal-dolese nelle varie cerchie dei suoi amici. La prima e più famosa è quella che fu approntata da fra Michele, discepolo di Traversari e fedele dei
21. TRAVERSARI, Epistolae, XIII 15, col. 623-624 = LUISO XIII 27 (a Michele, 7-8 feb-braio 1438): « Cupit Ariminensis noster seligi epistolas nostras, quae sunt electiores et in volumen redigi. Eam curam volo sumant sibi nostri Philippus et Paulus et quae vide-buntur digniores, transcribantur, et reliquae omittantur tantique viri votis fiat satis. Fa-miliares illae vel ad Hieronymum fratrem, vel ad alios magna ex parte queunt omitti, in quibus sola de re familiari vel privata agitur. Abbas noster Florentinus quaeritur earum non sibi factam abs te copiam, et quum ille vobis patris loco semper fuerit, nolumus ulla ratione illius honesto desis desiderio »; cfr. SOTTILI, Epistolografia fiorentina, p. 201.
22. Cfr. E. NUNES, Dom Frey Gomez, abade de Florença (1420-1440), Braga 1963; A. D. DE SOUSA COSTA, D. Gomes, reformador da abadia de Florença, e as tentativas de reforma dos mosteiros portugueses no século XV, « Studia Monastica », 5 (1963), p. 59-164; F. CARRARA, La Badia fiorentina e la congregazione cassinese, in La chiesa e la città a Firenze nel XV secolo, a cura di G. ROLFI - L. SEBREGONDI - P. VITI, Firenze 1992, p. 105-118; A. LEADER, The Badia of Florence: Art and Observance in a Renaissance Mo-nastery, Bloomington et Indianapolis 2012.
23. Il materiale epistolare legato al riformatore portoghese è diviso in due volumi: BML, Ashb. 1792 (che contiene prevalentemente la corrispondenza ufficiale e diplomatica in particolare con i sovrani portoghesi) e BNCF, Conv. Soppr. da ordinare, Badia 4, che ci interessa in prima istanza in quanto conserva le lettere ricevute da Gomes da prelati e monaci e qualche sua risposta; cfr. G. BATTELLI, Due celebri monaci portoghesi in Firenze nella prima metà del Quattrocento. L’Abate Gomes e Velasco di Portogallo, « Archivio storico italiano », 96/2 (1938), p. 218-227 (221-223); DE SOUSA COSTA, D. Gomes, reformador da abadia de Florença e P. O. KRISTELLER, Iter Italicum: a finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries, I-VI, London 1963-1997; I, p. 165.
24. Cfr. SOTTILI, Epistolografia fiorentina, p. 201; PONTONE, Lettere inedite di Am-brogio Traversari.
21-Caby.indd 530 09/04/2015 14:47:16
GLI EPISTOLARI CAMALDOLESI LATINI NEL QUATTROCENTO 531
Medici, per incarico e con l’aiuto di Cosimo dei Medici: contiene 548 epistole divise in 18 libri, secondo un ordine scelto dal monaco.25 Un’al-tra raccolta, forse più interessante dal mio punto di vista, raccoglie 435 epistole ripartite in 13 libri: limitata alle familiares, ad esclusione delle lettere al papa, ai prelati e ai nobili e potenti, fu forse allestita in am-biente monastico,26 probabilmente (è una mia ipotesi da verificare) nel contesto del generalato del discepolo del Traversari, Mariotto Allegri.27
25. Cfr. IARIA, Un discepolo di Ambrogio Traversari, p. 244-246; PONTONE, Lettere inedite di Ambrogio Traversari. I tre principali testimoni sono BML, Strozzi 102; BAV, Vat. lat. 1793 e Lucca, Biblioteca Capitolare, codice 540.
26. Su questa collezione che apre con lettere a monaci camaldolesi e limita a soli tre libri quelle a corrispondenti letterati, cfr. A. FAVI, Note sulla trasmissione testuale dell’epistolario di Ambrogio Traversari, p. 97 e PONTONE, Ambrogio Traversari monaco e umanista, p. 191-192. La collezione è conservata nei codici: BNCF, Conventi Soppr. C. 2. 38 (sottoscritto da Giovanni da Laterina nel 1468); ibidem, D. 4. 37 (acefalo e mutilo); ibidem, G. 3. 35 (sottoscritto da Rinaldo di Ludovico Volterrano nel 1463; cfr. I manoscritti datati del fondo conventi soppressi della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, Firenze 2002 (Manoscritti datati d’Italia, 5), n. 100, p. 95-96); Napoli, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II, Brancacci, VI. A. 8, citati da PONTONE, Lettere ine-dite di Ambrogio Traversari e FAVI, Note sulla trasmissione testuale dell’epistolario di Ambrogio Traversari. Va aggiunto, secondo me, un altro testimone raramente citato, la cui analisi meriterà di essere approfondita: si tratta del manoscritto Volterra, Biblioteca Guarnacciana, 6185 [LVI. 6. 3] (descrizione in Catalogo di manoscritti filosofici nelle biblioteche italiane, II, Firenze 1981, n° 9, p. 217-218), non datato ma copiato dallo stesso Rinaldo di Ludovico Volterrano. Potrebbe trattarsi della copia allestita negli anni Cin-quanta del Quattrocento ricordata in varie lettere scambiate con Giovanni de’ Medici: cfr. ASF, MAP, VI 101 (Rainaldo Lodovici da Volterra a Giovanni de’ Medici 5 marzo 1450: « A presso vorrei mi serviste di quelle epistole del Generale Ambrosio innaçi che voi andaste al Bagno, che le scriverrei in questa quaresima; io ne dissi a Piero, quan-do costì fui: dissemi non erano in casa »); VIII 94 (23 marzo 1450, Rainaldo chiede a Giovanni di prestargli per un mese o due le epistolae d’Ambrogio Traversari); ibidem, VI 180 (18 giugno 1453, Rainaldo chiede a Giovanni di pagare al cartolaio Michelino il prezzo della rilegatura dell’epistolario di Traversari e altri). Queste lettere sono citate da ROSSI, L’indole degli studi di Giovanni di Cosimo de’ Medici, in « Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, classe di sc. mor., stor. e filol. », s.V, 2 (1893), p. 38-60 e 129-150 (42) e in P. VITI, L’archivio Mediceo avanti il principato e la cultura umanistica, in I Medici in rete, a cura di I. COTTA - F. KLEIN, Firenze 2003, p. 185-231 (rispettivamente p. 199 note 56 e 239), con un errore nella collocazione di una lettera e senza collegare la prima e le ultime due lettere a causa di una variante grafica nel nome di Rainaldo se-gnalato sotto due voci (Raynaldus Ludovici et Rainaldo di Ludovico) nell’indice generale.
27. Due testimoni dei cinque conservati sono datati del generalato di Mariotto: 1463 per l’autografo di Rinaldo di Ludovico Volterrano (BNCF, Conv. Soppr. G. 3. 35), 1468 per quello di Giovanni da Laterina (ibidem, Conv. Soppr. C. 2. 38). L’altro autografo di Rinaldo di Ludovico Volterrano attualmente a Volterra potrebbe essere stato realiz-zato negli anni 1450-1453. Sui legami molto stretti fra Mariotto e Traversari, CABY, De l’érémitisme, p. 650-657 e E. GUERRIERI, Mariottus de Allegris prior generalis, in EAD., Clavis, p. 125-129.
21-Caby.indd 531 09/04/2015 14:47:17
CÉCILE CABY532
Queste due collezioni di maggior successo costituiscono il principale canale di conservazione delle lettere di Traversari: un canale conforme alle pratiche umanistiche, anche per la raccolta detta monastica, che non ha niente a che vedere con il canale tradizionale di conservazione delle lettere dei priori generali camaldolesi fin dalla fine del Duecento. Dal generalato di Gerardo II, infatti, i priori generali camaldolesi, in questo conformi a una prassi comune in numerosi ordini religiosi e istituzioni dal Duecento in poi, usano registrare le lettere amministrative con le quali, in accordo e nel rispetto delle decisioni del capitolo generale, esercitano il governo dell’Ordine. I registri di queste lettere formano una serie non completa ma di una notevole consistenza, attualmente conservata all’Archivio di Stato di Firenze.28 Questa serie si interrompe alla fine del generalato di Giovanni degli Abbarbagliati (fine Trecento) con qualche stralcio per il generalato di Benedetto Lanci da Forlì pre-decessore del Traversari (1422-1431). È del tutto spoglia per il generalato del Traversari e di due dei suoi immediati predecessori (Antonio del Ferro, Raffaele Bonciani) e successori (Gomes e Francesco da Agna), mentre la serie riprende saltuariamente con Mariotto Allegri a partire dal 1456. Ora, non vi è alcun dubbio che l’incarico di priore generale abbia portato Traversari a spedire all’interno del proprio Ordine let-tere di un tenore ben diverso e in un numero ben superiore a quello delle lettere ai monaci selezionati nelle varie collezioni epistolari, come mettono in evidenza la regolare scoperta di lettere sparse, di impronta tradizionale (cioè per lo più conforme alle norme strutturali e formulari dell’ars dictaminis) segnalate dai filologi per il gusto dell’autografo e della “trouvaille”.29 Oltre a queste lettere, il cui numero si accrescerebbe
28. ASF, Camaldoli App., 19-39 ai quali va aggiunto un frammento di registro del priore Gerardo (1278) nell’Archivio di Stato di Modena, Corporazioni Religiose Soppresse, S. Maria di Vangadizza, 7; cfr. CABY, De l’érémitisme, p. 35 e 49; P. LICCIARDELLO, Le-gislazione camaldolese medievale (XI-XV secolo). Un repertorio, « Benedictina », 54 (2007), p. 23-60 (31).
29. Colgo l’occasione per segnalare la presenza nell’Archivio di Camaldoli di un documento proveniente da un insieme di pergamene di S. Mattia di Murano scampate all’incorporazione nei fondi Manimorte dell’Archivio di Stato di Venezia, recentemente ricollocato in ASC, Perg. S. Vito, 16 bis (segnatura attuale a matita; collocazione moderna Diversa LXXVII), che consiste in una lettera di collazione dell’abbazia di S. Vito a un certo Luca de Alemania, scritta della mano del Traversari e spedita da S. Maria degli Angeli, il 29 agosto 1439, meno di due mesi prima della morte del generale. Questa no-mina interviene dopo un periodo difficile nel monastero vicentino documentato dall’Ho-doeporicon del Traversari (A. TRAVERSARI, Hodoeporicon, ed. in A. DINI-TRAVERSARI, Am-brogio Traversari e i suoi tempi. Albero genealogico Traversari ricostruito. Hodoeporicon, Firenze 1912, p. 76); il priore Luca è ancora in carica nel 1456 (ASF, Camaldoli App., 36, f. 20r) ma rinuncia dopo 24 anni di governo il 6 maggio 1460 (ASC, Perg. S. Vito, 18); su
21-Caby.indd 532 09/04/2015 14:47:17
GLI EPISTOLARI CAMALDOLESI LATINI NEL QUATTROCENTO 533
probabilmente indagando la totalità dei fondi dei vari monasteri camal-dolesi, non sappiamo invece se Traversari approntò un registro di tipo notarile e amministrativo. In una lettera del 4 febbraio 1432 – ossia due anni prima degli accenni alla raccolta di Cristoforo da S. Marcello – il Traversari, allora a Roma, chiede a suo fratello Girolamo di inviargli il quaderno delle sue lettere trascritte dal monaco Parente e un altro quaderno più piccolo di sua mano.30 A giudicare dal tipo di rapporto fra il monaco Parente e Traversari, così come risulta dalle epistole di quest’ultimo,31 Parente era richiesto per mansioni di un certo livello, come la copia di un codice di Origene, e si può ipotizzare che il qua-derno delle epistole che era stato incaricato di copiare non fosse un banale registro amministrativo. Si può addirittura immaginare che Tra-versari, eletto di recente, non disponesse ancora di cancellieri di fiducia al di fuori del manipolo dei suoi discepoli degli Angeli. Comunque sia, rimane delicato immaginare a che tipo di registro di lettere questi due quaderni (il quaderno di Parente e il quadernetto della mano di Tra-versari) si potessero riferire. Abbiamo infatti visto prima che Traversari al momento di comporre la sua raccolta epistolare richiese ad alcuni suoi corrispondenti di inviargli le lettere loro spedite nel passato, il che sembra mettere in evidenza che non registrava in modo sistematico le proprie lettere.
È stata in passato suggerita da monsignor Mercati (sulla base di una segnalazione di Mehus),32 e ripresa anche di recente senza reale approfondimento,33 l’idea che uno di questi registri di lettere d’ufficio
di lui, si veda anche G. MANTESE, Memorie storiche della Chiesa Vicentina, III/2, Vicenza 1964, p. 360). Ringrazio Ubaldo Cortoni per la segnalazione della lettera.
30. Cfr. TRAVERSARI, Epistolae, XI 13, col. 492: « Quaternionem quoque epistolarum nostrarum Parentis nostri manu, et alium manu nostra breviorem quaeso ut mittas; nam nescio quo pacto remansit apud vos. Inquire illos in cellula nostra, illic enim credo utrumque reperire »; SOTTILI, Epistolografia fiorentina, p. 193-194; PONTONE, Ambrogio Traversari monaco e umanista, p. 193; EAD., Lettere inedite di Ambrogio Traversari, p. 73 e 79. Difficile stabilire il rapporto con il registrum voluto dal monaco Facino lo stesso anno, cfr. sopra nota 10.
31. Su questo monaco cfr. SOTTILI, Epistolografia fiorentina, p. 194, nota 58 (che giustamente contesta l’identificazione con il personnaggio delle Disputationes Camaldu-leneses).
32. MERCATI, Traversariana, p. 51, in part. nota 2, che si rifà alla descrizione del manoscritto proposta da L. MEHUS (AMBROSII TRAVERSARII [...] latinae epistolae, I, p. IV) e da A. M. BANDINI (Bibliotheca Leopoldina Laurentiana, seu Catalogus manuscriptorum qui iussu Petri Leopoldi Arch. Austr. Magni Etr. Ducis in Laurentianam translati sunt. Quae in singulis codicibus continentur accuratissime describuntur, edita supplentur et emendantur, Florentiae 1791-1793, II, col. 456).
33. IARIA, Un discepolo di Ambrogio Traversari, p. 245, nota 10.
21-Caby.indd 533 09/04/2015 14:47:17
CÉCILE CABY534
potrebbe essere identificato nell’attuale Strozziano 104 della Biblioteca Medicea Laurenziana, proveniente, si badi, dalla biblioteca della Badia fiorentina. Cosa però nasconde precisamente questo manoscritto? 34 Si tratta di un codice miscellaneo scritto da una mano cancelleresca non sprovvista di qualche influenza umanistica, di modulo piccolo e fitto, probabilmente quella del Benedictus Biffolus thabellio Florentinus che nel margine inferiore del f. 15r, che corrisponde alla fine di un primo gruppo di lettere di Ambrogio Traversari, annuncia che ha copiato altre lettere dello stesso Ambrogio suo conoscente (« in ipsius prelibati sacerdotis memoria, quem cognovi »). Se non si tratta di un omonimo, il copista è quindi il notaio e poeta fiorentino Benedetto Biffoli, che, con questo codice, si approntò uno zibaldone di lettere che raccoglieva lettere e traduzioni dal greco di Leonardo Bruni, lettere appunto del Traversari, alcune missive pubbliche nonché la traduzione del Charon di Luciano a cura di Aurispa.35 Ma che cosa e da dove copiava il notaio? Il fascicolo delle lettere del Traversari si apre con un titolo (« Hoc est registrum litterarum obbedientialium tam iustitie quam aliorum quocumque negotiorum apertarum sub sigillo offitii et apodia anuli reverendissimi in Christo patris et domini Ambrosii sacre Chamaldu-lensis heremi prioris totiusque Ordinis generalis » 36), che rimanda a un formulario amministrativo caratteristico dei volumi dei registri dei priori generali.37 Le lettere che seguono, però, possono tutte esser collegate con lettere presenti nelle grandi sillogi canoniche, con le solite varianti (per esempio nell’intitulatio, nella data o, più interessante, nella presenza di copiosi post scriptum).38 Le lettere trascritte sono indifferentemente
34. Sul codice: Censimento dei codici dell’epistolario di Leonardo Bruni, a cura di L. GUALDO ROSA, II, Roma 2004, p. 62-64; J. HANKINS, Notes on the textual tradition of Epistulae familiares, ormai in ID., Humanism and Platonism, I, Roma 2003, p. 63-98 (77); dai quali si ricava la descrizione seguente: cart. XV ½, f. III (recc.) + II + 167 (num. sec. XVII che salta i fogli bianchi) + III’ (rec.); scrittura semigotica di modulo piccolo e fitto, alcune iniziali miniate con bianchi girari; al f. 1 « Est Abbatiae Flor. 5. n° 15 ».
35. Su Benedetto Biffoli, cfr. R. SCRIVANO, Biffoli, Benedetto, in DBI, X, 1968, p. 393 e B. BIFFOLI, Le Rime, a cura di R. GENTILE, Roma 1994. Si tratta forse dello stesso Bif-folus della lettera di Traversari a Mariotto del 23 dic. 1436 (TRAVERSARI, Latinae epistolae, XV 43, col. 715 [= LUISO, XV 48]).
36. BML, Strozziano 104, f. 42r.37. Per esempio, le lettere di Bruni copiate nello stesso codice sono introdotte in
questo modo (ibidem, c. 1r): « Hoc est registrum epistolarum famosissimi viri domini Leonardi de Arretio viri clarissimi ac Florentini poete ad plures amicos atque benivolos suos transmissarum, et alia quedam opuscula per eum e greco in latinum conversa ».
38. Questa osservazione si basa sul confronto fra il manoscritto e le due principali edizioni moderne, quella di Edmund Martène e Ursmer Durand (E. MARTÈNE - U. DU-RAND, Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium
21-Caby.indd 534 09/04/2015 14:47:17
GLI EPISTOLARI CAMALDOLESI LATINI NEL QUATTROCENTO 535
di due tipi. Da un lato, in particolare per quelle ai superiori o monaci dell’Ordine che non hanno un commercio epistolare intenso con Tra-versari, sono missive di tipo amministrativo, la cui struttura retorica (in particolare quella dell’arenga) riproduce quella in uso nelle cancellerie e teorizzata dall’ars dictaminis: sono in tutto paragonabili a quelle recentemente pubblicate da Simona Iaria o da Marzia Pontone, ma anche – merita di esser sottolineato – a tante altre presenti nelle sillogi epistolari canoniche del Traversari. Da un altro lato, in particolare per le lettere al fratello o a Mariotto, anche quando si dilungano su aspetti molto concreti della vita dell’Ordine, sono lettere segnate dalla nuova impostazione umanistica e dalle regole tacite della lettera familiare (con intitulatio ridotta, uso della datazione topica sotto forma Ex monasterio piuttosto che Datum in monasterio, ecc.). A parte qualche rara eccezio-ne, le lettere del primo gruppo copiato nel manoscritto Strozziano 104 sono tutte indirizzate a monaci. Le date indicate si limitano al giorno e al mese, senza anno per la maggioranza dei casi, ma sono databili fra l’ottobre 1431 (quindi a ridosso dell’elezione del Traversari al capitolo di Bertinoro) e l’anno 1436: l’ordine delle lettere però non è strettamente cronologico e sembra combinare ordine cronologico e per destinata-rio. Un dato singolare (che sembra indicare uno strumento di lavoro in corso) sta nel fatto che numerose date espresse secondo il sistema della successione dei giorni nel mese sono state cancellate dal copista e corrette con il sistema del calendario romano. Questi elementi, e altri che talvolta non concordano, non permettono nello stato attuale della ricerca di trarre conclusioni definitive: manca in effetti uno studio pre-ciso sull’organizzazione delle lettere nelle varie sillogi canoniche, che le edizioni hanno in gran parte sconvolto. Nell’immediato, però, non esclu-derei che si possa trattare della traccia non tanto di un registro d’ufficio, quanto di un carteggio raccolto nel corso della travagliata operazione di preparazione dell’epistolario da parte del Traversari stesso, paragonabile a quello che si conserva nel codice Trivulziano 1626 dell’Ambrosiana di Milano e che M. Pontone ha recentemente caratterizzato come una delle « raccolte primordiali » che circolavano prima delle collezioni “ufficiali”.39 Una cosa è sicura: la prassi epistolare del Traversari nonché il suo uso della registrazione erano ben diversi da quelli dei suoi predecessori, ma anche di quelli dei suoi successori, come Mariotto Allegri o Pietro Dolfin, che non registrarono nei loro registri nient’altro che lettere di tipo cancelleresco, affidando nel secondo caso le lettere di impronta
amplissima collectio, III, Parisiis 1724, col. 1-728) e quella di P. Canneti e L. Mehus (cfr. sopra, nota 9).
39. PONTONE, Lettere inedite di Ambrogio Traversari, p. 79 per l’espressione citata.
21-Caby.indd 535 09/04/2015 14:47:17
CÉCILE CABY536
umanistica ad altri luoghi di conservazione e diffusione. Insomma, tutto tende a dimostrare che così come la scrittura umanistica del Traversari tende a sconfinare in documenti di tipo burocratico e amministrativo,40 la prassi epistolare del Traversari tende, anche in raccolte che riman-dano a pratiche chiaramente umanistiche, a far coesistere missive che rispettano norme e formulari delle artes dictaminis con altre conforme agli usi della lettera umanistica.
PIETRO DOLFIN O L’ESUBERANZA EPISTOLARE
Nel caso di Pietro Dolfin, lontano successore del Traversari al ge-neralato dell’Ordine, nonché suo dichiarato ammiratore, la divisione fra le due prassi epistolari, quella che chiamo per comodità umanistica e quella amministrativa, è a prima vista più netta in quanto si conservano, oltre a varie versioni manoscritte e a stampa della raccolta epistolare, tre registri delle lettere amministrative. Si tratta dei registri 37 (1480-1491), 38 (1493-1509) e, in parte soltanto, del registro 39 (1510-1522) della serie Appendice Camaldoli dell’Archivio di Stato di Firenze, che raccolgono le lettere e gli atti generalizi di Dolfin in quanto priore generale non-ché, in fine al primo volume, una raccolta di lettere inviate a Dolfin da Francesco Todeschini Piccolomini cardinale di S. Eustachio e cardinale protettore dell’Ordine dall’aprile 1479.41 Le lettere o le minute delle let-tere sono scritte in ordine cronologico da vari cancellieri, laici o monaci camaldolesi, che si alternano nel lavoro, e riguardano sistematicamente le vicende amministrative dell’Ordine. A prescindere dalle variazioni nei particolari della registrazione e dell’indicizzazione, si tratta in definitiva di registri di tipo notarile o amministrativo sul modello di quelli che producono tante istituzioni dell’epoca e soprattutto sul modello dei registri dei priori camaldolesi precedenti.
Ben diversi sono invece le raccolte epistolari frutto di una “posture” di tipo umanistico, maturata in Dolfin grazie agli scambi con l’uma-nesimo veneto, fin dalla formazione presso il maestro Pietro Pierleoni
40. Cfr. PONTONE, Ambrogio Traversari monaco e umanista, p. 205-215.41. Mentre il primo registro è ordinato, gli altri due lo sono sempre di meno. Il vo-
lume ASF, Camaldoli App., 39 è chiamato dal cancelliere, che lo inizia il 25 aprile 1510, « registrum tertium quam plurimum et diversorum actorum et scripturarum emanantium et procedentium ab officio priorarus et generalatus reverendissimi in Christo patris et domini D. Petri Delphini sancte Camaldulensis eremi prioris et totius Ordinis eiusdem generalis » (c. 1r); ma la parte del registro che comprende le decisioni del priore generale Dolfin si conclude a c. 52v (2 luglio 1513), un anno circa prima della rinuncia alla carica di generale, il 13 giugno 1514.
21-Caby.indd 536 09/04/2015 14:47:17
GLI EPISTOLARI CAMALDOLESI LATINI NEL QUATTROCENTO 537
da Rimini, dalla frequentazione degli autori antichi e dal modello del suo predecessore Traversari.42 Dolfin scrive tanto, a numerosissimi cor-rispondenti e con lo scopo esplicito di trasmettere le sue lettere a un pubblico dotto e ampio. L’attenzione alla conservazione della propria produzione epistolare e al suo allestimento nasce probabilmente prima del generalato, come testimonia il fascicolo di 168 lettere scritte fra 1462 e 1480, che precede la silloge del generalato nel primo codice berlinese proveniente da S. Michele di Murano.43 Ma a partire dall’accessione al generalato (10 dicembre 1480), Dolfin comincia probabilmente a far trascrivere la totalità delle sue lettere agli scribi di Camaldoli: da un lato le lettere ad familiares o di qualche pretesa letteraria; dall’altro le lettere amministrative.
Disperse, ma non meno utili, sono le notizie che, nelle lettere fa-miliari, trasudano sulle tappe e sulle modalità di quello che diventa molto lentamente un progetto di raccolta organica e organizzata, di cui conserviamo almeno tre versioni di autore: due manoscritte 44 e una a
42. Sulla formazione veneta, si vedano R. ZACCARIA, Dolfin, Pietro, in DBI, XL, 1991, p. 565-571 e il contributo di E. Guerrieri in questo volume, che rimandano alla bibliografia pregressa; sul modello di Traversari, C. CABY, Culte monastique et fortune humaniste: Ambrogio Traversari, “vir illuster” de l’ordre camaldule, « Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge. Temps modernes », 108 (1996)/1, p. 321-354 e EAD., I Pa-dri nell’osservanza camaldolese: uso, riuso, abuso, in Tradizioni patristiche nell’Umanesimo, a cura di M. CORTESI - C. LEONARDI, Firenze 2000, p. 175-191.
43. Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Lat. Fol. 668, identificato da Lucia Merolla come il manoscritto 1048 di S. Michele di Murano: cfr. L. MEROLLA, La biblioteca di San Michele di Murano all’epoca dell’abate Giovanni Bene- detto Mittarelli. I codici ritrovati, Manziana (Roma) 2010, p. 487-488 che ne attribuisce la copia a Bernardino Gadolo sulla scia di Mittarelli. 167 di queste lettere anteriori al generalato furono pubblicate da Martène e Durand, assieme ad altre 74 degli anni del generalato fino ai primi mesi dopo la deposizione: PETRI DELPHINI [...] Epistolae CCXLII quae ineditis desiderantur [...], in MARTÈNE-DURAND, Veterum scriptorum, III, Parisiis 1724 (d’ora in poi DELPHINI Epistolae, ed. MARTÈNE-DURAND), col. 913-1212; su questa edizione cfr. A. BARZAZI, Gli affanni dell’erudizione: studi e organizzazione culturale degli ordini religiosi a Venezia tra Sei e Settecento, Venezia 2004, p. 292-293 e il contributo di E. Guerrieri in questo volume.
44. La prima silloge manoscritta è composta dai tre volumi Berlin, Staatsbiblio-thek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Lat. Fol. 669-670-671 [d’ora in poi Berlin, Lat. Fol. 669-670-671], che corrispondono ai manoscritti 723-724-725 di San Michele di Murano: cfr. H. DEGERING, E. JACOBS, Neue Erwerbungen der Handschriftenabteilung, I. Lateinische und Deutsche Handschriften erworben 1911, Berlin 1914, p. 34-36 e MEROLLA, La biblioteca di San Michele di Murano, p. 335-337. La seconda silloge manoscritta sta nel codex in quattro tomi Firenze, BNC, Conv. Soppr. E. 3. 405. Esiste anche una copia dell’epistolario della fine del secolo XVI probabilmente a partire dagli attuali co-dici berlinesi (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. XI. 92 [3828]), sul quale vedi MEROLLA, La biblioteca di San Michele di Murano, p. 335 e S. MARCON, Pietro Dolfin
21-Caby.indd 537 09/04/2015 14:47:17
CÉCILE CABY538
stampa.45 Mi soffermerò qui soltanto su alcune di queste notizie – il cui censimento deve ancora essere completato – scelte per il loro carattere esemplare nell’ambito di questo intervento. Appena eletto priore gene-rale, Pietro Dolfin concede all’ancora novizio Bernardino Gadolo l’uso della sua cella a S. Michele e dei libri che vi sono rimasti; 46 nello stesso tempo, gli affida la lettura e la trascrizione di un gruppo di lettere scrit-te dal vescovo di Belluno, Pietro Barozzi, sottolineando il gusto comune dei tre chierici per la scrittura epistolare e, in particolare, per le raccolte epistolari.47 Dopo la morte del vescovo, nel frattempo passato alla sede di Padova, Dolfin riprese il suo antico progetto di raccogliere in un vo-lume le lettere ricevute dal Barozzi.48 Nel novembre del 1483 il generale
« Epistolae », in San Michele in Isola. Isola della conoscenza. Ottocento anni di storia e cultura camaldolesi nella laguna di Venezia, a cura di M. BRUSEGAN, P. ELEUTERI, G. FIACCADORI, Torino 2012, p. 291-292.
45. Si tratta dell’edizione curata da Dolfin stesso che comprende esclusivamente lettere posteriori all’elezione generalizia (1480-1524): PETRI DELPHINI [...] Epistolarum volu-men, Arte et studio Bernardini Benalii, Venetiis 1524 (EDIT16: CNCE 17444) = DELPHINI Epistolarum volumen. Su questa antologia a stampa vedi il contributo di E. Guerrieri in questo volume e i suoi lavori in corso.
46. BNCF, Conv. Soppr. E. 3. 405, I, p. 17; Berlin, Lat. Fol. 669, c. 9rv (a Ber-nardino Gadolo novizio, 13 ott. 1481): « [...] Libros et epistulas, ubi fidelis se obtulerit baiulus, mittam ad te. Meas vero epistulas tot accipies, quot ego accipiam tuas. Scribe itaque saepius quia totiens rescribam, neque causeris imperitiam quando profecto scri-bentis affectum metior, non ornatum et animi ac morum munditiam, non verborum ac stili cultum requiram. De cellulae nostrae habitatione quod tibi coram consilium dedi, illud teneas. Si tibi eam maiores tui promiserint, non recuses; sin autem secus eis visum fuerit ne moleste feras. Omnino ad huiusmodi noli cor apponere, sed memento cellae beati Hilarionis quam instar sepulchri fuisse legimus et cogita quia non locus sanctifi-cat hominem sed homo locum. Si tamen illius habitator fueris, cum libros manu mea conscriptos inspexeris, arripueris, evolveris, erumpant gemitus imo de pectore ac dicito: Heu miserum hunc olim horum scriptorem. In deliciis paradisi celae constitutus ubi suavissimos scripturarum carpebas fructus, in quos modo fluctus eiectus es? Et ita mihi compatiens pro me frequenter Dominum invocabis. Vale, fili carissime. Ex Fontebono, die XIII octobris MCCCCLXXI ».
47. Cfr. infra, note 92-93.48. Cfr. DELPHINI Epistolae, ed. MARTÈNE-DURAND, III 223, col. 1172-1173 (a Euse-
bio Priul monaco di Murano, 9 luglio 1511): « Subiit animum velle curare, ut colendæ memoriæ Paduani episcopi, quas ad me olim scripsit epistolas, redigantur in codicem atque uno volumine pariter copulentur. Aggressurus tale opus, cum per ordinem eas cœpissem digerere, quota quæque scripta fuisset, ut seriatim et deinceps in libro descri-bentur, reperi deesse omnes illas, quas ante Generalatum dedisset ad me » (vedi anche sotto, nota 66); ibidem, 235, col. 1180 (al sottopriore Mattia, 11 dic. 1512): « In trascriben-dis epistolis Patavini antistitis nulla tibi futura sit mercedis ratio [...] Epistolas nostras numquam tibi displicuisse palam demonstrasti. Verum ubi legere episcopi nostri litteras cœperis, tanti te illas facturum non dubito, ut tamquam similam furfuri, ita eas nostris meritissime præferendas putes ».
21-Caby.indd 538 09/04/2015 14:47:17
GLI EPISTOLARI CAMALDOLESI LATINI NEL QUATTROCENTO 539
camaldolese spedisce allo stesso Gadolo una lettera nella quale, oltre a dare consigli sui modelli da emulare nella scrittura epistolare, svela che il suo corrispondente aveva avviato, per conto suo, una raccolta delle lettere del priore generale, che quest’ultimo lo prega di non divulgare.49 Un decennio più tardi, Dolfin è probabilmente in grado di ordinare un primo volume delle proprie missive, che deposita presso Bernardino Gado lo: in diverse lettere spedite a questo proposito durante l’autunno 1493, Dolfin dà della sua collezione epistolare un’immagine che può sem-brare più burocratica che letteraria, dal momento che insiste soprattutto sull’uso che egli stesso potrebbe farne, o che potrebbe esserne fatto, come strumento di difesa contro gli oppositori al suo governo.50 Ma il
49 BNCF, Conv. Soppr. E. 3. 405, I, p. 86-87 = Berlin, Lat. Fol. 669, c. 44r; DELPHINI Epistolae, ed. MARTÈNE-DURAND, III, 177, col. 1128 (a Bernardino Gadolo, 13 novembre 1483): « Non respondeo litteris tuis ubi primum illae redduntur ob multiplicia que superveniunt negocia. Quod facerem quam libentissime tum quia te diligo, tum quia meas summa (ut scribis) legis volupate. Pluris tamen illas facis quam merentur, presertim cum pleræque fere omnes minus accurate conscriptæ sint, nec dignæ profecto que (ut scribis fecisse) redigantur in codicem. Quas itaque collegisti non sunt publicandæ, sed serventur penes te, aut saltem intra domesticos cohibeantur parietes. Neque enim si illas edideris ita ab aliis sicut a te comprobabuntur, eruntque complures qui utrumque nostrum temeritatis arguent. Quamobrem si eas suppresseris ac neglecte potius iacue-rint, melius feceris nosque multorum subduxeris calumniae qui vilia contemnendaque in volumen collecta irridebunt, ut primum conspexerint. Lege bonorum auctorum an-tiqua volumina. Sume in manus bonorum auctorum frequen ter Hieronymi Cyprianique epistolas, de gentilibus autem Ciceronis ac Plinii, ceterorumque complurium. Horum si te lectione oblectaveris fuerisque ipsorum studiosus facile quam cupis epistularum conscribendarum consequeris facultatem ». Cfr. SCHNITZER, Peter Delfin, p. 51-52 e infra nota 62.
50. BNCF, Conv. Soppr. E. 3. 405, II, p. 131-132 = Berlin, Lat. Fol. 670, c. 71r = Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. XI. 92 (3823), ep. 85, c. 467 (a Bernardino Gadolo, Fontebuono, 16 sett. 1493): « Epistolarum mearum volumen cuicumque creden-dum non est, cum vel domi vix securum existimerim [Berlin existimem]. Expettere illud audio colendissimum protectorem et nonnihil hos diebus inter prandendum innuit mihi [prima nella lettera, Dolfin segnala che ha incontrato il cardinale Piccolomini protettore dell’ordine camaldolese]. Nisi apetius postulaverit, non edam. Quid enim est in illo ut a tanto viro legi debeat. Ambrosii predecessoris nostri epistoles venales non inveni. Si inciderint in manus nostras, faciam satis votis tuis »; BNCF, Conv. Soppr. E. 3. 405, II, p. 133-134 = Berlin, Lat. Fol. 670, c. 72rv (a Gadolo, Fontebuono, 2 ott. 1493): « Missu-rus ad te et collegam tuum visitationis mandatum satisfaciendum duxi hac occasione tum tuo desyderio, tum meo animo ut epistolarum mearum volumen deponerem apud te, quod non semel a nobis contendisti. Verum non ille votis tuis facture sint satis [Berlin Verum vero illae votis tuis facturae sint satis], tu videris. Me sane ea preter ceteras pervicit ratio ut transmitteretur tibi, ut si forte hominum malignitate que hac nostrorum temporum fece in dies excrescit multa nimis, aliquid de mea aministratione sinistri et culpe obnisii audieris, habeas quid pro me oblocutoribus respondeas atque obtreffatoribus [Berlin obtrectatoribus] meis. In hoc enim epistolarum volumine singula
21-Caby.indd 539 09/04/2015 14:47:17
CÉCILE CABY540
confronto fra le lettere anteriori al 1493 conservate nelle sillogi epistolari e quelle dei registri amministrativi non lascia sussistere dubbi sulla diffe-renza di natura dei due tipi di raccolta.51 Innanzitutto, la presentazione delle lettere rispetta la logica dell’edizione epistolare umanistica e non quella della raccolta notarile: prevede in particolare l’eliminazione in ogni lettera della formula di saluto iniziale e la sostituzione della forma completa dell’indirizzo con una breve inscriptio. Per quanto riguarda l’impostazione delle singole missive – mi baso sull’esempio delle lettere scambiate con Bernardino Gadolo che ho studiato più da vicino – benché abbondino in riferimenti “tecnici” sulla strategia di salvataggio dell’Ordine camaldolese o di espansione della Congregazione de unitate di S. Michele di Murano, e benché Gadolo sembri lamentarsi spesso dell’aridità delle missive che il suo maestro e amico gli invia per di più troppo raramente, si tratta di lettere che rispettano i canoni stilistici della lettera umanistica. Dimostrano una netta consapevolezza della va-rietà generica delle epistole (in particolare le consolatorie 52) e indulgono,
fere seriatim descripta invenies que [Berlin add. mihi] in generalatu acciderunt adversa utique plurima ac pene omnia, prospera vero et læta, aut nulla aut certe rarissima. Quorum cognitione poteris etiam nonnihil proficere ut remotus ab omni ambitione in eo magis ac magis proposito confirmeris exemplo meo, ne aliquando tibi ulla surrepat celsioris gradus ac dignitatis cogitatio. Est enim periculosa eiusmodi titillatio animi et a qua paucos immunes novi. Cave autem ne cuiquam ex coenobium precipue legendum librum tradas. Sunt enim in eo complura que non omnibus permittenda existimo ut legantur, ne forte ad aures eorum perveniuant qui adversus illos prompta defensione atque ordinis et vere et libere protuli, sicque periculo exponatur, tum liber ipse, tum libri autor. Custodies itaque depositum quoadusque id repetendum censuero ». BNCF, Conv. Soppr. E. 3. 405, II, p. 145-146 = Berlin, Lat. Fol. 670, c. 78r = Marc. Lat. XI 92 (3823), ep. 4, c. 474 (allo stesso, Firenze 26 ott. 1493): « Si tibi gratum fuit quod deposui apud te epistularum mearum volumen, nihil miror. Evenit hoc tibi sive curiositate, ut sit, nove rei, sive, ut honestius pro te loquor, quum me plurimum diligis. Quomodocumque sese res habeat, cave ne tuto a me positum loco in portu faciat naufragium [...] Am-brosii epistolas perquiram diligentius et si alicubi venales invenero, curabo ut emantur tibi [...] Utrumque librum per Antonium mihi transmissum illesum accepi, et gratias ago diligentie tue. Erit Byblia indivisus semper in eorum ininerum ac peregrinaturum comes, quum revera sine ipsa, vel in amplissima bybliotheca sine libris mihi esse videor. Legi epistulam tuam ad reverensissimum patriarcham, accomodate et ornate scriptam [...] »; alcune di queste lettere erano state già citate dal codice veneziano in SORANZO, Pietro Dolfin, p. 21-22.
51. Basta confrontare le lettere a Bernardino Gadolo nelle raccolte epistolari e quelle allo stesso conservate nei registri, come la notificazione di un documento papale del 9 dicembre 1492 (ASF, Camaldoli App., 37, c. 159v) o la lettera patente del 30 maggio 1493 a proposito del fuggiasco Urbano Malumbra (ibidem, c. 162rv).
52. Cfr. per es. BNCF, Conv. Soppr. E. 3. 405, II, p. 81 = Berlin, Lat. Fol. 670, c. 45rv (a Bernardino, 1° febbraio 1493): « Nudius tertius litteras tuas una cum litteris reverendissimi protectoris accepi quibus ambo me hortamini ad leniendum levandumque
21-Caby.indd 540 09/04/2015 14:47:17
gli epistolari camaldolesi latini nel quattrocento 541
per esempio, al gusto per la narrazione di notizie straordinarie (l’orso regalato a Barozzi, la giraffa offerta a lorenzo il magnifico dal sultano, l’assedio di camaldoli, i vari segni che precedono la morte del magni-fico, ecc. 53), per i racconti di viaggio (e dolfin non smette di andare e venire da camaldoli a Firenze, a roma, a Venezia per conto suo o in compagnia di qualche prelato come il cardinale giovanni dei medici 54), per le notizie sugli amici comuni (spesso membri del patriziato veneto, come pietro priul), per la discussione sui libri e sulle opere famose,55 sulle opere d’arte 56 e sugli uomini illustri (come pico e poliziano, che
dolorem dignationis sue quo ob illustrissimi ducis amalphie fratris sui mortem pluri-mum afflictus videbatur. satisfeci ex temporali epistola, offitio meo non tamen utriu-sque desyderio neque enim ita doctus sum in hoc regno coelorum ut facile proferre de thesauro meo possim nova et vetera. preterea tamen variis modo distractus sum curis, adeo molestis e gravibus ut nesciam an alius quispiam preter cardinalem senensem cui omnia sine ulla debeo exceptione me adscribendum in ea materia compulisset ».
53. per l’orso di Barozzi, BncF, conv. soppr. e. 3. 405, i, p. 247 = Berlin, lat. Fol. 669, c. 142v; Delphini Epistolae, ed. Martène-DuranD, iii 196, col. 1149-1150 (a pietro Barozzi, 17 maggio 1487). per la giraffa: BncF, conv. soppr. e. 3. 405, i, p. 307 = Berlin, lat. Fol. 669, c. 176v-177r; ed. Delphini Epistolarum volumen, i 76 (a Bernardino gadolo, 24 gennaio 1488): « mense octobri proxime preterito, adducta est Florentiam ex aethiopia camelopardalis ad Florentinum dominum a soldano missa. quae ingressa urbem, maximo totius populi concursu atque tripudio excepta est [...] Hanc, cum ante duos menses essemus Florentiae, et ipsi vidimus ad nostrum usque monasterium, ubi morabamur, perductam nostri gratia. nactus pauxillulum ocii, huius te rei volui facere certiorem et ut eam ex pictura, qualis sit facilius noveris, aere impressam cum his ad te litteris mitto ». per l’assedio di camaldoli nel dic. 1498, cfr. la lettera a pietro Barozzi del 5 dic. 1498 Delphini Epistolarum volumen, v 82 e Ann. Cam., vii, p. 365-367; in una lettera al procuratore curiale mariano cuccini, il 9 marzo 1499, dol-fin parla del racconto come del « libello nostro de oppugnatione camalduli et eiusdem victoria » (BncF, conv. soppr. e. 3. 405, iV, p. 42). per il cataclisma e gli altri signa che precedono la morte di lorenzo, Berlin, lat. Fol. 670, c. 10rv (a Ventura abbate di san michele di murano, 12 aprile 1492).
54. per il viaggio del neo-cardinale giovanni dei medici a roma, Berlin, lat. Fol. 670, c. 8v-10r; ed. Delphini Epistolarum volumen, iii 27 (a guido priore degli angeli, 1492 aprile 7).
55. per esempio gli scambi con Bernardino gadolo a proposito di « orationem quendam pogii in laudem Venetorum olim editam (si tratta dell’Oratio in laudem rei publicae Venetorum, in poggio Bracciolini, Opera, a cura di r. FuBini, torino 1964, ii, p. 925-937): BncF, conv. soppr. e. 3. 405, i, p. 242 (a Bernardino gadolo, 27 apri-le 1487) = Delphini Epistolae, ed. Martène-DuranD, iii 195, col. 1149 e BncF, conv. soppr. e. 3. 405, i, p. 683 (allo stesso, 28 gennaio 1492).
56. a questo proposito, si vedano per esempio i fitti scambi riguardo al cantiere di s. michele di murano, c. caBy, « Nostre religionis verum etiam hujus civitatis decus et ornamentum »: les chantiers religieux en Italie à la fin du Moyen Âge (à propos de la reconstruction de San Michele di Murano), in Pouvoirs et édilité. Les grands chantiers dans l’Italie communale et seigneuriale, dir. É. crouzet-pavan, roma 2003, p. 159-193.
21-Caby.indd 541 04/05/2015 14:34:32
CÉCILE CABY542
Dolfin consiglia a Gadolo di incontrare durante il loro soggiorno vene-ziano nel 1491 57).
D’altronde, numerose testimonianze sottolineano l’impegno letterario con il quale Dolfin cura la sua scrittura epistolare. Una cura che si alimenta a uno studio minuzioso dei modelli più prestigiosi dell’episto-lografia umanistica: gli autori antichi come, in primo luogo, Cicerone, al quale dedica due opuscoli,58 e Plinio; quelli patristici, in particolare Girolamo, del quale trascrive le lettere per appropriarsele,59 nonché le lettere di Bernardo da Chiaravalle; 60 e infine la collezione epistolare di
Ma si trovano numerose allusioni a opere pittoriche esistenti o commissionate come, per esempio, la lettera del 28 gennaio 1492 a Bernardino Gadolo (cit. nota 55) nella quale Dolfin chiede che gli sia mandato un modello di costume dogale e di prospettiva della piazza San Marco per la rappresentazione della conversione del doge Pietro Orseolo nella predella di una tavola d’altare per il monastero di Prataglia.
57. Vedi BNCF, Conv. Soppr. E. 3. 405, I, p. 624 = Berlin, Lat. Fol. 669, c. 336r (a Bernardino Galolo, 28 luglio 1491); vedi anche A. J. HUNT, An Unpublished letter to Politian, « Rinascimento », 25 (1985), p. 127-138 (130-131).
58. Le opere su Cicerone sono: Argumenta in Epistolas Ciceronis (cfr. BAV, Vat. Lat. 13700), Argumenta in quinquaginta et octo orationes et invectivas Marci Tullii Ci-ceronis (di cui si conserva l’autografo in Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. XIV. 112 (4283), c. 92r-104r; un’altra copia anch’essa ritenuta autografa è stata recente-mente segnalata nella Biblioteca Classense di Ravenna, ms. 114, cfr. scheda 51, p. 147-148 in I Libri del Silenzio. Scrittura e spiritualità sulle tracce della storia dell’Ordine camal-dolese a Ravenna, dalle origini al XVI secolo, a cura di C. GIULIANI, Ravenna 2013); e Notae marginales ad libros IV « Retoricum Ciceronis ad Herenium » = San Michele di Murano, ms. 800, attualmente irreperibile. Dolfin segnala il secondo opuscolo in una lettera a Francesco Casonio d’Oderzo (5 maggio 1520): DELPHINI Epistolarum volumen, XII 9. Vedi R. ZACCARIA, Dolfin Pietro, in part. p. 569 e GUERRIERI, Clavis, p. 271-272.
59. L’ammirazione per Girolamo è ricorrente nelle lettere di Dolfin: cfr. SCHNITZER, Peter Delfin (cit. nota 8), p. 49 e le lettere seguenti: DELPHINI Epistolae, ed. MARTÈNE-DURAND, III 14, col. 940-944 (a P. Barozzi, 1472 ott. 19); 171, col. 1122-1123 (a Pietro da Portico, 1482 sett. 30); DELPHINI Epistolarum volumen, III 4 (a Ugolino Verino, 29 nov. 1491): « Longe secus, quam vereri ipse visus es, evenit mihi. Terrendum me dubitasti magnitudine voluminis. Ego vero perlegi totam quam ad me misisti, poematis tui par-tem et ea sane voluptate, ut semel sumptum opus legendi gratia, vix deposuerim donec ad novissimum usque versum illud percurrissem. Intermisi, quae mihi erat in manibus, epistolarum divi Hieronymi lectionem: eleganti heroico tuo mirum in modum delectatus. Si reliquum miseris, ne iota quidem unum, aut unum apicem praetermittam quin legam totum »; DELPHINI Epistolae, ed. MARTÈNE-DURAND, III 204, col. 1156-1157 (al monaco Paolo, 3 marzo 1497) e DELPHINI Epistolarum volumen, VIII 33 (a Benedetto di Mandello monaco a S. Michele di Murano, 4 nov. 1505). Sulla trascrizione delle lettere di Giro- lamo nel codice BAV, Vat. Lat. 13702, e in generale sulle altre trascrizioni umanistiche di Dolfin, cfr. E. GUERRIERI, Clavis, p. 280 e il suo contributo in questo volume.
60. Cfr. DELPHINI Epistolae, ed. MARTÈNE-DURAND, III 217-218, col. 1168-1169: all’abate di Settimo, 19 sett. 1508 e 10 agosto 1510.
21-Caby.indd 542 09/04/2015 14:47:18
GLI EPISTOLARI CAMALDOLESI LATINI NEL QUATTROCENTO 543
Ambrogio Traversari.61 In una lettera a Bernardino Gadolo del 13 no-vembre 1483, Dolfin consiglia per esempio al monaco di S. Michele di leggere le opere antiche dei buoni autori, di aver sempre sotto mano le epistole di Girolamo e di Cipriano, nonché quelle di Cicerone e di Plinio.62 In un’altra lettera allo stesso, del 3 dicembre 1495, con la quale Dolfin commenta un consiglio datogli da Gadolo sull’opportunità di usare la lingua volgare nella corrispondenza con il Senato veneto, il priore generale ringrazia e concorda, ma giustifica la sua consuetudine di scrivere in latino dal modello dei padri antichi e recenti:
Emulo sia gli antichi Padri della Chiesa, sia anche i nostri contem-poranei e, per primo, Ambrogio, che diresse il nostro Ordine e del quale esistono epistole latine all’illustrissimo Dominio di Venezia e agli altri principati: io stesso ho usato la lingua latina e l’ho fatto tanto più consapevolmente che nessuno di questi padri non ha mai scritto nessuna lettera altrimenti che in latino. Farò tuttavia secondo le tue esortazioni [...].63
Ma torniamo alla cronologia (per quanto difficile da stabilire e an-cora del tutto provvisoria) della realizzazione della raccolta di Dolfin. Il deposito da parte del generale, nel 1493, di un volumen epistolarum presso Bernardino Gadolo, a S. Michele di Murano, fu meno tempo-raneo di quanto proclamato allora ed è probabile che venne a formare l’embrione della raccolta veneziana delle lettere attualmente a Berlino.
61. DELPHINI Epistolae, ed. MARTÈNE-DURAND, III 227, col. 1175 (a dom Ambrogio priore degli Angeli, 17 febbraio 1512): « Deprehendi paulo ante, dum epistolas Ambrosii antecessoris nostri revolverem, scripsisse illum ex urbe Roma Hieronymo fratri suo, tunc monacho ipsius coenobii Angelorum, reperisse se apud sanctam Caeciliam triginta octo homelias Origenis in Lucam ab Hieronymo traductas, quas pollicebatur se transcriben-das curaturum. Erit mihi pergratum, si perquisieris diligenter, an memorate homiliae sint apud vos [...] ». Cfr. CABY, De l’érémitisme, p. 640-641.
62 BNCF, Conv. Soppr. E. 3. 405, I, p. 86-87 = Berlin, Lat. Fol. 669, c. 44r; DELPHINI Epistolae, ed. MARTÈNE-DURAND, III 177, col. 1128 (a Bernardino Gadolo, 13 novembre 1483): « Lege bonorum auctorum antiqua volumina. Sume in manus bonorum auctorum frequen ter Hieronymi Cyprianique epistolas, de gentilibus autem Ciceronis ac Plinii, ceterorumque complurium. Horum si te lectione oblectaveris fuerisque ipsorum studiosus facile quam cupis epistularum conscribendarum consequeris facultatem ». Cfr. SCHNITZER, Peter Delfin, p. 51-52 e sopra nota49, a proposito delle righe che prece-dono la citazione e alludono a una raccolta delle epistole del generale.
63. DELPHINI Epistolarum volumen, IV 69; BNCF, Conv. Soppr. E. 3. 405, II, p. 420-421 = Berlin Lat. Fol. 670, c. 215rv: « Emulatus tamen tum antiquos patres ecclesiasticos, tum etiam contemporaneos nostros et in primis Ambrosium, qui olim nostro praefuit ordini, cuius extant et ad illustrissimum dominium Venetum et ad alios principatus latinae epistolae et ipse latinum usurpavi sermonem. Quod eo feci consultius quomodo ab eisdem nunquam nisi latino stilo litterae conscriptae sunt, faciam tamen ut hortaris ».
21-Caby.indd 543 09/04/2015 14:47:18
CÉCILE CABY544
Quando, nel marzo 1498, Gadolo lasciò S. Michele per recarsi a Firenze, dove era stato nominato priore di S. Maria degli Angeli, Dolfin gli scris-se per dargli qualche consiglio a proposito del destino della ricca col-lezione di libri che Gadolo aveva raccolto. Menziona en passant la sua raccolta epistolare personale: « Deponi presso chi preferisci il volume delle nostre epistole, finché non verrò a visitare il monastero ».64 Nel 1511, Dolfin scrive ad Eusebio Priul, monaco di S. Michele di Murano, an-nunciandogli che avrebbe portato appena possibile il terzo volume delle sue epistole affinché fosse conservato a Murano assieme ai primi due.65 Lo stesso anno, incarica lo stesso Eusebio di ritrovare a S. Michele la raccolta delle lettere ricevute da Pietro Barozzi ante generalatum.66 Ma cinque anni più tardi scrive al priore di Oderzo, Giacomo da Brescia, di aver dedicato l’otium invernale – trascorso a S. Michele di Mura-no – alla realizzazione dell’indice dei quattro volumi della sua raccolta epistolare: 67 quattro volumi erano quindi stati allestiti e un quinto era
64. BNCF, Conv. Soppr. E. 3. 405, II, p. 745 = Berlin, Lat. Fol. 670, c. 373v-374r (a Bernardino Gadolo, 17 marzo 1498): « Epistolarum nostrarum volumen apud quem malueris fidelem nihilominus deponatur, donec venero ad revisendum coenobium ».
65. DELPHINI Epistolarum volumen, X 24 (a Eusebio Priul, 1° sett. 1511): « Volumen tertius epistolarum mearum, cum isthuc deo permittente advenero, mecum feram, ut cum aliis duobus apud Sanctum Michaelem conservetur. Neque enim contentus forem ut alio transferrentur aut quisquam sibi illa vendicaret [...] ».
66. Cfr. DELPHINI Epistolae, ed. MARTÈNE-DURAND, III 223, col. 1172-1173 (a Eusebio Priul monaco di Murano, 9 luglio 1511): « Aggressurus tale opus [l’allestimento della rac-colta delle lettere di Barozzi a Dolfin, cfr. sopra nota 48], cum per ordinem eas cœpissem digerere, quota quæque scripta fuisse, ut seriatim et deinceps in libro describerentur, reperi deesse omnes illas, quas ante Generalatum dedisset ad me. Eas alibi esse non posse quam in isto monasterio, nequaquam dubito. Perquires itaque diligentius, si non fuerint in cella tua. Apud quem sint et collectas simul atque alligatas, ubi tibi occurerit fidus lator, Ravennam mittes ad D. Andream. Inde enim ad me facilius perferentur. Eas arbitror quadragenarium numerum excedere. Ideo autem illas reddi mihi celerius cupio, quod ab iis inchoandum sit opus, quæ priores conscriptæ sunt ».
67. Lettera inedita a Giacomo priore d’Oderzo, 8 marzo 1516 (BNCF, Conv. Soppr. E. 3. 405, I, fasc. 2, p. 163-164; segnalata in SCHNITZER, Peter Delfin, p. 189): « Brevem epistolam tuam quam Mansueto abbati dedisti ad me ante complures dies accepi: non respondi more meo clerius ut expedirem me prius opere quod me occupatum detinuit menses aliquot et modo solutior atque ociosior tibi rescriberem. Confeci hac hieme indicem quatuor voluminum epistolarum mearum, quas in generalatu edidi et per alpha-betum seriatim descriptum redegi in codicem. Succurrerunt mihi illas legenti multa que mihi bona ex parte exciderat temporis diuturnitate et quantas ostenderit mihi Dominus tribulationes multas et malas per triginta et sex annos ad memoriam revocavi. Ego Deo gratias quod tot ac tantis vexatus procellis tot undique agitatus tempestatius non aliquando naufragium fecerim, non sim obrutus elationibus maris; benedicam propterea Dominum in omni tempore semper laus eius in ore meo. Ipse enim solus ambulantem in medio tribulationis vivificavit me et super iram inimicorum meorum extendit manum
21-Caby.indd 544 09/04/2015 14:47:18
GLI EPISTOLARI CAMALDOLESI LATINI NEL QUATTROCENTO 545
in corso di realizzazione; essi corrispondono alle lettere del generalato, allora presenti anche a Camaldoli (e attualmente a Firenze). La raccolta veneziana (attualmente parzialmente conservata a Berlino) sembra esser stata corredata da un sesto libro, come si evince dalla lettera a Zaccaria Mauroceno del 20 febbraio 1520.68 In realtà, si tratta cronologicamen-te del primo volume in assoluto, composto dalle lettere scritte prima dell’elezione come priore generale e da alcuni discorsi che Pietro Dolfin aveva probabilmente raccolto fin dalla gioventù, evitando però di farli circolare prima di questa data avanzata. Di una tale raccolta si conserva un unico testimone coevo, proveniente da S. Michele di Murano (il co-dice 1048), l’attuale Berlin, Lat. 668, considerato dal Mittarelli autografo del Dolfin e da altri della mano di Bernardino Gadolo.69 L’impegno di Dolfin per la conservazione ragionata della propria collezione epistolare prenderà in realtà, fra il 1522 e il 1524, una strada molto diversa, poiché, dopo non poche esitazioni, Dolfin accettò di curare l’allestimento di una versione a stampa del suo epistolario,70 che lo costrinse ad un pesante lavoro di selezione nella massa esuberante delle raccolte manoscritte.71
suam et salvum me fecit dextera sua. Ipse inquit eripuit animam meam de morte, oculus meus a lachrymis, pedes meos a lapsu. Ipse sit benedictus in sæcula. Verum hæc per excessum dicta sint [...] ».
68. DELPHINI Epistolarum volumen, XII 3 (a Zaccaria Mauroceno, 20 febbraio 1520): « Legisti tu omnes epistolas meas quas in generalatu meo edidi quinque utique vo-lumina ineptiarum mea rum. Ubi hoc volumen sextum percurreris earum epistolarum quas ante initium generalatus conscripseram, futurus es nimirum conscius omnium ex quo ad religionem me contuli, non solum actionum, verventiam prope consiliorum et cogitationum mearum ».
69. Sul manoscritto, il numero 1048 nell’inventario della biblioteca di S. Michele di Murano di Mittarelli, cfr. J. DEGERING, Neue Erwerbungen der Handschriftenabteilung, I. Lateinische und Deutsche Handschriften erworben 1911, p. 33-34; MEROLLA, La biblioteca di San Michele di Murano, p. 487-488. Sugli altri due testimoni moderni (Venezia, Biblio-teca Nazionale Marciana, Lat. XI. 92 [3828] e Ravenna, Biblioteca Comunale Classense, ms. 385), vedi rispettivamente MARCON, Pietro Dolfin « Epistolae » (cit. nota 44) e il contributo di E. Guerrieri in questo volume (in part. nota 42).
70. Il risultato si legge nel volume DELPHINI Epistolarum volumen pubblicato nel 1524 dal priore di Oderzo, Giacomo da Brescia, allievo dell’ormai defunto Bernardino Gadolo (cfr. la lettera consolatoria del Dolfin, 30 giugno 1499, a proposito della morte di Gadolo, « conterraneum tuum, magistrum tuum »: DELPHINI Epistolarum volumen, V 98). Cfr. SORANZO, Pietro Dolfin, p. 27-29; SCHNITZER, Peter Delfin, p. 194-198 e i lavori in corso di E. Guerrieri. Sulla stampa a Camaldoli, vd. per ultimo E. BARBIERI, « Le lectre belle ne lo suo stampire ». Cultura camaldolese e arte tipografica tra Quattro e Cinquecento, in San Michele in Isola-Isola della conoscenza, p. 353-361.
71. Non sembra aver avuto nessun esito il primo progetto di stampa delle opere di Dolfin, promosso da Paolo Giustiniani e Giustiniano da Bergamo nel 1520, all’interno di un progetto più ampio di stampa delle opere dei priori camaldolesi: cfr. DELPHINI Epistolarum volumen, XII 15, a Paolo Giustiniani, 1° ott. 1520 (« De imprimendis Am-
21-Caby.indd 545 09/04/2015 14:47:18
CÉCILE CABY546
In ogni caso, l’ordine scelto per le raccolte è quello cronologico, eco della loro costituzione sulla base di una registrazione continua delle lettere. Anche l’introduzione di una ripartizione in tre parti, suddivise in 10 libri di 100 epistole ciascuno, nella raccolta veneziana attualmente conservata in parte a Berlino, o in 12 libri di 100 epistole ciascuno, nella versione a stampa, rispetta un criterio principalmente cronologico e di ripartizione quasi meccanica della massa testuale, senza la minima attenzione alla gerarchia dei destinatari.72 Se Dolfin si distingue in questo dalle scelte non solo di Traversari e dei suoi di-scepoli, ma anche degli umanisti di inizio Quattrocento, adotta invece una logica conforme a quello che possiamo trovare in epistolari della fine del Quattrocento, numerosi non tanto nelle cerchie monastiche
brosii antecessoris nostri et aliorum priorum eremi operibus, non improbo consilium tuum [...] Est apud vos epistolarum eius volumen: est itinerarium manu ipsius conscriptum, quod ad vos cubicularius noster cum miraculis sanctissimi patris nostri Romualdi haud multo ante detulit. Itaque potestis pro arbitrio illius scripta imprimere. De meis vero quid sentiam, reddam te paulopost certiorem ») e XII 16, a Giustiniano da Bergamo, 1° ott. 1520 (« Accæpi codicem nuper impressum apud vos, pro quo gratias ago [...] Quod te offers curaturum pro viribus ut correcta et castigata penitus scripta nostra imprimantur, spero te ubi hoc evenerit reipsa impleturum. Verum de hoc post dies paucos apertius significabo »). Dolfin dedicò invece molta energia, a partire dal 1522, alla publicazione di un’antologia di 1200 lettere scelte da se stesso e puntualmente riscritte, cioè principal-mente tagliate. Le difficoltà dell’impresa trassudano da alcune lettere come: DELPHINI Epistolarum volumen, XII 88 (a Timoteo e Severo monaci di S. Maria degli Angeli, 27 febbraio 1522): « Subiit animum prioris Oppitergini paulo ante currare ut pars epi-stolarum nostrarum sumptibus suis imprimeretur. Fuit propterea mihi necessarium, ubi inter ipsum et impressorem convenit, occupari assidue in deligendis iis quas potissimum imprimendas putarem. Urgente siquidem impressore, ne se vacare mea negligentia per-mitterem, institi die noctuque perficiendo operi, non sine meo incommodo et labore, prætermissis aliis minus necessariis quæ interea occurrebant negociis [...] Cupiebam ego ut si quid composuissem, quod aliquando imprimendum foret, post decessum meum, id esset futurum. Sed diu ante a priore conceptum rei conficiendæ desyderium sisti ac reprimi nequaquam potuit, quin effectui manciparetur. Exposuit me manifesto periculo in quem varie sentientium contorquenda sunt tela. De uno tantum confido quod carpi haud facile a quoque poterit inserta nimirum epistolis sacri eloquii testimonia. Hoc feci de industria, homo præsertim religioni asscriptus, imitatusque sum Ecclesiæ doctores qui nihil scripserunt, quod non scripturæ divinæ allegationibus confirmaverint. Reli-qua iudicent singuli pro gustu cuiusque et monasticam stili simplicitatem pro arbitrio contemnant [...] »; o ibidem, XII 90 (a Giustiniano da Bergamo, 14 luglio 1523): « Epi-stolarum nostrarum impressio lente procedit atque, ut ita dicam, simul claudicantibus et ipso impressore et ipsius impressionis autore. Cum absolutum fuerit opus poteris et tu particpes fieri ».
72. La raccolta fiorentina è più semplicemente composta di 4 volumi cronologici, senza suddivisioni, ai quali fu aggiunto alla fine del primo volume un fascicolo di lettere estravaganti, raccolte dopo la stesura della raccolta principale.
21-Caby.indd 546 09/04/2015 14:47:18
gli epistolari camaldolesi latini nel quattrocento 547
quanto in quelle dei chierici secolari (per esempio matteo Bossi) e dei prelati della curia come iacopo ammanati piccolomini, giannantonio campano, agostino dati, ecc.
Bernardino Gadolo tra formazione umanistica veneta e modelli camaldolesi
di dolfin, nelle mani del quale emise la sua professione monastica, e più globalmente dalla cultura veneta nella quale era stato educato prima di entrare a s. michele di murano come maestro di scuola e poi come monaco, Bernardino gadolo eredita la passione per i libri, la scrittura epistolare e un ricco réseau di corrispondenti.73 della sua prassi episto-lare siamo informati direttamente tramite la sua raccolta personale di lettere e indirettamente dalle numerose lettere che dolfin, ormai priore generale e residente lontano da murano, gli inviò: queste lettere, indi-pendentemente dal loro contenuto, sono testimoni di uno scambio epi-stolare fra gadolo e dolfin, ma anche con altri corrispondenti comuni, molto più fitto di quanto lasci percepire l’epistolario di gadolo, compo-sto da una selezione di 49 missive soltanto. È molto difficile ricostruire, allo stato attuale della ricerca, i tempi e i modi di costituzione di questa raccolta. essa è conservata in due codici provenienti da s. michele di murano e attualmente a camaldoli (n. 734 e 735), il più antico dei quali (735) vergato da più mani, a cavallo fra quattro e cinquecento, e forse in parte autografo.74 ne sussiste probabilmente un’altra traccia, forse composta da minute autografe, all’eremo tuscolano, dove è però sottratto allo sguardo e all’esame degli studiosi.75 la raccolta attestata
73. su Bernardino gadolo, oltre ai riferimenti della nota 3, cfr. c. caBy, Bernardino Gadolo ou les débuts de l’historiographie camaldule, « mélanges de l’École française de rome. moyen Âge », 109 (1997), p. 225-268 e ead., De l’érémitisme, ad indicem; g. moro, Gadolo (Gadola, Gadoli, Gadolus) Bernardino, in dBi, li, 1998, p. 181-184.
74. l’ultima descrizione si trova in merolla, La biblioteca di San Michele di Murano, p. 346-348.
75. nell’impossibilità di consultare il manoscritto F ii bis dell’archivio del sacro eremo tuscolano di monte porzio catone (roma), ci si deve accontentare della descri-zione di e. massa, I manoscritti originali del beato Paolo Giustiniani custoditi nell’eremo di Frascati: descrizione analitica e indici con ricerche sui codici avellanesi di san Pier Damiani, roma 1967, p. 149-151 che elenca 13 « minute autografe con emendamenti e sottolineature » di gadolo senza però collegarle alle lettere dell’epistolario conservato a camaldoli. dagli incipit riportati da massa, sono riuscita ad identificare 5 delle 13 unità con lettere dell’epistolario di camaldoli; si tratta della lettera a iacopo Filippo da Ber-gamo (n. 175, c. 275r-282v della descrizione di e. massa; asc, San Michele di Murano, ms. 735, p. 1-41), la lettera a pietro dolfin del 22 novembre 1496 (n. 176, c. 283r-284r;
21-Caby.indd 547 04/05/2015 14:56:11
CÉCILE CABY548
nel codice 735 di Camaldoli fu sicuramente allestita in vari tempi: non solo i cambiamenti di mano corrispondono ad unità epistolari diverse, ma si trovano nel codice numerosi spazi bianchi, che arrivano fino alla lunghezza di vari fogli.76 Questi spazi bianchi interrompono, spesso in corrispondenza della fine di un fascicolo, la copia continua delle lettere, così come la troviamo in altre sezioni dell’epistolario, e possiamo forse interpretarli come spazi lasciati vuoti nell’attesa di nuove lettere da copiare, e soprattutto, e più certamente, come il segno che le lettere furono copiate, secondo prassi, su fascicoli autonomi che furono rilegati in seguito e non necessariamente durante la vita del Gadolo. Quest’ul-tima ipotesi potrebbe spiegare la difficoltà a far emergere una qualsiasi coerenza chiara nell’ordine di disposizione delle lettere.
La lettera più recente conservata nella silloge è datata al 24 maggio 1498 e narra il supplizio di Savonarola a Firenze il giorno precedente: 77 è quindi probabile che Gadolo abbia messo un’ultima mano alla sua raccolta epistolare durante il suo breve soggiorno a Firenze e preci-samente fra il 24 maggio 1498 e la morte, il 22 aprile 1499.78 Ma non emerge nessun criterio deciso di organizzazione della raccolta. Si apre
ibidem, p. 190-203), la lettera a Marsilio Gambara senza data (n. 178, c. 285r-288r; ibidem, p. 121-139), la lettera a Sebastiano Badoer, Girolamo Zorzi e M. Antonio Morosini, da Firenze il 24 maggio 1498 (n. 187; ibidem, c. 291v-292v) e ai fratelli di S. Maria degli An-geli della quale il codice di Camaldoli tramanda solo le prime righe (p. 273-274) mentre il codice dell’eremo Tuscolano sembra trasmettere la missiva completa, datata marzo 1498 (n. 183, c. 291r). La lettera a Bernardo Bembo del codice dell’eremo Tuscolano (n. 180, c. 288v) ha un incipit e un explicit diversi da quelli dell’unica lettera a Bembo conservato nel codice di Camaldoli (p. 312).
76. Per es. dopo l’opuscolo sulla storia dell’ordine, sono lasciati in bianco 7 fogli fino alla fine del fascicolo (ASC, San Michele di Murano, ms. 735 [BERNARDINO GADOLO, Epistolario], c. 42-48); dopo la lettera dedicatoria di un opuscolo perduto a Marsilio Gambara o la lettera sulla morte di Savonarola, si trovano 7 fogli bianchi (ibidem, ri-spettivamente, c. 140-142 e 183-189); dopo il frammento ai monaci degli Angeli sulla sua elezione 4 fogli e mezzo sempre fino alla fine del fascicolo (ibidem, c. 274-278).
77. La lettera del 24 maggio 1498 indirizzata da S. Maria degli Angeli a tre patrizi veneti è cronologicamente l’ultima che si conservi nella silloge. Tramanda il racconto del supplizio di Savonarola: ASC, San Michele di Murano, ms. 735 (BERNARDINO GADO-LO, Epistolario), c. 162-182, ed. a cura di G. CACCIAMANI, Il supplizio di G. Savonarola, « Camaldoli », 6 (1952), p. 64-71.
78. Mi pare molto emblematico che della lettera ai monaci degli Angeli, tramite la quale Gadolo annuncia alla comunità la sua elezione come priore, sia stato copiato sol-tanto un frammento di 7 righe (c. 273-274) seguito da 5 fogli bianchi che corrispondono alla fine di un fascicolo, e che non sia stata inserita l’intestatio in inchiostro rosso come altrove; sulla conservazione ipotetica di una versione completa di questa lettera, cfr. so-pra nota 75. Sul soggiorno a Firenze e l’impegno contro Savonarola, vedi S. DALL’AGLIO, L’eremita e il sinodo: Paolo Giustiniani e l’offensiva medicea contro Girolamo Savonarola, 1516-1517, Firenze 2008, p. 39-47.
21-Caby.indd 548 09/04/2015 14:47:18
gli epistolari camaldolesi latini nel quattrocento 549
con un gruppo di lettere in forma libelli, copiate su fascicoli autono-mi, tra le quali la lettera sulla storia dell’ordine a iacopo Foresti da Bergamo 79 o l’epistola dedicatoria al perduto opuscolo Aurea corona.80 in seguito, la selezione delle lettere privilegia in generale le epistole lunghe (ma ci sono delle eccezioni) e particolarmente curate dal pun-to di vista del contenuto o dello stile. si potrebbero fare numerosi esempi, ma mi limiterò a pochi. per quanto riguarda il contenuto, sono state selezionate epistole a corrispondenti prestigiosi (cardinali, vescovi, letterati come poliziano), ricche di dettagli storiografici (come la lunga lettera a matteo Bossi sulla riforma di s. michele, occasione di una bella galleria di uomini illustri 81) o biografici (come la lettera a domenico trevisan sulla sua formazione e vocazione monastica 82), di riferimenti a eventi memorabili (come la lettera già citata sulla mor-te del savonarola, o quella sulla morte di Federico iii 83), di notizie artistiche (come le lettere dell’8 aprile e 24 maggio 1494 al cardinale protettore sul cantiere di s. michele e l’attività di scultori e architetti, come il famoso mauro codussi, e di pittori, come giovanni Bellini 84) o di curiosità librarie (il suo progetto di edizione di opere di gregorio magno 85 o di edizione della Vulgata; 86 l’edizione delle opere complete di san Bernardo e, in generale, tutte le novità dell’edizione a stampa 87), per non parlare delle tradizionali lettere di congratulazioni (al patriarca
79. Caby, Bernardino Gadolo ou les débuts de l’historiographie camaldule, p. 225-268.80. asc, San Michele di Murano, ms. 735 (bernardino Gadolo, Epistolario), p. 121-
139 (a marsilio gambara, senza data): « circa hominis animam multa cognitur digna uti-liaque annotavi, collegi, conscripsique atque in hunc de anima librum composui, quem “auream coronam” libuit appellare. in quo quidem confi ciendo studii, laboris atque vigiliarum quam plurimum insumpsi, et horatiano usus consilio, de cimum in annum pressi atque decoxi [...] » (ibidem, p. 124-125).
81. Ibidem, p. 143-161.82. Ibidem, p. 226-230.83. Ibidem, p. 236-238 (a ludovico ambasciatore alla curia di massimiliano i
d’absburgo, 10 ott. 1493).84. Ibidem, p. 209-213 e 213-215; sul cantiere e il rapporto con codussi e Bellini,
cfr. Caby, « Nostre religionis verum etiam hujus civitatis decus et ornamentum ».85. asc, San Michele di Murano, ms. 735 (bernardino Gadolo, Epistolario), p. 222-
226 (a tommaso donà, patriarca, s. d.).86 Ibidem, p. 317 (al cardinale piccolomini, s. d.).87. cfr. per es. la lettera al familiare del cardinale piccolomini martino nimira
(ibidem, p. 251-256) che segnala diverse novità editoriali e in particolare « omnia opuscula devotissimi Bernardi preterquam super cantico canticorum, pulcris sed valde parvis caracteribus impressa » che progetta di regalare al cardinale, quel che fece probabilmente come testimonia la lettera al cardinale del primo luglio 1494 (ibidem, p. 262-264). altri esempi in Caby, De l’érémitisme, p. 660-661; vd. anche barbieri, Il libro nella storia, p. 30.
21-Caby.indd 549 04/05/2015 14:57:46
CÉCILE CABY550
Tommaso Donato) o di consolazione (a Marco Bastiano per la morte di Andrea Capelli).88
Per quanto riguarda lo stile epistolare usato, esso è in tutto confor-me allo stile umile della conversazione fra amici uniti dalla consuetudo,89 dalla condivisione di gusti comuni 90 e dallo scambio di favori e di ogget-ti.91 D’altronde, oltre ai modelli antichi e patristici condivisi dalla cultura umanistica e che Dolfin gli aveva raccomandato, in particolare Cicerone, Plinio e Girolamo, sappiamo che Gadolo si ispirava ad alcuni modelli contemporanei: il modello del suo superiore monastico e principale corrispondente, Pietro Dolfin, ma anche quello del vescovo di Belluno e in seguito di Padova, Pietro Barozzi. Gadolo legge e copia le lettere del prelato fin dal 1481,92 e in una lettera del 1485 al vescovo Barozzi, Gadolo ricorda di aver copiato e raccolto in un volume circa 28 delle lettere del prelato che gli erano state affidate dal Dolfin proprio perché imparasse a imitarle copiandole: 93
88. Rispettivamente ASC, San Michele di Murano, ms. 735 (BERNARDINO GADOLO, Epistolario), p. 222-226 (a Tommaso Donà, patriarca, S. d.) e p. 215-222 (a Marco Ba-stiano, 1° sett. 1493).
89. Cfr. le prime righe della lettera a Pietro Barozzi, il 15 luglio 1485, ibidem, p. 230-235.
90. Cfr. la lettera a Martino Nimira del 4 marzo 1494: ibidem, p. 244-247.91. Ibidem, p. 247-250: ad Agostino Piccolomini, senza data, a proposito di un
munusculum e di vendite di libri a stampa.92. Cfr. la lettera di Dolfin a Bernardino novizio a San Michele, il 26 ottobre 1481
(BNCF, Conv. Soppr. E. 3. 405, I, p. 18-19 = Berlin, Lat. Fol. 669, c. 10r): « Mitto ad te epistulas Bellunensis episcopi quas tibi, cum adesses coram, missurum pollicitus fueram. Sunt autem eiusmodi, ut facile iudicio meo et propter hornatu verborum et propter orationis sententiarumque gravitatem priscis illis nostris doctoribus conferri valeant. Hac vero condicione illas accipies ut, sicut isthic convenimus, noveris te ad eas transcriben-das obligatum. Libros non missi ne nimium gravaretur lator, ac ne pluviarum periculo exponereur. Mittam alias si domino placuerit. Persiste modo in timore Dei, fili mi, et ita ex assidua lectione proficere stude, ut intelligas te, singulari Dei munere, saeculi huius ereptum periculis, sola aeterna meditari debere [...] »; e la lettera fra gli stessi del 26 novembre 1481 (BNCF, Conv. Soppr. E. 3. 405, I, p. 23 = Berlin, Lat. Fol. 669, c. 12r): « Gratas tibi fuisse reverendissimi episcopi nostri Bellunensis epistolas gaudeo. Eas frequentius perlegas, neque enim ex illarum lectione parum proficies, nam cum sint preter elegantiam qua maxime nitent etiam sententiarum succo plenae plurimum inde aedificationis exauries. Transcribes autem illas cum potueris commode, ne alia que tibi forte iniuncta uerunt monasterii negocia, hac occasione intermittantur. Tantum cura ne mendose transcribas [...] ».
93. ASC, San Michele di Murano, ms. 735 (BERNARDINO GADOLO, Epistolario), p. 231-232: « Habui penes me, ex quo habitum religionis suscepi, tuarum epistolarum circiter octo et viginti, quas quarto ante anno dedit mihi dono idem reverendissi mus pater meus Generalis, ut illas inscribendo immitarer; quarum profecto fui semper studio sissimus, legique eas bis terve, ac saepius, nova sibi semper succedente voluptate, inde pluri mum
21-Caby.indd 550 09/04/2015 14:47:18
GLI EPISTOLARI CAMALDOLESI LATINI NEL QUATTROCENTO 551
Ho avuto con me, da quando ho preso l’abito religioso, circa 28 delle tue lettere, che mi sono state date quattro anni fa dal mio reveren-dissimo padre il generale affinché le imitassi copiandole; da allora, le ho sempre studiate con grande cura, le ho lette due, tre o addirittura più volte, trovandoci sempre un piacere nuovo, traendone tante cose utili, tant’è vero che leggendole ho molto progredito. Infine le ho trascritte e raccolte in un codice nell’ordine in cui furono scritte.
Bisognerebbe aggiungere modelli occasionali, come Francesco Filelfo, evocato come modello di scrittura consolatoria,94 ma preme soprattutto sottolineare l’emulazione del Traversari, evocato in varie lettere e che costituisce un modello condiviso fra Gadolo e Dolfin. In una lettera a Gadolo del 16 settembre 1493, Dolfin risponde probabilmente a una domanda del monaco veneto, che cercava una copia dell’epistolario del Traversari, scrivendogli che non è stato in grado di reperire un mano-scritto delle lettere di Ambrogio in vendita ma che, se gli capitasse in futuro, realizzerebbe sicuramente il desiderio del suo corrispondente.95 Un po’ più di un mese più tardi, in una lettera che allude sia all’episto-lario del Dolfin, sia ai lavori del Gadolo sulla Bibbia, il priore generale promette di nuovo di cercare un codice delle epistole del Traversari da acquistare.96 Forse è già l’epistolario del Traversari che Gadolo cerca nel 1485 quando Dolfin gli risponde da Fontebuono che il loro proprietario lo ha portato con sé a Valdicastro.97
hauriens utilitatis, ita ut sentiam me earum lectione haud parum profecisse. Demum il las transcripsi ac redegi in codicem ordine quo fuerant scriptae... ».
94. ASC, San Michele di Murano, ms. 735 (BERNARDINO GADOLO, Epistolario), p. 217: « Legi alias mutorum tractatus super mortibus carorum consolatorios et precipue Hier-ronymi, Ambrosii et Bernardi, Francisci quoque Philelphi, quos si quid praestantioris remedii cupis, lege et videbis christiani mortem non nisi ab iis qui infideles sunt, ani-mam simul cum corpore inteerite existimant, lugendam esse ».
95. BNCF, Conv. Soppr. E. 3. 405, II, p. 131-132 = Berlin, Lat. Fol. 670, c. 71r (cfr. anche Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. XI. 92 [3823], ep. 85, c. 467), a Bernardino Gadolo, Fontebuono, 1493 sett. 16: « Ambrosii predecessoris nostri epistolas venales non inveni. Si inciderint in manus nostras, faciam satis votis tuis ».
96. BNCF, Conv. Soppr. E. 3. 405, II, p. 145-146 = Berlin, Lat. Fol. 670, c. 78r (cfr. anche Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. XI. 92 [3823], ep. 4, c. 474 (allo stesso, Firenze, 1493 ott. 26): « Ambrosii epistolas perquiram diligentius et si alicubi venales invenero, curabo ut emantur tibi ».
97. Non so se la lettera BNCF, Conv. Soppr. E. 3. 405, I, p. 118-119 = Berlin, Lat. Fol. 669, c. 60v-61r (a Gadolo, 27 febbraio 1485) si riferisce già all’epistolario del Traversari: « Epistolas quas totiens petisti, mississem perquam libenter, sed is cuius sunt, secum hinc illas abstulit; non enim amplius mecum moratur, verum alio, quamvis invitus commigravit. Reliquam omnem suam tum librorum, tum ceterarum rerum suppellecti-lem hic tuto reliquit. Illas cui fidenter crederet invenit neminem. Non aderam quoniam
21-Caby.indd 551 09/04/2015 14:47:18
CÉCILE CABY552
È proprio sulla potenza del modello di Traversari che vorrei con- cludere questo intervento, d’intento prevalentemente programmatico. Infatti, mi pare che al difuori di altre motivazioni più generali, che rimandano da un lato al carattere irruente della “rivoluzione epistola-re” alla fine del Quattrocento e dall’altro lato alla grande permeabilità dell’Ordine camaldolese a forme culturali locali e/o contemporanee a causa del carattere globalmente incompiuto, e quindi flessibile, delle sue strutture scolastiche e alla quasi totale impermeabilità alla cultura uni-versitaria di alcuni suoi centri (come S. Maria degli Angeli e, in forma meno radicale, S. Michele di Murano), al di là quindi di questi fattori globali di spiegazione, l’importanza nell’Ordine del modello di Traversari sia come priore generale, sia come umanista, grazie alla costruzione a cura dei suoi discepoli più o meno diretti e immediati (diciamo da fra Michele a Dolfin) del suo ritratto come monaco umanista ideale, abbia contribuito a legittimare, per così dire, e quindi a garantire un successo in un certo senso anomalo alla forma e alla prassi umanistica dell’epistolografia nella modesta cerchia del monachesimo riformato che rappresenta l’Ordine camaldolese nel Quattrocento. Un successo che andò forse al di là di questi limiti, se si considera l’enorme importanza che l’epistolario del Traversari ebbe sull’autore di uno degli altri rari esempi di epistolari umanistici prodotti in ambiente benedettino che io conosca, ossia quello di Girolamo Aliotti: abate di S. Fiora ad Arezzo nella seconda metà del Quattrocento, egli vede nella raccolta epistolare del Traversari una presenza concreta del maestro defunto e un modello per la costruzione del proprio epistolario nel corso degli anni Settanta del Quattrocento. Ma si tratta di un’altra storia.98
profectus est, nam forte mihi eas commississet. Consulo ut ad illum scribas ipse, prece-risque ut eas abste transcribendas per fidelem nuncium tibi transmittat, data prius fide quam arctissima te illas ubi voluerit, et cuicumque voluerit redditurum. Est autem is Fabriani apud abbatem Vallis Castri et quia complures Fabrianenses mercatores Venetiis negociantur, si non fueris negligens eris facile hoc pacto ac citissime compos voti tui ».
98. Su tutto questo vedi C. CABY, Autoportrait d’un moine en humaniste. Réseaux sociaux, pratiques discursives et réforme religieuse dans l’Italie du XVe siècle, autour de l’itinéraire de Girolamo Aliotti, mémoire inédit pour l’habilitation à diriger des recher-ches, Université Lumière-Lyon 2, 2013, capp. 2 e 4.
21-Caby.indd 552 09/04/2015 14:47:18