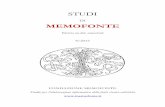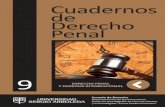I rapporti epistolari di Pietro Bembo con i Gonzaga, «Giornale Storico della Letteratura...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of I rapporti epistolari di Pietro Bembo con i Gonzaga, «Giornale Storico della Letteratura...
Vol. CLXXXIII ANNO CXXIII Fasc. 6022° trimestre 2006
DIRETTO DA
E. BIGI - F. BRUNI - M. CHIESA - A. DI BENEDETTO - M. MARTI - M. POZZI
2006
LOESCHER EDITORETORINO
GIO
RN
AL
E S
TO
RIC
O D
EL
LA
LE
TT
ER
AT
UR
A I
TA
LIA
NA
- F
asc.
602
- V
ol.
CL
XX
XII
I
(Fas
c. 2
°)
CO
D.
DI3
2
FRANCO MONTANARI
– 2432 pagine– 140 000 lemmi tratti dalla letteratura
arcaica, classica, ellenistica, dai testidi età imperiale e tardo-antica, dalle opere dei primi secoli del Cristianesimo, dalle testimonianze di papiri ed epigrafi
– circa 15 000 verbi sottoposti a esamesistematico per comporne i paradigmi in base alle forme realmente attestate negli autori antichi. Tutti i paradigmi posti in evidenza accanto al lemma
– 130 specchietti riassuntivi delle vocipiù complesse
– chiara strutturazione delle voci accompagnata da un fitta e articolatarete di esempi con precise traduzioni
– costanti e puntuali citazioni dei luoghi e delle fonti
– evidenziazione delle reggenzee dei costrutti sintattici
– ampio numero di lemmi aiuto e voci dirimando anche per le forme avverbiali
– esplicitazione di alcune abbreviazioniper evitare ambiguità
– svolgimento di molte parole abbreviateo puntate per quanto riguarda soprattutto aggettivi sostantivati, participi e varianti a lemma
VOCABOLARIO DELLA LINGUA GRECA
SECONDA EDIZIONE con CD-ROM e con la Guida all’uso del Vocabolario e del CD-ROM e Lessico di base
La seconda edizione del GI nasce principalmente con l’intento di potenziare l’effica-cia didattica dei contenuti rispettando in particolare le esigenze degli studenti più gio-vani. Gli interventi di revisione, condotti con metodo fedele al rigore scientifico cheha contraddistinto la prima edizione, hanno contribuito a rendere più agevole la con-sultazione delle voci con il risultato, fra gli altri, di arricchire notevolmente il già am-pio repertorio di informazioni, ora consultabile anche in formato elettronico.
Poorly Attested Words in Ancient Greek – un repertorio on-line di termini della lin-gua greca scarsamente attestati a cura dell’Università di Genova in collaborazione con Loescher Editore. Per maggiori informazioni visitate l’indirizzo www.loescher.it/dizionari.
MEDIACLASSICA - un sito ricco di materiali e strumenti per lo studio e la didatticadelle lingue classiche, alla pagina www.loescher.it/mediaclassica.
Loescher Editorevia Vittorio Amedeo II, 18
10121 Torinotel. 011 56 54 111
fax 011 56 25 822 / 011 56 54 200www.loescher.it
copertina giornale 19-06-2006 12:49 Pagina 1
FRANCESCA FAVARO, «Siegui di Lesbo la soave Musa». Afro-dite, Saffo e il giovane FoscoloM.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.
VITILIO MASIELLO, Il canone crociano della letteratura italia-naM.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.
VA R I E T ÀMARZIA MINUTELLI, I rapporti epistolari di Pietro Bembo con
i GonzagaM.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.PANTALEO PALMIERI, Scheda leopardiana: il destino di Cle-
liettaM.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.MARIA TERESA IMBRIANI, Dieci poesie di Sibilla Aleramo ne-
gli archivi del VittorialeM.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.MN O T E E D I S C U S S I O N ILUISELLA GIACHINO, Su una nuova edizione degli «Amo-
rum libri» del BoiardoM.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.
B O L L E T T I N O B I B L I O G R A F I C OMANUELE GRIGNOLATI, Experiencing the Afterlife. Soul and Body
in Dante and Medieval Culture, (Mario Marti), p. 290. – Ilmito nella letteratura italiana, opera diretta da PIETRO GIBEL-LINI, volume III, Dal Neoclassicismo al Decadentismo, a curadi RAFFAELLA BERTAZZOLI (Simonetta Randino), p. 293. –GUIDO GOZZANO, I tre talismani. La principessa si sposa e al-tre fiabe, a cura di MATILDE DILLON WANKE, (Donato Piro-vano), p. 299. – SERGIO SOLMI, Saggi di letteratura francese, I.Il pensiero di Alain. La salute di Montaigne e altri scritti, a curadi GIOVANNI PACCHIANO, (Francesca D’Alessandro), p. 302. –VOLKER KAPP - FRANK RUTGER HAUSMANN - STEFANI ARNOLD -CHRISTINE ASIABAN, Bibliographie der deutschen Übersetzungenaus dem Italienischen von 1730 bis 1990 (Enrico Mattioda), p.306.
A N N U N Z I , a cura di MARIO CHIESA, ARNALDO DI BENEDETTO,MARIA LUISA DOGLIO, LUISELLA GIACHINO, ENRICO MATTIODA,MARIO POZZIM.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.
Si parla di: Margarita amicorum. – I. BERTELLI. – M. FIORILLA. –«Albertiana». – R. BESSI. – A. IURILLI. – P. COSENTINO. – L.CASTELVETRO. – M. VALENTE. – E. BALMAS. – Rire et dérision àla Renaissance. – Storici e storia in età postridentina. – Stanzesegrete. – Pietro Guerrini. – G. CARNAZZI. – A. DI BENEDETTO.– S. VERHULST. – S. VALERIO. – I. CALIARO. – S. CORAZZINI. –E. BOTTASSO. – Con l’ali de l’intelletto. – Machina. – L. MAR-COZZI. – Accademia delle scienze di Torino. – FondazioneLuigi Firpo.
Vol. CLXXXIII Fasc. 602
SOMMARIOPag. 161
» 194
» 221
» 257
» 263
» 278
» 310
VOCABOLARIO DELLA LINGUA LATINA
CASTIGLIONI - MARIOTTI
TERZA EDIZIONE con CD-ROM
A distanza di trent’anni l’opera è stata sottoposta a un accurato lavoro di revisione con-dotto sulla base delle edizioni critiche più recenti, all’insegna del rigore scientifico checostituisce il grande pregio dell’opera. Esso ha comportato, in più casi, la riorganizza-zione delle voci, l’aggiornamento della traduzione dei passi d’autore, l’aggiunta di infor-mazioni di carattere etimologico e di altri utili complementi.
La terza edizione è disponibile anche in versione CD-ROM. Si tratta di un potente pro-gramma di ricerca, ricco di funzionalità, che offre un rapido e agevole accesso agli ol-tre 50 000 lemmi latini: è infatti possibile risalire da una qualunque forma flessa allemma e da esso alla glossa del dizionario. Due milioni di forme catalogate permettonoallo studente di cogliere la ricchezza lessicale e grammaticale della lingua latina.La consultazione delle voci può avvenire non solo in base all’ordine alfabetico, ma an-che attraverso le molteplici chiavi di ricerca del software di interrogazione: si possonoinfatti estrarre dal repertorio gruppi di vocaboli accomunati da criteri diversi, quali si-gnificato, origine etimologica, attestazione nelle fonti antiche, modelli grammaticali.
Per maggiori informazioni visitate l’indirizzo www.loescher.it/dizionari.
I volumi per recensione devono essere inviati esclusivamente alla Direzione del Giornalepresso Loescher Editore, via Vittorio Amedeo II, 18 - 10121 Torino
Abbonamento annuale 2005: E 77,00 (Italia); E 103,00 (estero) - Prezzo del singolo fascicolo: E 26,50I versamenti vanno effettuati sul C.C.P. n. 96136007, indirizzati a S.A.VE s.r.l.
Via Dell’Agricoltura 12 - 00065 Fiano Romanoindicando nella causale il titolo della rivista
Il sommario è consultabile nel sito Internet www.loescher.it
Registrato al N. 571 del Registro Periodici del Tribunale di Torinoa sensi del Decreto-legge 8-2-48, N. 47. — Direttore responsabile: Arnaldo Di Benedetto.
Redazione: Mario Chiesa (segr.), Enrico Mattioda.Fotocomposizione: Giorcelli & C. (Torino) - Stampa: Tipografia Gravinese (Torino)
Loescher Editorevia Vittorio Amedeo II, 18
10121 Torinotel. 011 56 54 111
fax 011 56 25 822 / 011 56 54 200www.loescher.it
copertina giornale 19-06-2006 12:49 Pagina 2
VARIETÀ
I RAPPORTI EPISTOLARI DI PIETRO BEMBO CON I GONZAGA
1. Le lettere: i manoscritti e le edizioni
In un corpus epistolare pure vastissimo (poco meno di duemi-laseicento testi) quale quello con cui Pietro Bembo venne pun-tualmente accompagnando i giorni della sua – per i parametri deltempo non breve – esistenza, dalla primavera del 1492 fin proprioalle imminenze della morte, è vano andare in traccia dei vestigi diuna liaison con Isabella d’Este che, attesa l’inconcussa «fiducia» delletterato «nella grazia sensibile e illuminante della donna» (1), sa-rebbe piaciuto immaginare del tutto particolare, intensa e durevole,ancorché ovviamente di altra natura rispetto a quella intrattenutacon la di lei cognata Lucrezia Borgia. Nemmeno le crestomazie ditesti corresponsivi assemblate in vista di future stampe sotto la – inverità piuttosto discontinua – supervisione dell’autore a partire dal1532 rendono minima giustizia all’eccellenza di tale interlocutrice:nella raccolta di lettere volgari di esclusiva destinazione muliebre,compiutamente organata già in quell’anno entro un codice oggi con-servato nell’Archivio Segreto Vaticano (2) e data fuori postuma, perle cure degli esecutori testamentarî Gualteruzzi e Querini, presso ifratelli Scotto nel 1552 (3), non un solo documento attestadell’intrinsichezza dell’intellettuale veneziano con colei che una con-solidata tradizione storiografica saluta quale «primadonna del Rina-
(1) C. DIONISOTTI, Prefazione a M. SAVORGNAN-P. BEMBO, Carteggio d’amore(1500-1501), a cura del medesimo, Firenze, Le Monnier, 1950, pp. XXV.
(2) Il manoscritto, rubricato come Lettere di Messer Pietro Bembo in diversi tem-pi scritte a molti uomini e a molte donne, appartiene al Fondo Borghese e reca la se-gnatura II, 499.
(3) Cfr. Lettere di M. Pietro Bembo [...] a prencipesse et signore et altre gentilidonne scritte divise in due parti [...]. Quarto volume, Venezia, Scotto, 1552.
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 221
scimento» italiano (4), stranamente escludendola da quel pomeriodi gran dame che, per quanto selettissimo, accanto a una VittoriaColonna marchesa di Pescara o a una Veronica Gambara contessadi Correggio annovera non solo ambedue le sue cognate duchesse(rispettivamente di Ferrara e di Urbino), Lucrezia Borgia ed Elisa-betta Gonzaga, ma addirittura la sua stessa – e da lei tanto poco sti-mata – primogenita Eleonora, consorte di Francesco Maria DellaRovere e a propria volta signora della reggia feltresca. Né le molte-plici sillogi epistolari bembiane editate successivamente, fino allametà del secolo XIX, hanno provveduto a sopperire a tanto singo-lare lacuna, talché nel 1887 un fan di Isabella dell’impavida com-battività di Vittorio Cian poteva a buon diritto adergersi a indigna-to paladino della reietta principessa:
A siffatta mancanza, durata fino a questi ultimi anni, non di lettere solo, ma dialtri documenti accennanti esplicitamente a relazioni fra il Bembo e l’Isabella, deve-si attribuire il silenzio completo che a questo riguardo serbano quanti o incidental-mente o di proposito s’occuparono del letterato veneziano. Il qual fatto appunto,mentre da una parte tolse ai biografi e agli storici l’occasione di arrischiare amplia-menti retorici o congetture fantastiche, dall’altra li ritenne anche dall’avviare indagi-ni nuove (5).
Ma in realtà il riscatto operato dallo studioso in un contributo purpregevole per completezza di documentazione e impeccabilità diinformazione, giusta i robusti criterî empirici della migliore scuolastorica, non importa risultanze qualitative o quantitative che con-sentano di definire il rapporto tra i due personaggi in termini altrida quelli di un legame poco consistente e a tratti puramente mer-cantile: non tanto perché appena una decina sono le lettere speditedallo scrittore alla marchesana nel corso di oltre un ventennio, quan-to perché i contenuti e i modi di tale conversazione riescono assaimeno significativi di quelli delle epistole indirizzate, per esempio, aognuna delle gentildonne rammentate di sopra. A dire il vero, l’in-cartamento tutto della corrispondenza del Bembo con la casata man-tovana risulta piuttosto esiguo e, seppure a Isabella ne venga riser-vata la parte più cospicua, ai fini di un’analisi attendibile è natural-mente indispensabile investigarlo nel suo complesso, con un occhiodi riguardo, in particolare, al “secondo” interlocutore, Ercole Gon-zaga (destinatario di nove lettere), e dedicando un supplemento diindagine alla di lui sorella Eleonora, il carteggio con la quale (ottolettere), sebbene spazialmente e cronologicamente eteroclito, può
VARIETÀ222
(4) Tale appunto è, ad esempio, il titolo di ben due biografie divulgative sullafigura della marchesana di Mantova: quella di E. P. MEYER, First lady of the Renais-sance, Boston-Toronto, Powell, 1970, e il «ritratto» di M. FELISATTI Isabella d’Este, laprimadonna del Rinascimento, Milano, Bompiani, 1982.
(5) V. CIAN, Pietro Bembo e Isabella d’Este Gonzaga. Note e documenti, in que-sto «Giornale», IX, 1887, pp. 81-136 (cito da p. 81).
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 222
riuscire comparativamente abbastanza istruttivo. Più marginali – solo un paio rivestono infatti un concreto interesse – i messaggiinviati, uno ciascuno, al marchese Francesco, al dinasta Federico eall’ultimogenito Ferrante, al tempo del viceregno di Sicilia; i due bi-glietti per il cancelliere Mario Equicola e l’uno per il segretario per-sonale di Ercole, Agostino, in virtù delle sue benemerenze cliente-lari illustrato del cognome Gonzaga (6).
La globalità delle epistole spedite a Isabella e a Francesco, comepure a Federico e all’Equicola, è custodita nell’Archivio Gonzagadell’Archivio di Stato di Mantova (7). I manoscritti delle lettere in-dirizzate a Ercole, avanti e dopo l’elevazione al cardinalato, si tro-vano invece sparsi in svariate sedi: tre nell’Archivio Segreto Vaticano(ove è pure la missiva ad Agostino Gonzaga) (8), altri tre nellaBiblioteca Ambrosiana di Milano (9), uno nella Biblioteca Marcia-na di Venezia (10), uno nella Bodleian Library di Oxford (11), unonella Biblioteca Palatina di Parma (12) e un ultimo ancora nell’Ar-chivio Gonzaga (13). Quanto alla corrispondenza con Eleonora, treepistole sono detenute dalla British Library londinese (14); una, per-venutaci in duplice esemplare, dalla Bibliothèque Nationale di Pa-rigi e dall’Archivio Segreto Vaticano (15), depositario anche di altre
VARIETÀ 223
(6) A prescindere dall’amatissima Elisabetta di Urbino, sorella del marcheseFrancesco, anche tre esponenti di rami collaterali della famiglia dominante a Man-tova figurano tra i corrispondenti del patrizio veneziano, come documenta l’edizio-ne critica completa delle sue Lettere condotta da Ernesto Travi (cfr., infra e nota 28):Camilla Gonzaga, moglie di Luigi da Porto, cui sono inoltrate tre epistole (6 Mag-gio e 7 Luglio 1524, 4 Dicembre 1526); la contessa di Colisano Susanna Gonzaga diCardona, destinataria di una responsiva del 26 Gennaio 1525, e il condottiero Lui-gi Gonzaga di Bozzolo, cognominato «Rodomonte», cui ne è diretta una del 29 Mag-gio 1532 e di cui viene pianta la scomparsa in un messaggio al Gualteruzzi del Na-tale 1532. Nessuno di tali personaggi, tuttavia, intersecò gli scambî epistolari con ilBembo alle relazioni intrattenute con i più augusti parenti, per cui la loro inclusio-ne nel carteggio mantovano dello scrittore appare implausibile.
(7) Precisamente nelle buste 1077, 1239, 1458 della Serie E. XXVI. 1-5 (Corri-spondenza estera dei Gonzaga – Pesaro e Urbino); nella busta 1891 della Serie E. LXI.1 (Corrispondenza estera dei Gonzaga – Carteggio di Isabella d’Este); nella busta 2498della Serie F. II. 8 (Lettere ai Gonzaga da Mantova e Paesi dello Stato) e nella busta8 della Raccolta d’autografi.
(8) I quattro documenti si leggono nel codice I, 175 (P. BEMBO, Lettere correttedi sua mano [copia per la tipografia con interventi autografi]) del Fondo Borghese.
(9) Un’epistola di pugno bembiano è compresa nel ms. D. 335 inf. (Lettere delRamusio) e due copie nel ms. D 475 inf. (P. BEMBI Epistularum aliquot libri eius manucorrecti [esemplare per la stampa con interventi dell’autore]).
(10) Cfr. il ms. Latino XII 211 (4179): si tratta dell’originale di una delle duemissive conservate in apografi presso l’Ambrosiana.
(11) Cfr. il ms. Italiano C 23 (Lettere originali del Bembo).(12) Cfr. il ms. Palatino 1019, VIII (P. BEMBO, Lettere latine e italiane), fasc. X.(13) Nella Busta 2498 di cui nella precedente nota 7.(14) Cfr. il ms. Additional 6873.(15) Cfr., rispettivamente, i mss. Italiano 1005 (trascrizione per la stampa) e II,
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 223
tre lettere (16), mentre la restante è tràdita soltanto da un testimonea stampa (17). Della missiva a Ferrante, infine, l’originale si conser-va presso l’Archivio di Stato di Parma (18) e una copia presso laBiblioteca Comunale Estense di Modena (19).
Riguardo alla pubblicazione dei sopraelencati documenti, raris-sime sono le antiche sillogi epistolari includenti una o più lettere arappresentanti della casata mantovana: onde far risultare immedia-tamente evidente la scarsa consistenza di tale fortuna editoriale e in-dividuare nel contempo coloro che ebbero a beneficiarne, è oppor-tuno redigere l’inventario completo delle cinquecentine in questio-ne in ordine di apparizione.
La prima raccolta a contenere una missiva per Leonora è il Novolibro di lettere scritte da i più rari auttori, impresso a Venezia, perPaolo Gherardo, nel 1544 e varie volte ristampato fino al 1561 (20):si tratta di una di quelle pubblicazioni collettive che improntavanocampioni della corrispondenza del cardinal Bembo senza la suaautorizzazione e anzi verosimilmente con suo sensibile disappunto(nella seconda edizione dell’opera i testi del porporato, che pure invia cautelare figuravano senza l’indicazione di mittente e destinata-rio, scesero da quarantadue a tredici appena). Nel 1548, a quasi dueanni dalla scomparsa dell’autore, un paio di sue epistole a ErcoleGonzaga vedono la luce nel primo volume per così dire autorizza-to Delle lettere di M. Pietro Bembo (Lettere [...] a sommi ponteficiet a cardinali et ad altri signori et persone ecclesiastiche scritte, divi-se in dodici libri), dato fuori a Roma dai fratelli Dorico per solleci-tudine (ma anche con clamanti contravvenzioni alle volontà del de-funto) dei «suoi veramente fedeli Commessari M. Girolamo Quiri-no e M. Carlo Gualteruzzi» (21). Ancora cinque missive al monsi-gnore mantovano sono ospitate nell’ultimo degli Epistularum fami-liarum libri VI (22), la silloge delle lettere latine che, congiunta-mente ai quattro volumi di corrispondenza volgare, materia la prin-ceps ufficiale del carteggio bembiano: uscita, a partire dal secondovolume, a Venezia nel 1552 per i tipi degli Scotto (23), tale edizio-
VARIETÀ224
449 del Fondo Borghese (Lettere di Messer Pietro Bembo, cit. [trascrizione per lastampa con correzioni autoriali]).
(16) Sono comprese nel ms. Barberiniano Latino 5692 (Lettere originali del Card.P. Bembo scritte a diversi [autografo]).
(17) Cfr., infra e nota 25.(18) Cfr. Epistolario scelto, 2 (Bembo card. Pietro: lettere).(19) Cfr. il ms. a S 1 36, Ital. 854 (Gonzaga-Lettere), t. III.(20) Cfr. c. 95 r-v.(21) Cfr. libro III, pp. 144, 145-146 (la citazione deriva dalla precisazione che
introduce la stampa).(22) Figurano alle pp. 238-239, 239-241, 243, 245-247, 354-355 dell’edizione di
cui infra (cfr. la nota seguente).(23) In realtà tale secondo volume era già stato pubblicato, sempre nella città la-
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 224
ne deve infatti considerarsi – sempre a onta di più o meno consi-derevoli manomissioni del duo Gualteruzzi-Querini, non sempre li-gio alle indicazioni linguistiche, strutturali e distributive dei mano-scritti – sostanzialmente provvista del beneplacito dello scrittore,che, passato di questa vita senza avere compiuto la revisione defi-nitiva del proprio materiale corresponsivo, si era espressamente ri-messo nelle sue ultime disposizioni alla discrezione degli amici col-laboratori. Ancora all’interno della monumentale pubblicazione, ri-spettivamente nei volumi terzo e quarto (quest’ultimo consacrato, siè detto, alla corrispondenza con blasonate esponenti del gentil ses-so), si leggono la missiva ad Agostino Gonzaga (24) e quattro del-le epistole per Leonora (incluse l’una già apparsa nell’edizione Ghe-rardo e quella non pervenutaci in esemplari manoscritti) (25).
Ercole con sette lettere (ma si dovrà pure considerarlo il desti-natario indiretto del messaggio recapitato al suo servitore) e la suasorella maggiore con quattro sono dunque soli chiamati a rappre-sentare la casata gonzaghesca – in entrambi i casi, si badi, non perscelta operata dagli editori, ma per esplicito desiderio dell’epistolo-grafo – entro il copioso Gotha politico-intellettuale dei corrispon-denti bembiani stimato degno di venire segnalato alla posterità.Nondimeno, il primo vi si trova accolto essenzialmente in virtù delsuo alto status ecclesiastico, la seconda in qualità di duchessa di Ur-bino, esattamente come la zia paterna Elisabetta: nessun esponentedel marchesato mantovano stricto sensu popola dunque i volumi del-le conversazioni cartacee che l’autore delle Prose ritenne di racco-mandare alle stampe. Quanto, tra le ragioni di tale esclusione, an-cora pesassero i residui di un antico malanimo nei riguardi di Fran-cesco Gonzaga, reo di averlo prontamente sostituito nelle disinvol-te grazie lucreziane, e di Isabella, fieramente avversa alla cognata findal suo ingresso nella corte paterna, non è dato sapere, ma il casoparallelo dell’ingenerosa estromissione dall’epistolario ufficiale di unaltro – stavolta letterario – antagonista quale Ludovico Ariosto su-scita più di qualche dubbio (26).
VARIETÀ 225
gunare, «per i figliuoli di Aldo» nell’Ottobre 1550, ma «a seguito della rinuncia diquesti all’impresa veniva fatto proprio dallo Scotto, che sovrimpresse nel colofone lasua marca e la data 1551» (T. ZANATO, Pietro Bembo, in Storia letteraria d’Italia. IlCinquecento, a cura di G. Da Pozzo, Padova, Piccin Nuova Libraria, p. 444). Lostesso stampatore rieditò pure il volume inaugurale della raccolta, con addizioni,omissioni e spostamenti di pezzi rispetto alla fermatura Dorico, ancora imputabili aicustodi testamentarî bembiani.
(24) Cfr. Lettere di M. Pietro Bembo [...] a prencipi et signori et suoi famiglia-ri amici scritte divise in dodici libri [...]. Terzo volume, Venezia, Scotto, 1552, pp. 174-175.
(25) Cfr. il cit. Quarto volume delle Lettere di M. Pietro Bembo, pp. 80-81, 81-83,85, 86-87.
(26) Cfr. in proposito le sottili osservazioni del Dionisotti: «Il quale [Bembo]
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 225
Per sollevare – e faticosamente – una tale cortina di oblio ci vol-lero quasi tre secoli: dopo la Scotto del 1552 e relative ristampe eriprese cinque, sei e settecentesche, si dovette infatti attendere finoal medio Ottocento perché ulteriori documenti dei rapporti delBembo con i signori di Mantova venissero via via esumati da pol-verosi scaffali di archivî e biblioteche per vedere il giorno in com-pilazioni erudite, opuscoli e plaquettes il cui reperimento risultavacomunque malagevole per la comunità degli studiosi: GiovanniGaye nel 1839, Carlo D’Arco nel 1845, Amedeo Ronchini nel 1853,quindi Pietro Ferrato nel 1875, Giuseppe Càmpori nel 1877 e infi-ne il Cian nel 1885 e nel 1887 provvidero a ogni buon conto a di-vulgare, complessivamente, altri quindici pezzi di quel disgraziatocarteggio, praticamente tutto ciò che ne restava di inedito (27). Sol-tanto in anni a noi vicini, tuttavia, la pubblicazione integrale dell’e-pistolario bembiano cronologicamente ordinato a opera del recen-temente scomparso Ernesto Travi ha restituito il mosaico nella com-pletezza (e nell’autenticità) delle sue tessere, offrendo finalmente lapossibilità di un’analisi esaustiva dell’incartamento in questione (28).
VARIETÀ226
raccogliendo verso la fine della sua vita il suo epistolario, incluse sì una lettera a Ga-lasso Ariosti, ma nessuna a Lodovico. E ci sono indizi sufficienti, nonostante l’elo-gio appiattato in una lettera al Mosti e quello più esplicito di un breve, scritto anome di Leone X, se non di una gelosia del Bembo per l’autore dell’Orlando furio-so, certo di una ostile diffidenza. Di che bisogna tener conto per una valutazione sto-rica dell’apporto del Bembo alla poesia italiana del Cinquecento» (C. DIONISOTTI, In-troduzione a P. BEMBO, Prose della volgar lingua. Gli Asolani. Rime, a cura del me-desimo, Milano, TEA, 1989, pp. 48-49 [ristampa dell’edizione dei «Classici italiani»UTET, Torino, 1966]).
(27) I contributi cui si fa riferimento sono i seguenti: AA.VV., Carteggio ineditod’artisti dei secoli XIV, XV e XVI [...], pubblicato da C. Gaye, Firenze, Molin, III,1840, pp. 71, 76, 79-80, 82 (quattro epistole a Isabella); C. D’ARCO, Notizie di Isa-bella Estense moglie a Francesco Gonzaga aggiuntivi molti documenti inediti [...], in«Archivio storico italiano», Appendice al vol. II, 1845, pp. 203-326: 311-312 (altredue epistole alla marchesana); A. RONCHINI, Lettere d’uomini illustri conservate in Par-ma nel Regio Archivio di Stato, Parma, Reale Tipografia, 1853, p. 56 (epistola a Fer-rante); P. FERRATO, Alcune lettere del cardinal Pietro Bembo tratte le più dall’ArchivioStorico dei Gonzaga in Mantova, per nozze Dionisi-Bembo, Padova, Prosperini, 1875,pp. 11-15, 17 (cinque epistole a Isabella, comprese le due già fatte conoscere dalD’Arco, e la lettera a Francesco); AA.VV., Lettere di scrittori italiani del secolo XVI[...], per cura di G. Campori, Bologna, Romagnoli, 1877, p. 35 (epistola a Federi-co); V. CIAN, Un decennio della vita di M. Pietro Bembo (1521-1531). Appunti bio-grafici e un saggio di studî sul Bembo con appendice di documenti inediti, Torino, Loe-scher, 1885, p. 198 (biglietto all’Equicola); ID., Pietro Bembo cit., pp. 93-94, 95, 102,113-114, 127 e nota 1 (cinque epistole – con omissioni –, di cui due inedite, allamarchesana, una all’Equicola e stralci di altre lettere a Isabella, a Francesco e a Er-cole). Una missiva alla signora di Mantova del I Luglio 1505, già più volte data allestampe, riprodussero ancora A. LUZIO e R. RENIER nella celebre monografia La col-tura e le relazioni letterarie d’Isabella d’Este Gonzaga – 4. Gruppo veneto, in questo«Giornale», XXXVII, 1901, pp. 201-245 (alle pp. 203-204).
(28) I quattro volumi di cui consta l’edizione critica sono usciti, presso la Com-missione per i testi di lingua di Bologna, rispettivamente nel 1987 (lettere degli anni
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 226
Non si potrà, nondimeno, passare sotto silenzio la non sempre ot-timale fruibilità dell’oggetto di lavoro, talvolta scarsamente attendi-bile anche dal rispetto ecdotico. Infatti, indici imprescindibili per ilconcreto utilizzo di un’opera di tale genere e di tale mole (sprovvi-sta per giunta di note introduttive ai singoli testi e di chiose esege-tiche) come quelli dei destinatari e dei nomi propri, delle opere, deiluoghi appaiono stilati con corriva disinvoltura, considerata anche lagenerosa disponibilità di informazioni bibliografiche sui milieux fre-quentati dal letterato veneziano: corrispondenti e personaggi citatio non risultano neppure catalogati (particolarmente lacunoso l’Indi-ce dei destinatari del III volume) o, quando non ci si limita a ri-produrne ad verbum la spesso indeterminata designazione anagrafi-ca bembiana (29) e si provvede a una loro identificazione, vengonoregistrati nei modi più disparati e senza gli essenziali rimandi inter-ni (problematico soprattutto il riconoscimento delle destinatarie,censite ora sotto il cognome proprio o del coniuge, ora sotto la qua-lifica sociale [duchessa e simili], ora sotto il nome di battesimo o ad-dirittura l’ipocorismo), ciò che conduce fatalmente a confusioni e aequivoci grossolani (30). Per quel che è poi del Glossario posto in
VARIETÀ 227
1492-1507), nel 1990 (lettere degli anni 1508-1528), nel 1992 (lettere degli anni1529-1536) e nel 1993 (lettere degli anni 1537-1546). Tutte le citazioni da epistolebembiane prodotte d’ora in poi rinviano a tale stampa, di cui si indica in nota il nu-mero del volume, quello del documento e la pagina o le pagine interessate.
(29) È il caso dell’intestataria della lettera del 14 Aprile 1507 (I, 255, pp.249-250), dallo scrivente genericamente definita «Mad. Prefettessa» e come tale im-perturbabilmente contemplata nell’Indice dei destinatari (sub voce «Madonna»!), chenon richiedeva particolari industrie interpretative ravvisare in Giovanna da Monte-feltro, vedova del duca di Sora e prefetto di Senigallia Giovanni Della Rovere, so-rella del duca Guidubaldo e madre di quel Francesco Maria destinato a succedereallo zio nella signoria urbinate. E non si tratta, purtroppo, di un esempio isolato.
(30) Dell’impasse doveva del resto essere perfettamente conscio lo stesso Travi,che, a congedo dell’ultimo volume (IV, p. 675), apponeva evasivo un opinabile co-dicillo dall’inequivocabile sapore dell’excusatio non petita: «L’indice dei destinatariandrà ricontrollato alla singola voce nell’indice dei nomi propri, delle opere, dei luo-ghi. Infine si precisa che, allorquando si provvide a stendere i codici per l’edizione,avendo Pietro Bembo, o chi per esso, presentato il destinatario solo con il titolo del-la carica da quest’ultimo nel frattempo raggiunta (ad esempio: "cardinale"), ciò puòaver favorita una inesatta interpretazione. Il "cardinale Santacroce" può essere infat-ti indifferentemente il cardinale con tale cognome (come da me proposto), ma an-che Marcello Cervini, o Savelli, che furono appunto chiamati cardinali Santacroce».Un macroscopico fraintendimento, relativo proprio a uno dei personaggi oggetto del-la presente ricerca, è quello riguardante la lettera del 6 Aprile 1538, indirizzata – atenore dell’intestazione, contenente un patente errore verosimilmente già cinquecen-tesco – «alla Signora Marchesa di Pesaro <Vittoria Colonna>» (IV, 1925, p. 108), maassegnata nell’Indice dei destinatari (IV, p. 629) a «Leonora duchessa d’Urbino», o sidirà più precisamente a Eleonora Gonzaga in Della Rovere (per incredibile che pos-sa sembrare, nessuno dei due legittimi cognomi di una principessa tanto celebre ecosì spesso ricordata nell’epistolario viene riportato negli indici): in realtà, come d’al-tronde si evince tanto dal tono quanto dal contenuto della missiva, la destinataria neè proprio l’amica e corrispondente prediletta degli ultimi anni Vittoria Colonna, mar-
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 227
coda all’opera, i rilievi di Manlio Cortelazzo (pertinentissimi pur nel-la loro fin troppo remissiva urbanità) bastano e avanzano a docu-mentare le carenti competenze linguistiche e dialettologiche del fi-lologo, facendo sorgere giustificati sospetti circa l’effettiva intelli-genza, e dunque la bontà della lezione adottata, di svariati passi (31).
2. Temi, tempi e luoghi del carteggio
Venticinque testi – cui mette conto annettere, in funzione con-trastiva, gli otto destinati a Eleonora di Urbino – compongono dun-que il risicato patrimonio epistolare sul quale fondare la presenteindagine (tenue risarcimento alla scarsa consistenza dell’oggetto, allaquantità delle lettere sopperisce talvolta, specie nel caso di quelledestinate a Ercole Gonzaga, la loro notevole estensione); temi, tem-pi e luoghi di tale corrispondenza appaiono nondimeno esem-plarmente compenetrati, sì da rendere il fascicolo sufficientementerappresentativo delle peculiarità di almeno tre distinte stagioni esi-stenziali bembiane. L’ultimo scorcio veneziano e i primi anni urbi-nati, franchi da negozî civili e brighe politiche, fanno da sfondo allaspensierata relazione artistico-culturale dell’elegante gentiluomo conla raffinata marchesana; la maturità severa del letterariamente fe-condo esilio nel buen retiro padovano è il tempo del commercio epi-stolare, bilanciato tra contingenze pratiche e interessi speculativi,con il dotto collega monsignor Ercole, mentre all’estrema vecchiaiaromana attiene la tenera amicizia, larga di esortazioni e di riguardipaterni, dell’ormai universalmente rinomato cardinale e vescovo conla precocemente disillusa (e di cattolicità alquanto eterodossa) du-chessa Eleonora.
VARIETÀ228
chesa comunque non già di Pesaro, dal 1512 parte integrante del ducato roveresco,ma di Pescara. Sempre allo stesso proposito, è da segnalare che la «Sig.ra Duches-sa» menzionata nelle epistole del 14, del 22 (due) e del 27 Novembre 1543, rispet-tivamente destinate a Elisabetta Querini, al Gualteruzzi e a Elena Bembo (cfr. IV,2383, p. 455; 2386, p. 458; 2388, p. 462, e 2389, p. 464), non è, come inferito dal-l’editore (IV, Indice dei nomi propri, delle opere, dei luoghi, p. 648), Leonora Gon-zaga, ma la di lei nuora Vittoria Farnese, moglie di Guidubaldo II.
(31) Cfr. M. CORTELAZZO, Postille al lessico delle «Lettere» di Pietro Bembo, in«Studi linguistici italiani», XXIV, 1998, pp. 90-98. Data la triviale consistenza di al-cuni abbagli, denuncianti la mancata consultazione perfino di strumenti di lavoro deipiù ordinarî quali i dizionarî di Battaglia o di Tommaseo e Bellini («si ha l’impres-sione che il compito sia stato eseguito piuttosto frettolosamente e di malavoglia», as-serisce lo studioso stesso a proposito del Glossario [p. 91]), non si comprendefrancamente il tono di scusa, fra umile e circospetto, di cui il Cortelazzo ammantale sue impeccabili osservazioni: «Non vorremmo che queste note in margine venis-sero male interpretate. Esse non intendono assolutamente costituire un rilievo allapluriennale opera, altamente meritoria, di Ernesto Travi [...], ma sommessamente ri-cordare che, specialmente per alcuni autori, non c’è filologia senza dialettologia» (p.90). Il truismo dell’asserzione, infatti, di là da ogni verbale cortesia, la dice lunga sul-la natura delle "colpe" dell’editore.
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 228
Il periodo, per così dire, isabelliano del carteggio del Bembo concasa Gonzaga si sdipana infatti tra l’Aprile del 1505 (ma una signi-ficativa anticipazione ferrarese rimonta al Gennaio di due anni pri-ma) e il Novembre del 1508, con un paio di isolate reviviscenze nel-l’Ottobre del 1513 e nel Gennaio del 1524; la totalità di tali lettereviene recapitata a Mantova (una sola volta l’indirizzo è il feudo cam-pagnolo di Sacchetta, luogo di villeggiatura della marchesana) daVenezia e da Urbino, fatte salve le due ultime, inviate, ri-spettivamente, da Roma e da Padova. Ancora dalla città natale èspedita l’epistola a Francesco del 27 Agosto 1505, da Roma quelladel 23 Ottobre 1513 al delfino Federico, da Governo-lo (32) e da Padova quelle del 22 Giugno 1519 e del 10 Gennaio1524 a Mario Equicola: documenti, questi ultimi, di trascurabile ri-lievo, che per pura comodità classificatoria si annettono a tale pri-ma fase della corrispondenza (33). Fino al 1508 gli argomenti dellaconversazione con la signora di Mantova sono unicamente di carat-tere letterario e artistico (le stesse commendatizie di cui si fa paro-la appaiono a essi strettamente connesse) (34), mentre nelle due mis-sive seriori, come anche in quelle al marchese, a Federico eall’Equicola, è questione, assai più ordinariamente, di favori impe-trati e resi, di esternazioni di servitù clientelare e di incombenzediplomatiche (35).
Le lettere dirette a Ercole Gonzaga in un arco trilustre, dal 17Agosto 1525 al 10 Luglio 1540, contemplano essenzialmente in Pa-dova, o tutt’al più nella villa suburbana di Noniano, e in Mantovai rispettivi poli di partenza e di arrivo (a tale incartamento si è det-to ascriversi a pieno titolo pure la comunicazione del 7 Marzo 1527ad Agostino, segretario privato del presule); solo l’epistola del 9Marzo 1539 è vergata da Venezia, mentre quella del 10 Luglio 1540già appartiene – come del resto la missiva indirizzata qualche gior-no più tardi al viceré di Sicilia Ferrante (36) – al secondo soggior-no a Roma dell’autore delle Prose, conseguente all’ottenimento del-l’agognato cappello rosso. Nei primi due anni della relazione l’og-getto esclusivo ne è costituito, come si vedrà, da una raccomanda-zione alquanto sui generis (37), dopodiché i temi affrontati spazia-
VARIETÀ 229
(32) Con tale borgo, oggi comune, del Mantovano si dovrà senz’altro identificareil «Governo» dell’explicit del biglietto, annunciante l’imminente («questa sera») arri-vo alla corte gonzaghesca del suo estensore.
(33) Dal 1512 al 1521, in realtà, ha luogo la prima dimora romana dello scrit-tore, portatosi nell’urbe quale ospite temporaneo di Federico Fregoso e quindi ri-mastovi a séguito dell’elezione a segretario pontificio di Leone X.
(34) Cfr. I, 146, 203, 206, 209, 219, 225, 234; II, 281.(35) Cfr., nell’ordine, II, 335, 469; I, 208; II, 334, 390, 468.(36) Il documento, scritto il 10 Luglio, non reca annotazioni circa la destinazione,
ma fu recapitato verosimilmente a Guastalla, possedimento personale del Gonzaga.(37) Cfr. II, 581, 678, 717, 749 (ad Agostino), 763.
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 229
no dalle spedizioni e dalle richieste di opere letterarie proprie e al-trui agli scambî di favori e alle condoglianze (la prematura mortedel duca Federico sta all’origine pure del messaggio per Ferrante,teso in realtà all’ottenimento di un vantaggio pecuniario) (38).
È durante l’ultimo periodo romano – dal 22 Maggio 1541 al 9Maggio di cinque anni dopo – che l’ormai attempato cardinale in-trattiene un affettuoso dialogo epistolare con Eleonora di Urbino (lalettera del 19 Dicembre 1543, in realtà, venne spedita da Gubbioall’indomani della presa di possesso di quel vescovado) (39), a ec-cezione di una prima, remota responsiva indirizzatale da Padova giàil 12 Dicembre 1525. Per argomenti trattati quest’ultima serie di te-sti si presenta come la più eterogenea: rallegramenti per nascite visi avvicendano a consolatorie per lutti, informazioni artistiche a bol-lettini sanitarî, raccomandazioni per terzi a confidenze persona-li (40).
Prima di passare ad analizzare in dettaglio le caratteristiche diciascuno dei carteggi in oggetto sarà opportuno soffermarsi alquan-to su un dato, tanto singolare quanto rivelatore, che emerge a tut-ta evidenza anche da un sommario censimento dei documenti: a es-sere bandita senz’appello dalla corrispondenza bembiana con casaGonzaga è la storia, sia sotto la specie di notizie e riflessioni su ac-cadimenti politici di vasta portata sia sotto quella, non di necessitàancillare, di reportages di cronaca locale e di notazioni di costume.Neppure nei più inamidati colloquî con Ercole, neppure a proposi-to della soffertissima pratica de cardinalatu l’epistolografo si conce-de la minima considerazione su fatti e personaggi dell’affollato am-biente che lo circonda: quella giovanile insofferenza a intraprende-re la strada, peraltro già lusinghieramente battuta dal padre Ber-nardo, delle cariche marciane per lasciarsi tutto assorbire da un’e-sclusivissima vocazione umanistica; la scelta stessa, opportunistica sealtre mai, della carriera ecclesiastica come quella che meglio sem-brava garantirgli – in grazia della spregiudicata consuetudine dei be-nefici sine cura – le condizioni di otium indispensabili a sprofon-darsi nei diletti studî sembrano insomma riverberare su queste pa-gine risolutamente impermeabili all’interesse per gli aspetti pubbli-ci dell’esistenza, collocandole in una sorta di iperuranio franco dal-le servitù della vita civile (la contraddizione tra tali orientamenti eil coscienzioso svolgimento dell’incarico di storiografo della Repub-
VARIETÀ230
(38) Cfr., nell’ordine, III, 1276; IV, 1873, 2018, 2074, 2200, 2202.(39) Nonostante la nomina ufficiale a pastore eugubino rimontasse al 29 Luglio
1541, soltanto sul finire del 1543 il Bembo si decise a stabilirsi nella diocesi umbradi Sant’Ubaldo, stanziandovisi effettivamente il 2 Novembre (cfr. la già citata missi-va alla Querini del 14 di quel mese [IV, 2383, p. 455]), salvo abbandonarla di nuo-vo e per sempre nel Marzo dell’anno successivo.
(40) Cfr. II, 628; IV, 2248, 2259, 2275, 2313, 2330, 2400, 2536.
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 230
blica di San Marco, assunto nel 1530 e protratto fino agli ultimianni, è solo apparente, stante la scarsa inclinazione palesata dal ses-santenne Bembo per quel cómpito – dagli esiti, del resto, alquantomediocri –, la cui accettazione rappresentò piuttosto un tardo ten-tativo di ribadire «la sua pertinenza di uomo a una nobile patria»un tempo tradita) (41).
3. Lettere ad personam: implicazioni del rapporto mittente-destinata-rio
a) I carteggi con Isabella e con sua figlia Eleonora
1. Appunto nel segno della letteratura, e proprio in quello fati-dico dell’idolatrato Petrarca, si inaugura la storia della relazione epi-stolare tra il trentunenne Bembo e l’appena più giovane signora diMantova. Più che di storia, tuttavia, bisognerebbe parlare di preisto-ria, atteso che i rapporti tra i due personaggi, anziché diretti, risul-tano mediati per il tramite di un diligente informatore artistico isa-belliano, il liutaio Lorenzo Guarnasco da Pavia, che in una celebremissiva del Luglio 1501 relativa all’imminente uscita dell’aldina “ta-scabile” dei Rerum vulgarium fragmenta si diffonde sulla devozioneprofessata alla dotta marchesana dal curatore e dallo stampatore delvolume:
[...] è in compagnia di dicto maestro [il Manuzio] messer Pero Bembo, el qua-le è stato quelo ha fato stampare diti Petrarcha, et che è aficionatissimo a la S.V. [...]Finito che sia, subito mandaròlo a la S.V., e voleno che el primo che insa sia vostroe che l’hano per bono augurio e tengono per certo de fare de gran bene de dita ope-ra per avere dato primo principio la S.V. (42)
Il primo documento ad attestare l’instaurarsi di un effettivo contat-to è invece una responsiva stesa dal Bembo, al tempo della sua se-conda permanenza ferrarese, a due mani con l’amico anfitrione Er-cole Strozzi nell’Epifania del 1503 per declinare cavallerescamenteun’offerta di recarsi a Mantova da parte di Isabella, evidentemente
VARIETÀ 231
(41) DIONISOTTI, Introduzione cit., p. 49. Al segretario dei Dieci Giovan BattistaRamusio il 21 Giugno 1529 l’amico senza infingimenti confessava: «[...] vi dico cheio sono assai rimoto da quella vita e da quelle azion publiche che sono in gran par-te materia della istoria, e per volontà mia, ché dato mi sono a gli studi; e per lo ec-clesiastico che da loro mi separa, oltra che, in tante maniere dello scrivere alle qua-li ho alle volte posto mano e dato alcuna opera, mai non ebbi pure un pensieruzzodi volere scrivere istorie» (III, 988, p. 57 [il destinatario del messaggio non è elen-cato nel relativo indice]).
(42) Cfr. in merito CIAN, Pietro Bembo cit., pp. 83-84, e, soprattutto, A. LUZIO-R.RENIER, La coltura e le relazioni letterarie d’Isabella d’Este Gonzaga – I. La coltura, inquesto «Giornale», XXXIII, 1899, pp. 1-62 (cito dalle pp. 17-18).
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 231
svelta «ad accorgersi che tanto astro avrebbe finito per dar troppaluce alla cognata» (43); ma ancora a tale altezza, come prova unacerimoniosa perifrasi epistolare («uno di noi per ancora non le hacon la persona fatto riverenza»), il corrispondente non conosceva devisu la sua interlocutrice (44). Circostanza tanto più curiosa quan-do si consideri che i rapporti dei Gonzaga, e della marchesana inspecie, con casa Bembo erano da tempo dei più stretti e cordiali(basti pensare alle svariate lettere di argomento così politico-diplo-matico come familiare e alle mutue visite intercorse tra il padre dello scrittore e l’augusta coppia o alla benevolenza dimostrata daIsabella a Carlo, fratello minore di Pietro, spesso suo ospite a cor-te) (45). Né la promessa contenuta in quell’epistola di onorare l’in-vito «alcun giorno» sarebbe stata adempiuta nel lasso di due anniabbondanti: nell’autunno del 1504 (andato pure fallito un tentativodella tenace madonna di incrociare il poeta a Ferrara nell’Aprile del1503) un tiepido proposito di recarsi a omaggiare i signori di Man-tova – ma la meta reale della gita erano i rimpianti appartamentidell’ex amante Lucrezia – venne vanificato dall’improvvisa scom-parsa di Ercole I (46), e ancora l’8 Aprile dell’anno successivo, nel-la sua prima lettera personale a Isabella, l’impacciato scrivente si in-
VARIETÀ232
(43) Il puntuto rilievo è di M. BELLONCI, Lucrezia Borgia, la sua vita e i suoi tem-pi, Verona, Mondadori, 19426 (19391), p. 400.
(44) Cfr. I, 146, p. 139 (l’autografia bembiana del testo è inequivocabile). Coluiche non aveva mai incontrato la dama non poteva certo essere lo Strozzi, fedele fau-tore degli Este e intimo della principessa fin dall’infanzia di lei. Nota sempre la BEL-LONCI, ivi, pp. 400-401, che il letterato veneziano «anche se non ancora in quel tem-po innamorato, era troppo galante cavaliere per abbandonare una signora che gli eracortese, e proprio per la sua rivale»: con il sodale aveva perciò imbastito «scuse va-ghe, ma che significavano che quei due avevano preso un partito e non intendeva-no tradirlo. Ad ogni modo, Isabella era donna da saper benissimo superare il suo di-singanno, senza dimenticarlo, in attesa di una rivincita futura».
(45) Di una di tali visite discorre per l’appunto il Bembo in una responsiva alfratello del 14 Dicembre 1502 (cfr. I, 144, p. 137). La dimestichezza tra i Gonzagae la famiglia veneziana (che autorizzò fra l’altro il cavalier Bernardo a richiedere almarchese «due cavalcature» per il secondo viaggio a Roma del giovane Pietro nel1502) non deve minimamente stupire, stanti le mansioni di capitano dell’esercito del-la Serenissima reiteratamente assolte da Francesco e le cariche di vicedomino dellaRepubblica marciana in Ferrara e quindi di podestà di Verona rivestite dal Bembosenior. Per un diligente resoconto di questa amicizia cfr. ancora CIAN, Pietro Bembocit., pp. 84-91 (e vedi pure, infra, nota 61).
(46) Apprendiamo la notizia dal carteggio del Bembo con la Borgia, missiva daVerona datata 8 Ottobre 1504: «[...] da Bergamo e da Brescia ritornato volea pas-sare a Mantova, e d’indi a Ferrara, per saziare in alcuna parte la mia annual sete [...].Ma giunti che siamo stati qui abbiamo inteso il Signor Duca, Socero di V.S., o es-sere di questa vita passato, o non lontano ritrovarsi da quel passo, e il Marchese ela Marchesana esser venuti a Ferrara per questa nuova. Il che m’ha fatto mutar pen-siero non mi parendo, questo, tempo di poter fare a V.S. riverenza riposatamentecome io vorrei. E così [...] ho diliberato indugiare a questo Carnavale il venire a Fer-rara [...]» (I, 195, p. 181).
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 232
gegnava a giustificare con convenzionale adulazione quelle che or-mai agli occhi della destinataria dovevano irrecusabilmente qualifi-carsi come volontarie differite:
Se io non ho per ancora potuto, Ill.ma Madonna, così con la fronte fare a V.S.reverenza come l’ho fatta già buon tempo continuamente col core, V. Ec.za si de-gnerà imputarlo parte alle mie occupazioni, che non me l’hanno conceduto, partealla mia disaventura, che le più volte si suole opporre alle cose che io più disidero.Ben rendo infinite grazie a V.S., che m’ha fatto invitare per suo nome più fiate al ve-nire a Mantoa: il che io debbo sommamente in ogni tempo cercare, senza invito, edisiderare; come certo fo, e come spero m’averrà esserci di brieve (47).
L’impressione, insomma, che – a onta delle congetture di segno op-posto avanzate dal Cian – si riporta da questi prodromi della rela-zione tra i due personaggi è quella di una mancata reciprocità: men-tre la marchesana si prodiga mercé i buoni uffici dell’umanista fer-rarese Timoteo Bendedei, in arte Filomuso, prima (48) e di altriignoti mediatori poi per accaparrarsi – in neanche troppo sot-terranea competizione con l’aborrita cognata – la presenza alla suacolta reggia di uno dei più contesi gentiluomini del periodo, ricer-cato rimatore e latinista impeccabile, fascinoso intrattenitore didame nonché estimatore di arte antica e moderna, Pietro Bembo – cui certo non difettavano le possibilità logistiche di soddisfare unavolta o l’altra a profferte tanto amorevolmente reiterate – sembraprovare un assoluto disinteresse, se non si vorrà dire una precon-cetta antipatia, nei confronti di colei che pure passava per la musaispiratrice degli intellettuali di mezza Italia (ben altrimenti prepo-tente sarà, qualche mese più tardi, il desiderio di raggiungere l’au-la feltresca per decidersi ipso facto a eleggerla a stabile dimora, ana-logamente a quanto era accaduto, qualche anno prima, per la cor-te dei duchi d’Este).
Comunque sia, l’epistola dianzi citata registra un discreto pro-gresso nei rapporti tra l’autore degli Asolani (usciti a stampa pro-prio nel precedente Marzo) e Isabella: nella clausola, infatti, il cor-rispondente afferma di inviare a Mantova, per il tramite dell’amicoconcittadino Giovan Francesco Valier, assiduo di casa Gonzaga, «tregiovani non prima di casa uscitigli» (49), cioè tre composizioni inrima di cui la donataria, collezionista accanita di vient-de-paraître in
VARIETÀ 233
(47) I, 203, p. 191.(48) All’interposizione di questo comune sodale facevano espresso riferimento il
Bembo e lo Strozzi nella sopracitata lettera del 1503: «Messer Timoteo invitandocil’altr’ieri per nome di V.S. con calde e onorate parole a venire a Mantoa, e fare conlei tre giorni, e all’invito aggiungendo pungentissimi sproni, quelli piaceri raccon-tandone che nuovamente esso ha avuti, e che si sogliono aver sempre dove è V.S., elietissimi e tristissimi ci ha fatti ad un tempo [...]» (I, 146, p. 138).
(49) I, 203, p. 191.
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 233
prosa e in versi (50), dovette rimanere assai soddisfatta. Quasi tremesi più tardi anche il voto di recarsi nella città gonzaghesca «dibrieve» verrà adempiuto: di ritorno dall’ambasceria effettuata aRoma in compagnia, tra gli altri, del padre e del poeta Paolo Canallo scrittore si deciderà finalmente a rendere omaggio alla signora ea trattenersi presso di lei per qualche giorno. Che, tuttavia, a taledecisione non fossero state estranee le esortazioni della cognata pre-diletta dalla marchesana, quell’Elisabetta di Urbino che fin dal pri-mo incontro con il Bembo prese a esercitare su di lui un ascendenteparticolare (51), sembra provato dalla lettera di presentazione ver-gata manu propria dalla duchessa per la «soror hon.ma» il 10 di Giu-gno:
[El Mag.co Piero Bembo] ha determinato capitar lì solum per visitar V. Ex.tiaet darseli da cognoscer come persona che molto è affectionata ad quella, la qual pre-go sia contenta crederlo volentier et acharezarlo, sì per respecto de le virtù et dotede l’animo che in lui sono, sì etiam per amor mio, havendoli dicto che, cognosciutoharà la S.V. presentialmente [...], concluderà li effecti non solo esser corrispondentia la grande opinion ch’el se ne ha facto, ma quella pur assai avanzar (52).
Accompagnato dal Canal, l’attesissimo ospite giunse a Mantova sulfinire del mese e il poco tempo trascorso alla corte isabelliana (il“rivale” marchese si trovava in quei giorni a Firenze) (53) dovette
VARIETÀ234
(50) Cfr. in merito il mio studio Poesia e teatro di Galeotto Dal Carretto. Rifles-sioni in margine al carteggio con Isabella d’Este, in «Nuova rivista di letteratura ita-liana», VII, 2004, pp. 123-178. CIAN, Pietro Bembo cit., p. 95, crede di ravvisare nei«giovani» in questione dei sonetti, senza tuttavia motivare il proprio convincimento.Come si vedrà infra l’identificazione appare tutt’altro che automatica.
(51) Proprio durante il viaggio alla volta della curia papale i diplomatici marcianifecero tappa presso i Montefeltro, «bene visti et acarezati» – come riferiva al marche-se Francesco suo fratello Giovanni il 19 Aprile – «da questa Ill.ma M.ma Duchessa»(cfr. Archivio Gonzaga, serie E. XXVI, 3). L’accoglienza e le conversazioni con la damadovettero riuscire così grate a Pietro Bembo che, di ritorno dall’urbe, abbandonava ilresto della comitiva per passare ancora qualche giorno assieme ai principi marchigianinella residenza di Gubbio prima e poi di nuovo nel castello urbinate.
(52) Riproduco, adeguando all’uso moderno iniziali e segni interpuntivi, il testoda CIAN, Pietro Bembo cit., p. 98. Anche la fida compagna di Elisabetta Emilia Pioproduceva lusinghiere commendatizie in favore dello scrittore in una missiva all’a-mica mantovana del seguente 16 Giugno.
(53) Di tale assenza, e contemporaneamente della considerazione di cui dovevagodere anche presso Francesco II, siamo informati proprio dall’unico messaggio delpatrizio veneziano al Gonzaga di cui si abbia notizia: «M. Zuan Fr<ancesco> Vale-ro m’ha referito quanto umanamente V. Ec.za li scrisse fin da Fiorenza, dimostran-do che a V.S. fusse caro che io fussi a Mantoa, e che io fussi accarezzato e onorato;e quanto poi, ritornato di Toscana, V.S. gli ha parlato onorevolmente di M. mio pa-dre, e amorevolmente di me». Affettando gratitudine per tanta fiduciaria benevolen-za, lo scrivente auspica cortigianescamente che «il cielo» gli «doni un giorno tantaforza e potere che egli vaglia e sia buono ad operarsi per V.S. secondo il suo disio»(I, 208, p. 295): voto, notoriamente, destinato a non essere adempiuto. Nell’episto-lario bembiano, del marchese, menzionato di passata pure in una famosa missiva a
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 234
contribuire a modificare alquanto la sua scarsa opinione al riguar-do (54). Un’apprezzabile differenza di tono si registra infatti nellamissiva che, con sintomatica premura, egli si affrettò a indirizzarealla Gonzaga non appena rientrato a Venezia, dove l’esibita nostal-gia per «quella felice sera» in cui contemplò la regale creatura piz-zicare il liuto con «la bella e vaga mano» dispiegando nel canto «lapura e bella voce» appare – di là dalle inevitabili infiorettature dit-tologiche petrarcheggianti – bastantemente autentica. E proprio alcavalleresco desiderio «che alcun suo verso sia recitato e cantato»dalla virtuosa corrispondente, «estimando che nessuna grazia pos-sano avere le cose sue maggiore che questa» («[...] se saranno can-tati da V.S., si potranno dire fortunatissimi, né altro bisognerà per-ché agli ascoltanti piacciano, e siano cari avuti») (55), il poeta at-tribuisce l’omaggio alla marchesana di parecchie sue liriche di fre-schissima confezione. Vellicato nel suo amor proprio di aristocrati-co rimatore in volgare dall’insospettata competenza isabelliana inmateria, Bembo auspicava evidentemente che le sue composizioni,debitamente musicate dai reputati maestri in servizio presso i Gon-zaga Bartolomeo Tromboncino e Marchetto Cara, avessero agio dicompetere – per schiacciarle mercé la ritrovata eleganza “classica”della lingua e dello stile – con quelle di cui riforniva assiduamentela signora la vecchia guardia dei poeti cortigiani: Gasparo Visconti,il Tebaldeo (56), Niccolò da Correggio, Galeotto Dal Carretto, Se-rafino Cimminelli e via seguitando. Ma – e qui è la piccola sorpre-sa riservata dal documento – cadrebbe in errore chi, a tenore deipresupposti teorici neoplatonici degli Asolani, avallanti una liricaamorosa essenzialmente declinata nel solco del sommo trecentista (si
VARIETÀ 235
Vincenzo Querini del 10 Giugno 1508 (II, 280, p. 22), si ragiona diffusamente, e conbenignità attribuibile alla crucialità del frangente, in una lettera al padre Bernardodel 10 Novembre 1509 (II, 290, pp. 31-33) incentrata sui casi relativi alla prigioniaveneziana del Gonzaga.
(54) Grande simpatia gli ispirò – come del resto a molti altri nobiluomini, cle-rici e intellettuali – la seducente Alda Boiardo, una delle damigelle più frizzanti e di-sinibite del séguito della principessa, prima cugina di Matteo Maria. Di essa infattiBembo si ricorderà nei suoi saluti epistolari fino al 1513 (cfr. I, 206, 209, e IV, 1513)e da una responsiva all’amico Bibbiena del 5 Febbraio 1506 apprendiamo che conlei intrecciò pure un carteggio: «Ebbi lettere da Brescia nelle quali Mad. Alda miscrive che, scrivendovi io, la vi raccomandi» (I, 226, pp. 211-212). Ancora il Dovizisi fece carico di trasmettere alla Boiardo i rispetti del sodale contenuti in una lette-ra per la marchesana del 26 Dicembre 1509 (cfr. B. DOVIZI DA BIBBIENA, Epistolario,a cura di G. Moncallero, Firenze, Olschki, I, 1957, p. 338).
(55) I, 206, p. 194.(56) Il verseggiatore ferrarese, buon amico del Bembo, doveva aver avuto parte
nella risoluzione di questi di recarsi a Mantova: in un’epistola speditagli dalla mar-chesana il 4 Luglio di quell’anno, infatti, a proposito della visita dei due letterati ve-neziani si fa cenno ai suoi uffici di mediatore: «Essendo vuy stato di ciò causa, comone scriviti, vi ne restamo cum obligo et ringratiamovene» (cito, con i soliti ammo-dernamenti grafici e interpuntivi, da CIAN, Pietro Bembo cit., p. 100).
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 235
consideri la presenza nella princeps del dialogo di ben nove canzo-ni sullo schema di quelle del Canzoniere, vale a dire la spiccata pre-ferenza accordata a un metro “alto” reietto dalla contemporanea ri-meria cortigiana), ne ritenesse l’autore sacerdote di un credo giàindefettibilmente petrarchista: a essere spediti a Isabella, infatti,sono sì ben «dieci sonetti» che non si ha ragione di dubitare esem-plati sugli aurei archetipi, ma pure un paio di «tramotti uscitialquanto dalla loro regola»: prodotti, cioè, di quel genere – popo-lareggiante se altri mai, ma tanto alla moda nelle regge del tempo –di cui si spartivano il monopolio Tebaldeo, Dal Carretto e l’Aquila-no (57). A questa altezza, insomma, la selezione dei metri poetabi-li che condurrà all’esemplificazione normativa delle Rime, impressea partire dal 1530, appare ancora assai lontana da una rigorosa at-tuazione (del resto, un cauto sperimentalismo perdura fino alla sil-loge a stampa, se ancora vi «sopravvivono elementi “eslegi” come ilternario e lo strambotto, pur ridotti al minimo di presenze») (58).
VARIETÀ236
(57) Nel prosieguo della lettera, lo scrivente specifica – come d’altronde già ac-cadeva per le tre poesie accodate a quella dell’8 Aprile 1505 – che, tra i sonetti, «nesono non avuti più da altri» e che gli strambotti sono «in tutto novi, né pure vedu-ti da alcuno»: un evidente atto di riguardo che avrà compiaciuto non poco la desti-nataria. È ragionevole ipotizzare che qualcuno almeno dei sonetti sia poi rifluito nel-la princeps delle Rime o in una delle due stampe successive, entrambe accresciute diversi in gran parte "di recupero", come può darsi che uno degli strambotti si iden-tifichi non già con l’unico accolto nella silloge (su cui cfr. la nota seguente), ma conil dialogo galante tra due innamorati – di struttura metrica, tuttavia, assolutamenteregolare – che si legge nelle Rime rifiutate dell’edizione delle Opere in volgare bem-biane a cura di M. Marti, Firenze, Sansoni, 1961, p. 570, n. XVI. La sottolineata no-vità dei due testi in ottave esclude invece l’eventualità di ravvisarli in quelli, risalen-ti al 1500 e dedicati alla Savorgnan, figuranti nel corpus delle Lettere giovenili an-nesso al cit. Quarto volume delle Lettere (cfr., nelle citt. Opere, le Lettere giovenili,nn. 39 e 74, pp. 198 e 245, e, nell’edizione Travi, I, 88, p. 73, e 129, p. 123), ri-prodotti dal Dionisotti tra le Rime rifiutate in Prose della volgar lingua. Gli Asolani.Rime cit. (nn. X e XII, pp. 682-683, 684-685).
(58) ZANATO, Pietro Bembo cit., p. 414 (a p. 386 lo studioso definisce i dodicicomponimenti recapitati alla Gonzaga una «mini-raccolta, non identificabile», ravvi-sandovi uno dei più precoci organismi di liriche bembiane – l’altro è una serie di se-dici pezzi contenuta nel ms. Italiano 1543 della Nazionale di Parigi – di cui si abbianotizia). Involontariamente "petrarchistico" l’errore in cui incorre Fedi, che, nel ri-tratto dello scrittore recentemente tracciato (cfr. R. FEDI, La fondazione dei modelli.Bembo, Castiglione, Della Casa, in Storia della letteratura italiana, diretta da E. Ma-lato, vol. IV [Il primo Cinquecento], Roma, Salerno Editrice, 1996, p. 548), derubri-ca dall’inventario delle Rime lo strambotto in lode di Ercole Strozzi, verosimilmen-te posteriore alla morte del poeta ferrarese (1508) – n. LXV nelle citt. edizioni Martidelle Opere, p. 487, e Dionisotti di Prose della volgar lingua. Gli Asolani. Rime, p.562, giusta l’edizione postuma definitiva delle Rime, la Dorico del 1548 – , incre-mentandolo però di un madrigale, con cui il componimento viene evidentementescambiato. D’altro canto già il CIAN, Pietro Bembo cit., p. 101 (e cfr., ivi, nota 2) as-seriva «con piena sicurezza» che nel «ricco canzoniere bembesco» «rigorosamentefedele alla tradizione petrarchesca [...] non troviamo mai rappresentato quel generepoetico, neppure nella sua costituzione metrica più regolare».
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 236
Durante la breve gita a Mantova, il Bembo promise anche allamarchesana di adoperare la propria influenza acché il richiestissimoGiovanni Bellini approntasse per lei una seconda tela da collocarenello Studiolo a pendant con quella, raffigurante la Vergine conGesù bambino e il Battista, recapitatale nel 1504 (59). Dell’artistasuo concittadino egli era infatti grande estimatore e buon cono-scente: tempo addietro aveva posato nel suo atelier per un ritrattoe ne aveva celebrato le lodi nel primo di una coppia di sonetti com-posti, alla maniera di Petrarca, sopra un’«imagine» su tavola dell’a-mata Maria Savorgnan:
O imagine mia celeste e pura,che splendi più che ’l sole agli occhi mieie mi rassembri ’l volto di colei,che scolpita ho nel cor con maggior cura,
credo che ’l mio Bellin con la figurat’abbia dato il costume anco di lei,che m’ardi, s’io ti miro, e per te seifreddo smalto, a cui giunse alta ventura (60).
La circostanza ci offre il destro di sorprendere l’autore delle Prosenella veste a noi meno familiare – ma al tempo la sua rinomanza diintenditore di pittura, antichità e numismatica era tutt’altro cheoscura – di consulente artistico (61). Le vicende della commissionedi tale quadro, infatti, costituiscono il perno attorno a cui ruota ilrestante carteggio con Isabella fino al definitivo allontanamento delBembo da Venezia, rappresentando dunque il centro focale del com-mercio epistolare tra i due. Le notizie intorno ai testi poetici, inve-
VARIETÀ 237
(59) Per ottenere quel dipinto, ordinato nel 1501 per il tramite degli emissarîLorenzo da Pavia e Michele Vianello, la signora aveva dovuto aspettare ben tre anni,ma ne rimase pienamente appagata. Oggi perduto, figurava tuttavia ancora censitonel 1627 in un Inventario della Galleria di quadri e di altri oggetti d’arte della cortedel duca di Mantova riprodotto da C. D’ARCO in Delle arti e degli artefici di Manto-va, Mantova, Agazzi, II, 1857, p. 168, n. 200.
(60) BEMBO, Prose della volgar lingua. Gli Asolani. Rime cit., pp. 521-522 (i duesonetti sono il XIX, da cui ho derivato la citazione, e il XX). Nella sua lussuosa di-mora padovana lo scrittore esibiva anche alcune opere di Iacopo Bellini (cfr. al pro-posito LUZIO-RENIER, La coltura e le relazioni letterarie cit., 4, p. 205 nota 2, e L. PUP-PI, La residenza di Pietro Bembo «in padoana», in «L’Arte», VII, 1969, pp. 30-65).
(61) La passione per le belle arti era, in verità, condivisa da altri membri di casaBembo, il cui palazzo marciano esibiva svariati pezzi pregevoli sui quali l’intrapren-dente principessa di Mantova non aveva naturalmente mancato di mettere gli occhi.È dell’estate del 1502 la pratica relativa all’esemplazione di certi ritratti di Dante, delPetrarca e del Boccaccio condotta a buon fine dalla dama dopo una visita al cava-lier Bernardo. Grazie alla squisita disponibilità di Carlo («non gli è cosa in casa no-stra che non sia al comando de la S.a vostra»), essa si vide pure recapitare a Man-tova, per meglio ammirarle ed eventualmente trarne copia, «altre poche cosette» e«un San Ziovani et una Veronica [...], ambi lavor oltramontano» di proprietà dellafamiglia (riproduco la lettera giusta CIAN, Pietro Bembo cit., p. 85).
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 237
ce, malauguratamente scompaiono già nella missiva seguente (27Agosto), in cui lo scrivente si scusa di non poter «mandare cosanova alcuna» per trovarsi troppo «occupato», né argomenti letterarîverranno mai più affrontati in séguito (62). La pratica con il pitto-re, in compenso, è stata felicemente avviata con il concorso del co-mune amico Paolo Zoppo («gli avemo dato tanta battaglia che ’l ca-stello al tutto credo si renderà») e una «calda lettera» (63) di-rettamente all’interessato di proprio pugno della signora dovrebberiuscire determinante. La marchesana, forse per disturbi cagionatidalla gravidanza di Ercole, avrà modo di attenersi a tali istruzionisolo il seguente 19 Ottobre, accludendo la missiva per il Bellini, chesi deciderà finalmente ad accettare l’incarico, a un’epistola indiriz-zata al patrizio veneziano (64). Qualche tempo dopo, per il tramitedel fido segretario Benedetto Capilupi, Isabella disvela alquanto in-cautamente al pittore il suo ambizioso disegno: strappare a messerPietro l’«inventione», ossia la concezione del soggetto del quadro;idea che non dovette andare per nulla a genio all’artista, orgogliosoe malsofferente di ingerenze nel proprio lavoro, come sembra pro-vato dal fatto che nella successiva lettera bembiana, vergata il 20Novembre al ritorno da un viaggio nella Marca Trevigiana, non vie-ne fatta parola della nuova collaborazione richiestagli:
Sono [...] stato oggi con esso M. Zuan Bellino, e ho veduto così essere: che hadeliberato al tutto di sodisfare al disiderio di V.S. e farallo, sono certo, diligentissi-mamente. Aspetto solo la risposta da V.S. delle misure e della luce e delle altre cosescrittele sopra ciò (65).
Ma neppure gli affanni del parto hanno il potere di far recederel’instancabile committente dal suo proposito: ancora sul letto deltravaglio, il 2 Dicembre, eccola infatti esortare espressamente loscrittore a «pigliare lo asumpto di fare una inventione a modo suoche satisfatia al Bellino, che, per havere [...] visto le altre che sononel camerino, saperà accomodarni una in proposito et di vario et
VARIETÀ238
(62) Arduo avanzare congetture circa le ragioni di tale repentina cessazione diomaggi lirici: poco persuasiva (manca di pezze d’appoggio documentali) l’ipotesi cheun sempre più deciso orientamento del gusto del Bembo in direzione petrarchescalo allontanasse dal genere della poesia per musica tanto grato alla corrispondente.Da notare che LUZIO e RENIER, La cultura e le relazioni letterarie cit., 4, p. 204, espri-mevano l’immotivata convinzione che egli continuasse a inviare «sue nuove produ-zioni alla marchesa, alla spicciolata forse per lo più, in foglio volante, ché nel-l’inventario di Isabella non v’è traccia di raccolta dei versi bembeschi, mentre vi fi-gura un esemplare stampato su pergamena degli Asolani».
(63) Per questa e per le precedenti citazioni cfr. I, 209, p. 196.(64) Il testo di quest’ultima si legge in uno dei Copialettere particolari di Isabel-
la d’Este custoditi nell’Archivio Gonzaga, Serie F. II. 9 e, b. 2994.(65) I, 219, p. 204.
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 238
elegante significato» (66). Parole, queste, che sembrerebbero postu-lare una tela di soggetto storico o comunque profano, probabil-mente indulgente – dal momento che doveva fiancheggiare nel «ca-merino» le allegorie mantegnesche oggi custodite al Louvre – a queilambiccati sottosensi simbolici che la dama tanto mostrava di ap-prezzare così nei dipinti come nelle imprese e, perfino, nelle toilet-tes di gala (67). Stavolta l’interlocutore epistolare non può esimersidal prendere posizione e promettere, salomonicamente, di trovare«la inventione [...] al dissegno» a patto che «s’accomodi alla fanta-sia di lui che l’ha da fare, il quale ha piacere che molto segnati ter-mini non si diano al suo stile, uso, come dice, di sempre vagare asua voglia nelle pitture che, quanto è in lui, possano sodisfare a chile mira» (68). In guisa di contraccambio per la propria prestazione,domanda però alla principessa un servigio analogo a quello da leirichiestogli: interporre la sua influenza affinché il più insigne pen-nello della corte mantovana, Andrea Mantegna, si decida a onorarel’impegno preso con il veneziano Francesco Corner, suo stretto con-giunto e intimo amico, di eseguire «alcuni telari» al prezzo a suotempo pattuito. Il favore è impetrato ricorrendo a uno spiritoso jeude mots sui nomina-omina che costituisce l’unica boutade, la sola in-dulgenza a una qualche colloquiale familiarità nell’ambito di unacorrispondenza – a onta della notoria facetudo isabelliana – assaicontrollata e dai toni poco confidenziali:
Il quale [Mantegna] priego io e supplico V. Ec.za, se la mia servitù è in alcunconto appresso lei, che V.S. persuada M. And<rea> ad attendere alla fede data a M.Franc<esco>, e a dar principio alla tolta impresa delle sue pitture, massimamente ri-chiedendosi a lui, più che a veruno altro, il mantenere delle promesse, che è chia-mato il Mantegna dal mondo, acciò che, altrimenti facendo, non sia seco medesimodiscordante, essendo e non essendo Mantegna ad un tempo, se mi lece del vero conV. Ec.za motteggiare (69).
A tale lettera dell’11 Gennaio 1506 la marchesana rispondeva l’ul-timo di quel mese che avrebbe provveduto a inviare a Venezia, in-sieme con la caparra, le «misure et ajere» del dipinto (70); ma laviolenta epidemia pestilenziale scoppiata a Mantova nella seguenteprimavera, costringendo la corte a traslocare in tutta fretta nella do-mus iucunditatis di Sacchetta, ne distolse provvisoriamente il pen-siero da progetti artistici. Ancora l’11 Maggio, infatti, il perdurare
VARIETÀ 239
(66) Cito, con i soliti ammodernamenti, da CIAN, Pietro Bembo cit., p. 106 (ildocumento, ancora da un Copialettere isabelliano, è di pugno del Capilupi).
(67) Cfr. in proposito A. LUZIO-R. RENIER, Il lusso di Isabella d’Este marchesa diMantova. I, in «Archivio storico italiano», LXIII, 1896, s. IV, pp. 441-469.
(68) I, 225, p. 209.(69) Ivi, p. 210.(70) Il documento è parzialmente riprodotto in CIAN, Pietro Bembo cit., p. 107.
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 239
del flagello non le aveva consentito di recapitare quanto promessooltre tre mesi prima; esortava tuttavia il Bembo, nonché a «compo-nere la poesia [scil. il soggetto della tela] ad sua satisfactione», aprocacciarle, con l’aiuto dei factotum marchionali Lorenzo da Paviae Taddeo Albano, un vaso di agata e un quadro raffigurante la«summersione di Faraone» appartenuti al nobile marciano MicheleVianello testé defunto (71). A giro di posta (13 Maggio) il letteratosi professava disposto ad assolvere la vecchia e la nuova incomben-za, dichiarando tra l’altro di avere intrapreso la Pasqua precedenteun’inutile gita a Mantova per «la principal causa» di rivedere laGonzaga: l’affermazione, se non costituisce una di quelle gratuitegalanterie verbali per cui si distingueva il viveur veneziano (72), po-trebbe deporre per un meno fievole interesse nutrito rispetto al pas-sato nei confronti della dama, forse preludente – ove non avesseavuto luogo il definitivo trasferimento dal caos politico e mercante-sco della laguna ai quieti recessi dell’aula feltresca – all’instaurarsidi un legame altrimenti solido e profondo (73).
Viceversa, con il passaggio a Urbino si conclude, in sostanza, larelazione corresponsiva con la marchesana: ragionevolmente il di-pinto – come già inferì il Braghirolli – (74) non venne eseguito dal-l’ottuagenario Bellini, e ben due anni e mezzo ebbero a trascorrereprima che Bembo, ormai soggiogato dall’eletta atmosfera del circo-lo marchigiano, riprendesse la penna in mano per trattenersi un
VARIETÀ240
(71) Ibidem.(72) Cfr. I, 234, p. 223. È infatti lecito sospettare che lo scopo reale della tra-
sferta fosse quello di recuperare un prezioso «horologio picolino [...] fatto già permano de maestro Piero Mantoano» portato da Pietro a riparare presso una bottegalocale al tempo della sua prima visita. Il padre, cui il gioiello apparteneva, verosi-milmente non ebbe mai a recuperarlo (se ne veda la missiva al marchese Francescodel 7 Maggio 1506 stralciata in CIAN, Pietro Bembo cit., pp. 109-110).
(73) Non si comprende francamente come FEDI, La fondazione dei modelli cit.,p. 532, possa annoverare nella «serie di viaggi e di soggiorni presso le corti italiane»effettuati dal Bembo intorno ai quarant’anni «Mantova e Urbino soprattutto, dal1506 al 1511»: se è indiscutibile l’influenza esercitata sulla personalità umana e arti-stica dell’autore delle Prose dalla quinquennale continuativa residenza presso losplendido palazzo del duca Guidubaldo, non si può certo dire altrettanto di un purcelebrato carrefour culturale quale la corte isabelliana, la cui frequentazione, menoche sporadica, è ben lungi dal rappresentare per lo scrittore un’esperienza di arric-chimento intellettuale: oltre alle due brevissime gite già considerate, effettuate a fineGiugno del 1505 e nella settimana santa del 1506, si può ipotizzare infatti soltantouna sua permanenza presso i Gonzaga di una quindicina di giorni nel Novem-bre-Dicembre 1509 (cfr. p. sg. e nota 78). Dopodiché bisogna attendere fino al Giu-gno-Luglio del 1519 per ritrovare – stavolta per quasi un mese – il Bembo nella cittàlombarda, non tuttavia sponte sua ma per espresso incarico leoniano, e della tardaprimavera 1537 è la sua ultima, meno che settimanale, dimora mantovana (cfr infrae note 80 e 81).
(74) Cfr. W. BRAGHIROLLI, Carteggio d’Isabella d’Este Gonzaga intorno ad un qua-dro di Giambellino, in «Archivio Veneto», XIII, II, 1877, pp. 370-383.
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 240
poco – e tutt’altro che disinteressatamente – con l’interlocutriceestense. Né sarà un caso che i contatti epistolari con Mantova ven-gano riallacciati proprio a poca distanza dalla scomparsa di Guidu-baldo: assurto cioè al potere, sotto la tutela della zia Elisabetta, quelGiovanni Maria Della Rovere destinato a coniugarsi di lì a un anno(ma già da tre ufficialmente fidanzato) con la primogenita dei Gon-zaga (75). Si tratta ancora di una missiva di argomento artistico (nesono oggetto un «cameo» e un «vasetto» istoriato, donati dal neo-signore alla futura suocera grazie alla mediazione dello scultore GianCristoforo Romano) (76), ma è l’ultima del genere (77), dopodiché– nonostante i due personaggi avessero forse occasione di rein-contrarsi nella reggia mantovana sullo scorcio del 1509 in occasionedella traductio di Leonora sposa – (78) bisogna scorrere la corri-spondenza dello scrittore fino al 25 Ottobre 1513 per rinvenireun’ulteriore comunicazione (del resto assai poco significante) all’in-dirizzo della dama (79), e con la lettera (del pari trascurabile) del
VARIETÀ 241
(75) Sulla morte del duca urbinate e sulle modalità della successione del nipotesi sofferma la già ricordata lettera al Querini del 10 Giugno 1508 (cfr. II, 280, pp.19-23).
(76) Il fine effettivo del messaggio è, ancora una volta, squisitamente utilitaristi-co: ottenere dalla proprietaria un calco in gesso della pietra intagliata («perché iodisidero grandemente poter mostrare lo impronto del cameo ad un mio carissimoamico, che me ne ha richiesto credendo che ’l ditto cameo fusse ancora qui» [II,281, p. 23 – 25 Novembre 1508]).
(77) Indirette testimonianze del ricordo che il patrizio veneziano serbava di Isa-bella nel periodo trascorso presso i Montefeltro risultano essere esclusivamente unframmento della missiva inviata alla marchesana da Emilia Pio nel Novembre 1509(cfr. CIAN, Pietro Bembo cit., pp. 114-115) e i saluti contenuti nella già ricordata let-tera doviziana alla signora del successivo 26 Dicembre (cfr. DOVIZI DA BIBBIENA, Epi-stolario cit., I, p. 338).
(78) L’unica notizia di questo viaggio al séguito di Elisabetta di Urbino quale com-ponente del corteo nuziale è in un biglietto al segretario ducale Federico de Biliis del15 Novembre di quell’anno e non trova conferma in altre fonti: «Luni dì partiremoper Mantoa» (II, 291, p. 33). Un’ammirata descrizione della giovane Gonzaga all’in-domani dell’insediamento a palazzo, condita da qualche piccante particolare sulla suaprima notte di matrimonio, si legge in una responsiva del I Gennaio 1510 all’arcive-scovo Fregoso (II, 294, p. 37) su cui avrò occasione di soffermarmi più avanti.
(79) Vi si tratta di «una grazia ottenuta per el R.do Mons.or della Guardia, Me-dico e Tesorero dello Ill.mo Signor Federico [...]», dietro richiesta inoltrata al Bem-bo stesso, nella sua qualità di abbreviatore pontificio, da Francesco Gonzaga nel pre-cedente Settembre, consistente in una licenza per malattia a favore del prelato man-tovano; l’annuncio è comunque accompagnato da un’abbastanza calorosa professio-ne di servitù: «[...] quantunque ella abbia molti in questa corte, e principalmenteMons.or R.mo el Cardinale di Santa Maria in Portico [il Bibbiena] sopra modo de-sideroso e attissimo a far per lei, massimamente in cose grandi e di momento, non-dimeno nelle cose non così importanti alle quali io sia bastevole, me troverà semprenon manco desideroso né manco pronto che sua S. R.ma e ciascun altro» (II, 335,p. 79). Nella stessa data lo scrivente inviò pure al delfino Federico un più stringatomessaggio – l’unico a tale destinatario – di identico contenuto (cfr. II, 334, p. 79; siricorderà per inciso che al marchesino, quando adolescente si trovava a Roma ostag-
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 241
10 Gennaio 1524 – intercorsa un’ulteriore frequentazione romananegli anni 1514-’15 e un abboccamento ufficiale a Mantova nell’e-state del 1519 – (80) l’ormai episodico commercio epistolare vieneinterrotto definitivamente (81). Ragione per cui sembra oggettiva-
VARIETÀ242
gio di Giulio II, il letterato veneziano aveva dedicato un componimento poetico, eche, quando nel 1534 pendeva presso Carlo V la causa del Monferrato, il giovaneduca si rivolse tramite l’ambasciatore Agnello all’allora storico della Serenissima perottenerne documenti archivistici atti a suffragare le sue rivendicazioni). Durante ilpapato di Leone X in effetti, abbracciata i Gonzaga una linea politica filomedicea infunzione scopertamente antimarciana, numerosi sono i brevi loro destinati di manodel segretario pontificio Pietro Bembo, che i marchesi ritenevano perciò convenien-te omaggiare ora di «uno bossoletto» di unguento profumato per capelli, ora di «unopiato de carpioni» dei laghi mantovani, ora di una pregiata «coltra di piumino» dicigno (per le circostanze relative a tali donativi cfr. ancora CIAN, Pietro Bembo cit.,pp. 118-123, e LUZIO-RENIER, La coltura e le relazioni letterarie cit., 4, p. 206).
(80) Tra l’inverno del 1514 e la primavera seguente Isabella effettuò un soggior-no "politico" a Roma e a Napoli, trattenendosi a lungo nell’urbe, splendidamentequanto interessatamente ospitata da Leone X e circondata da intellettuali della rino-manza di Bembo, di Sadoleto, di Angelo Colocci, del Dovizi (cfr. A. LUZIO-R. RENIER,Contributo alla storia del malfrancese ne’ costumi e nella letteratura italiana del secoloXVI, in questo «Giornale», V, 1885, pp. 408-432, in particolare p. 410). Feste e ceri-monie la vedevano sempre ammiratissima in prima fila, com’è lo stesso segretario pa-pale a lapidariamente testimoniare in un’epistola del 22 Febbraio 1515 a Giuliano de’Medici: «Qui abbiamo avuto un bellissimo Carnassale, mercé della Sig.ra Marchesa-na» (II, 362, pp. 108-109). Nel Giugno del 1519, invece, fu il Bembo a portarsi aMantova, inviatovi in missione diplomatica dal pontefice, come attestano il messaggiorecapitato all’Equicola il 22 di quel mese per informarlo del suo arrivo in città la serastessa; la lettera del seguente 20 Luglio al Bibbiena, annunciante l’espletamento del-l’incarico (cfr. II, 390, p. 132, e 391, p. 133), e un dispaccio dell’agente gonzaghescoDonato de’ Preti del 6 Luglio, riferente di una visita allo scrittore nel suo palazzomarciano (cfr. Archivio Gonzaga, Serie E. XLV [Affari in Venezia]. 6). Il CIAN, Pie-tro Bembo cit., pp. 124-125, riteneva che lo scopo del viaggio fosse quello di reinte-grare nel favore e nella carica di cui godevano in precedenza presso Francesco II EneaFurlano, genero del signore, e un non meglio precisato cavalier Cavriana: in realtà sitratta dello stesso personaggio, Enea Furlano Gonzaga, segretario marchionale edeques maior (donde il soprannome antonomastico di Cavaliere), che soltanto l’annosuccessivo, a séguito di una nuova permanenza mantovana dell’ambasciatore papaleFabrizio Pellegrini, riuscì a ottenere la grazia impetrata.
(81) L’estrema missiva, spedita da Padova (come pure il sincrono biglietto per il«Cavaliere e poeta unico» Mario Equicola [cfr. II, 468, pp. 203-204: 203]), costitui-sce una commendatizia per il protetto frate Michele da Napoli, chiamato a predica-re a Mantova nella seguente Quaresima. La raccomandazione è avanzata con la con-sueta scaltra cerimoniosità: «Esso ha predicato questo Advento in Venezia, dove haavuta bellissima audienza. Stimo sia per avere così costà, quando non v’avesse altroche V. Ec.a» (II, 469, p. 204). Posteriormente alla data del documento, il Bemboebbe modo di rivedere Isabella a Roma in occasione del Giubileo del 1525 («[...] laS.ra Marchesana, molto onorata e bene accompagnata, va con le sue carrette or quaor là: il che fa non men bello che nuovo apparimento» informava da Pesaro Elisa-betta di Urbino il 10 Aprile [cfr. II, 523, p. 243] e tramite una lettera da Padova del4 Dicembre 1526 a Camilla Gonzaga porgeva alla principessa i suoi rispetti [cfr. II,722, p. 390]); a Bologna nell’inverno del 1529 (cfr. le epistole inviate a Vettore So-ranzo il 7 e il 9 Novembre di quell’anno [III, 1023, p. 84, e 1024, p. 85]); a Vene-zia nel 1532; ancora a Mantova – dove lo scrittore si era recato, sotto pretesto di vo-
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 242
mente impossibile condividere l’opinione del Cian, secondo il qualeil carteggio tra lo scrittore e Isabella d’Este avrebbe conosciuto duedistinti periodi: a «spiccato carattere artistico» il primo «e più inte-ressante»; concernente «la politica, gli affari», come anche «argomenti futili, volgari, che dimostrano la preoccupazione costan-te dei bisogni e delle piccole comodità della vita», il secon-do (82). Riesce per contro evidente che uno solo e sostanzialmentegiovanile è il tempo della corrispondenza in questione: con il pas-saggio del Bembo, risoluto ormai a progredire nell’intrapresa carrieraecclesiastica, a Roma all’inizio del 1512 e con il parallelo infittirsi del-le cure statuali dell’incupita marchesana quel rapporto tutto di su-perficie venne infatti a perdere ogni residuo motivo di essere.
2. Se, insomma, non è molto più di una commissione artisticaquella che tiene per qualche tempo il letterato veneziano in contat-to epistolare con la domina di Mantova, altrettanto non si può affer-mare del suo carteggio con Leonora Gonzaga, che, pur non costi-tuendo di certo un dossier ponderoso né affrontando tematiche dipeculiare rilievo, si dispiega tuttavia in modi e toni diversamentespontanei e affabili (si è visto, d’altronde, essere stato lo stesso Bem-bo a volerne commessi alcuni pezzi alle edizioni a stampa). Baste-rebbe la già ricordata descrizione della sposa sedicenne consegnataalla lettera latina, debitamente inclusa nel IV libro delle Familiares,del I Gennaio 1510 all’arcivescovo di Salerno Federico Fregoso – amico dei più fraterni tra quanti lo scrittore ebbe a contarne nelcorso della sua lunga esistenza, nonché personaggio interlocutorenelle Prose – per comprendere come colei che presso i contempo-ranei passava antonomasticamente per la «duchessa bella» avessecolpito dritto nel cuore il recente teoreta del neoplatonismo amo-roso, appassionato assertore della funzione spirituale esercitata dal-la grazia muliebre:
Leonoram, novam nuptam Urbini Ducem, salutavi tuis verbis [...]. Credas hocmihi velim: venustiorem, festiviorem, suaviorem puellam nunquam sum colloquutus,
VARIETÀ 243
ler ammirare le recenti costruzioni di Giulio Romano, per collocare il figlio Torqua-to – nel Giugno del 1537 (cfr. le lettere a Pietro Panfilio del 20 e alla Gambara del26 Maggio; a Ludovico Beccadelli e al Gualteruzzi del 6 Luglio, e al Panfilio del 15Luglio di quell’anno [IV, 1841, p. 34; 1844, p. 37; 1858, p. 50; 1859, p. 51; 1863, p.54]), e infine forse di nuovo a Venezia nell’autunno del 1538, durante l’ultima gitadella signora in quella città. Da notare che nella missiva al siniscalco roveresco Pan-filio del 20 Maggio 1537 è esternato il timore di non riuscire a incontrare la Gon-zaga con parole improntate a un sincero riguardo: «[...] scrivetemi [...] quanto [l’e-dizione ha quando] sarete per dimorare in Mantova, e anco se la Sign. Marchesanavi è; ché io intesi dalla Signora Duchessa [Leonora] che S. Sig. voleva andar non sodove. E se ella vi sarà fra dieci o dodici dì ancora. Ché mi dorrebbe troppo, venendoa Mantova, non poter fare a S. Sig. riverenza e non vederla».
(82) Cfr. CIAN, Pietro Bembo cit., rispettivamente pp. 100, 116 e 128.
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 243
quae cum ingenio est amabili, tum mehercule prudentiae notam omnibus in rebusprae se fert, in ea aetatula vix credendam. Quid? quaeris. Eius omnia mirabiliter medelectant, neque me solum, sed plane omnes, et praecipue, quod maxime optaba-mus, eius virum [...]. Ipse etiam se Dux beatiorem in dies fortunatioremque nuncu-pat, qui quidem hanc puellam coniugem habeat (83).
Al paragone di un apprezzamento così incondizionatamente plena-rio, il miglior elogio della marchesana (la quale – sia detto per in-ciso – dimostrò alla primogenita per tutta la vita un’indifferenza va-riamente interpretata), affidato a una missiva in latino per ErcoleGonzaga del 23 Agosto 1537 destinata a propria volta a confluirenell’ultimo degli Epistularum familiarium libri, pecca quantomeno dilaconicità: «Matrem tuam, foeminam cum fortunatissimam, tumetiam prudentissimam <foeminarum omnium>, salvere velim iubeasmeis verbis. Valde illam in oculis habeo» (84).
La prima lettera inoltrata dal Bembo a «Madonna Leonora» dataal 12 Dicembre del 1525, ma non mancano negli anni e nei mesiprecedenti cordiali menzioni della giovane principessa nella posta didestinazione urbinate (85). La responsiva in oggetto non è sicura-mente un documento apprezzabile per originalità di contenuto, con-sacrata com’è ai rallegramenti alla puerpera per la nascita di unabambina; ma in essa, lungi dalle coatte esternazioni di giubilo cheaffliggono di solito tale genere di gratulatorie, circola già quel calo-re di intima confidenza e di paterna sollecitudine che si è detto con-traddistinguere questa corrispondenza (86), la cui ulteriore parte si
VARIETÀ244
(83) II, 294, p. 37. Non troppo dissimile il panegirico della «duchessa nova» rac-comandato dal Castiglione alle pagine del IV libro del Cortegiano, ove, con eloquenteesubero, è asserito che «se mai furono in un corpo solo congiunti sapere, grazia, bel-lezza, ingegno, manere accorte, umanità ed ogni altro gentil costume, in questa tan-to sono uniti che ne risulta una catena che ogni suo movimento di tutte queste con-dizioni insieme compone ed adorna» (cito da Opere di Baldassare Castiglione, Gio-vanni della Casa, Benvenuto Cellini, a cura di C. Cordié, Milano-Napoli, Ricciardi,1960, p. 289).
(84) IV, 1873, p. 61 (indicativo che le parole da me aggiunte tra parentesi an-golari si leggano nell’edizione Scotto, ma non nell’autografo del documento conser-vato all’Ambrosiana di Milano tra le Lettere del Ramusio). Per tale testo cfr. infra enota 106.
(85) Oltre che in quella al Fregoso sopracitata, amorevoli ricordi della Gonzagafigurano nelle epistole a Francesco Maria Della Rovere del 4 Dicembre 1513 (cfr. II,336, p. 80); al cardinal Bibbiena del I Gennaio 1515 (cfr. II, 356, pp. 100-101); alladuchessa Elisabetta del 25 Aprile e del 2 Ottobre 1522 (cfr. II, 426, p. 169, e 429,p. 173); a Benedetto Mondolfo del 6 Giugno 1523 (cfr. II, 440, p. 182); al vescovodi Senigallia Marco Vigerio del 29 Agosto 1525 (cfr. II, 589, p. 292); ad AgostinoBeazzano del 4 Novembre 1525 (cfr. II, 617, p. 313).
(86) Cfr. le seguenti affermazioni: «Io non arei potuto a questo tempo intendercosa che più grata mi fosse, di questa che voi per le vostre lettere mi fate intendere[...]; del qual parto, per ciò che voi ne stavate in affannoso pensiero, conveniva chei servitori vostri ne temessero altresì»; «E tanto più ancora maggiormente ne la rin-grazio [scil.: «la divina maestà»], quanto io non dubito che voi vi risanerete di tutta
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 244
sdipana tuttavia solo molto più tardi, nell’arco del quinquennio1541-1546, quando il tempo ha ormai convertito la jeune fille enfleur dell’aula urbinate in una bolsa vedova al giro di boa del mez-zo secolo: una duchessa madre acciaccata e paturniosa che semprepiù spesso cede il luogo, negli impegni ufficiali e nelle pubblichecerimonie, all’intraprendente nuora Vittoria Farnese (87). Anchenelle restanti sette lettere – eccettuate, forse, quella relativa alla con-fezione di un epitaffio per Francesco Maria Della Rovere, che rial-laccia dopo un ventennio le fila del dialogo cartaceo con la signora(88), o quella in cui è esternato l’apprezzamento per l’edificio pe-
VARIETÀ 245
la indisposizion passata vostra, e tornerete più sana e più bella che giamai. Basciovila mano. Di quella Padova che è rimasa sola e maninconosa per la partita vostra»(II, 628, p. 322). Da avvertire che è questa l’unica epistola tra quelle di competen-za gonzaghesca ad avere conosciuto l’onore di una duplice edizione: nel 1544 pres-so il Gherardo e nel 1552 nel IV volume della Scotto.
(87) Anteriormente al 22 Maggio 1541, data della seconda lettera al suo indiriz-zo, attestati di affetto nei confronti di Leonora occorrono fittissimi nell’epistolariobembiano: cfr., nel III volume, 1037, p. 95 (al Fregoso, del 22 Dicembre 1529); 1039,p. 96 (a Innocenzo Sinibaldi, del 7 Gennaio 1530); 1117, pp. 156-157 (al Panfilio,del 27 Giugno 1530); 1236, p. 249 (allo stesso, dell’8 Giugno 1531); 1252, p. 260(allo stesso, del 6 Luglio 1531); 1342, p. 322 (allo stesso, del 18 Marzo 1532); 1366,p. 340 (al governatore di Bologna Francesco Guicciardini, del 23 Maggio 1532);1372, p. 343 (al Panfilio, del 2 Giugno 1532); 1414, p. 377 (allo stesso, del 17 Set-tembre 1532); 1445, p. 403 (allo stesso, del 3 Gennaio 1533); 1506, p. 451 (a Gio-van Iacopo Leonardi, del 28 Luglio 1533); 1512, p. 456 (al duca di Urbino, del 22Agosto 1533); 1538, p. 475 (al Fregoso, del 30 Dicembre 1533); 1601, p. 521 (allostesso, del 26 Agosto 1534); 1624, p. 538 (allo stesso, del 31 Ottobre 1534); 1673,p. 581 (al Panfilio, del 29 Marzo 1535); e, nel IV volume, 1841, p. 34 (allo stesso,del 20 Maggio 1537); 1863, pp. 54-55 (allo stesso, del 15 Luglio 1537); 1871, p. 60(allo stesso, del 10 Agosto 1537); 1880, pp. 68-69 (allo stesso, del 10 Settembre 1537);1891, p. 82 (a Costanza Fregoso, del 22 Ottobre 1537); 1896, p. 85 (al Panfilio, del30 Ottobre 1537); 1903, p. 91 (allo stesso, del 2 Dicembre 1537); 2056, p. 208 (allostesso, dell’11 Aprile 1539); 2072, p. 218 (al Fregoso, del 29 Aprile 1539); 2133, p.268 (allo stesso, del 26 Ottobre 1539); 2200, p. 316 (a Ercole Gonzaga, del 10 Lu-glio 1540).
(88) Il duca governò Urbino dall’11 Aprile 1508 al 31 Maggio 1516, quando, aséguito della spogliazione perpetrata da papa Medici, che assegnò lo stato a suo ni-pote Giuliano, si vide costretto all’esilio. Scomparso sul finire del 1521 Leone X,poté recuperare la signoria e reggerla fino alla morte, avvenuta a quarantotto anni il20 Ottobre 1538. Le "istruzioni per l’uso" contenute nella missiva allegata al testofunebre commissionato epistolarmente dalla vedova al Bembo forniscono particolaricuriosi sulla sua concezione di tale genere di componimenti, nonché qualche inte-ressante notizia sulla biografia del principe: «El quale [epitafio], se è venuto alquantopiù lunghetto di quell’altro, che ella mi mandò con le sue lettere per lo Gallo, dicoche si potria levarli qualche parola. Ma se li levaria l’ornamento, che é molto neces-sario a dover piacere a gli uomini di giudicio. Suole esser molto usato in tali scrit-ture il porvi gli anni che visse il defunto, del quale si parla. V.S. li farà porre in quel-lo spazio che io gli ho lasciato, che è per gli anni e per i mesi e per li giorni. Mons.rR.mo Fregoso [...] mi dice che ’l S.r Duca non perdé lo Stato se non due volte, ein quello che mi portò il Gallo v’è tre volte. Facciasi in ciò secondo la verità. Saràbene porvi il Milesimo al modo nostro, e dire l’anno che S. Ec.za morì, e non que-sto nel quale V.S. vi fa l’epitafio. [...] V. Ec.za vuol porre questo epitafio col
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 245
sarese dell’Imperiale eretto da Bartolomeo Genga (89), entrambenon a caso consegnate dall’estensore al volume “femminile” del suoepistolario – non sono gli argomenti a destare speciale interesse,trattandovisi delle consuete raccomandazioni reciproche in favore diterzi, di progetti nuziali per la rispettiva prole, di una gita a Vene-zia dell’indisposta madonna e della diocesi di Gubbio, alla cui gui-da l’indigente cardinale sottentrò nel 1543 al defunto Fregoso (90).A colpire profondamente – considerata l’algida tempra del Bemboepistolografo, cuore secco perfino nella corrispondenza amorosa digioventù – è la vicinanza di sentire, l’etimologica compassione tra ilvecchio monsignore di tutto sommato ortodossa cattolicità e l’um-bratile principessa precocemente segnata dalla malattia e dal dolo-re, che nell’adesione a quel movimento riformista di cui la comuneamica Vittoria Colonna era un apostolo tra i più fervorosi cercavaqualche sollievo alle irrequietudini del suo spirito. Sommamente in-dicativa al proposito è la lunga commossa responsiva bembiana perla morte del Fregoso, antico compagno di entrambi, dove gli affet-tuosi sensi nutriti – e in esemplare corresponsione, come palesa lostesso documento – per l’interlocutrice attingono accenti di premu-
VARIETÀ246
corpo, in Santa Chiara, dove esso non sarà mai né letto né veduto da altri che daquelle monache; e ciò volete fare per questo: che il S.re così ordinò nella morte sua.Io crederei che fosse ottimamente fatto che V. Ec. lo ponesse in più celebre luogo,dove il sepolcro potesse esser veduto e letto da le persone. [...] Certo che io lodereiche V.S. lo ponesse in San Bernardino, dove sono i suoi maggiori; ché ponendolo inSanta Chiara sarà veramente sotterrato il nome col corpo insieme» (IV, 2248, p. 354[22 Maggio 1541]).
(89) «Venni poi a Pesaro [...]. E vidi l’Imperiale di V. Ec.za con infinito piacermio, sì perché io disiderava molto di vederlo, e sì perché è fabrica, per quello cheella è, meglio intesa e meglio condotta con la vera scienza dell’arte, e con più modiantichi e invenzioni belle e leggiadre che altra che a me paia aver veduta fatta mo-dernamente. Di che con V.S. mi rallegro grandemente. Certo il mio Compare Gen-ga è un grande e vero architetto, e ha superato d’assai ogni espettazion mia» (IV,2400, p. 475 [19 Dicembre 1543]).
(90) Di un non meglio specificato patrocinio della duchessa in favore del poetaveneziano Bernardo Cappello si discorre nella missiva del 5 Settembre 1541, ai ma-neggi per l’ottenimento di una prebenda per il funzionario Panfilio è consacrata l’e-pistola del 6 Marzo 1542 e una generica intercessione per Innocenzo Sinibaldi con-tiene la responsiva del 9 Maggio 1546 (cfr. IV, 2275, p. 375; 2313, pp. 406-407, e2536, p. 568 [di nessuno dei tre testi l’autore autorizzò la pubblicazione]). Sulsoddisfacente accasamento della sua terzogenita Elena il Bembo si diffonde nella let-tera del 19 Dicembre 1543 e il collocamento di due figlie di Leonora viene auspi-cato in un biglietto del 9 Maggio 1546 (cfr. IV, 2400, p. 475, e 2536, p. 568), men-tre di un soggiorno della signora in laguna a scopi terapeutici è questione in una bre-ve epistola del 10 Giugno 1542 (cfr. IV, 2330, p. 418). Circa il non del tutto pacifi-co insediamento del settantatreenne prelato nel vescovado eugubino e nella residen-za estiva dell’abbazia camaldolese dell’Avellana offrono informazioni le responsive del2 Agosto 1541 e del 19 Dicembre 1543 (cfr. IV, 2259, p. 364; 2400, p. 475, e vedi,supra, nota 39). Tutti questi documenti, tranne il conciso messaggio del 1546, sonoconfluiti nel IV volume della Scotto.
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 246
rosa tenerezza che non trovano troppi confronti nell’arco tuttodell’epistolario:
Di me non dirò molto, sì perché già ne scrissi a questi dì a V. Ec.za alcuni po-chi versi, e sì ancora perché, sì come io conosco dal mio il grave dolor di lei, chésapea l’amor e la osservanza che tra l’una e l’altro di voi era, così sono certo che V.S.conosce il mio cordoglio per la stata già tanti anni verso me carità di quel Signore,e la mia verso lui osservanza e affezione ardentissima, non mai offese da una solaparola né dall’uno né dall’altro di noi, da la prima e tenera giovanezza sua e virilitàmia insino a questo giorno. Sommi oltre a ciò doluto ché veggo V.S., questi anni lun-gamente attristata dalla morte del Sig.or suo di bona memoria, e ora da questa delCar.le, augurarsi d’avere a viver poco. Il che non è già officio della bontà e pruden-za che ho sempre conosciuta in lei, e che predicava il Car.l medesimo. Perciò chetanto più dee V.S. pensar di vivere, quanto sète più rimasa sola a procurare il benee commodo delle vostre tenere piante, che a canto vi sono. Oltra che, vivendo, po-trete giovare più lungamente alle anime di questi due Signori, pregando e bene ope-rando per loro, e sarete utile e commoda a tante altre parti che dal vostro santo ani-mo attendono ogni lor bene e prosperità e vita. Dunque V.S. non parli più così, anzi,si conforti col Re del cielo, che così ha permesso che sia, e s’accordi con la sua vo-lontà e giudicio, che non può errare. Quanto alla parte dove ella dice che io le sonorimaso in luogo di questo buon Signore per patrone e per padre e per fratello, larendo sicura che nessun dì verrà mai nel qual io non disideri potere adoperarmi adogni volere e satisfazione di V. Ec.za, né cedo in questa parte a Mons.or Reveren-diss. vostro fratello. V.S. mi tenga per veramente e propriamente e debitissimamentesuo, e per tale mi spenda, e di me si vaglia senza risparmio alcuno, che ne le dò diciò e dono e consegno piena libertà, la qual libertà e facultà, mentre io averò vita,non le sarà da potere alcuno della fortuna rivocata giamai. A l’incontro pregherò oralei, che attenda alla sua sanità e a vivere, e non solo a vivere, ma ancora a vivere piùlieta che ella può: e a questo modo si vendicherà della fortuna, che tanto s’è ado-perata per attristarla (91).
b) Il carteggio con Ercole Gonzaga
La definitiva conclusione della corrispondenza con Isabella coin-cide approssimativamente con l’inizio di quella con il secondo deifigli maschi della marchesana: è infatti del 17 Agosto 1525 la primamissiva, che il sonoro latino destinerà al corpus ciceroniano delle Fa-
VARIETÀ 247
(91) IV, 2259, pp. 363-364: è la già ricordata lettera del 2 Agosto 1541. «Percondolersi a nome suo della repentina e importuna morte di Mons.r ReverendissimoFregoso, e per le altre cose appartenenti al Vescovato d’Ogobbio» il cardinale ave-va mandato da Roma, ove si trovava, a Pesaro il suo segretario Marcantonio Flami-nio, secondo è asserito nella missiva al Panfilio della stessa data, in cui il fido servi-tore roveresco viene significativamente esortato «a confortar la Ill.ma Signora Du-chessa, e a tenerla più allegra che può» (IV, 2260, pp. 364-365). Anche nella conso-latoria per la scomparsa del sodale che Bembo indirizzava già il 25 Luglio, a pochigiorni dall’evento, a Costanza Landi, sorella dell’arcivescovo e sua «comare» (IV,2258, pp. 362-363), si evidenzia l’immenso «dolore sentito» in quel frangente dalla«Ill.ma Sig.ra Duchessa», di cui la destinataria era intima amica, come prova l’allu-sione alla solitudine di Leonora dopo la «partita» della Fregoso da Urbino in unacomunicazione al Panfilio dell’11 Settembre 1546, l’ultima in cui corra memoria del-la principessa («la qual io porto sempre nel mio animo con molta osservanza» [IV,2552, p. 579]).
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 247
miliares, al ventenne Ercole (92), il cui precoce e tutt’altro cheordinario ingegno il Bembo aveva verosimilmente avuto modo di ap-prezzare durante il soggiorno a Mantova in qualità di emissariopontificio di sei anni prima. Sebbene non sussistano testimonianzecirca un’eventuale frequentazione intercorsa tra i due nel frattempo,la stima nutrita nei confronti del cadetto gonzaghesco dallo scritto-re quando si decise ad avviare con lui un dialogo epistolare eratutt’altro che affettata o fiduciaria, come rivela il seguente stralciodi una lettera del 18 Luglio di quell’anno al professore bologneseRomolo Amaseo, che era stato invitato da Ercole a trascorrere qual-che tempo in sua compagnia:
[...] tibi, ut debeo, gratulor de ea, quam quidem iam video cum iuvene nobilis-simo, eodemque liberalissimo, omnibusque bonis artibus dedito, Hercule Gonzaga,tibi esse benivolentiam constitutam. Laetorque invitatum ab eo esse te, ut apud seseesses (93).
Proprio l’ottimo concetto formatosi del giovane signore (in cui re-putava confluissero quelle ideali doti principesche di dottrina, ma-gnanimità e liberalità evidentemente difettanti al regnante Federi-co) (94) spinse il letterato veneziano a prendere la penna in manoper presentargli Francesco Bellini, un adolescente suo concittadinocon aspirazioni artistiche di cui auspicava che il novello corrispon-dente si adergesse a protettore. Attorno alla figura di questo perso-naggio oscuro, amato dal Bembo di un amore davvero singolare,ruota il carteggio – interamente raccomandato al VI degli Epistula-rum familiarium libri – fra i due uomini di chiesa nel corso di unbiennio, avvertendoci, da un lato, circa il reale conto in cui il re-cente autore delle Prose teneva il milieu intellettuale di orbita gon-zaghesca (perlomeno quello ristretto e seletto afferente al dotto pre-sule) e offrendoci, dall’altro, un’ennesima cristallina prova di quel
VARIETÀ248
(92) Segnala il Travi (II, p. 288 nota) di avere accolto «la data del ms. Marcia-no [«XVI Kal. Septembres MDXXV»] perché la lettera fa riferimento ad una esta-te quasi interamente trascorsa in campagna», mentre sia la copia per la stampa con-servata all’Ambrosiana che l’edizione Scotto recano «Kalen. Aprilis MDXXVI», am-mettendo la possibilità «che sia stato lo stesso Bembo ad aver corretto la data».
(93) II, 530, pp. 247-248 (il testo termina con queste parole: «Tu meis verbisHerculi tuo, quem ego unum omnium facio plurimi, dicito multam salutem»). Nel-l’Indice cronologico delle lettere, II, p. 562, Travi assegna l’epistola al 18 Maggio, mala datazione, univoca nei testimoni («Ad XV Kal. Sextilis MDXXV» [p. 248]), nonlascia stavolta adito a incertezze; forse l’equivoco è stato generato dall’arcaizzante im-piego del nome Sextilis, designante sì il sesto mese dell’anno, ma quello dell’anticoanno romano (notoriamente comprendente solo dieci mesi a partire da Martius), poiridenominato Augustus in onore dell’imperatore Ottaviano.
(94) Del ventilato spostamento all’ateneo padovano per seguirvi i corsi di Gio-vanni Spagnoli da parte di Ercole Gonzaga, già da un triennio brillante studente diarti a Bologna sotto la guida del Pomponazzi («il Peretto»), Bembo informa com-piaciuto Giovan Battista Ramusio il 17 Agosto 1525 (cfr. II, 580, p. 287).
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 248
train de vie gaudente e sregolato talmente endemico alla corte man-tovana che neppure il più contegnoso e posato dei suoi esponentiriusciva a restarne del tutto immune. Infatti, all’ossequiosissima let-tera di presentazione del portentoso pupillo, fresco estensore perl’appunto di un epicedio in distici elegiaci per il precettore di Er-cole Pietro Mantovano («Qui cum mihi valde probarentur, statui eos[versus] ad te mittere, cum ut pueri [...] tui quidem iam sponte suastudiosissimi atque amantissimi clarum ingenii lumen, et ad poeticesstudia mirificum [...], §nyousiasmÒn agnosceres tum ut videres quidde te optima iam ingenia iudicent») (95), segue nove mesi appres-so la prevedibile richiesta, in nome «mutuae [...] nostrae benivo-lentiae», di accogliere il garzone nell’entourage gonzaghesco, affin-ché possa serenamente attendere ai diletti studî:
[Franciscus Belinus] accensus virtutum tuarum splendore, ardet cupiditate in-credibili ut se in familiaritatem tuam suscipias, apud teque velis esse: ut quod illi,propter rei familiaris angustias facere diutius non licet, te auctore tuisque in laribus,optimarum artium studia, quarum est ille quidem unus omnium prope cupidissimus,quaeque domi tuae praecipue vigent, tibi astans teque intuens prosequi, atque in iis,quod te libente fiat, proficere ac plane progredi possit. Se vero id, quod optat, meacommendatione consequuturum magnopere confidit (96).
Già nel seguente Novembre, come fa fede una breve ma calorosis-sima commendatizia dell’11 di quel mese, il protetto trova alloga-mento presso Ercole (97), ma l’utopica rêverie bembiana – forse no-
VARIETÀ 249
(95) La considerazione, senza dubbio sincera, nei riguardi del destinatario con-duce tuttavia progressivamente l’epistola sui binarî encomiastici proprî della più ro-rida oratoria curiale: «quo te ipse acrius etiam et vehementius incitares ad id ipsumquod facis, ut quam de te iam quidem apud omnes homines spem expectationem-que excitasti, eam sustinere ac tueri possis. Quod non eo dico, quo te id non dili-gentissime facturum existimem: quid enim mihi esse tua virtute, tuo in omnes bonasartes [l’edizione ha arteis] amore, vel ardore potius animi, certius ac exploratius po-test? Sed quoniam valde te amo, aut etiam quia ea ipsa, quae de te sibi alii polli-centur, mihi ipse plenius atque uberius spondeo: aveo etiam quam primum quam-que consumatissima cum a me ipso, tum ab omnibus maxime cognosci ac perspici»(II, 581, p. 288).
(96) II, 678, p. 359 (alla missiva, del 13 Maggio 1526, erano allegati «pauculiBelini versiculi»). Il prolisso documento si modula da qui in avanti sui toni di un’o-razione de magnanimitate principis a tratti irritante nel suo pur accorto registro pa-renetico; ma è da tenere presente che fin dall’autunno precedente, come attesta lagià citata lettera al concittadino Beazzano del 4 Novembre (cfr. II, 617, p. 313), Bem-bo era stato edotto da Leonora di Urbino in merito alle manovre relative alla pros-sima elevazione cardinalizia del di lei fratello, seguita infatti nel Settembre dell’annosuccessivo: ragione per cui, cattivarsi i favori del presule in tempi ancora non so-spetti poteva riuscire una mossa determinante nell’ambiziosa strategia di escalationecclesiastica del veneziano.
(97) Cfr. II, 717, pp. 387-388: «Nunc Belino ad te proficiscenti [...] has ad telitteras dedi, quibus tibi eum quasi de manu traderem, adolescentem et pudentem,et probum, et optimis artibus deditum, atque in primis tui amantissimum, eiusquerei cupidissimum, ut tibi studium et operam navare aliquam possit [...]. Ego cum
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 249
stalgica proiezione dell’antica esperienza urbinate – di un illumina-to mecenatismo potente a educare astri nascenti delle patrie letterenell’asettica serra degli studia humanitatis è destinata a infrangersidi lì a quattro mesi contro una realtà assai più prosaica: giochi d’az-zardo e passatempi triviali nella chiassosa reggia mantovana inter-vallano disinvoltamente le attività intellettuali, né l’austero neopor-porato ha facoltà o volontà di mutare un andazzo evidentemente in-veterato. È al segretario personale del Gonzaga, Agostino, che loscrittore inoltra, in un volgare stimato degno delle Lettere [...] aprencipi et signori et suoi famigliari amici, le sue costernate (ma sem-pre riguardosissime) lamentele, con il diplomatico pretesto di rite-nere il reverendo all’oscuro delle «particolari bisogne» della corte,ma in verità perfettamente conscio che la lettera finirà quanto pri-ma nelle sue mani e quindi di fatto chiamandolo a principale re-sponsabile dell’avviato traviamento del candido Francesco:
[...] ricercandolo io [scil.: il Bellini] della vita che egli ora tiene, e de’ suoi stu-di, sì come colui che disidero che egli non si fermi, che sarebbe peccato grandissi-mo, ma vada innanzi di dì in dì là dove lo chiama la sua stella che gli ha donatocosì chiaro ingegno, truovo che egli è in compagnia bene onorata del Maestro delSignore Ercole, ma di qualità che egli poco può attendere allo studio, per cagion degli essercizi che in quella camera si fanno: i quali, quantunque sieno per lo più dilettere, pure a lui tolgono la quiete e l’ozio particolar suo. Intendo, oltre a ciò, cheegli è stato posto a quelle tavole, tra le quali il suo mondo e levato animo più per-de, che il corpo non acquista (98).
Poco tempo dopo, nell’Aprile, a séguito di un colloquio padovanocon il suo beniamino, Bembo tenta un’ultima carta, rivolgendosidirettamente al cardinale, in sostenuto latino, e adottando una tat-tica ancora più raffinata, che, nel mentre squaderna con apparentenoncuranza le indegnità del trattamento riservato al giovinetto (l’in-felice non percepiva ancora il più misero stipendio né era autoriz-zato a sedere alla mensa del patrono), fa aggio sull’aspirazione deisovrani mecenati all’immortalità letteraria (99); nondimeno, consta-
VARIETÀ250
tibi eum ita commendo, ut et ipsius virtus postulat, et amor summus erga illum meus,et si non vereor, ne brevi tibi se ipse reddat suis moribus suaque virtute commen-datissimum; tum tibi illud promitto et spondeo: quibuscumque in rebus eius operauti voles, et ingenii tibi illum fructum et laboris et diligentiae, fidei quidem certe,pietatis observantiae cumulatissime praestaturum».
(98) II, 749, p. 413 (missiva del 7 Marzo 1527: emendo in camera il camea del-l’edizione). Da notare che l’oculata reprimenda si apre su un mirato panegirico "uma-nistico" del fresco monsignore: «Il Signor Ercole, Signor vostro e certo ancor mio,non solo perché è nato Signore, ma molto più perciò che egli si veste e fregia, da sestesso, di quegli ornamenti che io sopra l’altre cose tutte onoro, e che fanno gli uo-mini ben degni d’essere de gli altri uomini Signori [...]».
(99) Il testo, del 26 Aprile 1527, è infatti abilmente bilicato tra dissimulati rin-facci e avvedute esortazioni da un lato («Verum cum tu nihil illi opis adhuc quidemdari praeter escam et potum iusseris, credo quod id tibi in mentem non venit, nu-mulos nescio quot, domo quos attulit, cum audio defecisse. Quare feceris ex libera-
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 250
tando che nemmeno tale genere di lusinghe ha presa sul coriaceointerlocutore, si risolve a indirizzare il ragazzo – che non ha facoltàdi accogliere presso di sé, causa i «soverchi pesi» di cui è carico –verso altri lidi e già nel Luglio caldeggia la sua collocazione pressol’amico protonotario Giovan Girolamo de’ Rossi («non servite piùad ingrato Signore, e confortatevi che alla virtù non mancò mai, némancherà patrocinio») (100).
Certo, la delusione patita dallo scrittore nell’avvedersi che il cor-rispondente non ipostatizzava quell’ideale di principe rinascimentaleda lui con qualche sincerità vagheggiato e il disappunto vero-similmente provato dal Gonzaga per l’improvvisa dipartita di un po-tenziale futuro celebratore non poterono mancare di raffreddare irapporti tra i due ecclesiastici, che sospesero infatti ogni scambioepistolare per quattro anni abbondanti. La relazione, nondimeno,non dovette interrompersi del tutto, così come il riconoscimento perl’alta statura morale e la profonda cultura filosofica di Ercole nonvenne mai meno presso il Bembo, frattanto investito del lusinghie-ro incarico di storiografo della Serenissima. Proprio un favore biblio-grafico – la richiesta di un’orazione «nella causa di alcuni ebrei del-la sua diocese» composta dall’amico Iacopo Sadoleto, vescovo diCarpentras – costituisce l’occasione di un nuovo messaggio (il pri-mo in volgare) inviato al cardinale il 4 Settembre 1531 (101), e del
VARIETÀ 251
litate tua, si iuveni perpudenti, qui dura omnia perpeti potius quam verbum apud tefacere iis de rebus audebit, tantum stipis curare facies, quantum ei satis sit ad ne-cessitatem. Quod si eum etiam honore mensae tuae convictuique affeceris [...] etipsius animum fractum prope ac moerentem exhilarabis atque eriges, et mihi faciesgratissimum») e adulanti vaticinî di fama imperitura dall’altro («[...] spero fore, si eivita suppetet, neque deerunt quae homini dedito bonis artibus tua in domo deessevix possunt, clarum ut ille celebreque sibi nomen magnamque laudem brevi tempo-re apud omnes homines, nostris in studiis praesertimque poëtices, pariat; cuius qui-dem laudis pars atque portio est ad te, qui illum foveris, alueris, multo maxima mul-toque iustissima perventura» [II, 763, p. 424]).
(100) Missiva al Bellini del 28 Luglio 1527 (II, 795, p. 449). All’apprendista poe-ta toccherà comunque una sorte benigna, come documenta la corrispondenza bem-biana seriore: dopo una prima provvisoria sistemazione presso il monsignore pado-vano, a sua volta verseggiatore petrarcheggiante, evincibile da un messaggio allo stes-so de’ Rossi del 14 Giugno 1530 (III, 1108, pp. 150-151), e una successiva nel cor-teggio del cardinale Turnonio (cfr. le epistole al Bellini del 7 e al vescovo GiorgioSelva dell’8 Settembre 1534 [cfr. II, 1606, pp. 524-525, e 1609, p. 527]), Francescotroverà ricetto addirittura presso Paolo III, che lo impiegherà come «familiaris» (cfr.la lettera al pontefice, contenente le consuete esondanti lodi del prediletto, del 13Maggio 1539 [IV, 2076, pp. 220-221]).
(101) Nel biglietto era sollecitato l’invio, su autorizzazione dell’autore, di una co-pia dell’opera manoscritta (cfr. III, 1276, p. 279); ma il presule mantovano dovettecortesemente spedire l’originale, se il 29 Gennaio 1532 Bembo informava Carlo Gual-teruzzi di avere dimenticato di restituire il «libro» al monsignore e pregava il colla-boratore, qualora nel frattempo non avesse provveduto diversamente, di reca-pitarglielo assieme a una comunicazione a noi non pervenuta (cfr. III, 1329, p. 311).Ancora il 9 Agosto, tuttavia, il volume si trovava a Padova presso lo scrittore, che
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 251
progressivo riavvicinamento testimonia pure una lettera al Ramusiodel 14 Giugno 1532, da cui si inferisce che il mittente procacciavaper procurare «alli R.mi Salviati e Mantoa» una copia del Simplicio(verosimilmente l’insieme di quei commentarî a dialoghi aristoteliciin cui lo stagirita aveva operato un aggancio sincretico con la dot-trina platonica) (102). Tuttavia corrono ancora altri quattro anni, delcui assoluto silenzio è stavolta più arduo divinare le ragioni, primadi rinvenire nell’epistolario bembiano un nuovo incondizionato at-testato di stima – ancorché rifugiato nel poscritto di una responsi-va a una creatura del porporato, Ubaldino Bandinelli – nei confrontidel figlio di Isabella:
Herculi Cardinali Mantuano, quem ego virum propter eximiam eius virtutem, etin optimarum artium studiis singularem praestantiam colo, summopere iam pridematque amo, salutem dicito (103).
Si trattava evidentemente di spianare il terreno in vista di una pro-gettata gita primaverile a Mantova allo scopo di affidare l’inetto se-condogenito Torquato alle cure del dotto Benedetto Lampridio (edunque di fatto collocarlo nell’orbita gonzaghesca), che la malfermasalute costrinse il quasi settuagenario genitore a dilazionare fino alLuglio (104). Comunque, durante i «cinque o sei dì allegramente»trascorsi en touriste ad ammirare «li lochi belli» della città, i rap-porti con Ercole, ripetutamente visitato dall’illustre ospite, ebberomodo di progressivamente rinsaldarsi:
Feci [...] riverenza più d’una volta al Cardinale; il quale ho trovato un buono eun virtuosissimo Sig.re, in tanto che ha superato ogni espettazion mia. Come che ioaltre volte l’abbia e conosciuto e riverito grandemente (105);
VARIETÀ252
ne dava notizia in un’epistola latina allo stesso Sadoleto (cfr. III, 1406, p. 370), e ilsuccessivo 26 Ottobre si risolveva addirittura a non inviarlo né al Gonzaga né a Gio-van Francesco Pico né a divulgarlo altrimenti senza ordine espresso del vescovo diCarpentras, cui chiedeva, sempre in lingua latina, chiarimenti in proposito (cfr. III,1421, p. 385).
(102) III, 1379, p. 348. Dal canto suo, anche il Gonzaga si impegnava per il de-finitivo appianamento dei dissapori con Pietro Bembo. In una responsiva di que-st’ultimo al Gualteruzzi del 30 Dicembre 1532 si legge infatti: «Di Benevento veggoche avete più cura voi, alle cose mie, che io stesso, poscia che per la lettera, impe-trata per V.S. dal R.mo di Mantoa, si verrà nella valuta di quelli form<enti> tolti dalcommune alla mia precettoria» (III, 1443, p. 402).
(103) IV, 1830, p. 26 (lettera del 26 Febbraio 1537).(104) «Quel poco di male del piede, che io già avea quando voi vi partiste di
Padova, crebbe in maniera che io mai non ho potuto mettermi in via di venire aMantova come io avea deliberato [...]. Spero tuttavia fra 6 dì di poter montare a ca-vallo e venirmene», scriveva il Bembo al Panfilio il 20 Maggio 1537 (IV, p. 34), mafino agli ultimi di Giugno non fu in condizione di intraprendere il viaggio (cfr. la re-sponsiva al Beccadelli del 6 Luglio, in cui è fatto cenno all’avvenuta sistemazionemantovana del figlio [IV, 1858, p. 50]).
(105) Ibidem. Circostanze e impressioni puntualmente confermate al Gualteruz-
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 252
e i colti conversari intercorsi tra i due uomini (prima che di chiesa)di lettere diedero luogo a una, pur blanda, ripresa della frequenta-zione epistolare, ancora una volta nel segno di un’umanistica fedeltàall’osmosi culturale: già il 23 Agosto 1537, scortati da quella missi-va – l’ultima in latino – in precedenza ricordata per contenere unformale encomio della marchesana, giungevano infatti in dono almonsignore un esemplare a stampa del De Metauriensibus ducibus(meglio noto come De Guido Ubaldo Feretrio deque Elisabetha Gon-zagia Urbini ducibus liber), commosso ritratto dei suoi compianti ziipaterni, e copie delle edizioni degli altri tre Dialoghi latini (il DeAetna, il De Virgili Culice et Terentii fabulis e l’epistola De imita-tione) composti dal Bembo in tempi diversi e tutti pubblicati o ri-pubblicati nella strategica infornata del 1530 (106). Al dupliceomaggio, certo, non era estranea una finalità immediatamenteutilitaristica: come ebbe a puntualizzare il Dionisotti, «quale che fos-se il convincimento suo intimo, egli sapeva che una fama guadagnatacon opere volgari inevitabilmente portava ancora su di sé il sospet-to della leggerezza e della meschinità» (107), sospetto che eranecessario ingegnarsi con tutti i mezzi (ivi compreso rinfrescare lamemoria del corrispondente circa la propria qualità di prosatore, senon di poeta, perfettamente bilingue) a dissipare, avvivandosi viep-più la speranza, rinfocolata fin dall’elezione nell’Ottobre 1534 dipapa Farnese, di conseguire finalmente la porpora. E nonostante unnuovo motivo di disappunto spingesse lo scrittore, qualche mese piùtardi, a ritenersi «ingannatissimo da S. R.ma S.» (108), la prudenza,o l’opportunismo, gli consigliò di chiudere un occhio sulle presun-te inadempienze del potenziale sostenitore: infatti, in una lettera alGonzaga del 9 Marzo 1539 riguardante la vexata quaestio dell’ere-dità del comune amico Tebaldeo, sottratta d’arbitrio al servitore di
VARIETÀ 253
zi quello stesso giorno: «Anco ho visitato più d’una volta il Car.l [...], il quale m’èparuto e molto dolce e molto grave e molto buono» (IV, 1859, p. 51). Le due cita-zioni nel testo rimandano, rispettivamente, a una responsiva bembiana al Panfilio del15 Luglio 1537 (IV, 1863, p. 54) e a un dispaccio del precedente 5 Aprile di Bene-detto Agnello, corrispondente ordinario da Venezia del duca Federico, al castellanodi Mantova Gian Giacomo Calandra relativo a una prossima «venuta» in città di«Sua S.ria» (il documento è parzialmente riprodotto in CIAN, Pietro Bembo cit., p. 130).
(106) Cfr. IV, 1873, p. 61. Particolarmente curiose appaiono, nella medesima let-tera, le notizie relative a un modellino in scala del pons Iulianus edificato da Cesaresul Reno, posseduto dallo scrivente, di cui l’erudito destinatario voleva prendere vi-sione per confrontarlo con la descrizione fornitane dallo storico latino, ma che nongli venne recapitato perché troppo ingombrante.
(107) DIONISOTTI, Introduzione cit., p. 49.(108) L’affermazione è contenuta in una responsiva del 5 Gennaio 1538 all’ami-
co Ludovico Beccadelli (IV, 1910, p. 97) e si riferisce a un vescovado che il cardi-nale di Mantova non aveva concesso súbito, «per rissegnarglielo al suo tempo», atale Filippo, evidentemente un protetto del Bembo.
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 253
questi, in soccorso del quale Ercole aveva auspicato la mobilitazio-ne bembiana, lungi dal lasciare affiorare il minimo residuo di ani-mosità, faceva abilmente scivolare un accenno a «un gran testimo-nio» dell’«amorevole animo» del destinatario nei proprî confronti,con ogni evidenza alludendo all’affaire del cappello rosso, che si sta-va ormai avviando alle battute conclusive (109). Fedele alle pro-messe, nella riuscita dell’impresa il futuro presidente del concilio diTrento giocò un ruolo tutt’altro che trascurabile: di fronte a un sa-cro collegio decisamente “pretridentino”, in parte prevenuto e mal-disposto – circostanza rara per quel tempo, a favore dello stagiona-to candidato non deponevano benemerenze politiche, familiari o pe-cuniarie che avrebbero esortato a sorvolare sui suoi trascorsi mon-dani e sulle sue nugae volgari –, appoggiò con la consueta fermez-za colui che salutava come l’uomo di lettere per excellentiam, la cuiequilibrata e matura saggezza non avrebbe potuto se non giovarealla causa cattolica in quel critico frangente (110). Ma – ciò che la-scia alquanto interdetti – di tanto disinteressato tributo al suo valo-re di intellettuale (questo sì mecenatesco nel più alto significato deltermine) il novello monsignore – la nomina ufficiale a cardinale dia-cono di San Ciriaco in Thermis venne pubblicata il 19 Marzo – siprese la briga di ringraziare per iscritto il benefattore soltanto il 6
VARIETÀ254
(109) Cfr. IV, 2018, pp. 180-181 (il documento è accolto nell’edizione Dorico).Sulle disattese volontà testamentarie del poeta ferrarese vedi pure la sincrona missi-va ad Angelo Colocci (IV, 2019, p. 181). Che il Bembo avesse per qualche giornocreduto di essere già stato pronunziato cardinale ai primi di Marzo – l’elezione erainfatti riservata in pectore fin dal 20 Dicembre 1538 – è testimoniato dalle sue re-sponsive a Romolo Cervino del 5 (cfr. IV, 2016, pp. 178-179) e a monsignor RodolfoPio del 15 (cfr. IV, 2021, pp. 182-183) di quel mese.
(110) Sui retroscena dell’elevazione del Bembo (tra i suoi più velenosi denigra-tori i cardinali di Santa Croce e di Chieti) offrono interessanti ragguagli, oltre a quel-le citate nella nota precedente, le seguenti epistole: a Cola Bruno, del 25 Dicembre1538 (cfr. IV, 1998, p. 164); a Paolo III, del 28 Dicembre (cfr. IV, 2001, pp. 165-166); al cardinale Alessandro Farnese, della stessa data (cfr. IV, 2002, pp. 166-167);a Paolo III, della stessa data (cfr. IV, 2003, pp. 167-168); a Elisabetta Querini, dell’8Gennaio 1539 (cfr. IV, 2007, p. 171); al Gualteruzzi, del 13 Gennaio (cfr. IV, 2008,p. 172); a Marco Benavides, del 22 Gennaio (cfr. IV, 2009, p. 173); al cardinale diCarpi Rodolfo Pio, del 24 Gennaio (cfr. IV, 2010, pp. 173-174); al cardinale Farne-se, del 5 Febbraio (cfr. IV, 2011, p. 175); al cardinale di Carpi, del 5 Marzo (cfr. IV,2017, p. 180); al cardinale di Trento Bernardino Clesio (cfr. IV, 2022, pp. 183-184)e a Vittoria Colonna, del 15 Marzo (cfr. IV, 2024, pp. 184-185); al cardinale Farne-se, del 16 Marzo (cfr. IV, 2025, pp. 186-187). Stando a due missive indirizzate daRoma a monsignor Ercole il 15 e il 22 Gennaio 1539 dal suo agente Nino Sernini,parzialmente riprodotte in LUZIO-RENIER, La coltura e le relazioni letterarie cit., 4, p.208 nota 1, il maggiore ostacolo al conferimento della dignità all’attempato aspiran-te sarebbero stati i suoi costumi di inveterato sottaniere: «[...] non sanno dargli al-tra taccia se non che pubblicamente ha tenuta una femmina et havutone figliuoli, ech’or tiene una sua donzella da che essa è morta. Il che però non pare molto stra-no a questi tempi d’hoggi, et vi s’aggiunge per qualche mala lingua che esso cardi-nale è huomo et conosce carnalmente le donne di questo paese».
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 254
Maggio, dopo avere sollecitamente esternato la propria cartacea ri-conoscenza a mezza curia pontificia e non solo, a partire dall’in-fluentissimo porporato nipote di Paolo III, il poco più che adole-scente Alessandro Farnese (111). Per giunta nella missiva, dovero-samente ospitata nel III libro delle Lettere ai religiosi già nella stam-pa romana del 1548, il sentimento, pure autentico, di gratitudine èoffuscato more solito dalla verbosa convenzionalità dell’ossequio:
[...] ho giudicato mio gran debito fare a V.S. questi pochi versi [...] e dirle chea me non è punto nuova e la bontà e la umanità generale di V.S., e l’amore parti-colare verso me suo. Né fora bisognato che ella si fosse trovata in Roma al tempoche fu di me in Consistorio ragionato sopra la dignità che m’ha N.S. novellamenteconferita, a fine che ella avesse potuto mostrarmi quanta e quale sia la estimazionche ella fa di me [...]. Però che io l’ho di gran tempo addietro conosciuta, e ne lesentiva infinito obligo. [...] e giungerò al mio animo, antico servo di V.S., la memo-ria di sì grande obligo apresso alle altre che egli serba e serberà sempre. E pregheròil cielo che mi doni occasione di poternele esser grato, e lei, che si degni coman-darmi, e per sua fedel moneta spendermi dove ella valer si possa di me, senza ri-sparmio (112).
L’ultimo messaggio bembiano a Ercole, come quello indirizzatodieci giorni più tardi al di lui fratello minore Ferrante, è listato alutto: data al 10 di Luglio del 1540 e dal 28 del mese precedente ilduca Federico ha lasciato questo mondo, fiaccata anzitempo la suagià logora fibra da un ennesimo attacco di sifilide. Importa osser-vare come in questa rapida lettera di condoglianze, più che il po-sticcio rimpianto per la prematura dipartita del principe (d’altron-de non un rigo era stato vergato, l’anno precedente, in occasionedella scomparsa della marchesana Isabella) o le trite professioni di
VARIETÀ 255
(111) La fausta notizia raggiunse lo scrittore a Venezia il 29 Marzo per mezzodel cubiculario papale Ottaviano Zeno (cfr. la lettera a Paolo III del 31 di quel mese[IV, 2029, pp. 189-190]) e sùbito l’emissario gonzaghesco Agnello si recò a felicitar-si con lui, come è lo stesso agente a raccontare al duca Federico in un dispaccio delgiorno seguente (cfr. CIAN, Pietro Bembo cit., pp. 135-136 e nota 1). Immediatamentelo scaltro Bembo si diede a tessere una fittissima rete epistolare per ringraziare siacoloro che si erano complimentati con lui per la nomina (dal vescovo di Nocera Pao-lo Giovio al duca di Ferrara Ercole II, dal conte Agostino Lando al cardinale Ago-stino Trivulzio, dal Fracastoro a Veronica e Uberto Gambara, da Andrea Alciato al-l’arcivescovo Fregoso, per limitarmi ai nomi più illustri), sia, soprattutto, coloro cheriteneva avessero patrocinato la sua causa o l’avessero comunque difeso dalle calun-nie dei detrattori, ossia il 31 Marzo il cardinale Farnese (IV, 2028, pp. 188-189), laSerenissima in persona di Marco Antonio Contarini (IV, 2026, p. 187), il cardinaleGaspare Contarini (IV, 2027, p. 188) e il cardinale di Carpi (IV, 2032, p. 192); il IAprile ancora il Farnese (IV, 2033, p. 193) e il cardinale Girolamo Ghinucci (IV,2034, p. 194); il 4 nuovamente il Farnese (IV, 2037, pp. 195-196) e Vittoria Colon-na (IV, 2039, p. 197 [ma cfr. pure la responsiva del 6 Aprile ad Ascanio Colonna[IV, 2048, p. 203]); il 5 il vescovo di Brescia e chierico di camera apostolica AndreaCornelio (IV, 2042, p. 199); il 6 il cardinale Domenico Grimani (IV, 2043, p. 200),Girolamo Orsini e suo fratello Francesco vescovo di Tricarico (IV, 2045, p. 201).
(112) IV, 2074, p. 219.
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 255
incondizionata devozione («s’io già non fossi tutto tutto suo, comeper i meriti suoi sono già buon tempo fa»), emerga con spontaneitàche rasenta l’improntitudine il rammarico per la temporanea lon-tananza da Roma, dove nel precedente Ottobre il nicchiante cardi-nale si era a malincuore dovuto trasferire, di colui che veniva con-templato come un sicuro paladino (dell’involontaria sconvenienzal’avvertito epistolografo dovette per tempo rendersi conto, se di tut-to il carteggio con il Gonzaga questo pezzo fu l’unico a non otte-nerne l’imprimatur) (113):
E veramente poche cose conosco che tanto dispiacere mi avessero potuto reca-re, quanto questa morte ha fatto, che ne ha tolto quel buon Signore così repentina-mente. E quel che m’accresce il dispiacere è che perciò mi veggio tolta ancora la spe-ranza di riveder V.S. R.ma in questa corte così tosto, come era il disiderio mio e dimolti altri suoi servitori, per poterla meglio servire e riverire alla presenza (114).
Posteriormente al Luglio 1540, non sussiste il minimo lacerto dicorrispondenza tra il Bembo e il più giovane collega, rammentatodi passata in non più di tre lettere (115). Un silenzio che, per quan-to sia ragionevole porre in relazione con i di necessità frequenti in-contri tra i due ecclesiastici nelle sale vaticane, non manca di avva-lorare il fastidioso sospetto di una frequentazione in massima parteinteressata: conseguito lo scopo primo per cui si era dato pena dicoltivare negli anni quello stentato legame, il vecchio scrittore, cheaveva frattanto avuto agio di adattarsi all’ambiente – peraltro sem-pre meno ostile – della curia e fibrillava in spasmodica caccia dinuove prebende per sé e per l’insipiente Torquato, doveva giudica-re assai poco conveniente spendere il poco tempo rimastogli in col-loquî epistolari ormai improduttivi. Lo sentenziava già un monosti-co (il CDLXXVII) di Menandro: «Dopo il dono molto presto invec-chia la riconoscenza».
MARZIA MINUTELLI
VARIETÀ256
(113) L’altra eccezione – in ragione evidentemente della sua natura di "comuni-cazione di servizio" – è costituita dal breve messaggio del 4 Settembre 1531 (su cuicfr. supra e nota 101).
(114) IV, 2200, pp. 315-316. Ancora più tenuemente improntata a sensi di com-passione la missiva per Ferrante, dove l’improvvisa «morte dello Ecc.mo S.or Ducasuo fratello» non rappresenta più di uno sbrigativo pretesto per introdurre, e in tonopiuttosto impositivo, la sconcertante richiesta di un beneficio "alimentare" che il de-stinatario, nella sua qualità di viceré di Sicilia, poteva agevolmente garantire: «Disi-dero di esser provisto di cento salme d’orzo per mio uso di costà, attenta la diffi-cultà che si ha a provedersene di qua» (IV, 2202, p. 317).
(115) Cfr. IV, 2259, p. 364 (a Leonora, del 2 Agosto 1541); 2289, p. 387 (alGualteruzzi, del I Ottobre 1541), e 2400, p. 475 (ancora alla duchessa di Urbino,del 19 Dicembre 1543). Di un «M. Angelo del R.mo di Mantoa» è fatta parola indue responsive a monsignor Contarini, che con il creato del Gonzaga aveva eviden-temente una vertenza, del 2 e del 25 Giugno 1541 (cfr. IV, 2250, p. 356, e 2253, p. 339).
221-256 19-06-2006 12:34 Pagina 256