Letà del Bronzo nel Tavoliere interno: nuovi dati dalle ricognizioni nella valle del Celone
Il tabacco a Napoli. Architettura e produzione nelle manifatture ottocentesche, in Le fabbriche del...
Transcript of Il tabacco a Napoli. Architettura e produzione nelle manifatture ottocentesche, in Le fabbriche del...
179
Manifatture a Napoli. Una storia didismissioni e di riusi
La storia dei due tabacchifici ottocenteschi diNapoli si intreccia innanzitutto conuna delle pra-tiche più esercitate nel lungo periodo, nell’ambitodell’edilizia di carattere produttivo, sia alla scalaarchitettonica sia a quella urbanistica. Infatti, inentrambe gli impianti diNapoli San Pietro Mar-tire e diNapoli Santi Apostoli− come spesso veni-vano denominate nella pubblicistica tecnica ledue manifatture installate in preesistenti edificireligiosi − la dismissione e il riuso funzionale delcontenitore architettonico non rappresentano leultime fasi del ciclo vitale delle due fabbriche deltabacco napoletane,ma segnano, invece,momentirilevanti del loro intero percorso storico-produt-tivo. Dismissione e riuso, in altre parole, costitui-scono in questo caso due categorie interpretativedalle quali non si può prescindere per compren-dere in una prospettiva storica logiche di mercatoe strategie imprenditoriali, applicazioni scientifi-che e soluzioni tecnologiche, caratteristiche archi-tettoniche e dimensioni socio-antropologichedello spazio del lavoro1.La stessa storia della più recente manifattura
tabacchi di via Galileo Ferraris – gestita, nella suadelicata fase di alienazione, dalla Fintecna Spa eoggi a rischio di demolizione, con il nulla ostadella locale Soprintendenza ai Beni Architetto-nici e Ambientali2 – sancisce a partire dal 1930 lagraduale dismissione delle due manifatture otto-centesche.Secondo i programmi di ampliamento e di svi-
luppoprevisti in età fascista per la zona industrialedi Napoli, la nuova manifattura tabacchi dovevasorgere nel 1932 su un’area di 100.000mq (confi-nante con l’Arsenale di Artiglieria) con l’obiettivodi dare lavoro a circa 2000 operai per una produ-zione annuale di 10.000 kg dimanufatti (tra sigarie sigarette), riunendo in un’unica struttura tuttigli impianti esistenti da lungo tempo nel cuore
della città storica: oltre alle due principali mani-fatture di San PietroMartire e dei Santi Apostoli,anche i depositi per i tabacchi (greggi e lavorati)situati ai Granili, ai Ponti Rossi e in via FlavioGioia3.Tuttavia, il nuovo impianto napoletano fu
inaugurato solo nel 19564 e le due fabbriche diSan PietroMartire e dei Santi Apostoli cessaronodi svolgere la loro funzione produttiva solo a par-tire da quella data: più recentemente, il primoimpianto è stato convertito in una sede dell’Uni-versità di Napoli “Federico II”5, il secondo in unLiceo Artistico Statale6.Delle due manifatture napoletane solo quella
di San Pietro risale agli inizi dell’Ottocento, rien-trando l’attivazione dell’impianto dei Santi Apo-stoli nei piani postunitari di riassetto nazionaledell’intero comparto produttivo del tabacco. Inentrambe i casi, comunque, le fabbriche furonoinsediate in edifici preesistenti e più precisamentein due antichi monasteri, entrambi soppressi,rispettivamente nel 1808 e nel 1809, durante il“decennio francese” (1805-15).Nel Mezzogiorno preunitario, come in molti
altri stati italiani, un nuovo e sistematico impulsoalla produzione di tabacco (da fiuto e da fumo) sideve infatti alla presenza dei napoleonidi nelRegno di Napoli. GioacchinoMurat, nel novem-bre 1809, sancì la dismissione delle officine per lafabbricazione dei tabacchi attive da lungo temponei pressi dell’antico edificio della Dogana7,imponendo a tutti i “tabaccari” di trasferire gliimpianti nel vicinomonastero di San PietroMar-tire8 e l’anno seguente, con decreto del 19 ottobre1810, emanòuna specifica legge sulla privativa deltabacco, con l’intenzione di realizzare nell’anticastrutturamonastica unamanifattura “principale”,cui sarebbero seguiti eventualmente nuovi analo-ghi impianti anche in altre città del Regno. Poli-tica che perseguirono successivamente anche iBorbone, come si può attestare per Cava, princi-pale polo campano di coltivazione del tabacco,
Il tabacco a Napoli.Architettura e produzione nelle manifatture ottocentescheROBERTO PARISI -Università del Molise
tabacchi:Layout 1 28-03-2012 17:54 Pagina 179
180
dove intorno al 1845 il Ministero delle Finanzerealizzò una succursale adattando allo scopo unedificio presente in località Passetto9 oppure perTorre Annuziata dove, in seguito alla dismissionedi alcuni impianti militari, si cominciarono adavviare una serie di sperimentazioni botaniche supiante da tabacco, poi portate avanti, nei primianni Sessanta dell’Ottocento, nell’ex polverificioborbonico di Scafati10.Proprio nell’ambito di una politica nazionale
di riassetto dell’intero settore di produzione deltabacco e contemporaneamente di recupero e ditrasformazione del patrimoniomilitare preunita-rio ereditato dal giovane Regno d’Italia, si collocainfine la nascita del secondo tabacchificio deiSanti Apostoli, che insieme alla fabbrica di SanPietroMartire concorse a rendere il polo produt-tivo napoletano uno dei più importanti d’Italiafino alla primametà del Novecento11.
Napoli San Pietro Martire (1809-1953)
Aunmese dalla dismissione dell’impianto sei-centesco in largo della Dogana vecchia, il 1°dicembre 1809, fu ufficialmente aperta la nuovafabbrica napoletana di San PietroMartire12. Al dilà dell’intento propagandistico, è evidente che ilprocesso di riconversione della struttura mona-stica avrebbe comportato tempi più lunghi per farentrare a regime la produzione e, infatti, anchedopo la seconda restaurazione borbonica, conti-nuando a funzionare a pieno regime, la manifat-tura fu progressivamente sottoposta a interventi
di accorpamento di nuovi magazzini siti lungo ilati esterni del complesso, fino a utilizzare lo spa-zio interno del chiostro, che cominciò gradual-mente a ridursi mediante la tamponatura dei por-tici laterali.Per i primi tre decenni di vita della manifattu-
ra appaionoancora scarne lenotizie relative sia alletecniche e ai modi di produzione, sia alle caratte-ristiche dello spazio architettonico destinato allevarie fasi di lavorazione, e altrettanto si può soste-nereper il periodocompreso tra il 1842ed il 1848,quando ilMinisterodelleFinanzeborbonicodeci-se di appaltare ad imprenditori privati la gestionedelle fabbriche di tabacco. Tuttavia, un quadropreunitario delle condizioni degli impianti e del-le varie fasi di lavorazione si evince da alcune fon-ti del 1857.Nella riedizione della seicentesca guida di
Napoli del Celano, Giovan Battista Chiarinidescrisse in dettaglio il ciclo di lavorazione deltabacco da naso e da fumo − dalla preparazionealla fermentazione, alla trasformazione fino allavendita − che si praticava nelle diverse officinedella Real Fabbrica di San PietroMartire.Le varie specie di tabacco venivano separate e
quindi destinate alle officine dei rappati o dei trin-ciati, dove le operazioni dimolitura, crivellatura etaglio avvenivano mediante macchine azionate avapore. Da qui il prodotto passava alle officinedelle preparazioni per la conciatura e la fermenta-zione. Un settore a parte era quello per la produ-zione di sigari, che occupava circa 2000 operaie13.Maggiori dettagli sugli ambienti di lavora-
zione apparvero anche sul “Giornale del Regnodelle Due Sicilie”14, dove la fabbrica vennedescritta come «un vasto edificio, in ogni suaparte sontuosamente decorato e restaurato,abbondantemente servito di acque, aria e luce»,ma ciò nonostante era ritenuta allo stesso temponon più sufficiente per la grande mole di lavoro emerce prodotta.Al piano terra vi erano molti depositi dove
venivano depositate foglie di tabacco “beneven-tane” o “americane”, ma altri 13 depositi eranostati ricavati all’esterno della fabbrica. L’officina diseparazione delle foglie da trinciare rispetto aquelle da avvolgere era stata localizzata in uno deinumerosi ammezzati ricavati negli ordini sovrap-posti del portico del chiostro; in ambienti ipogeiera invece disposta una macchina a vapore di 16
Roberto Parisi
Napoli. Manifattura di San Pietro Martire (1809-1953).Particolare della pianta di Napoli, 1872-80.
tabacchi:Layout 1 28-03-2012 17:54 Pagina 180
181
cavalli che azionava 10 mulini da tabacco, ungrande staccio, trinciatoi a ruota e a mannaia.Dagli ambienti destinati all’inscatolamento in
confezioni di carta, rivestite internamente dipiombo, il prodotto finito veniva infine deposi-tato negli ambienti delle cosiddette “materie per-fette”. Il cortile interno – sensibilmente ridottorispetto all’originario chiostro conventuale – eraanche utilizzato per lo smistamento dellamerce inentrata e in uscita, mediante un sistema articolatodi argani posti a ridosso della ciminiera.Vi è da sottolineare che la nuova Amministra-
zione dei Sali e Tabacchi, riorganizzata da Ferdi-nando I (già IV) di Borbone e sottoposta aldiretto controllo delMinistero delle Finanze, nondisponeva di un ufficio interno di progettazione eche la cooptazione di tecnici esterni – spesso inalternativa all’utilizzo di ingegneri già strutturatiin altre istituzioni pubbliche come il corpo diponti e strade e il Genio Militare – non rispon-deva a specifici criteri selettivi, ma dipendeva dalruolo che architetti e ingegneri rivestivano nel-l’ambito di una ristretta élite di professionisti.Daquesto puntodi vista, per la primametà del-
l’Ottocento, una figura di primo piano fu senz’al-tro l’architetto StefanoGasse (1778-1840)15, il cuiimpegno nei progetti di ampliamento e di manu-tenzione della fabbrica di San Pietro Martire èattestato per gli anni 1836-3916. Gasse avevaassunto nell’ambiente imprenditoriale locale unruolo di primopiano fin dai primi anni di governo“francese”, consolidando la propria posizione nelcorso degli anni Venti e Trenta, quando in pienamaturità professionale poteva considerarsi tra itecnici napoletani di maggior prestigio nazionalee internazionale, tanto da risultare insieme aPasquale Poccianti membro esterno del RoyalInstitute ofBritishArchitects17.Oltre a figurare datempo come «architetto dei dazi indiretti» e piùin generale, come consulente esterno del Mini-sterodelle Finanze–per il quale progettò, a partiredagli anni Venti, tutto il nuovo sistema daziario diNapoli (dal cosiddetto muro finanziere alle bar-riere e ai palazzi della dogana)18 –Gasse fu inoltreimpegnato in specifici progetti di edilizia di carat-tere produttivo o di servizio all’industria: dalsistema dei mercati e dei macelli pubblici dellacittà di Napoli alle opere che gli imprenditoriWenner e Wonwiller gli commissionarono per ilvillaggio tessile di Fratte a Salerno19.
Un analogo percorso si può riconoscere nel-l’esperienza di ErricoAlvino, uno dei protagonistidella cultura architettonica italiana nel primodecennio postunitario. Alvino subentrò al Gassenei rapporti con il Ministero delle Finanze e difatto seguì la progettazione ed il controllo di tuttele fabbriche di tabacco impiantate nella capitaleborbonica e nella provincia, a partire dagli anniQuaranta, quando il Regno delle Due Siciliecominciò a dare in concessione a privati lagestione del ramo dei tabacchi.In questo comparto, una figura centrale, nel
Mezzogiorno preunitario come negli Stati dellaChiesa, fu certamente l’imprenditore romanoAlessandroTorlonia, il quale ottenne in appalto ilramo sali e tabacchi sia a Roma, sia in Sicilia e nelMezzogiorno continentale20.Le fasi di ampliamento e profonda trasforma-
zione della manifattura di San PietroMartire cheimpegnarono Alvino, senza soluzione di conti-nuità, tra il 1842 ed il 1859, si incrociano appuntocon l’ingresso nella gestione del ramo tabacchi diDomenico Benucci, uno dei cosiddetti “soci diindustria” del Torlonia, già responsabile dell’ana-logo appalto ottenuto a Roma dal banchiere efuturo principe del Fucino21.Benucci gestì ufficialmente ilmonopolio otte-
nuto dal Torlonia per i «Domini al di qua delfaro» (la parte continentale del Regno delleDueSicilie) nei primi anni Quaranta fino al 1848,anno della suamorte, ma in realtà egli era già pre-sente sulla piazza di Napoli con un proprio uffi-cio nel 1837, in virtù della medesima RegìaCointeressata dei Sali e Tabacchi che Torloniaaveva ottenuto, insieme al Carafa, per la Sicilia(«Domini al di là del Faro») fin dal 183422.Opportunamente, in uno dei primi studi siste-matici sulla sua figura, Giuseppe Bruno e RenatoDe Fusco posero in stretta relazione l’incaricoche Alvino ottenne dal Benucci per la realizza-zione della sua residenza a Castellammare di Sta-bia (1843, successivamente trasformata in HotelRoyal) con l’intervento che l’architetto napole-tano progettò e diresse in quegli stessi anni neltabacchificio di San PietroMartire23.Tuttavia, va tenuto conto che la presenza a
Napoli del Benucci risale alla fine degli anniTrenta, quando i lavori nella manifattura eranoancora seguiti da Gasse per conto del Ministerodelle Finanze, e soprattutto che il 1842 non solo
Il tabacco aNapoli. Architettura e produzione nelle manifatture ottocentesche
tabacchi:Layout 1 28-03-2012 17:54 Pagina 181
182
coincide con la data del regio decreto con cui egliottenne la cittadinanza napoletana24, ma anchecon la rottura definitiva dei suoi rapporti di colla-borazione con Torlonia, che si conclusero per viagiudiziaria nel 184425. Una serie di elementi che,poco dopo l’uscita di scena di Gasse e la breveparentesi dell’ingegnere FedericoBausan, peraltrosottoposto ambiguamente a una serie di criticheper inadempienze burocratiche, rendono ancorapoco chiare le dinamiche che caratterizzaronol’ingresso di Alvino nell’entourage dei consulentidel Ministero delle Finanze, per il quale l’archi-tetto lavorò assiduamente nei due decenniseguenti, in diversi altri comparti oltre quello deitabacchi26.Nel corso degli anni Cinquanta, comunque, la
fabbrica di tabacchi subì sotto il profilo architet-tonico profonde trasformazioni, finalizzate nonsoltanto a ricavare ulteriori spazi utili per le nuoveofficine dei sigari, realizzate con corpi aggiunti insopraelevazione sulle strutture già ampliate lungoil perimetro del chiostro interno, ma anche, pre-sumibilmente, a curare l’aspetto formale ed este-tico della fabbrica sia per quanto attiene all’arredoe all’allestimento degli spazi interni – come neicitati locali delle «materie perfette» dotati di
scaffalature in legno di larice rosso di Venezia cheAlvino disegnò in stile neorinascimentale27 – siaper quanto riguarda i fronti esterni. Con una pre-cisa scelta stilistica Alvino rinunciò all’uso diordini architettonici nella configurazione dellefacciate e, assumendo per lo schema distributivogli stessi criteri adottati nei «precetti d’arte» dalConsiglio Edilizio (1854), propose un impiantosu quattro livelli con una parte basamentale abugne orizzontali al piano terra e una scansioneregolare di finestre incorniciate da un «arco sca-ricatore» che copre completamente la parte supe-riore dell’apertura, attingendo al tema figurativodell’«ornia a giogo», proprio della tradizionelocale di derivazione catalana28.Restano, tuttavia, ancora poco indagati gli
interventi che caratterizzarono un ulteriore esignificativo processo di trasformazione degliimpianti e della parte strutturale avviato dopo ilterribile incendio che colpì la fabbrica il 30novembre 188029. Innescatosi nei depositi alpiano terra, ben presto l’incendio distrusse granparte degli ambienti superiori, salvandosi soloalcuni reparti di fermentazione. Evacuato il perso-nale, occorsero diversi giorni per domare lefiamme e l’impegno di operai specializzati prove-nienti dagli stabilimenti metalmeccanici dellaPattison e della Guppy.I lavori di salvataggio e di ricostruzione della
manifattura – che coivolsero le stesse societàmetalmeccanicheGuppy e Pattison – si sarebberoconnessi di lì a poco con le grandi opere del Risa-namento avviate a partire dal 1885, che compor-tarono l’apertura del «rettifilo» tra la stazioneferroviaria e il Palazzo della Borsa, con la conse-guente distruzione del nucleo di edifici prospi-cienti la piazzetta antistante la chiesa di SanPietroMartire, sulla quale oggi prospetta una parte dellafacciata principale del complesso progettata dal-l’Alvino.Ma se il Piano di Risanamento della cittàsalvava l’intero impianto per oggettive ragioni dicarattere produttivo, ben diverse erano le prospet-tive insite nel piano di ricostruzione postbellicaelaborato da Luigi Cosenza e approvato nel 1946,dove per la fabbrica di tabacchi inaugurata daMurat si prevedeva la totale distruzione e sostitu-zione con nuova edilizia.Evacuata nel 1953 in vista della inaugurazione
della nuova fabbrica insediata nella zona indu-striale ad oriente della città, la manifattura fu
Roberto Parisi
Napoli. Manifattura di San Pietro Martire (1809-1953). Ilcortile interno durante i lavori di restauro del complessoconventuale. Da S. Pietro Martire, Napoli 1983.
tabacchi:Layout 1 28-03-2012 17:54 Pagina 182
183
acquisita dall’Università di Napoli “Federico II”,ma rimase inutilizzata e destinata ad un inesora-bile processo di abbandono fino al 1977, quandosi avviarono i lavori di restauro (1977-83), direttidall’ingegnere Roberto Di Stefano ed eseguitidalla società cooperativa “La Stradale”.
Napoli Santi Apostoli (1862-1970)
Il passaggio allo Stato unitario comportò unaserie di trasformazioni strutturali nel sistema diproduzione del tabacco in provincia di Napoli,che coinvolsero molte strutture militari incame-rate dal nuovo governo, per alcune delle quali fuappunto avanzata l’ipotesi di trasferirvi nuoviimpianti produttivi.A parte i lavori di manutenzione e amplia-
mento diretti dallo stesso Alvino nella piccolasuccursale diCava de’Tirreni, alla quale si sostituìpiù tardi un nuovo opificio, convertendo alloscopo l’antico conservatorio di Santa Maria delRifugio, già utilizzato come casermamilitare, ana-loghe ragioni di spazio motivarono la scelta delgoverno italiano di riutilizzare l’antico complessomonastico di San Pietro Apostolo in piazza Car-dinale Pacca aBenevento, dove si insediò nel 1866l’Agenzia Tabacchi (distrutta totalmente nel1943) e allo stesso scopo il polverificio borbonicodi Torre Annunziata, già dismesso nel 1852 inconcomitanza con la costruzione del nuovogrande impiantomilitare di Scafati.Napoli, TorreAnnunziata e Scafati furono i tre
poli principali intorno ai quali tecnici e ammini-stratori, alla scala locale come a quella nazionale,discussero a lungo per individuare strategie e stru-menti più adatti per potenziare il settore produt-tivo. Naturalmente la questione “tabacchi” erasolo un capitolo di un più complesso sistema diproblemi di carattere economico che caratterizza-rono gli anni 1861-65, successivi ad un biennioancora più difficile che, a partire dalla morte diFerdinando II di Borbone, avvenuta il 22 maggio1859, fu caratterizzato, per Napoli, come pertutto il Regno delle Due Sicilie, da una serie disignificative trasformazioni politiche, durante lequali si susseguirono il breve governo costituzio-nale di Francesco II, la dittatura garibaldina, leluogotenenze Farini, Carignano, Ponza di SanMartino e Cialdini, l’unificazione italiana ed il
conseguente riordinamento delle amministra-zioni comunali delle varie città delMeridione30.In tale contesto si colloca innanzitutto la deci-
sione del luogotenente Farini di abrogare la dispo-sizione legislativa del 12 marzo 1860 che avevadisposto il passaggio all’Episcopato delle strutturedel convento teatino dei Santi Apostoli per adi-birli a seminario gesuitico, mantenendo invece laproprietà statale del complesso conventuale, cheinfatti fu destinato amanifattura dei tabacchi condecreto del 27 novembre 186031. L’anno dopo, inun dettagliato resoconto relativo al suo mandatopolitico, Vittorio Sacchi, segretario generale delMinistero delle Finanze, incaricato dall’aprile del1861 di reggere il Dicastero dei lavori pubblicinelle province meridionali, delineò lo stato del-l’arte e il quadro delle iniziative messe in atto permigliorare il comparto del tabacco nella provinciadi Napoli.Partendo dalla constatazione che la«Fabbrica
di S. Pietro Martire in Napoli, per l’angustia deilocali, e per gli edifici che la circondano, rendeasidisadatta alla lavorazione dei tabacchi»32 e che lapresenza di ben 18 depositi sparsi nella città nonfavoriva una razionalizzazione dell’intero ciclo
Il tabacco aNapoli. Architettura e produzione nelle manifatture ottocentesche
Napoli.Manifattura di San PietroMartire (1809-1953). Lafacciata attuale dal corsoUmberto, dopo i lavori di restaurodel complesso conventuale. Da Il patrimonio architettonicodell’Ateneo fridericiano, Napoli 2004.
tabacchi:Layout 1 28-03-2012 17:54 Pagina 183
184
produttivo, fu avanzata l’idea di delocalizzaretutta la produzione presso l’antica fabbrica d’armie polverificio di Torre Annunziata.In quel vasto complesso militare si era comin-
ciato già nel giugno 1861 a costruire i nuovimagazzini per il deposito di«foglie estere e nazio-nali», dismettendo nel mese di luglio tutte lestrutture sparse nell’ex capitale, dove peraltro lasituazione dei depositi era diventata improcrasti-nabile a seguito dell’incendio scoppiato nell’aprileprecedente nel principale magazzino ricavato nel-l’albergodei Poveri, conundanno stimato intornoai 300.000 ducati.Sempre a Torre Annunziata, con l’impiego di
circa 800 operai, si avviarono celermente le operedi costruzione per delocalizzare dalla fabbrica diSan Pietro i reparti per la lavorazione dei trinciatie dei rapati, mentre si profilava l’idea di realizzarenella porzione di terreni demaniali annessi al sitodell’ex polverificio un orto sperimentale per la col-tivazione del tabacco e allo stesso tempo di trasfe-rire in questa sede anche la lavorazione dei sigari.Ma il piano del Segretariato generale della
finanza era ancora più ambizioso poiché rispon-deva all’idea di trasformare il polo militare diTorre Annunziata in un vero e proprio villaggioindustriale per la coltivazione e la produzione deltabacco, dotato di scuole professionali. Ragionicome la salubrità dei luoghi, la possibilità didecomprimere l’asfissiante presenza di molti ope-rai nella città di Napoli, il più efficace controllo,anche igienico, dei lavoratori e delle fasi di lavora-zione legittimavano la convinzione chel’ampiezza dei locali, l’estensione del terreno, lasua elevazione, l’isolamento dell’abitato per-
metterebbe di farne un grandioso stabilimento,che sarebbe incontestabilmente il primo d’Ita-lia, e potrebbe non solo sopperire al bisognodelle provincie Meridionali, ma a provvedereanche alle altre parti del Regno33.
Tuttavia, a questo piano, che si configuravacome una consapevole e ponderata soluzionestrutturale alla questione napoletana dei “tabac-chi” e che peraltro trovava un ulteriore elementoa favore nella vicinanza del sito di Torre Annun-ziata alla ferrovia, fu affiancata come propostaalternativa, ritenuta meno efficace, ma attuabilepiù a breve termine, quella di recuperare a talescopo il convento dismesso dei Santi Apostoli,secondo quel decreto del 1860 che con la soppres-sione della luogotenenza era stato in qualchemodo disatteso.Previsione cheperò si rivelò infondatanon solo
perché i lavori, benché iniziati nei primi mesi del1862, furono interrotti più volte e sostanzialmen-te completati nel 1870, ma soprattutto perché larelativa spesa comportòunaggravioper il fiscodel50% oltre l’importo stanziato, con modalità chenella fase iniziale di avvio del cantiere appaionotutt’oggi poco chiare e ambigue, come del resto sipuò facilmente intuire dalla lettura dei numerosiappelli rivolti al governo centrale e dei relatividecreti disposti per sanare sia la situazione dibilancio, sia l’ambigua impalcatura di relazioni tratecnici, consulenti, imprese e amministratorimes-sa inpiedi subitodopo ilmandatodiVittorio Sac-chi come commissario straordinario delle Finan-ze a Napoli (20 ottobre 1861 - 1° febbraio 1862).Da questo punto di vista, l’indagine critica sullamanifattura dei SantiApostoli fa emergere innan-zitutto una storia di conflitti, tra centro e perife-ria, tra pubblico e privato, come tra tecnici eamministratori. Una storia nella quale – oltre alruolo del progettista-consulente e dell’impresa dicostruzione, terzo vertice raramente preso in con-siderazionenella lettura dello spazio architettoni-co della fabbrica – può emergere anche la figura,solo apparentemente più statica e controllata, deltecnico pubblico, “di stato” o “municipale”, garan-te non solo delle politiche del governo nazionaleo locale, ma anche dell’interesse collettivo dellasocietà civile. Aspetto, quest’ultimo, spesso sotto-valutato a tal puntoda ridurre l’attività di architet-ti e ingegneri “pubblici” esclusivamente ad una
Roberto Parisi
Napoli.Manifattura dei Santi Apostoli (1862-1970). Parti-colare della pianta di Napoli 1872-80.
tabacchi:Layout 1 28-03-2012 17:54 Pagina 184
185
mera azione di controllo burocratico34. Laddove,invece, un ostacolo normativo o una qualsiasidivergenza d’opinione, tra pubblico ufficiale elibero professionista, su questioni tecniche o dicarattere estetico, può evidenziare conflitti d’in-teresse di varia natura, così come può favorire lacomprensione di un’opera architettonica o di unprogetto urbanistico, facendo emergere talvoltasituazioni abbastanza ambigue35, dove i ruoli deltecnicopubblico, quellodel progettista edel diret-toredei lavori oquellodell’imprenditore edile dif-ficilmente appaiono ben definiti e differenziati.Avendoadisposizione tutta l’areademanialedi
Torre Annunziata – posta peraltro lungo unadirettrice storica di sviluppo industriale che colle-gava attraverso il fiume Sarno la fabbrica d’armiposta sulla costa tirrenica agli insediamenti inter-ni di Scafati e Sarno – non si comprende ancoraperché si preferì insistere sul riuso dell’antico con-vento teatino, reiterandouna logicadi allocazioneindustriale ormai consumata, che mostrava chia-ramente i propri limiti di carattere igienico-urba-nistico oltre che economico.I fatti che seguirono il lucido rapporto di Sac-
chi – dagli appelli al generale Lamarmora e allaPrefettura del direttore della Manifattura Tabac-chi di Napoli, Achille Perelli, a quelli della Dire-zione generale delle Gabelle per perorare l’affida-mento dell’incarico ad Alvino e allo stesso tempoper ridurre la supervisione dell’ingegnere Federico
Travaglini, direttore dell’Ufficio per i fabbricatipubblici e demaniali del Genio Civile, ad una piùtranquilla funzione burocratica – rispondevanoad una logica efficientista del fare che trovò unapiena legittimazione nel 1863, quando un cata-strofico incendio colpì il polverificio di Scafati. Inseguito a quell’esplosione furono recuperati dal-l’impianto di Scafati diversimacchinari – come adesempio i laminatoi, una macchina a vapore di 18cavalli, alcuni motori di trasmissione e pompeidrauliche – da destinare sia al nuovo complessodei Santi Apostoli, sia alla fabbrica di San PietroMartire.Oltre alle opere architettoniche, l’ingegnere
Travaglini coordinò anche l’approvvigionamentoe l’adeguamento degli impianti, aggiungendo allemacchine provenienti da Scafati alcuni macchi-nari presenti a Torre Annunziata e altri da com-missionare ad aziende specializzate, come lasocietà napoletana Macry & Henry. Alle ditteesterne Travaglini propose di commissionareanche i disegni tecnici delle nuove macchine,risultandogli difficile fornirli attraverso il proprioufficio tecnico sulla base delle richieste avanzatedalla direzione della manifattura.Riguardo ai lavori in corso per adattare a fab-
brica di sigari il cinquecentesco convento teatino– che peraltro era già stato adattato agli inizi del-l’Ottocento ad archivio, successivamente utiliz-zato come caserma e, per il breve periodo bellico
Il tabacco aNapoli. Architettura e produzione nelle manifatture ottocentesche
Napoli.Manifattura dei SantiApostoli (1862-1970). Interno dopo i lavori di restauro del complesso conventuale.Da “Archi-tetura e/o architettura”, n. 1 (1984).
tabacchi:Layout 1 28-03-2012 17:54 Pagina 185
186
preunitario, come ospedale militare – vi è da sot-tolineare che ilmassiccio intervento di trasforma-zione fu necessario per adattare al piano terravarie tipologie di depositi, al primo livello i labo-ratori e i vari reparti per la lavorazione dei sigari,al secondo livello quelli dell’asciugatura e per ilperfezionamento.Altre opere già previste negli anni 1862-63,
come ad esempio alcune scale interne e alcuniammezzati, un ampio portico d’ingresso a tre for-nici, furono stralciate dall’appalto per contenere laspesa rispetto al budget messo a disposizione.Come per il complesso di San Pietro Martire,
anche per questa fabbrica manca ancora uno stu-dio approfondito sulle ulteriori opere dimanuten-zione e di adeguamento funzionale condotte dopogli anni Ottanta dell’Ottocento. In entrambe icasi, tuttavia, le tracce ancora superstiti degli ele-mentimetallici di strutture di sostegno, come telaisu pilastri o colonne e solai a travature reticolari,talvolta poggianti su mensole ammorsate nellamuratura, testimoniano la progressiva acquisi-zione, nelle pratiche costruttive locali, di nuovimateriali e di un linguaggio strutturale in sintoniacon analoghe esperienze di industrializzazioneedilizia, in Campania o in altre regioni italiane.Se è vero però che nonmancavano i mezzi e le
competenze, né le capacità imprenditoriali, èanche vero che a Napoli, a parte la realizzazionedelle cupole in ferro e vetro delle due note gallerieurbane, come le numerose infrastrutture viarie eferroviarie che l’impresa dell’ingegnere Cottrauesportò in tutta Italia ed anche all’estero, nondisponiamo per l’ultimo ventennio dell’Otto-cento di numerose informazioni sulle architettureindustriali a scheletro metallico, secondo loschema classico del cosiddetto «cottonmill».Poche tracce, oggi in gran parte perse, di ele-
menti strutturali in ghisa o in ferro si sono riscon-trate, nel corso di ricerche condotte in questiultimi tre decenni: ad esempio nella tessituraBeaux nel quartiere di Sant’Erasmo ai Granili(intelaiatura portante di pilastri e travi metalli-che) o nella metallurgica Corradini a Vigliena(pilastri con capitelli a stampella, rampe elicoi-dali, archi in tufo su tozze colonne di ghisa,capriate Polonceau). Tuttavia, il processo di evo-luzione morfologica indotto con l’introduzionedi elementi in ferro nell’architettura industrialenapoletana – dove peraltro operavano a partire
dagli anni Cinquanta le aziende degli ingegneriThomas Guppy e John Pattison e dal 1872 quelladi Alfredo Cottrau – è più evidente in alcuniimpianti molitori e pastifici censiti (ma anche inquesto purtroppo in gran parte manomessi odemoliti) a Torre Annunziata, dove emerge conchiarezza il passaggio da strutture multipianoancora legate al repertorio figurativo e strutturalelocale a contenitori edilizi caratterizzati invece dainvolucri esterni in muratura. Questi racchiu-dono spazi interni quasi a pianta libera, perchésoggetti solo all’ingombro di una intelaiatura sot-tile di pilastri in ghisa che, ancorata ai muri peri-metrali per mezzo di travi binate, sorregge, tra-mite putrelle in ferro, dei solai costituiti dasemplici tavolati in legno36.Alcune analogie formali e tecnologiche pre-
senti nelle poche ma significative tracce di ele-menti metallici della manifattura dei Santi Apo-stoli con quelle superstiti della fabbrica di SanPietro, inducono a ritenere che a partire dalla rico-struzione di quest’ultima (1881-83) dopo l’incen-dio del 1880, i successivi interventi abbiano rispo-sto con maggiore sistematicità ad una comuneprogrammazione sia sul piano dell’adeguamentofunzionale e sia su quello del potenziamento tec-nologico degli impianti e deimodi di produzione.L’impianto dei Santi Apostoli sopravvisse
comunque alla chiusura di San Pietro per un altrodecennio, anche dopo l’inaugurazione dellanuova sede di Gianturco. Ancora nel 1962, inrisposta a una interrogazione parlamentare, nellaquale si chiedeva di mantenere in vita l’impiantoottocentesco per non aggravare ulteriormente la«pesantissima» condizione di disoccupazione dimolti napoletani, ilMinistero delle Finanze ricor-dava che la soppressione della manifattura deitabacchi dei Santi Apostoli era stata prevista condecreto presidenziale del 19 novembre 1961, mache in un’area a ridosso delle nuovemanifatture divia Galileo Ferraris era già stato predisposto unpiano di ampliamento per delocalizzarvi le lavora-zioni (e i lavoratori) della fabbrica ottocentesca37.La sua dismissione risale al 1970 e il progetto
di recupero architettonico e funzionale al 1972,quando il Provveditorato alle Opere Pubbliche,diretto dall’ingegnere PaoloMartuscelli, approvòil progetto finalizzato a trasformare quell’anticoconvento in una «eccezionale e “moderna” sedeper il Liceo Artistico» di Napoli.
Roberto Parisi
tabacchi:Layout 1 28-03-2012 17:54 Pagina 186
187
Ripristini conventuali e nuove archeologieda spoglio: manifatture in fumo?
La dimensione produttiva delle due manifat-ture napoletane appena descritte sembra final-mente entrata nella storiografia architettonica,uscendo dagli ambiti specifici della storia econo-mica e sociale. Tuttavia, per ragioni che andreb-bero indagate più a fondo, negli studi che hannoriguardato l’architettura delle due fabbriche napo-letane non è difficile constatare che lo spazio dellavoro è stato spesso restituito per frammenti e ciònon solo per l’assenza di sufficienti supporti docu-mentari.Paradossalmente, il vuoto più evidente che
caratterizza questi studi riguarda infatti il periodopiù recente e più propriamente industriale, dal-l’età giolittiana alla stagione del cosiddetto “mira-colo economico”, ovvero dai lavori successiviall’incendio che colpì la fabbrica di San PietroMartire nel 1880 alla graduale chiusura dei dueimpianti (1953-70).Eppure nonmancano contributi di storici eco-
nomici che hanno evidenziato dati e fonti di rife-rimento per possibili e proficui approfondimenti
anche in chiave storico-architettonica. Le statisti-che registrano ad esempio nel 1889 nei due stabi-limenti napoletani una produzione di 1.100.000kg di sigari e di 850.000 kg di trinciato ed unaoccupazione pari a 2216 addetti, numero che sep-pure inferiore agli operai su cui poteva contare lasola fabbrica di San PietroMartire alle soglie del-l’Unità, rendevano comunque il polo napoletanotra i più produttivi in Italia. Analogamente,intorno ai primi due decenni del Novecento, afronte di una graduale e progressiva diminuzionedegli addetti, è attestato un incremento degliimpianti ed un consistente passaggio dal vaporeall’elettricità. Tutti aspetti che ovviamente com-portarono rilevanti modifiche della strutturaarchitettonica e impiantistica e che, tuttavia, nél’indagine storico-documentaria, né l’opportunitàdi un approccio archeologico alle stratificazionipresenti nei due complessi manifatturieri, evi-denti nei rispettivi cantieri di restauro, hannomesso in evidenza.Sembra invece che, pur con una consapevo-
lezza differente rispetto alla lunga tradizione dei“falsi” restauri in stile, sia prevalso un atteggia-mento ancora discriminatorio sulla presenza di
Il tabacco aNapoli. Architettura e produzione nelle manifatture ottocentesche
Veduta dall’alto della manifattura tabacchi realizzata nel 1956 in via Gianturco a Napoli. Foto Roberto Parisi, 1996.
tabacchi:Layout 1 28-03-2012 17:54 Pagina 187
188
corpi strettamente funzionali alla produzione,rispetto a preesistenze che invece sono state con-servate in virtù «dei caratteri formali autentici edei molteplici stilemi propri del monumento»38e quindi nella logica di un recupero cheha«impo-sto di “smontare” gran parte di ciò che era statocostruito durante la fase di utilizzazione ottocen-tesca», compreso le «strutture di “archeologiaindustriale”»39.Non sono in discussione, naturalmente, la qua-
lità dell’intervento e le modalità di riuso dei duetabacchifici, quanto piuttosto l’uso equivoco deltermine “archeologia industriale” rispetto allereali finalità di questo specifico campo di studimultidisciplinare.Già in altra sede si è avuto modo di sottoli-
neare che la pratica del riuso è da considerarsiinnanzitutto comeparte integrante di quel dirittoinalienabile dell’uomo contemporaneo di abitarela Terra, manipolando, per la sua sopravvivenza,quanto si è stratificato in millenni di storia. Conriferimento ai temi dell’edilizia industriale storica,il riuso della fabbrica può dunque declinarsisecondo scale di valori e modalità anche moltodifferenti le une dalle altre. Non tutte natural-mente assecondano principi emetodi compatibilicon le istanze della conservazione e soprattuttodella trasmissione della cultura e della memoria
storica dei luoghi e degli uomini secondo un con-sapevole progetto storiografico. In teoria solo inquest’ultimo caso si dovrebbe parlare di patrimo-nializzazione delle testimonianze di archeologiaindustriale, trattandosi, negli altri casi, seppurelegittimi, di forme “altre” di rigenerazione, cheesulano dall’archeologia industriale, come dallastoria del patrimonio industriale.In un progetto storiografico che abbia come
finalità la trasmissione dellamemoria dello spaziodel lavoro, la riduzione della storia dell’ediliziaindustriale ad una selezione di reperti archeolo-gici è dunque una pratica difficile, dove il rischiodi perdersi in un processo di mistificazione di unpezzo importante del passato, anche relativa-mente recente, di una fabbrica è molto alto.Da questo punto di vista, la possibilità che una
storia delle manifatture napoletane del tabaccopossa trovare una forma di legittimazione ancheattraverso la recente ipotesi di recuperodell’ultimafabbrica superstite di via Gianturco, così come sipuò evincere dalle soluzioni costruite dalla Fin-tecna attraverso il gruppo di progettazioneMCA(Mario Cucinella Architects), appare sincera-mente ambiguo e poco condivisibile, forse nonsolo per quelle “tabacchine” che hanno vissuto il«secolo del lavoro»,ma anche per quelle personeche quel secolo non l’hannomai conosciuto.
Roberto Parisi
1 Sulle pratiche del riuso nella storia dell’edilizia italiana dicarattere produttivo non esiste ancora un percorso distudi ben delineato. Sul tema si veda GIANNI MEZZA-NOTTE, Infrastrutture e produzione nell’Italia napoleonica,inALDOCASTELLANO,ROBERTA SOMMARIVA (a cura di),Il Luogo del Lavoro. Dalla manualità al comando adistanza, XVII Triennale di Milano, catalogo dellamostra (Milano, maggio-settembre 1986), Electa,Milano 1986, pp. 65-72. Considerazioni e spunti utilisono in CARLO OLMO, Industria e territorio: il problemadell’edilizia industriale, in GIOVANNI PREVITALI, FEDE-RICO ZERI (a cura di), Storia dell’arte italiana, Einaudi,Torino 1983, vol. III, parte II, pp. 379-422.
2 Con decreto legge n. 282 del 24 dicembre 2002 si con-sentì all’Agenzia del Demanio di alienare un consistentepatrimonio dell’ETI Spa (Ente Tabacchi Italiani, creatonel 1998), che il 27 dicembre 2002 fu venduto a trattativa
privata alla Fintecna, società a capitale pubblico delgruppo ex IRI. Con quest’atto il destino di 26 immobili,tra i quali la manifattura napoletana, dei Monopoli diStato fu affidato alla Fintecna.
3 ALTO COMMISSARIO PER LA CITTÀ E LA PROVINCIA DI
NAPOLI (a cura di),Napoli. Le opere del Regime dal Set-tembre 1925 al giugno 1930, Napoli 1930, p. 100.
4 MONOPOLI DI STATO,La nuova Manifattura Tabacchi diNapoli “G. Ferraris”. Inaugurazione, Monopoli di Stato,Roma 1956. Sulla manifattura si veda ancora GENNAROSCOGNAMIGLIO, Lineamenti storici e attuali delle indu-strie di stato della provincia di Napoli, in Enciclopedia delcentenario. Contributo alla storia politica, economica, let-teraria e artistica dell’Italia meridionale nei primi centoanni di vita nazionale, D’Agostino,Napoli 1960, pp. 386-388; I nostri stabilimenti. LaManifattura Tabacchi ‘Gali-leo Ferraris’ di Napoli, in “Notiziario Monopoli”, n. 521
tabacchi:Layout 1 28-03-2012 17:54 Pagina 188
189
(luglio 1961), p. 11; ROBERTOPARISI,Lo spazio della pro-duzione. Napoli: la periferia orientale, Edizioni Athena,Napoli 1998, p. 157.
5 BEATRICE MELIS, ANTONIO ZEHENDER, Il restauro delcomplesso dei Ss.Apostoli inNapoli, Frati, sigari e infine arte,in “Architettura e/o architettura”, 1 (1984), pp. 15-17.
6 UNIVERSITÀDEGLI STUDI DINAPOLI FEDERICO II, S. Pie-tro Martire - Università degli Studi di Napoli, Arte tipo-grafica, Napoli 1983.
7 Sorto nel 1653, l’edificio«per la conservazione dei tabac-chi al largo della dogana [...] fu fatto costruire dal vice red’Ognatte per magazzino dei fabbricanti del tabacco.Questo genere dall’epoca del conte d’Ognatte divenne diprivativa del governo, che rendeva scudi 18mila annui, elo stesso conte d’Ognatte prognosticava che sarebbe dimolto aumentata questa rendita, perché fondata sulvizio». Cfr. FRANCESCO CEVA GRIMALDI, Della città diNapoli dal tempo della sua fondazione sino al presente,Stamperia e Calcografia, Napoli 1857, pp. 448 sg.
8 CARLOCELANO, GIOVANNI BATTISTACHIARINI,Notiziedel bello, dell’antico e del curioso della città diNapoli, 6 voll.,Stamperia Floriana, Napoli 1856-60, IV, pp. 277-282.
9 Sulle manifatture di Cava si veda BEATRICE SPARANO,Fumi& profumi. Storia del tabacco a Cava de’ Tirreni, DeRosa eMemoli, Cava de’ Tirreni 2004.
10 Nel 1890, in seguito alla realizzazione del nuovoimpianto militare di Fontana Liri, l’importanza del pol-verificio di Scafati cominciò a scemare, fino a quando, conregio decreto del 21 gennaio 1894, esso fu completa-mente dismesso e smantellato. L’anno successivo, conregio decreto del 17marzo 1895, e su progetto degli inge-gneri R. Sandri e G.C. Chelli, il polverificio fu trasfor-mato in Istituto Sperimentale e di tirocinio per la coltiva-zione del Tabacco, che, sotto la direzione di LeonardoAngeloni, fu attivo fino alla seconda guerra mondiale.Soppresso nel 1946, e ridotto ad azienda agricola, il com-plesso fu notevolmente rimaneggiato e riconvertito inIstituto Scientifico Sperimentale negli anni Settanta, mapoco tempo dopo, in seguito al sisma del 1980, fu defini-tivamente dismesso ed abbandonato. Cfr. LUIGI ANGE-LONI, Il Real Istituto per la coltivazione dei Tabacchi,Napoli 1900. Sul polverificio di Scafati si veda ROBERTOPARISI, Salnitriere e polveriere, in SALVATORE ABITA (acura di), Le armi al tempo dei Borbone, catalogo dellamostra (Napoli, giugno 1998), Edizioni Scientifiche Ita-liane, Napoli 1998, pp. 75 sg.
11 Sulla produzione di tabacco in Campania si veda SILVIODE MAJO, Coltivazione e trasformazione del tabacco inCampania dall’Unità d’Italia alla seconda guerra mon-diale, in “Proposte e ricerche”, n. 61 (2008), pp. 107-124.Sulle trasformazioni ottocentesche delle due fabbricheconventuali inmanifatture del tabacco si veda in partico-lare ROSALBA DE SANTO, Dal Chiostro all’opificio nellaNapoli dell’Ottocento: il riutilizzo di due antichi edificiconventuali nella Real Manifattura di Tabacchi, in“Napoli Nobilissima”, fascc. III-IV (2000), pp. 105-132.
12 Sull’impianto conventuale si veda GIUSEPPE COSENZA,La chiesa e il convento di S. Pietro Martire, in “Napoli
Nobilissima”, fascc. VIII e IX (1899); GAETANA CAN-TONE, Restauri antichi e nuovi nella chiesa di S. PietroMartire, in “NapoliNobilissima”, V (1966), pp. 220-232;GIULIOPANE, Il convento di S. PietroMartire, inARTUROFRATTA (a cura di), Il patrimonio architettonico dell’Ateneofridericiano, 2 voll., Arte Tipografica, Napoli 2004, I, pp.123-146.
13 C.CELANO,G.B.CHIARINI,Notizie del bello cit., pp. 277-282.
14Della Real Fabbrica de’ Tabacchi, in “Giornale del Regnodelle Due Sicilie”, n. 127 (15 giugno 1857).
15 ALFREDO BUCCARO, Opere pubbliche e tipologie urbanenelMezzogiorno preunitario, ElectaNapoli,Napoli 1992,pp. 20-22;MAURO VENDITTI,Gasse Stefano, inDiziona-rio Biografico degli Italiani della Treccani, s.v., vol. 52,1998, pp. 516-519.
16 R. DE SANTO,Dal chiostro all’opificio cit., p. 108.17Transaction of the Institute of British Architects of London,sessions 1835-36, London 1836, vol. I, p. VI.
18 A. BUCCARO, Opere pubbliche e tipologie urbane cit., pp.207-233.
19 VALENTINAMESSANA, Il Villaggio cotoniero svizzero nellaValle dell’Irno a Salerno, nel corso dell’Ottocento, in GRE-GORIO E. RUBINO (a cura di),Costruttori di Opifici /Mil-lwrights. Architettura del lavoro fra tradizione e innova-zione, Giannini, Napoli 2005, pp. 77-99.
20 Sulla figura di Alessandro Torlonia, con particolareriguardo alla sua attività imprenditoriale a Roma e nelloStato della Chiesa, si veda DANIELA FELISINI, “Quel capi-talista per ricchezza principalissimo”. Alessandro Torloniaprincipe, banchiere, imprenditore nell’Ottocento romano,Rubbettino, SoveriaMannelli 2004.
21 Torlonia ottenne l’appalto per ben 24 anni dal 1831 al1856. Cfr. CINZIA CAPALBO, Consumo e produzione deitabacchi in età moderna. Le vicende dello Stato pontificio,in “Proposte e ricerche”, n. 61 (2008), pp. 57 sg. Sull’atti-vità del Torlonia nel Mezzogiorno d’Italia si veda ancheROBERTO PARISI, ADRIANA PICA, L’Impresa del Fucino.Architettura delle acque e trasformazioni ambientali nel-l’età dell’industrializzazione, Athena, Napoli 1996.
22 D. FELISINI, “Quel capitalista per ricchezza principalissimo”cit., pp. 163 sg.
23 Cfr.GIUSEPPEBRUNO,RENATODEFUSCO,ErricoAlvino,architetto e urbanista napoletano dell’Ottocento, Napoli1962, pp. 86 sg. Vi è inoltre da sottolineare che Alvinoprogettò anche il sepolcro del Benucci nel quadrilaterodel cimitero di Poggioreale a Napoli. Cfr. CAMILLONAPOLEONE SASSO, Storia dei monumenti di Napoli edegli architetti che li edificavano dal 1801 al 1851, 2 voll.,Napoli 1856-58, II, pp. 184 sg.
24Decreto che naturalizza suddito del regno delle Due Sicilie,D. Domenico Benucci, romano, figlio di Saverio. (Napoli,25 Gennajo 1842), in Collezione delle leggi e de’ decretireali del Regno delle Due Sicilie, anno 1842, semestre I,Stamperia Reale, Napoli 1842, decreto n. 7497, p. 161.
25 TribunaleCivile diNapoli, Sentenza delCollegio arbitralenella causa fra Torlonia e Benucci, Napoli 1844.
Il tabacco aNapoli. Architettura e produzione nelle manifatture ottocentesche
tabacchi:Layout 1 28-03-2012 17:54 Pagina 189
190
26 Con riguardo alla creazione aNapoli di un “entrepot” peril porto commerciale si vedaR. PARISI,Lo spazio della pro-duzione cit., pp. 61 sg.
27 “Della Real Fabbrica de’ Tabacchi”, in “Giornale delRegno delle Due Sicilie”, n. 127 (15 giugno 1857).
28 G. PANE, Il convento di S. Pietro Martire cit., p. 136.29L’incendio alla fabbrica dei tabacchi, in “Il Giornale diNapoli”, n. 337 (2 dicembre 1880), p. 3.
30 Cfr. ALFONSO SCIROCCO, Il Mezzogiorno nella crisi del-l’Unificazione (1860-1861), SEN, Napoli 1981; GIOR-GIOCANDELORO, Storia dell’Italiamoderna, 11 voll., Fel-trinelli, Milano 1956-86. V. La costruzione dello statounitario 1860-1871, 1967.
31Decreto Luogotenziale del 28 novembre 1860, in Atti delGoverno. Estratti dal giornale officiale di Napoli, 1, 1860,p. 249. L’articolo 2 del decreto sanciva: «L’edificio sud-detto ritorna al Demanio ed è destinato ad uso dellaManifattura de’ Tabacchi».
32 VITTORIO SACCHI, Il segretariato generale delle finanze diNapoli dal 1 aprile al 31 ottobre 1861, Segretariato delleFinanze, Napoli 1861, p. 38.
33 Ibid., p. 39.34 A tale principio sembrano, ad esempio, sottendere le con-siderazioni esposte nell’ultimo studio sul progetto diAlvino per la riconversione del convento napoletano deiSanti Apostoli in Real Manifattura dei Tabacchi (cfr. R.DE SANTO, Dal Chiostro all’opificio nella Napoli dell’Ot-tocento cit, pp. 14 sg.). L’autrice di tale saggio – volendolegittimare «inequivocabilmente» l’attribuzione dellapaternità del progetto agli architetti E. Alvino, L. DellaCorte ed E. Benvenuto – non sembra cogliere nel docu-mento “probatorio” della propria tesi l’evidente conflittodi competenze creatosi tra la Direzione generale delleGabelle, rappresentata appunto dai succitati tecnici, el’Ufficio dei fabbricati pubblici del Genio Civile, direttoda FedericoTravaglini. Conflitto che, non a caso, indusse
il Ministero delle Finanze a riunire i quattro professioni-sti in un’apposita commissione di studio. Per il periodo1861-64 le dinamiche che caratterizzarono la prima fasedel progetto attribuito ad Alvino appaiono tutt’altro chechiare e necessiterebbero di ulteriori approfondimenti.(Su tale questione, a parte il breve cenno apparso inROBERTOPARISI,La città e l’industria: imprenditori, inse-diamenti produttivi ed Esposizioni di arti emanifatture, inCiviltà dell’Ottocento. Architettura e urbanistica, catalogodella mostra, Napoli 1987, p. 134, si veda R. PARISI, Lospazio della produzione. Napoli: la periferia orientale cit.,pp. 96-98.)
35 Qui torna utile il riferimento alle strette relazioni conl’ambiente politico-militare borbonico e postunitario checaratterizza la biografia dell’Alvino, e in particolare allecomplesse vicende della lottizzazione di via Pace aNapoliattraverso i due correlati progetti per il traforo del monteEchia e per il Palazzo Nunziante. Cfr. G. BRUNO, R. DEFUSCO,ErricoAlvino, architetto e urbanista napoletanodel-l’Ottocento cit., pp. 23-27 e 90-94; ALFREDO BUCCARO,Istituzioni e trasformazioni urbane nella Napoli dell’Otto-cento, Edizioni Scientifiche Italiane,Napoli 1985, pp. 226-230; ROBERTO PARISI, Luigi Giura 1795-1864. Ingegneree architetto dell’Ottocento, Electa, Napoli 2003, p. 45.
36 PAOLA GARGIULO, LEA QUINTAVALLE, L’industria dellapastificazione a Torre Annunziata e Gragnano, in CESAREDE SETA (a cura di), Manifatture in Campania, Guida,Napoli 1983, pp. 152-225, in particolare pp. 189 sg.
37 DOMENICO COLASANTO, Manifattura tabacchi SantiApostoli in Napoli, in “Atti parlamentari”, III legislatura,Camera dei deputati, seduta del 15 ottobre 1962,p. 11003.
38 B. MELIS, A. ZEHENDER, Il restauro del complesso dei Ss.Apostoli in Napoli cit., p. 17.
39 ROBERTODI STEFANO,L’intervento di restauro, in S. Pie-tro martire cit., p. 32.
Roberto Parisi
tabacchi:Layout 1 28-03-2012 17:54 Pagina 190














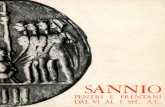











![Maranello e il suo territorio dalle origini all’alto Medioevo: due secoli di scoperte archeologiche, Milano 1996 [Donato Labate]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631f8d9663ac2c35640add5e/maranello-e-il-suo-territorio-dalle-origini-allalto-medioevo-due-secoli-di-scoperte.jpg)






