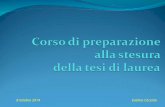Power point Tesi di Laurea Antropologia del patrimonio
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Power point Tesi di Laurea Antropologia del patrimonio
San Marco dei Cavoti si trova in provincia di Benevento, presenta un origine di notevole interesse . È da premettere che, nel territorio del comune ai tempi dei sanniti esisteva la città di “Cenna”, nella zona oggi denominata contrada Zenna, poco più a sud quando codesta era già distrutta da secoli, sorse il castello di San Severo (oggi contrada Santa Barbara) che rimase abitato fino alla metà del XIV; A causa di fenomeni avversi si spopolò completamente.
In seguito ad un editto di Carlo I d’Angiò la zona fu ripopolata grazie alla presenza di un ricco feudatario, Luigi Shabran che accolse quanti si vollero spostare attirandoli con larghe promesse di libertà e franchigie; fu così che un vasto gruppo di provenzali gli diede ascolto, correva l’anno 1356.L’etimologia richiama l’origine di coloro i quali vennero all’epoca ossia “dei Cavoti” che sarebbe l’equivalente di “provenienti della città di Gap”, (i gavots erano gli abitanti del borgo di Gap in Provenza). Toponomasticamente il paese è diviso in contrade, alcune ricordano la presenza dei provenzali: contrada Borgognone, contrada Francisi, contrada Franzese; ricordiamo anche l’antica “Torre dei Provenzali”, prima carcere poi trasformata in campanile della chiesa parrocchiale.
Sulle origini circa la fondazione di San Marco persistono ancora oggi miti che si tramandano oralmente di generazione in generazione risalenti addirittura a circa cinquecento anni fa. È ovvio che la storia di una città inizia sempre con la sua fondazione simbolica, mitica e rituale, questo è un aspetto chiave per comprendere la storia, le credenze su cui si basa il proprio tempo. Possiamo risalire alla fondazione mitica di un posto grazie ai racconti tramandati oralmente dalle persone più anziane.
La leggenda narra dell’arrivo dei soldati francesi presso questo piccolo centro abitato con l’intento di saccheggiarlo, lungo il percorso, però, nei pressi di San Marco trovarono un anziano seduto su una roccia che li fermò chiedendo loro dove fossero diretti, chiaramente il vecchio venne deriso e beffeggiato i cavalli invece, si inginocchiarono di fronte a tale uomo.
I soldati a seguito tale avvenimento erano rimasti perplessi dal comportamento degli animali, continuando il loro percorso entrarono in paese, il quale allora, molto probabilmente non si chiamava San Marco, visitando il posto persero la bellicosità e visitando una chiesetta, forse la prima a quell’epoca, tra le statue portate via da San Severo videro quella di San Marco. Chiesero ai cittadini quella statua chi rappresentasse rendendosi conto che era la stessa persona che li aveva fermati sul percorso al quale i cavalli si erano inginocchiati.
Era stata “l’apparizione miracolosa” di San Marco ai soldati. I paesani riconoscenti al santo diedero il nome al paese. I francesi poi si integrarono con la popolazione del posto.
Si diceva che le ginocchia dei cavalli avessero lasciato l’impronta sulla roccia nel luogo conosciuto come “morgia di Santu Marco”.
“La Festa dei carri” è una festa religiosa popolare a carattere rurale che si svolge annualmente a San Marco dei Cavoti la seconda domenica d’agosto in concomitanza con la festa della Madonna SS. del Carmine. La “festa” è nata come atto di ringraziamento per la raccolta annuale di grano attraverso un’offerta votiva di carri adorni di spighe. “Lo spazio paesano viene sacralizzato e affidato alla dimensione protettrice della santità per riaffermare il legame singolo-divinità, inoltre la festa si pone come mezzo di riaffermazione della propria identità, personale e di gruppo”
In passato, le contrade allestivano carri trainati da buoi e mezzi agricoli all’insegna della più pura tradizione contadina: gli addobbi, difatti consistevano in covoni di grano, che sfilavano numerosi per le strade del paese al seguito della statua della Madonna, rivestita dei monili facenti parte del suo tesoro.
L’allestimento di un carro richiede una certosina applicazione quotidiana per circa un mese, cui si dedicano gli attivi contadini e non; in genere sono i più anziani che illustrano e insegnano ai più giovani e spesso anche ai bambini, le tecniche per pulire e lavorare il grano, così l’addobbo del carro diventa anche un momento di confronto generazionale e di trasmissioni di usanze.
“La Festa dei carri è nata agli inizi del ‘700, quest’idea è suffragata da un fenomenometeorologico definito piccola glaciazione: secondo il popolo fu un annata in cui durante tuttoIl mese di luglio si ebbe pioggia continua e i
contadininon potevano “scognare” il grano; il grano era giàstato raccolto e depositato sulle aie pronto per latrebbiatura però la pioggia non permetteva lalavorazione, i contadini si rivolsero alla Madonnadel Carmine chiedendole il miracolo (la Madonna
delCarmine perché si festeggia a luglio)portandola in processione presso il ponte diSan Rocco a “porta di rose” le acque del torrentesuperavano le arcate del ponte, gli anziani
raccontanoche quando la Madonna giunse presso questo luogoimprovvisamente smise di piovere, attribuendo
questofenomeno a circostanze miracolose. Quindi da quell’evento in poi a San Marco è stataorganizzata la “Festa dei carri di grano” perché icontadini come segno di riconoscenza hanno
donatoparte del loro raccolto alla Madonna, la festa prima
siorganizzava in maniera grossolana, poi in manierasempre più organizzata”
Riguardo il concetto di “Festa”, il termine assume vari significati e la sua valenza è mutata nel corso dei secoli. Filosofi, letterari e studiosi nel corso del tempo hanno esposto il loro pensiero in base alla “Festa”, alla “Festività e al “Tempo Festivo”. Già nell’antica Roma esistevano dei cicli festivi religiosi dedicati al dio Saturno.I famosi “Saturnali” avevano inizio con fastosi banchetti durante i quali ci si scambiavano auguri e doni. Durante questi festeggiamenti l’ordine sociale veniva sovvertito: gli schiavi diventavano uomini liberi e come tali potevano comportarsi.
Per la mentalità razionalista, la festa è un attività e una forma di associazione non motivata dall’utilità e perciò intrinsecamente sovversiva. La festa sembra riassumere tutto ciò contro cui si battono i philosophes: la pigrizia, lo spreco, la superstizione, il vizio, l’ignoranza, il fanatismo, l’entusiasmo… Per Voltaire, sono senza dubbio gli osti che hanno moltiplicato prodigiosamente il numero delle feste, ad uso soprattutto della religione dei contadini e degli artigiani, che conoscono il solo culto di ubriacarsi il giorno di un santo. È in quei giorni di ozio e di dissolutezza che tutti i delitti vengono commessi. Per Voltaire quindi, sono le feste che riempiono le prigioni e fanno vivere i cancellieri e i boia.
Per Rousseau togliendo al popolo le feste, gli si toglie la voglia di vivere e perciò si elimina la motivazione stessa del lavoro. Soprattutto si isolano gli individui rendendoli cattivi, si eliminano le occasioni che promuovono la socievolezza e perciò si distruggono le basi della società.
Secondo Freud una festa è un eccesso permesso, anzi offerto, l’infrazione solenne di un divieto. Gli uomini si abbandonano agli eccessi non perché siano felici per un qualche comando che hanno ricevuto. Piuttosto l’eccesso è nella natura stessa di ogni festa; l’umore festoso è provocato dalla libertà di fare ciò che è altrimenti proibito: è il caos dal quale si genera l’ordine sociale delle cose.
In un famoso saggio Mauss mostra che alle due stagioni che ritmano la vita eschimese corrispondono due forme di associazione. Durante l’estate i gruppi sono dispersi, l’intensità dei legami sociali è ridotta al minimo, i rituali sono scarsi e di natura privata. Al contrario, durante l’inverno la popolazione si concentra, i rapporti e gli scambi si intensificano, la vita religiosa è ricca e di natura collettiva. «Ci si può…rappresentare tutta la vita invernale come una specie di lunga festa».
per Durkheim, la commemorazione festiva è efficace perché è una riproduzione reale, non solo simbolica, della genesi dell’ordine sociale. La festa deve essere definita come il «parossismo della società» che purifica e contemporaneamente rinnova.
La “Madonna del Carmelo” riceve questo titolo a seguito delle apparizioni legate al Monte Carmelo che si trova in Palestina. In questo posto leggendario avvenne l’apparizione mariana a San Simone Stock, al quale la Madonna gli rivelava il privilegio dello scapolare: ossia quanti si fossero spenti indossandolo sarebbero stati liberati dalle pene del purgatorio il sabato successivo alla loro morte con la seguente promessa: «Questo è il privilegio per te e per i tuoi: chiunque morirà vestendolo, sarà salvo» San Simone Stock, secondo la tradizione si ritirò come eremita sotto un albero di quercia dove predicava (forse proprio da qui l’appellativo “stock” che in inglese vuol dire tronco di albero). Dopo un pellegrinaggio in Terra Santa maturò l’idea di entrare a far parte dell’ordine dei Carmelitani; andò a Roma per studiare, ove ricevette i voti del sacerdozio. Diventato Priore generale dello stesso Ordine, si mobilitò per attuare una riforma facendone un Ordine mendicante.
La “Congrega di Maria SS. Del Carmine e Monte dei Morti di San Marco dei Cavoti” fu costituita e riconosciuta con Real Assenso del 31-03-1752 emanato da Carlo III di Borbone.
Le regole del vecchio Statuto si differenziano da quelle annotate nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Benevento in data 12-08-1987.
Il Nuovo Statuto porta dei cambiamenti, come la possibilità alle donne di entrarne a far parte e l’innalzamento dell’accesso al diciottesimo anno d’età. L’ammissione è riservata ai cattolici osservanti e che non abbiano subito condanne per delitti o di particolare gravità, tale domanda deve pervenire per iscritto al Priore che deciderà, tramite Consiglio, l’eventuale accesso.
Ogni membro deve pagare una retta annua e qualora voglia dimettersi deve inviare lettera scritta al Priore tre mesi prima la scadenza dell’anno. Il testo è stato svecchiato e semplificato, gli scopi della Confraternita sono essenzialmente tre:
-L’esercizio collettivo della pietà verso il prossimo, specialmente per i Confratelli;
-Provvedere al culto e alla gestione della Chiesa per la quale la Confraternita è nata;
- Le onoranze e i suffragi dei Defunti. Anche le figure amministrative e i
relativi compiti sono diminuiti: la Confraternita è amministrata dal Priore e da quattro Consiglieri, è diretta spiritualmente dal Padre Spirituale nominato dal Vescovo.
I soci eleggono il Priore, i quattro Consiglieri ed il Segretario Tesoriere, il voto è segreto ed è necessaria la maggioranza dei 2/3, il Consiglio ha mandato triennale ed è rieleggibile; il Priore convoca i soci almeno una volta l’anno per illustrare l’attività svolta e il bilancio consuntivo.
Il grano oltre ad essere materia prima di grande importanza per il sostentamento e il fabbisogno alimentare di ognuno di noi è una preziosa fonte che regola l’economia dei paesi a carattere agricolo di tutte le culture del mondo.Da un punto di vista simbolico, la pianta del grano simboleggia il ciclo delle rinascite, poiché il cereale prima di nascere in primavera resta sotto terra per tutto l’inverno: è l’analogia del passaggio dell’anima dalle tenebre alla luce. .
Il grano inoltre è simbolo di fecondità: nella mitologia greca, Demetra veniva rappresentata con una corona di spighe di grano attorno alla fronte, inoltre era l’iniziatrice dei misteri eleusini, che conferivano una sorta di noviziato, in questi misteri le cerimonie erano collegate al movimento degli astri e quindi al ciclo delle stagioni. Il ciclo vita-morte collegato al grano traspare anche, con egual significato, nell’immagine di Osiride, dio egiziano dei cereali e della morte.
Il grano in semi è sentito come una metafora visibile e concreta: da un lato il suo aspetto inerme, la sua morte apparente, dall’altro la potenza di vegetale racchiusa in esso lo identifica come fonte di vita, territorio di nessuno nella frontiera tra il vivere e il morire: morendo, infatti, si moltiplica. Nella Bibbia molti sono i passi che fanno riferimento al grano: Il pane ottenuto dal grano diventa il corpo stesso di Cristo e, con il vino, il suo sangue, simbolo eucaristico per eccellenza. ”. In ambito antropologico questa può essere definita una pratica teofagica, dove il credente mangia il corpo della propria divinità per acquisire valore e magari inglobare le sue qualità.
Numerose sono le tradizioni in cui il grano viene utilizzato per propiziare la fecondità delle giovani coppie di sposi. In India, dopo la prima notte di matrimonio, la madre del marito, insieme con tutti i parenti, pone sul capo della sposa una misura di grano. In Corsica, invece, le donne di casa, allontanati uomini e bambini, fanno sedere la sposa su una misura di frumento. Il grano dunque simbolo di Fertilità, di Abbondanza ma anche di Fecondità.
Con la costruzione dei carri di grano avviene la “concretizzazione del rapporto col sacro. Il lavoro manuale richiede tanto tempo e tanta precisione dove le famiglie si incontrano presso una singola abitazione per allestire il carro rappresentante la propria contrada. Spesso il lavoro avviene anche la notte, nelle ultime settimane, prima della presentazione il giorno della festa. I carri di grano sono lavorati con tecniche molteplici: intrecci, stirature, composizioni varie, la pianta viene utilizzata interamente, dal chicco allo stelo, fino alla spiga per ottenere un risultato degno di essere chiamato “opera d’arte”. La contrada vincente otterrà il palio con l’immagine della Madonna del Carmine per un anno e il carro sfilerà nuovamente l’anno successivo.
La suddivisione del territorio in contrade, nell’ambiente rurale, risale ai tempi della fondazione (se non prima) ed è diversa dall’idea di quartiere che possiamo percepire in un ambiente urbano. A San Marco dei Cavoti, come in tutte le società agricole, i rapporti di vicinato, dove la vicinanza è relativa, poichè una masseria può essere distante l’una dall’altra anche più di 500 mt, sono molto più sentiti che in città dove due abitazioni o appartamenti che siano, sono divisi da una semplice e sottile parete.
Le famiglie durante l’anno collaborano tra di loro nei lavori dei campi, per la raccolta del fieno o per la lavorazione del tabacco, si scambiano prodotti della terra, animali e conserve. Ognuna è legata all’altra non solo da rapporti di parentela, amano riunirsi e festeggiare con banchetti e incontri conviviali che rafforzano e riaffermano i legami alla base della società.
La festa e tutto ciò che ad essa afferisce coinvolge, seppur su piani e in gradi diversi, tutti gli individui delle comunità. La festa tradizionale è un luogo dove non vi sono attori e spettatori. Tutti i componenti della comunità, senza differenza di status, genere, classe d’età, fanno parte della rappresentazione. In una qualche misura tutti hanno un ruolo attivo nella festa. Essa non è infatti solo “il giorno di festa”, la processione del santo, il banchetto comunitario, il giuoco ritualizzato, ma anche e soprattutto la sua organizzazione: preparazione di cibi, cura dell’abbigliamento, dei simulcri, dei paramenti, preparazione degli addobbi, etc. ogni gesto volto, insomma, a generare il cosiddetto “clima di festa”. Per Gadamer “assistere” significa “partecipare”, essere coinvolti fisicamente ed emotivamente alla drammatizzazione cerimoniale anche nella misura in cui «Chi ha assistito a qualcosa, è chiaramente al corrente di come essa si sia svolta veramente.
La seconda domenica di agosto il paese si sveglia di buon ora con il rumore dei botti e la musica della banda che gira per il paese: la “Festa dei carri” ha inizio! Il clima sale all’ennesima potenza e subito, all’arrivo dei carri, trainati da trattori, i primi curiosi accorrono per vedere i temi trattati dalle varie contrade.
Nell’analisi antropologica, durante le feste, i botti e i fuochi pirotecnici rivestono un ruolo simbolico: essi, si dice, che siano propiziatori, affinché gli spiriti maligni possano essere allontanati dallo spazio sacralizzato. Inoltre uno degli elementi che contraddistingue l’atmosfera festiva è dato dalla luce, infatti, la luce nelle sue varie forme, è parte integrante della festa, esse esaltano l’aspetto visivo costituendo, immagini efficaci che danno risalto allo spazio e lo dilatano. Rispetto al paesaggio circostante, permettono, la vista del paese anche da lontano, delimitandolo dalle altre zone scandendo così, lo spazio rituale.
La parata dei carri ha inizio prima di mezzogiorno preceduta dalla statua della Madonna del Carmine ricoperta con l’oro del “tesoro della Confraternita” (la quale viene portata temporaneamente nella Chiesa Madre): il percorso ha inizio dalla parte inferiore del paese fino a quella superiore per fare ritorno a Piazza Risorgimento.
La processione completa, che avviene di sera, ha carattere strettamente religioso, dove si lascia maggiore spazio alla preghiera; tutto ha inizio dalla Chiesa del Carmine passando subito per il ponte di Porta di Rose, luogo in cui avvenne il miracolo. La Madonna è preceduta dai membri della Confraternita e seguita dall’Amministrazione Comunale in prima linea, poi dai devoti divisi a coppie a due file ai lati. I carri di grano in questa circostanza appariranno solamente alla fine della processione per accogliere la Madonna al suo rientro in chiesa; tutto si concluderà con una messa all’aperto.
Numerosi sono i devoti, sammarchesi e non, che prendono parte a questo momento emozionante, dove si respira un clima di solennità e catarsi.
L’aspetto ludico della festa riprende il giorno successivo : premiazione e consegna del palio, spettacolo musicale e fuochi d’artificio sono i tre elementi che caratterizzano la “Festa dei carri di grano” a San marco dei Cavoti dalla nascita della festa stessa.
I cambiamenti di una festa nel corso del tempo sono ovvi e necessari in quanto tutto ciò che è culturalmente detto è soggetto a mutamento ed evoluzione; niente è statico ed immutabile: tutto cambia. La storia, la realtà socio-economica, la politica, la globalizzazione sono tutti elementi da prendere in considerazione quando si analizza antropologicamente una società.
Nella prassi le feste si incontrano con uomini sempre diversi e con nuove idee, tanto che per Lanternari ‘diventa fuorviante ogni pretesa di individuare significati fissi e immobili nello sviluppo di ciascun evento festivo.
Ma cos’è la tradizione e perché dovrebbe essere conservata? Per Lenclud la tradizione è qualcosa di antico, che si suppone essersi
conservato per lo meno relativamente immutato e che, per certe ragioni e secondo certe modalità, sarebbe stato oggetto di transfert in un nuovo contesto. La tradizione sarebbe dunque l’antico che persiste nel nuovo.
La tradizione è la rappresentazione di un contenuto che è portatore di un messaggio importante, culturalmente significativo e dotato di una forza agente, di una predisposizione alla riproduzione. A caratterizzarla non sarebbe solo il fatto di essere trasmessa, ma il mezzo con il quale è stata tramandata. Il termine “tradizione” deriva dal latino traditio, che designa non una cosa trasmessa quanto l’atto di trasmettere. Si può dire che è tradizionale ciò che passa di generazione in generazione per una via essenzialmente non scritta ma tramite la parola e l’esempio.
Gli aspetti della “Festa dei carri” che nel corso del tempo sono cambiati sono essenzialmente tre dettati, per l’appunto, dal cambiare dei tempi: i carri sono diventati delle vere e proprie opere d’arte, essi vengono trainati dai trattori, non più dai buoi (segno che la meccanizzazione ha fatto il suo corso) e la processione della Madonna avviene nel tardo pomeriggio.
Cambiano i comitati festa, le persone e le idee, l’aspetto ludico come si vuol dire, ma il vero senso della “Festa dei carri” rimane: essa è segno di devozione alla Madonna del Carmine.
Il rilevamento dei beni DEA, comporta anzitutto il loro riconoscimento all’interno delle comunità locali che li esprimono e li riproducono, un particolare impegno da parte di chi li studia a causa della loro natura spesso “volatile”, eventi unici e irripetibili, osservabili soltanto mentre vengono eseguiti. Tuttavia non tutto può coincidere nella patrimonializzazione dei beni DEA in modo scontato.
L’ UNESCO già dal 1989 ha cominciato ad affrontare in modo serio e impegnato la questione della salvaguardia della “cultura tradizionale e popolare” quale parte del patrimonio mondiale dell’umanità attraverso la “ Recommendation for the Safeguarding of Traditional and Popular Culture”, emessa in occasione della XXV Conferenza generale. In questo documento viene riconosciuta la «fragilità estrema di certe forme della cultura tradizionale e popolare, particolarmente quelle concernenti gli aspetti che provengono dalle tradizioni orali e il rischio che questi aspetti possano andare perduti».
È da ricordare la Dichiarazione universale sulla diversità culturale , adottata nella XXXI Conferenza generale dell’UNESCO, in essa si afferma che la diversità culturale è patrimonio condiviso dell’umanità ed è necessaria per il genere umano come la biodiversità lo è per la natura.
L’immensa premessa serve a tirare fuori delle conclusioni progettuali corpose ed ipoteticamente fattibili nel caso della “Festa dei carri di grano” trattata in oggetto: una costituzione di un museo, o meglio ancora, di un ecomuseo.
L’“ecomuseo”, a differenza del museo, ha come preciso orientamento, per l’attività, il carattere essenziale e organico del rapporto di questa istituzione con il suo territorio, con l’ambiente e con la popolazione, e insiste sul coinvolgimento attivo di quest’ultima . Infatti, la progettazione e costituzione dei musei etnografici e locali, come pure delle mostre e rappresentazioni dei mestieri, non sarebbe il prodotto di interventi dall’esterno e dall’alto, piuttosto un’iniziativa comunitaria fatta di creatività. Con De Varine, avviene la democratizzazione del museo, quello che avviene è la possibilità di mettere in risalto il patrimonio culturale come risorsa per uno sviluppo duraturo , sostenibile e condiviso, intendendo con “patrimonio culturale” quello della comunità.
La proposta della costruzione di un “ecomuseo” a San Marco dei Cavoti rispecchierebbe quello che Hugues De Varine idealizza in “Il museo al servizio dell’uomo e dello sviluppo” dove la comunità dovrebbe diventare attrice dello sviluppo: organizzando le attività culturali, prendendone parte attivamente affinché il museo diventi “vivo”.
Alla base di questa nuova museologia c’è la convinzione profonda che il museo, per ritornare a essere utile alla comunità, deve evolversi e trasformarsi al pari della comunità stessa: per questo i musei, o meglio, gli ecomusei, non possono riguardare solo il passato e non possono essere gestiti da figure portatrici di saperi inaccessibili: è la comunità che decide cosa salvare.
L’idea sarebbe quella di progettare un ecomuseo dove oltre ai beni materiali costituiti da attrezzi ed utensili legati al lavoro del grano, dalla semina alla raccolta, prima della meccanizzazione, ci siano anche computer all’avanguardia dotati di archivi digitali, di video e foto legati alla “Festa dei carri di grano”, interviste e percorsi guidati da coloro i quali “sono la festa”: persone di ogni età che accompagnano il visitatore alla scoperta della loro realtà che è attiva, viva ed interagisce con le altre comunità.
L’antropologo che si colloca nella scena italiana dell’antropologia del patrimonio si colloca in questa rete di operazioni complesse e mette in evidenza le poetiche e le politiche di una antropologia che opera nel contesto pubblico, che tratta con gli amministratori, che valorizza forme culturali, che produce negoziazioni sul significato e le incorpora nelle mostre, che promuove ricerca sulla memoria, sulla cultura locale, sul territorio in forme spesso collaborative.
L’antropologia del patrimonio si configura come una disciplina specialistica a sostegno delle pratiche e del discorso sul patrimonio culturale, competente rispetto ad un tipo particolare di beni (quelli “etnografici”, “folklorici”, materiali o volatili che siano), e con un rapporto ambivalente nei confronti delle discipline storico-artistiche: la dolorosa consapevolezza di giocare il ruolo dei “cugini poveri”, da un lato, e dall’altro la convinzione di rappresentare una raffinata avanguardia, in virtù di un uso più complesso concetto di cultura.
La concezione di patrimonio culturale dovrebbe essere plasmata, come afferma Palumbo, secondo un contesto politico nazionalista: l’idea di un corpus di beni intesi come possesso inalienabile di una comunità, organici al territorio e alla tradizione, nei quali sarebbero depositate le memorie storiche, i valori e in definitiva l’identità collettiva.
I riti, le feste e le rappresentazioni che hanno come protagonista il grano sono molteplici e attraversano la nostra penisola da nord a sud. Similitudini di una tradizione: tradizione legata alla “terra” nel senso stretto del termine seppur in luoghi diversi e a distanze evidenti. Nel caso di San Marco dei Cavoti, nel luglio 2013, è avvenuto il gemellaggio con la “Festa del grano” di Jelsi (CB) dove le comunità si sono promesse le dovute compartecipazioni con lo scambio di alcuni doni.
Mi sono proposta di tracciare un percorso, regione per regione alla ricerca delle “feste” legate al grano in onore di Santi e Madonne, ai processi che ne caratterizzano la lavorazione e alla sua esaltazione.
Piemonte: Rodello (CN) “Festa del grano” dal 1 all’11 agosto in concomitanza con
la festa patronale di San Lorenzo. Lombardia: 1. Guinzano Giussago (PV) “Festa del grano” l’ultimo week-end di giugno,
http://www.festadelgrano.com Veneto: 1. Villamarzana (RO) “Festa del grano” l’ultimo week-end di giugno e
prima settimana di luglio. 2. Quinto di Treviso (TV) “Festa della trebbiatura” l’ ultimo week-end
di giugno. Emilia Romagna: 1. Olmo (RE) “Festa del grano” le prime due settimane di agosto,
http://www.festadelgranoolmo.it Toscana: 1. Lecore (FI) “Festa della battitura del grano” la prima settimana di
luglio. 2. Montemurlo (PO) “Festa del grano” gli ultimi due sabati di giugno. Marche: 1. Campocavallo di Osimo (AN) “Festa del covo” la prima domenica di
agosto in onore della Beata Vergine Addolorata, http://www.festadelcovo.it
2. Rapagnano (FM) “Festa del grano” la prima domenica di agosto in onore di San Giovanni Battista, patrono del paese.
3. Spinetoli (AP) “Festa del grano” la seconda domenica di luglio. Abruzzo: 1. Manoppello (PE) “Festa del grano” la prima settimana di agosto. 2. Notaresco (TE) “Festa del grano” il primo week-en di di luglio. 3. Dogliola (CH) “Festa del grano” alla fine di luglio in onore di San Rocco. Umbria: 1. S. Angelo di Celle (PG) “Festa del grano” fine giugno inizio luglio. Molise: 1. Jelsi (CB) “Festa del grano” il 26 luglio in onore di Sant’Anna, http://www.festadelgranojelsi.it/ Campania: 1. Foglianise (BN) “Festa del grano” il 16 agosto in onore di San Rocco, patrono del paese 2. San Marco dei Cavoti (BN) “Festa dei carri di grano” seconda domenica di agosto in onore della Madonna
del Carmine. 3. Colle Sannita (BN) “Festa dei carri di grano” prima domenica di agosto in onore della Madonna del
Carmine. 4. Faicchio (BN) “Festa del grano” l’ultima settimana di giugno. 5. Casalbore (AV) “Festa del grano” il 2 agosto. 6. Flumeri (AV) “Il Giglio di Flumeri” 15 agosto in onore di San Rocco. 7. Fontanarosa (AV) “Il Carro di Fontanarosa” 15 agosto in onore della Madonna Assunta. 8. Mirabella Eclano (AV) “Il Carro di Mirabella Eclano” il sabato che precede la terza domenica di
settembre in onore della Madonna Addolorata. Puglia: 1. Rutigliano (BA) “Festa del grano” il primo week-end di luglio. 2. Ginosa (TA) “Festa del grano” la metà di agosto. 3. Troia (FG) “Festa del grano” il primo week-end di agosto Calabria: 1. Lattarico (CS) “Festa del grano” il terzo week-end di agosto. Sicilia: 1. Raddusa (CT) “Festa del grano” dal 6 all’8 settembre.