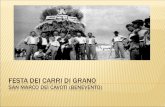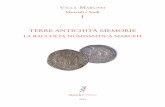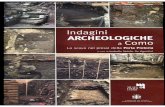Corso di Laurea: Scienze dello sviluppo e della cooperazione ...
LE MONETE DELLO SCAVO DEL CONDOTTO IDRICO DI CLASSE (tesi laurea magistrale 2014, unpublished)
-
Upload
mondodomani -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of LE MONETE DELLO SCAVO DEL CONDOTTO IDRICO DI CLASSE (tesi laurea magistrale 2014, unpublished)
1
Indice
Introduzione 2.
CAPITOLO I
Il contesto archeologico: il condotto idrico di Classe 3.
I. Le fasi di vita del condotto e i materiali 4.
II. Conclusioni alla luce dei nuovi ritrovamenti 7.
CAPITOLO II
L'evoluzione del sistema monetale dall'età tardo antica all'alto medioevo 12.
I. Le riforme e l'instabilità della moneta bronzea nel IV e V secolo d.C. 13.
II. Dalla riforma di Anastasio a Giustiniano 15.
III. L'Alto Medioevo 17.
CAPITOLO III
Le monete dal condotto 19.
I. Esemplari del I secolo d.C. 21.
II. La diffusione della moneta nell'epoca degli Antonini 22.
III. Dall'antoniniano al "follis" 24.
IV. Problemi di circolazione monetale nel territorio di Ravenna tra IV e V secolo d.C. 29.
V. Le emissioni di Ricimero 46.
VI. Le imitazioni di V secolo d.C. 52.
Conclusioni 55.
CATALOGO 56.
2
Introduzione
L'obbiettivo di questo lavoro è lo studio critico delle monete recuperate dal condotto idrico di
età romana di Classe. Si è cercato di ricostruire le fasi di vita del condotto di Classe, sulla base
di precedenti studi effettuati sui materiali archeologici rinvenuti nei vari pozzetti d'ispezione,
disseminati lungo il condotto. Si è cercato di contestualizzare il materiale numismatico,
rinvenuto all'interno di in un'area geografica di più ampia: l'area ravennate e altri siti
romagnoli. Lo studio riguarda i nominali bronzei: si è pertanto illustrata l'evoluzione del
sistema monetale del mondo romano dalla fine del III al V secolo d.C.; evidenziando i
mutamenti della moneta negli ultimi due secoli di vita dell'impero. Nell'ultimo capitolo sono
state presentate le monete rinvenute nei pozzetti 2 nord e 8 sud del condotto idrico, cercando
di tracciare attraverso di esse una storia della circolazione monetale dell'area ravennate.
Particolare attenzione inoltre è stata posta al V secolo, periodo in cui Ravenna diventa sede
della corte imperiale; evidenziando in particolare le emissioni del magister militum Ricimero.
Infine viene affrontato il problema delle imitazioni, in particolare del tipo con la croce greca,
alla luce della loro presenza all'interno del condotto idrico. Questo lavoro è stato affrontato
consultando la bibliografia esistente in materia e analizzando le differenti tesi proposte dai
numismatici in rapporto ai problemi discussi. Sono state fatte delle analisi quantitative sulle
evidenze numismatiche nell'area di interesse: autorità emittenti rappresentate , i tipi monetali
più diffusi e imitati, le zecche rappresentate. Lo studio ponderale e metrologico delle monete
bronzee è uno degli argomenti più discussi per comprendere la funzione della moneta, in
particolare nella parte Occidentale dell'impero in età tardo antica.
3
CAPITOLO I
Il contesto archeologico: il condotto idrico di Classe
Nell'area a sud di Ravenna sorgeva Classe, che raggiunse la dignità di città soltanto agli inizi del
V secolo d.C., quando nel 402 la corte imperiale romana si spostò a Ravenna e dotò il sobborgo
di mura, di un nuovo porto, e di una serie di monumenti. L'organizzazione di questo territorio
in età precedente non è stata completamente compresa, sappiamo che in quest'area
suburbana erano presenti diverse ville, necropoli e un porto voluto dall'imperatore Augusto1.
La nascita del condotto idrico in questione è ipotizzabile in un momento di risistemazione e
razionalizzazione dell'area classense, tra la metà e la fine del II secolo d.C.2 Nel 1984, durante i
lavori di controllo in un'area marginale delle necropoli, all'interno di una lottizzazione, a est
della Via Romea Vecchia, poco oltre la linea delle mura antiche di Classe, venne individuato un
condotto idrico. Questa zona in antico venne tagliata da uno scasso per far posto al condotto
in oggetto; largo più di 6 metri in superficie e profondo circa 5 metri dal piano di calpestio
antico (circa 7 metri da quello attuale). Lo scasso provocò lo smottamento delle pareti
sabbiose con conseguente collasso al suo interno delle sepolture presenti; successivamente
dopo la costruzione dell'opera vennero sovrapposte altre sepolture. Furono individuati una
serie di pozzetti che servivano per l'ispezione del condotto; nel 1987 iniziarono i lavori
(tutt'ora in corso) di recupero dei materiali giacenti all'interno dei pozzetti, grazie all'aiuto di
sommozzatori esperti e al nascente gruppo di volontari del G.R.A. (gruppo ravennate
archeologico). Grazie a delle sonde penetrometriche si è riusciti a stimare la lunghezza del
condotto di almeno 389 metri; esso era costruito lungo la linea antica di costa. Il condotto
sembra terminare a Nord in un invaso vallivo con sponde regolarizzate in muratura e presenta
una pendenza da Sud verso Nord di circa 30 centimetri. A Sud invece sembra originare da un'
area in cui sono state intercettate delle macerie riferibili forse ad una grossa struttura. Il
condotto stesso è costruito interamente in muratura, per lo più in laterizi della dimensione di
1 CIRELLI 2013, pp. 109-111.
2 MAIOLI 1989-1990, p. 14.
4
circa 30 x 45 cm, la larghezza esterna del condotto è di 1,62 m e l'altezza è di 1,75 m. Le misure
interne sono invece 65 cm per la larghezza e di 1,55 m per l'altezza; la copertura è a cupola e si
poggia su muri laterali di circa 50 cm lasciando una rientranza di 15 cm a 1,11 m dal fondo. La
conferma che i pozzetti ritrovati avessero una funzione di ispezione è data dalla mancanza di
mattoni ad intervalli regolari all'altezza delle aperture; servivano per l'alloggiamento dei piedi
di coloro che erano deputati alla manutenzione del sito. I pozzetti a tutt'oggi scoperti sono una
quindicina con una distanza tra loro di 16 metri e si presentano come strutture in muratura a
pozzo con un imboccatura di 60 x 50 cm. L'esplorazione del condotto ha portato allo scoperto
una quantità enorme e interessante di materiale; esso si presenta raggruppato in una serie di
crolli a forma di cuneo all'altezza di ogni pozzetto e si va diradando allontanandosi da essi.
Inoltre la conduttura oggi è completamente allagata fino alle bocche dei pozzetti, invece
quando era in funzione, l'acqua lo riempiva probabilmente in modo parziale. Ciò è spiegabile
col fenomeno della subsidenza che interessa l'area classense.
I. Le fasi di vita del condotto e i materiali
Gli accumuli di materiali rinvenuti hanno permesso di individuare varie fasi di vita del
condotto: una prima fase che va fino al III secolo d.C. in cui il condotto è stato costantemente
oggetto di regolare manutenzione3. I reperti ritrovati per questo periodo, infatti, sono molto
piccoli e potevano essere stati il frutto di occasionali smarrimenti: chiavi, strumenti d'uso,
oggetti da tavola in vari metalli, fibule, due piccoli oggetti in avorio, monete e pedine in osso (è
probabile che le bocche dei pozzi avessero delle coperture almeno parzialmente aperte).
Verso la fine del III secolo d.C. i pozzi iniziano ad essere utilizzati per lo scarico di materiale;
sono state trovate: ceramiche d'uso quotidiano, due coppe in vetro, piccoli oggetti in osso,
dadi e aghi crinali. La seconda fase di vita della conduttura corrisponde ad un probabile
periodo di abbandono quando fu adibita a discarica. Questa situazione è abbastanza simile a
quella documentata nelle aree vicine, dove si riscontra una situazione generale di collasso
delle strutture4. I materiali assegnati a questa seconda fase sono resti di vegetazione unita a
carcasse di animali gettati all'interno del condotto, a volte interi, come testimonia la numerosa
3 MAIOLI 1989-1990, p. 17.
4 ibidem.
5
presenza di cani; altri resti animali (capre, pecore e polli) sembrano essere stati gettati come
scarti di macellazione: teste intere, o solo parti dell'animale forse già parzialmente
decomposte. Inoltre sono stati rinvenuti i resti della parte posteriore di un cavallo,
sicuramente disarticolato per poter entrare in uno spazio così angusto; è presente inoltre
microfauna locale: rane, topi, tartarughe e un grifone (rapace che si nutre di carcasse, forse
morto accidentalmente mentre si nutriva di qualche carogna)5. Il condotto ha restituito anche i
resti di due infanti a testimonianza ulteriore del degrado della zona in questo periodo,
evidentemente furono deposti senza il bisogno di una sepoltura. L'ambiente anaerobico ha
permesso la conservazione anche di molti oggetti in legno: contenitori per l'acqua e piccoli
attrezzi per la navigazione. Molti sono anche i semi e i frutti che permettono una ricostruzione
generale sia della flora locale che delle coltivazioni presenti in loco. Questa fase di abbandono
è ascrivibile al IV secolo d.C. alla luce anche dei gruppi di sigilli plumbei ritrovati nel pozzo 2,
quasi alla sommità del deposito archeologico di questo periodo. I sigilli con sigla "DN CR"
vengono assegnati a Crispo (figlio di Costantino), divenuto Cesare nel 317 e morto nel 326. Il
condotto nella sua terza ed ultima fase di vita ha restituito una grande quantità di materiali in
ottimo stato di conservazione, per la maggior parte provenienti dalla parte alta del cumulo:
una serie di vasi in terracotta caduti l'uno sull'altro. I vasi che hanno le caratteristiche peculiari
della ceramica da cucina e d'uso comune si sono conservati quasi tutti intatti ad eccezione di
qualche esemplare frammentato tra quelli più in basso del cumulo. Le ceramiche
comprendono vasi biansati, anfore di dimensioni medio-piccole, boccaletti tra cui uno con
un'incisione in lettere greche "EY" dopo la cottura, piatti in terra sigillata chiara, riconducibili
sia alle produzioni africane che a quelle orientali, inquadrabili in base alle loro forme nel V
secolo d.C.6 Il materiale ceramico continua; vi sono ceramiche di impasto da fuoco e lucerne
ascrivibili tra l'inizio del V e il VI secolo d.C. Le lucerne sono sia di tipo orientale che di
produzione locale, a imitazione dei tipi africani (le più tarde). E' presente anche una vasta
gamma di brocche per lo più con corpo globulare, con beccuccio o con orlo rotondo; questi tipi
sono riscontrabili anche in diversi pozzi scoperti nel Modenese, Bolognese e nel Forlivese7 ma
mai nelle grandi quantità del sito in oggetto. Il problema riscontrato da questi materiali è la
datazione, infatti, queste forme sono molto comuni e tendono a perdurare nei secoli, gli stessi
6 AUGENTI, CIRELLI 2012, pp. 212-215.
7 MAIOLI 1989-1990, pp. 20-21.
6
vasi metallici ritrovati in questi depositi sono stati spesso restaurati ed hanno avuto una lunga
vita. Sono comuni nel deposito anche anfore di V-VI secolo d.C., del tipo detto "spatheion", del
tipo "Gaza", siriane, africane e produzioni locali da Classe8, molte delle quali con i tipici fori sul
collo per l'alloggiamento delle corde; sono presenti anche anfore con il tipico taglio a lato,
particolare che si riscontra quando vengono utilizzate per le sepolture (è probabile che
provengano dalle necropoli circostanti al condotto e gettate al suo interno come materiale di
scarico). Il materiale di questo periodo non è solo ceramico ma anche ligneo: pettini, tavoletta
scrittoria, cucchiai, mestoli, manici e altri oggetti d'uso frammentati. Come nello strato
precedente sono presenti oggetti lignei dell'armamentario navale e una misura metrica in
legno. Il materiale anche qui presenta omogeneità, infatti sono presenti piccoli oggetti in osso
(dadi, aghi, pedine, spilloni), piccoli ciondoli in ambra, gioielli in gaietto e anche oggetti vitrei
pertinenti a calici e piccoli bicchieri; oltre ad una grossa coppa in vetro verde quasi integra. Nel
pozzetto 39 è stato rinvenuto un gruzzolo di monete in bronzo10, riferibili al periodo che va da
Onorio a Valentiniano III; ciò oltre a confermare la datazione al V secolo d.C. di questa fase di
vita del condotto, dimostra il cambio d'uso di questo pozzetto per scopi di rifornimento
idrico11. I vasi rinvenuti dal deposito di questo periodo erano usati con tutta probabilità per
attingere l'acqua dal pozzo, spesso sono stati ritrovati col manico spezzato in antico e con fori
all'altezza del collo per permettere il passaggio di corde. Durante gli scavi condotti dal 2002 al
2005 si sono rinvenute diverse stele funerarie innestate nelle camicie dei pozzetti, si tratta di
un reimpiego di materiale atto a ricostruire le bocche dei pozzi ad una quota più alta,
probabilmente in età tardo antica il fenomeno della subsidenza aveva già intaccato il sito e
fatto si che l'acqua fosse arrivata all'orlo dei pozzi12. Di particolare interesse è una stele
funeraria rinvenuta nel settembre del 2003 nella camicia del pozzo 5 sud, è molto consunta su
un lato per l'effetto del passaggio continuo di corde usate per attingere l'acqua. Questa fase di
vita del condotto va vista in concomitanza dello spostamento della corte imperiale a Ravenna
8 AUGENTI, CIRELLI 2012, pp. 211-215.
9 Citato come pozzetto 3 in Maioli 1989-1990 p. 21, è possibile che i pozzetti abbiano cambiato nome nel corso delle
campagne di scavo, tutt'ora in corso (2014). 10
Durante lo studio delle monete non è stato possibile riscontrare la presenza di un tesoretto in base alla documentazione e al probabile cambiamento del nome dei pozzetti, soltanto due monete erano descritta in documentazione come provenienti da un gruzzolo ma da pozzo 3 (non preso in esame per questo lavoro). E' possibile però che il gruzzolo sia stato presente in uno dei due pozzetti presi in esame (2 nord, 8 sud) vista la grande quantità di moneta del V secolo d.C. e l'omogeneità del materiale. 11
MAIOLI 1989-1990, pp. 21-22. 12
CORTESI-NARDINI 2009, pp. 94-97.
7
e in un ottica di progettualità generale che doveva interessare la risistemazione delle strutture
precedenti, affiancata ad un nuovo slancio edilizio. In questa fase il condotto ha funzione di
approvvigionamento idrico fino alla fine del VI e probabilmente agli inizi del VII secolo d.C. (il
materiale è ancora in corso di studio). La chiusura dei pozzi avviene in età bizantina: i pozzetti
vengono occlusi con grosse quantità di macerie composte per lo più da laterizi di epoca
romana, resti di intonaci, pavimenti e frammenti di marmi ornamentali oltre che da stele
funerarie. La datazione alta della chiusura dei pozzi è probabile, perciò, in riferimento alla
presenza della voluta di un capitello marmoreo del V secolo d.C. all'interno del pozzetto 1.
Evidentemente la grossa quantità di materiale proveniva dalle numerose strutture dismesse di
età romana e tardo antica nei pressi del condotto. Al momento non è possibile sapere
l'effettiva motivazione che portò alla chiusura dei pozzi; probabilmente questo avvenimento è
da vedere sotto un'ottica di abbandono dell'area a sud di Classe e di un conseguente recupero
dell'abbondante materiale romano presente nella zona.
II. Conclusioni alla luce dei nuovi ritrovamenti
Il sito è stato interpretato come condotto fognario negli anni ottanta, ma alla luce dei nuovi
ritrovamenti l'ipotesi non sembra più sostenibile. Infatti i recenti scavi hanno messo in luce un
complesso di vasche attualmente a cielo aperto in cui sfocia il condotto a nord. Delle tre
vasche individuate, la prima, quella dove sfocia il condotto ha forma trapezoidale ed è larga
1,60 m all'imbocco, e 1,30 m dalla parte opposta, per una lunghezza di 1,90 m. Le altre due
hanno una larghezza costante di 1,20 m e sono entrambe lunghe 1,50 m con uno spessore
delle pareti di 40 cm. Fra una vasca e l'altra sono presenti dei restringimenti, formati da
basamenti (circa 90 x 120 cm) che probabilmente sostenevano delle arcate, la cui funzione è
ancora incerta13. Tracce di queste arcate si trovano in uno dei restringimenti. Recenti
prospezioni hanno indicato la possibilità che vi siano altre vasche oltre a quelle già ispezionate;
lo scopo dei prossimi scavi sarà appunto individuare le nuove vasche e capire possibilmente
dove terminino per poter ipotizzare una più probabile funzione d'uso dell'intero condotto.
Nonostante la particolarità della struttura rinvenuta, ad oggi un 'importante traccia può
13
CORTESI-NARDINI 2009, pp. 106-108.
8
aiutare a capirne la funzione, infatti, su uno dei basamenti delle vasche vi è la presenza di
solchi paralleli che sembrano indicare il continuo scorrere di un qualche ingranaggio
(probabilmente ligneo). Questo può far ipotizzare un meccanismo di adduzione dell'acqua
(noria14 ?). E' possibile che il condotto idrico rifornisse di acqua qualche struttura privilegiata
(villa15 ?) tramite queste vasche e non è da escludere che le stesse vasche, ammesso che
fossero a cielo aperto anche in antico, siano state sfruttate per la raccolta pubblica dell'acqua.
Questa ipotesi ovviamente è da verificare ma alla luce di questi nuovi ritrovamenti si è fatto un
grosso passo in avanti negli studi di questo importante opera idrica, e con tutta probabilità nei
prossimi anni nuovi scavi potranno fornire maggiori informazioni a riguardo.
14
La noria è una ruota idraulica che ha la funzione di sollevare acqua sfruttando la corrente di un corso idrico. 15
E' stata ritrovata una villa romana nel podere Marabina (nei pressi del condotto idrico) abbandonata agli inizi del III secolo d.C.: CIRELLI 2013, p. 113.
9
Fig. 2. Sezione del condotto in prossimità di un pozzetto di ispezione. Vista interna in direzione Est-Ovest, da MAIOLI 1989-1990.
Fig. 3. Sezione del condotto in prossimità di un pozzetto di ispezione. Vista esterna in direzione Nord-Sud, da MAIOLI 1989-1990.
Fig. 1. Il tracciato del condotto, da CORTESI-NARDINI 2009.
Fig. 5. Sezione di un tratto del condotto. Azzurro: acqua di falda; arancione: materiale di riempimento, da CORTESI-NARDINI 2009.
Fig. 4. Sezione di un tratto del condotto. In evidenza il cumolo di materiali che ostruisce il condotto solo all'altezza dei pozzetti, da CORTESI-NARDINI 2009.
10
Fig. 6. Un pozzo di accesso visto dall'esterno, da CORTESI-NARDINI 2009.
Fig. 7. Un pozzetto di accesso visto dall'interno, da CORTESI-NARDINI 2009.
Fig. 8. Pianta delle vasche, di Cristina Leoni (La Fenice Archeologia e Restauro S.r.l.).
Fig. 9. Le vasche, da CORTESI-NARDINI 2009.
11
Fig. 10. Lapidi funerarie romane reimpiegate per la camicia del un pozzo, da CORTESI-NARDINI 2009.
Fig. 11. Lapidi funerarie recuperate dalla camicia del pozzo. Quella di sinistra presenta una parte molto consumata dove scorrevano le corde per il recupero dell'acqua, da CORTESI-NARDINI 2009.
Figura 1
Fig. 12-13. Tracce lasciate dai probabili ingranaggi presenti all'interno delle vasche, da CORTESI-NARDINI 2009.
12
CAPITOLO II
L'evoluzione del sistema monetale dall'età tardo antica all'alto medioevo.
La produzione regolare di moneta aurea fu ripresa solo con Diocleziano e la sua riforma (286-
294 d.C.), dopo un intervallo di diverso tempo. Il peso era di 1/70 di libbra, dal 290 d.C.
divenne 1/6016. La riforma di Diocleziano agì anche sull'argento che recuperò nel 295 d.C. lo
stesso titolo del vecchio denarius prima dell'inflazione del III secolo d.C.; il nuovo denarius
pesava 1/96 di libbra e sia nell'oro che nell'argento veniva indicato il peso. Per quanto riguarda
il bronzo la politica monetaria di Diocleziano fu in linea con quella del precedente imperatore
Aureliano, l'antoniniano venne sostituito dal cosiddetto "follis" detto anche laureato grande
(circa 10 g). Vennero coniate due frazioni di "follis": il radiato (circa 3,90 g) e il laureato piccolo
(circa 1,50 g). Probabilmente la volontà dell'imperatore era quella di raggiungere un assetto
monetario stabile almeno tanto quanto quello del principato prima del periodo dell'inflazione.
I tassi di cambio erano di 4 aurei per libbra d'argento, quindi con 24 monete d'argento se ne
acquistava una d'oro. Un "follis" veniva cambiato a 20 denarii communes, un argenteus a 100
denarii communes, come citato nell'editto di Afrodisia del 30117. L'imperatore continuò ad
immettere grosse quantità di monete di bronzo sul mercato, soprattutto quelle di piccole
dimensioni che non erano nemmeno placcate d'argento. Queste riforme però andarono
incontro ad un fallimento, infatti la conseguenza di ciò fu l'aumento ulteriore dei prezzi e la
sopravalorizzazione delle monete d'oro e d'argento oltre il loro valore nominale corrente. Ciò
si nota anche nell'editto dei prezzi voluto dall'imperatore, in cui il prezzo dell'oro fu fissato a
50 mila denarii alla libbra, sia in verga che per monete. La grande considerazione che si aveva
per i metalli nobili è palese dall'editto di Diocleziano, a partire dal quale vennero valutati in
verghe, ovvero a peso.
16
CARLA' 2007, p. 160. 17
ibidem, p. 194.
13
I. Le riforme e l'instabilità della moneta bronzea nel IV e V secolo d.C.
Per un secolo e mezzo è difficile rintracciare l'andamento ponderale e di modulo delle monete
di bronzo. Nonostante ciò vi furono delle riforme occasionali atte a rinforzare il valore della
moneta di conto: nel 348 d.C. fu immessa sul mercato una serie di emissioni di peso maggiore,
nel 356 d.C. invece, vi fu una legge che dovette rimediare alla precedente, infatti,
successivamente alla riforma del 348 d.C. si manifestò un'instabilità ponderale delle monete in
bronzo e fu necessario confiscare tutte i divisionali del periodo precedente18. La confisca di
queste monete portò alla rifusione delle stesse e ad enormi speculazioni, infatti, furono
vendute ingenti quantità di nominali come merce, spesso addirittura i mercanti trasportavano
carichi di monete di bronzo con navi o animali da soma. Nel 395 d.C. il governo cercò di
ammettere sul mercato come valuta legale solo i centenionales nummi, che erano i minuscoli
pezzi di bronzo del peso di uno scrupolo (1/288 di libbra). Fino alla riforma di Anastasio della
fine del V secolo d.C. gli unici pezzi in bronzo coniati dalle zecche imperiali furono questi piccoli
nummi. L'oro e l'argento invece riacquistò grande importanza già dal regno di Costantino.
L'imperatore rimpinguò le tasse dello stato tramite la confisca dei tesori dei templi pagani; allo
stesso tempo immise sul mercato una nuova moneta d'oro: il solidus; del peso di 1/72 di
libbra, 4 scrupoli o 24 siliquae. Furono inseriti sul mercato anche due monete divisionali del
solidus, in oro: il semissis e il tremissis; quest'ultimo aveva il peso di mezzo scrupolo, dal regno
di Teodosio peserà invece 1/3 di solidus. L'argento invece vede il suo progressivo declino a
partire dalle metà del IV secolo d.C.; nel 348 d.C. prima con una riduzione a 1/144 di libbra, poi
nel 396 d.C. a 1/240 di libbra finché l'emissione regolare della moneta d'argento fu soppressa.
Prima del declino il milliarensis d'argento era battuto a 1/96 di libbra. Il peso della moneta
d'argento variava probabilmente a seconda del cambiamento di valore dell'oro e dello stesso
argento. Il prezzo ufficiale dell'argento sotto Costantino era di 4 solidi per libbra; di
conseguenza il milliarensis valeva 1/24 di solidus oppure una siliqua. Nel 397 d.C., si cercò di
assestare il prezzo dell'argento: 5 solidi per libbra; col valore di mezza siliqua per moneta. La
volontà dell'impero evidentemente, era però di incanalarsi in un circuito monetario
bimetallico. La legge richiedeva modalità di tassazione in libbre quando si parlava di argento e
mai in moneta bronzea. Non era possibile quindi riscuotere le tasse con moneta argentea,
18
HUGO-JONES 1999, p. 652.
14
visto il suo valore così altalenante e spesso tendente alla svalutazione. La preferenza dei solidi
d'oro sull'argento a peso rimarca ulteriormente la sfiducia verso questo metallo. Dalle fine del
IV secolo d.C. l'argento venne usato solo per i pagamenti in occasioni celebrative. La relazione
tra la moneta di bronzo e quella d'oro fu perfino più instabile: si arriva nella seconda metà del
IV secolo d.C. a sproporzioni grandissime, con le monete di bronzo che furono frequentemente
ritariffate e rimpicciolite. I calcoli per il bronzo erano effettuati in veri nummi e non più in
denarii (unità di misura per il bronzo nel IV secolo d.C.), infatti nel 445 d.C. Valentiniano III
decretò di vendere il solidus a 7200 nummi19. Un'unità di misura usata spesso in Africa nel IV
secolo d.C. era il follis che corrispondeva probabilmente a mille nummi Aurelianei;
successivamente diventò un divisionale vero (si può parlare di follis dall'epoca di Costantino).
La moneta di bronzo era un divisionale utile per il popolo ma di disinteresse assoluto per il
governo che come abbiamo visto solo saltuariamente ed in modo inefficace cercò di regolare.
Il governo tutti gli anni emetteva grandissime quantità di moneta spicciola sul mercato per i
pagamenti degli stipendia ai soldati, senza però nessuna tassa da pagare in bronzo che potesse
ritirare le tante monete di conto e regolamentare il mercato. Di conseguenza la
sovrabbondanza di queste monete che restava sul mercato portò alla svalutazione delle
stesse, e ad un aumento dell'inflazione. Si pensava in antichità che queste monete di bronzo
avessero valore nominale e si potessero svalutare soltanto se svilite o ridotte di peso. In Italia,
dove la struttura comitatense e l’amministrazione regionale fu virtualmente preservata
intatta, Odoacre continuò il modello di produzione di conio che ereditò dai suoi imperiali
predecessori. Dopo un periodo iniziale, comunque, il suo successore ostrogoto Teodorico
concentrò la produzione di conio con metalli preziosi principalmente su Roma, piuttosto che a
Milano o a Ravenna e fu seguito in questa politica dai suoi successori. Roma fu anche la zecca
dalla quale Teodorico ha riformato la coniazione di follis e delle frazioni di bronzo, dove erano
principalmente emesse. Sembra chiaro che la sua politica fosse inoltre desiderosa di conciliare
il senato di quella città. Intanto alla fine del V secolo d.C. specie sotto Teodorico l'inflazione si
abbassò perché vennero coniate meno monete di bronzo per i pagamenti e di valore
maggiore. Parallelamente si ebbero gettiti in oro superiori. Ormai non vi era più nulla tra la
moneta d'oro e i piccolissimi nummi dalla fine dal IV secolo d.C., visto che nemmeno più
l'argento veniva coniato se non sporadicamente. A far fronte a questo problema furono i regni
19
ARSLAN 2003, p. 28.
15
"barbarici" dell'Occidente: a Roma sin da Odoacre vennero coniate grosse monete di rame
con segno XI, nello stesso periodo circa a Cartagine i Vandali coniarono monete simili marcate
N XLII20. Queste monete Africane erano chiamate folles e forse non a caso nacquero qui, dove
questo termine era usato costantemente in passato nelle transazioni come unità di misura.
Vennero coniate anche nominali più piccoli del follis marcati XX, X e V, e pezzi che valevano la
metà o il doppio (marcati N XXI e N LXXXIII) sia in Italia che in Africa. Il valore del follis sarà
stato di 1/180 di solidus, 1/90 di semissis, 1/60 di tremissis, con la siliqua di 7,5. Alla fine del
regno di re Gunthamund (484-496 d.C.) il follis fu deprezzato a 350 al solido (14400 nummi).
II. Dalla riforma di Anastasio a Giustiniano
La riforma dell'imperatore Anastasio si andò ad inserire in un nuovo quadro economico che si
stava delineando ad Occidente; l'artefice fu il suo comes sacrarum largitionum Giovanni.
Secondo alcuni il comes copiò il sistema monetario dei Goti attuato già in Italia, un'altra
versione vuole invece che siano stati i Goti e i Vandali ad imitare il nuovo sistema monetario
dall'impero d'Oriente che emise monete di rame del valore di 40, 20, 10 e 5 nummi21. Queste
monete avevano impresso il loro valore in nummi inciso con una lettera: M, K, I, E22. La prima
serie di emissioni fu più leggera di quelle italiane visto che il follis fu battuto a 1/36 di libbra, la
serie successiva pesò il doppio (1/18) per essere successivamente di nuovo alleggerita (1/20).
La situazione ad Est rimase grossomodo inalterata, d’altra parte è probabile che il tasso di
produzione fu da allora su scala ridotta, e che questo in qualche modo comportò
un’interruzione di alcune zecche, sebbene la piccola misura e la pessima manifattura dei
nummi contemporanei renda la materia difficile da giudicare. La suggestione di
un’interruzione fu in qualche modo supportata dal fatto che la riformata coniazione in bronzo
di Anastasio fu il prodotto solo della zecche di Nicomedia e Antiochia, sebbene la riforma di
Giustino I invece fosse ancora una volta il prodotto di Salonicco, Nicomedia, Cizico, Antiochia e
Alessandria. In questo periodo furono poche le coniazioni in metallo nobile fuori da
Costantinopoli per via dello stanziamento della zecca comitatense in città. E' un caso
20
ARSLAN 2000, pp. 492-493. 21
GREIRSON 1999, pp. 17-18. 22
CASTRIZIO 2005, p. 12.
16
eccezionale quello dei solidi prodotti ad Antiochia per l’usurpatore Leonzio (484-488 d.C.), e
quelli prodotti dalla stessa zecca per l’imperatore Zenone; probabilmente durante
l’usurpazione metropolitana di Basilisco (475-476 d.C.). Sono coinvolti anche una sporadica
serie di solidi e tremissi di Salonicco che vanno fino a Tiberio II, se non oltre. Successivamente
ad Anastasio, furono continuate le emissioni di follis del peso oscillante tra 1/20 e 1/18 di
libbra, nel 539 d.C. Giustiniano fece rivivere temporaneamente il taglio pesante di 1/18 di
libbra. Un'altra innovazione attribuita ai regni "barbarici" dell'Italia e d'Africa fu la
reintroduzione della moneta d'argento, continuata da Giustiniano dopo la riconquista di questi
territori. I tagli di queste monete d'argento emesse dai Vandali furono tre: 1/576, 1/288, 1/144
di libbra, marcate rispettivamente DN XXV, DN L, DN C23. La libbra d'argento sembrerebbe
avere a quest'epoca il valore di 5 solidi, quindi l'unità di misura della moneta d'argento doveva
essere di 2880 al solido, e di 5 nummi (stando al valore del nummus di questo periodo). Le
monete d'argento di Giustiniano coniate dopo la conquista avevano valore: 1/240 e 1/480 di
libbra, marcate rispettivamente CN (250) e PKE (125). Queste monete d'argento erano
destinate alla circolazione locale; con questi pesi si possono ricavare inoltre le proporzioni di
12 mila nummi per solidus in Italia e 7200 in oriente sotto Giustiniano. Dopo il riassetto
amministrativo delle prefetture; Giustiniano concentrò la produzione dell'oro, come sembra,
nelle città sedi del prefetto: Cartagine, Tessalonica, Ravenna (sotto gli Ostrogoti in precedenza
fu spostata la produzione a Roma). In oriente non fu fatto nessun tentativo di coniazione
d'argento fino ad Eraclio. Con questa riforma si ottenne che il rapporto di peso tra la moneta
di rame e il solido non variasse eccessivamente, emettendo anche sul mercato quantità
controllate di nominali in bronzo. Nonostante tutto il solido non fu mai deprezzato e infatti
durante le transazioni venivano sempre pesati. Come visto in precedenza la zecca di
Tessalonica interruppe la coniazione di bronzo nel V secolo d.C. per coniare sporadicamente
l'oro nello stesso secolo e nel VI secolo d.C. Il bronzo fu nuovamente ribattuto inizialmente a
singhiozzo con Giustino I e poi a pieno regime con Giustiniano. I primi folles coniati portavano
la legenda "THESSOB" (Thessalonike obryza24) tipica dell'oro e successivamente tornarono con
la semplice scritta TES tipica delle monete di rame della zecca. Si hanno emissioni anche dalle
unità amministrative "anomale" istituite sotto Giustiniano; tre di queste avevano una zecca:
23
ARSLAN 2000, pp. 492-493. 24
Obryza: puro; riferito alla purezza dell'oro.
17
Cartagena in Spagna con un'emissione sporadica di tremissis d'oro da Giustiniano ad Eraclio,
Cherson emise delle serie di nummi sotto Giustino I, Giustiniano, Maurizio ed Eraclio. Salona
egualmente emise una serie di nummi probabilmente nel periodo del grosso dispiegamento di
forze militari (guerra greco-gotica) tra il 549-552 d.C.25 Vi sono altre serie in bronzo del VI
secolo d.C. di provenienza sconosciuta che probabilmente si inquadrano in ambito militare,
come emissioni gestite dalla questura dell'esercito.
III. L'Alto Medioevo
Verso la fine del VI secolo d.C. fu aperta una nuova zecca a Catania che dovette provvedere
alla coniazione di monete d'oro e bronzo. La moneta cardine nel VII secolo d.C. all'interno
dell'impero bizantino era ancora il solidus/nomisma del peso di 4,55g. La produzione
monetaria a partire dalla fine del regno di Eraclio fino agli inizi dell'VIII secolo (642-717 d.C.)
era strutturata in questo modo: solidus/nomisma del peso di 4, 50g circa e con la presenza del
98% d'oro puro al suo interno, con la stessa quantità d'oro vi erano il semissis e tremissis
rispettivamente del peso di 2,25g e 1,50g circa. Tra le monete d'oro e i nominali bronzei vi era
una moneta d'argento immessa sul mercato da Eraclio, soprattutto per evitare pagamenti e
donazioni in oro all'esercito e in occasione di festività. Questa moneta è l'exagramma del
peso di 6,72g circa e con la presenza del 96% di argento puro26. I nominali minori erano ancora
il follis (di 3g circa), mezzo follis, e il decanummo. Nel VII secolo d.C. progressivamente i
nominali minori avevano un valore in forte ribasso, infatti, vennero tolti dal mercato il nummo
e il pentanummo, ancora presenti nel VI secolo d.C. Il follis che in età giustinianea aveva
ancora una certa importanza, arriverà ad avere un peso bassissimo già sotto Costante II. Il
contenuto aureo del solidus di Costantinopoli invece diminuisce a partire solo dal 680 d.C.,
anche se in maniera molto limitata, senza mai scendere sotto il 95% di oro intrinseco. Le
zecche provinciali rimaste in Occidente si allontanano sempre più dalle norme della capitale,
sia nei loro tipi iconografici che nella metrologia. Cartagine ancora attivissima sotto Costante
II, a partire da Eraclio emette solidi molto più piccoli e spessi (detti "globulari") di quelli
costantinopolitani; il loro peso è ancora corretto ma la forma specifica sembra destinata a
25
MORRISSON 2011, p. 416. 26
GRIERSON 1999, p. 13.
18
rendere la coniazione più rapida e meno costosa. Fino alla fine del VII secolo d.C., a Cartagine
(chiusa nel 695 d.C.) come in Italia e in Sicilia l'oro resta di purezza quasi analoga a
Costantinopoli. A Siracusa, tra il 695 e il 705 d.C., scende addirittura tra l'80% e il 71%, prima di
stabilizzarsi all'82% fino agli anni venti del IX secolo d.C. Queste fluttuazioni coincidono con la
progressiva caduta dell'isola siciliana in mano araba; la stabilizzazione arriverà con la riforma
fiscale di Leone III (717-741 d.C.)27. Successivamente ci saranno nuove alterazioni del peso
dell'oro ancora maggiori fino ad arrivare al 47-40% sotto Michele III (842-867 d.C.)28 che
porteranno alla confisca delle rendite del patrimonio di San Pietro. L'alterazione della moneta
d'oro di Roma e Ravenna è meno conosciuta nei dettagli, inizia nello stesso periodo, ma le
autorità locali, con le risorse ridotte, non potevano arrestare un processo che riguardava
anche la monetazione longobarda nel Nord o in Toscana, così come a Benevento. La
frammentazione dei possedimenti bizantini in Italia e il sostegno sempre più limitato che essi
ricevono dalla capitale spiegano l'autonomia crescente delle autorità regionali anche in
materia monetaria: Ravenna, ormai isolata, ha una produzione sempre più ridotta e non è più
l'unica città a coniare l'oro. A Napoli i duchi, a partire già dal 660 d.C. circa, si dotano di una
zecca che di tanto in tanto batte solidi svalutati e rare monete di bronzo a nome
dell'imperatore. A Roma, i papi affermano progressivamente la loro autorità in una serie di
emissioni molto caratteristiche nei tre metalli conservando sulla moneta d'oro il nome del
basileus fino a Leone IV, ma contrassegnandole con il proprio nome di tanto in tanto a partire
dal 687 d.C., e continuamente dal 740 d.C. La maggior parte delle piccole emissioni in argento
che fino ad allora recavano il monogramma dell'imperatore o la sigla RM (Roma) subiscono
anch'esse la svalutazione. La prima moneta con titolatura interamente pontificale risale ad
Adriano I (772-795 d.C.), ma resta di ispirazione bizantina; poco dopo, i primi denari di tipo
carolingio saranno emessi dallo stesso pontefice, e con l'adozione della datazione per anno di
regno del re franco, nel 798 d.C., suggelleranno definitivamente l'entrata di Roma nell'orbita
economica monometallica carolingia29.
27
COSENTINO 2008, p. 203. 28
GRIERSON 1999, pp. 8-9. 29
La monetazione carolingia si basa esclusivamente sull'impiego dell'argento per le coniazioni.
19
CAPITOLO III
Le monete dal condotto
L'oggetto di questo studio è stato il materiale numismatico proveniente dai pozzetti di
ispezione 2 nord e 8 sud. Le monete prese in esame sono 189 su un totale complessivo di circa
400, le statistiche presenti riguardano circa la metà dei materiali disponibili. E' importante
ricordare come ogni pozzetto sia un contesto a sé stante, all'interno del quale si susseguono
diverse fasi di vita; questi momenti sono spesso simili cronologicamente a quelli degli altri
pozzetti. La pessima conservazione del materiale non ancora restaurato incide fortemente
sugli aspetti statistici e quantitativi : gli esemplari presentano ancora incrostazioni consistenti
quando non sono del tutto illeggibili per l'eccessiva consunzione. Le monete si ritrovano nel
condotto in seguito a smarrimenti (perse e cadute nel condotto) occasionali, fatta eccezione
della deposizione del gruzzolo scoperto negli anni '80 proveniente dal pozzetto 330 (i pozzetti
hanno cambiato nome negli anni). In linea generale si vede una grossa concentrazione di
materiale sia verso la fine del IV che nel V secolo d.C. anche se si sospetta che il gruzzolo
descritto proveniente dal pozzo 3 si tratti dello stesso materiale rinvenuto nel pozzo 8 sud; in
base a questa eventualità andrebbe riassegnato il primato per numero di monete tra le fine
del IV e gli inizi del V secolo d.C., in coerenza anche con gli altri ritrovamenti effettuati nella
area romagnola. Un'ultima premessa va fatta sulle monete di V secolo; questo materiale
ancora oggi oggetto del dibattito tra gli studiosi per la sua datazione è spesso illeggibile, quindi
la cronologia viene determinata in base al peso e al modulo, ma di questo ne parleremo più
avanti (paragrafo IV-V-VI). Gli standard ponderali e le dimensioni di queste monete tardo
antiche si mantengono inalterati per molto tempo: tutto il V fino ad arrivare al VI secolo
inoltrato, dopo un definitivo peggioramento avvenuto intorno al secondo quarto del V secolo
d.C. Per il periodo precedente invece è riscontrabile una quasi assenza di monete del I secolo
d.C., una ottima consistenza di nominali per la seconda metà del II e gli inizi del III secolo d.C.
Infine è riscontrabile una ripresa della quantità di moneta circolante agli gli inizi del IV che va
gradualmente aumentando verso la fine del secolo.
30
MAIOLI 1989-19990, p. 21.
20
Fig. 14. Prospetto cronologico riassuntivo delle monete rinvenute (valori quantitativi).
Sono state inserite nel grafico solo le monete identificate o attribuibili ad un secolo preciso.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
I secolo d.C. II secolo d.C. III secolo d.C. IV secolo d.C. V secolo d.C.
Pozzo 2
Pozzo 8
21
I. Esemplari del I secolo d.C.
La monetazione imperiale del I secolo d.C. proveniente dai due pozzetti presi in esame è quasi
assente; un solo esemplare è stato identificato con sicurezza ed un altro con approssimazione.
La moneta leggibile è un denario dell'imperatore Vespasiano del 69-79 d.C. Una spiegazione di
questa assenza può essere la mancata frequentazione dell'area specifica del sito. In realtà intorno
al 27 a.C. l'imperatore Augusto fece costruire nell'area classense un porto militare con funzione di
controllo della parte orientale del Mediterraneo. E' più probabile che da quando fu stanziata la
flotta l'area iniziò ad essere abitata dai militari, ma senza ancora una diffusione di funzioni
commerciali, iniziate probabilmente soltanto nel II secolo d.C. quando intorno al porto e alle
caserme nascerà un piccolo nucleo insediativo. Il numero di monete cresce gradualmente col
passare del tempo fino ad arrivare ad avere una buona presenza, sotto i regni di Antonino Pio e
Marco Aurelio; vista la natura del sito in questione c'è la possibilità che l'esemplare di Vespasiano
sia circolato anche più tardi, infatti, non si ha una stratigrafia certa, oltre al fatto che per i primi tre
secoli dell'impero il condotto fu puntualmente manutenuto. Da un punto di vista più ampio e
generale l'area ravennate non ha restituito grosse quantità di monete del I secolo d.C.; come
dimostrano gli scavi degli anni '70 e '80 della basilica di S. Croce (Ravenna), della basilica di S.
Apollinare in Classe31 e quelli del porto di Classe32. Gli scavi del porto di Classe non hanno
restituito monete di I secolo d.C. ma solo dal II secolo d.C. in poi, pur rintracciando spesso
strutture pertinenti alla prima età imperiale; nel caso in questione una villa romana. Anche gli
scavi presso S. Apollinare in Classe hanno restituito monete solo di periodo successivo a
confermare l'ipotesi precedentemente espressa. Gli scavi urbani di S. Croce invece hanno
restituito un gruzzolo monetale che va da Domiziano ad Antonino Pio33, queste monete
provengono da un pozzo romano connesso ad una domus più volte restaurata nei primi tre secoli
dell'impero romano. Quindi seppur sia presente moneta di I secolo d.C. (tra l'altro in piccola
quantità e da un gruzzolo), è da sottolineare che si tratta di un contesto urbano. Questo gruzzolo
conferma ancora una volta la circolazione monetaria massiccia solo a partire dal II secolo d.C. nell'
area di Ravenna e Classe.
31
MORELLI 2001, pp. 553-556. 32
CURINA 1983, p. 204. 33
STOPPIONI 1986, pp. 47-51.
22
II. La diffusione della moneta nell'epoca degli Antonini
Sono otto le monete di sicura attribuzione ad autorità del II secolo d.C. dal pozzo 2 nord; tre di
queste possono essere inquadrarte tra la fine del II e gli inizi del III secolo d.C. Nove monete
(sette assi, due sesterzi) sono illeggibili ma databili al I-III secolo d.C. Dal pozzo 8 sud non sono
pervenute monete imperiali fatta eccezione per un asse illeggibile datato
approssimativamente tra I e III secolo d.C. Le monete leggibili del pozzo 2 nord sono così
suddivise: un asse e un denario di Antonino Pio per Faustina I (138-160), un denario di
Antonino Pio (145-160), due assi per Faustina II di Antonino Pio o da Marco Aurelio (147-175),
un asse di Marco Aurelio (161-180), un denario e un asse di Commodo (177-192). Sono undici
invece le monete da collocare da Antonino Pio agli inizi del III secolo d.C., e con molta
probabilità ne sono presenti altre tra quelle illeggibili assegnate tra I-III secolo d.C. Salta subito
all'occhio la grossa discrepanza quantitativa con l'unico esemplare del I secolo d.C.; è evidente
come durante l'epoca degli Antonini la frequentazione fosse maggiore. Gli esemplari pervenuti
di denari sottolineano la grande diffusione di questo nominale seppur di scarso peso; questo
può giustificare la perdita delle tante monete in bronzo di ottimo peso come gli assi e i sesterzi
individuati. Il numero di monete può sembrare esiguo ma confrontandolo con gli scavi
sistematici effettuati a poca distanza dal condotto in esame si conferma la grande diffusione
della moneta per l'età degli Antonini nella zona di Classe in cui erano presenti importanti
strutture. Il rinvenimento di un solo esemplare coniato per Faustina II durante gli scavi del
porto di Classe34 tra il 1975 e il 1982 è eloquente in questo senso. Evidentemente l'area di
Classe nel II secolo d.C. fu insediata a macchia di leopardo35. La forte concentrazione
monetale che inizia con Antonino Pio aumenta con Marco Aurelio e continua con Commodo.
Dopo il principato di Commodo la circolazione dovette rimanere consistente almeno fino a
Gallieno 253-268 d.C. E' da presumere che nella prima metà del III secolo l'economia
monetaria e la circolazione sia molto simile a quella del II secolo d.C.; un'inversione di
tendenza si ha verso la metà del III secolo quando avvenne il passaggio dalla moneta bronzea
all'antoniniano in lega d'argento. Come accennato nel paragrafo precedente la presenza della
moneta alto imperiale scarseggia anche nella zona indagata a Sud di Classe presso la basilica di
34
CURINA 1983, p. 204. 35
CIRELLI 2013, pp. 112-113.
23
S. Apollinare36, anche se è accertata una necropoli romana di età alto imperiale presso la
basilica. Evidentemente questo luogo fu frequentato assiduamente solo a partire dalla
diffusione del cristianesimo come attestano le monete Costantiniane agli inizi del IV secolo
d.C.37 L'unico rinvenimento cospicuo di monete del II secolo d.C. proviene da Ravenna, dalla
basilica di S.Croce. Nel 1984 fu individuato un pozzo sotto la basilica connesso ad una domus; il
materiale si concentra soprattutto durante il principato dell'imperatore Adriano, agli inizi del II
secolo d.C.38 E' stato ipotizzato che le 34 monete in questione siano appartenenti ad un
gruzzolo unitario perduto o occultato probabilemente sotto il regno di Antonino Pio se si
considerano tutte le monete in questione, o alla fine del regno di Adriano se si considera solo il
materiale meglio conservato. Infatti i due dupondi di Antonino Pio e per la Diva Faustina si
presentano più consunti e forse estranei al gruzzolo. Le monete sono state ritrovate senza
contenitore ma molto vicine tra di loro sia fisicamente (vicino alla camicia interna del pozzo)
che dal punto di vista cronologico. Il dato numerico dimostra un grosso aumento della moneta
di bronzo durante i regni di Traiano e soprattutto Adriano, in concomitanza di un discreto
periodo di splendore di Ravenna. Il gruzzolo rappresenta un ottimo riflesso della circolazione
cittadina tra la fine del I e la metà del II secolo d.C. per via della vicinanza cronologica delle
monete. Questo può far pensare ad una perdita occasionale di un borsellino o un sacchetto
con all'interno il valore di una spesa giornaliera39 (il potere di acquisto delle monete insieme è
modesto); rispecchiante quindi la reale circolazione, non escludendo quindi che anche le
monete precedenti alla perdita del gruzzolo fossero ancora in circolazione. Il gruzzolo di S.
Croce mostra quindi un aumento del nominale in circolazione già prima del regno di Antonino
Pio come testimoniato dai rinvenimenti del pozzetto 2 nord; evidenziando una fase di
sviluppo economico e edilizio dell'area ravennate-classense già agli inizi del II secolo d.C. Una
conferma ulteriore proviene dai numerosi bolli impressi sui laterizi provenienti dalle strutture
rinvenute a Ravenna e a Classe, che iniziano con l'imperatore Adriano e continuano con i
successivi imperatori40.
36
MORELLI 2001, pp. 552-564. 37
ibidem, p. 560. 38
STOPPIONI 1986, pp. 48-49. 39
ibidem, p. 50. 40
PELLICIONI GOLINELLI 1993, pp. 57-59.
24
III. Dall'antoniniano al "follis"
Con la riforma di Caracalla del 215 d.C. fu immesso sul mercato un nuovo nominale: l'antoniniano.
Inizialmente era composto di lega ad alta percentuale argentea: aveva valore doppio e modulo
maggiore del denario. L'emissione del denario continuò al fianco di quella dell'antoniniano almeno
fino alla metà del III secolo d.C.; quando il primo andò incontro ad una grande svalutazione per far
fronte allo stato di guerra in cui versava l'impero. Intorno alla metà del secolo, il denario sempre
più svalutato, fu definitivamente eliminato e fu battuto soltanto sporadicamente a favore di una
capillare diffusione del nuovo nominale. Successivamente anche la nuova moneta andò incontro a
svalutazione, fu coniata lega d'argento con l'immissione di rame e stagno producendo così una
lega di biglione, molto simile all'argento. Sotto il regno di Gallieno (253-268) l'antoniniano era
composto ormai al massimo del 5-10% di argento; la moneta fu prodotta totalmente in bronzo con
un'argentatura esterna. Questa soluzione non fu duratura e spinse l'imperatore Aureliano (270-
275) a riformare l'antoniniano, decretando di immettere in ogni nominale venti parti di rame per
una d'argento. Infine l'antoniniano restò in circolazione ufficialmente fino alla riforma (286-294) di
Diocleziano. Le monete di III secolo di sicura attribuzione provengono solo dal pozzo 2 nord: un
antoniniano di Gordiano III (238-244) e due antoniniani di Gallieno (253-268). Salta subito
all'occhio la differenza tra l'antoniniano di Gordiano III e i successivi; il primo presenta il tipico
annerimento dell'argento; un antoniniano di Gallieno invece è completamente di colore verdastro
a testimonianza della perdita della patina argentea che ricopriva la sua anima in bronzo. L'altro
antoniniano di Gallieno invece non ha perso la patina argentea del tutto e risulta inscurito. In linea
generale gli antoniniani che avevano un buon valore intrinseco tendevano ad essere sottratti alla
circolazione in quanto moneta buona, mentre il bisogno di denaro per le operazioni correnti era
soddisfatto impiegando probabilmente gli esemplari svalutati (di Gallieno, e soprattutto di Claudio
il Gotico)41. Spesso gli antoniniani tendevano ad essere tesaurizzati per lungo tempo, si ritrovano
anche in tesoretti di V e VI secolo d.C. E' interessante la frequente presenza in questi tesoretti più
tardi dell'antoniniano a nome del Divo Claudio (post riforma di Aureliano 270) nel tipo della
consecratio; esso è presente nel tesoretto di Falerii Novi42(Viterbo) con quattro esemplari (nel caso
specifico tosati per essere utilizzati col peso dei nominali correnti del V secolo), nel ripostiglio di
Sassari43 (metà VI secolo), nel ripostiglio di Messina44 (metà VI secolo), nel ripostiglio di Rebelais-
41
CALLEGHER 1998, p. 26. 42
ASOLATI 2005, p. 75. 43
MOSTECKY 1993, p. 167.
25
Ain Merane45(Algeria, seconda metà V secolo). Questo nominale è presente anche in ripostigli
occultati poco dopo la sua coniazione: ripostigli della Venera, in provincia di Verona46, ripostigli
francesi di Bazarnes47 e di Sainte Pallaye48, questi ultimi interrati verso il 285. Il peso di questi
nominali all'interno dei ripostigli più tardi è sensibilmente minore di quelli presenti nei ripostigli
precedenti; probabilmente per via dell'usura legata alla manipolazione e alla circolazione.
L'antoniniano del Divo Claudio sembra essere stato oggetto di una selezione tesa a mantenere sul
mercato gli esemplari di lega peggiore o più leggeri. Proprio i pezzi più sviliti (e battuti in maggior
numero) sono quelli che circolano più a lungo; sia nel IV che nel V secolo d.C.49 Sono scarsi i
ritrovamenti di moneta di III secolo dagli scavi effettuati in area romagnola: un sesterzio di
Gordiano III del 240 d.C. proviene dagli scavi di Villa Clelia50 a Imola ed è stato rinvenuto in tomba;
probabilmente interrato in un periodo posteriore. L'assenza di monete dagli strati archeologici di
Villa Clelia precedenti alla riforma di Diocleziano conferma una bassa circolazione nell'area
indagata in questo periodo. Un aumento del circolante si avrà soltanto con la suddetta riforma e
l'immissione sul mercato del follis. Il vecchio antoniniano riformato venne sostituito appunto dalla
nuova moneta che inizialmente era in argento; gli stessi antoniniani e i nominali in bronzo, prima
di scomparire, vennero utilizzati probabilmente per piccole transazioni, tesaurizzati o usati come
"obolo di Caronte" come nel caso del sesterzio di Gordiano III ritrovato in tomba a Villa Clelia. La
concentrazione dei nominali di III secolo si concentra probabilmente presso i siti militari come
appunto Classe; l'eventualità di pagamenti alle truppe non è da scartare visto l'assetto bellico che
vigeva nell'impero in questo periodo. Proprio allora nacquero numerose zecche in tutto l'impero
per far fronte al bisogno di moneta per i pagamenti alle truppe e di conseguenza le coniazioni
aumentarono in maniera esponenziale.
44
MASTELLONI 1993, p. 514. 45
BRENOT-MORRISSON 1983, p. 203, nn. 3-5. 46
GIARD 1995, pp. 13-14; ESTIOT 1995, pp. 42-43. 47
AMANDRY-GAUTIER 1985, pp. 114-115. 48
ESTIOT-AMANDRY-BOMPAIRE 1993, pp. 90-91. 49
CALLEGHER 1998, pp. 26-27. 50
ERCOLANI COCCHI 1982, p. 369.
26
Le monete provenienti dal condotto sono un riflesso della situazione in questo senso; da altri
pozzetti ancora in corso di studio51 provengono monete successive a Gallieno, del periodo di
Claudio il Gotico (fig. 15, 268-270) e un probabile antoniniano riformato di Probo (fig. 16, 276-
282).
Fig. 15. Antoniniano di Claudio il Gotico dal pozzo 3 nord (foto dell'autore).
51
Pozzo 3 nord e vasca 6, non in catalogo.
28
Sulla base di questi dati si nota una discreta continuità seppur in numero esiguo di monete in
circolazione fino a Diocleziano. La salita al potere di questo imperatore è rappresentata da un
piccolo numero di rinvenimenti; come accennato in precedenza dagli scavi di Villa Clelia
provengono tre frazioni radiate di "follis" dal 297 al 299 d.C., dal condotto idrico52 invece,
proviene un follis ben conservato e di buon peso (9.42 g), infatti il peso delle prime emissioni di
questi nominali era stimato intorno ai 10 g.
Fig. 17. Follis di Diocleziano da vasca 6 (foto dell'autore).
52
Vasca 6, non in catalogo.
29
IV. Problemi di circolazione monetale nel territorio di Ravenna tra IV e V secolo d.C.
La scalata al potere di Costantino portò ad una riforma monetaria (309-310) che cambiò
l'assetto economico dell'impero. Oltre all'immissione sul mercato del solidus d'oro e delle
nuove monete d'argento, il nuovo imperatore modificò anche i divisionali in bronzo. Il
nummus centenionalis del peso di 3 g (spesso chiamato follis dai numismatici), sostituì il
vecchio follis di Diocleziano, era di misura più piccola e conteneva a mala pena un po'di
argento. Il "nuovo follis" mantenne il suo peso almeno fino al 330 d.C., successivamente andò
incontro ad una progressiva diminuzione di peso; dopo il 335-336 ormai dai circa 3 g iniziali
arrivò a pesare meno di 2 g. La svalutazione di questa moneta portò ad un massiccio utilizzo
nella circolazione giornaliera, con una conseguente maggiore possibilità di smarrimento.
Considerando anche la diminuzione del potere d'acquisto del follis, nel caso di un eventuale
smarrimento probabilmente non veniva data tanta importanza al recupero di essa. Il pozzo 2
nord del condotto idrico conferma tale trend; solo un follis di Costantino è precedente al 330,
datato al 314, con un peso di 2,76 g, vicino ai 3 g del peso originario. Il tipo rappresentato è
quello del Soli Invicto Comiti, proveniente dalla zecca di Roma; questo tipo è molto diffuso
nelle prime emissioni di Costantino, coniate dopo la vittoria contro Massenzio. Ben tre follis
invece sono stati datati dal 330 al 337: uno del tipo Urbs Roma, un'altro del tipo Gloria
Exercitus (due soldati e due stendardi), il terzo raffigura il busto elmato di Costantinopoli al
dritto, al rovescio è presente una vittoria alata su un rostro di nave. Le prime due monete
hanno un peso di poco superiore al grammo, a conferma della svalutazione dei bronzi
avvenuta intorno 335 d.C. La conseguenza fu una maggiore circolazione che permise ai
nominali di restare per lungo tempo sul mercato. La consunzione di queste monete è effetto
appunto del lungo permanere in circolazione. Il tipo del Soli Invicto Comiti pre 330 d.C. invece,
per via del suo maggiore valore circolò di meno, mantenendo quasi tutto il suo peso originario.
Anche il tipo commemorativo con Costantinopoli elmata, datato 330-337 ha un peso di 2,35 g;
infatti tra 330 e 335 il peso dei follis diminuì di 1/6 circa. Solo a partire dal 335-336 invece il
loro peso diminuisce drasticamente, arrivando a pesare solo la metà. Un'altra emissione
commemorativa pervenuta dal condotto è quella del tipo Urbs Roma; questa moneta è molto
consunta e pesa solo 1,07 g; è possibile che faccia parte delle serie più leggere emesse dopo il
335. I nominali di confronto provenienti da altri scavi nella zona non sono tantissimi. A Classe
30
si riscontra un nucleo consistente che va dal 330-341 d.C.53 , tra le poche monete riconoscibili
vi sono anche qui due del tipo Gloria Exercitus; una di queste è attribuibile a Costantino e
proviene dalla zecca di Tessalonica54. La presenza seppur modesta di monete dalla zecca di
Tessalonica al fianco di Roma, Aquileia e Siscia è testimoniata soprattutto tra il 347 e 348 dagli
scavi di Trento55. Altri due esemplari del 324-337 sono descritti come materiale sporadico
proveniente dall'abitato di Classe56. Dall'area comacchiese invece proviene un tesoretto di
monete ascrivibile alla fine del IV secolo; ritrovato in località Salto del Lupo. I nominali più
antichi presenti sono di età costantiniana databili tra il 324 e il 340. Si tratta di quattro pezzi e
l'unica zecca riconoscibile è quella di Roma57. Dopo la morte di Costantino; in un periodo ricco
di avvenimenti politico-militari si inserisce la riforma di Costanzo II: tra il 348-349 furono
coniati tre tipi di AE con modulo, peso e tipologia differenti. L' AE2 di modulo maggiore fu il
pezzo di riferimento del nuovo sistema; venne tagliato a pesi differenti a seconda della zecca,
in genere a 1/60 di libbra. Questa emissione circolò molto poco, venendo subito affiancata da
due nuovi tondelli: un AE2 di modulo e peso minore (1/72 di libbra) e un AE3 pari circa a 1/120
di libbra58. L'AE2 più pesante finì per essere tesaurizzato poichè era la moneta buona del
sistema; le altre due trovarono molto più spazio nella circolazione. Anche successivamente,
durante l'usurpazione di Magnenzio si tentò di mantenere queste nominali di buon peso, ma
non fu possibile per via dell'ingente bisogno monetale necessario ai pagamenti dell'esercito.
Magnenzio dovette per questo motivo svalutare le sue monete bronzee. Le modifiche al
sistema monetale non terminarono, infatti, dopo la morte dell'usurpatore, Costanzo II immise
sul mercato una moneta leggera (vietando l'uso di quelle precedenti): l'AE3 fel temp reparatio
che ebbe una grandissima successo sul mercato. Le conseguenze a cui portò l'entrata in circolo
di questo nuovo nominale furono enormi tesaurizzazioni delle monete precedenti, ovvero le
monete di buon peso coniate dal 348 al 354 (si trovarono ad essere di peso maggiore anche
rispetto alle monete costantiniane). I cospicui ritrovamenti dei nuovi AE3 fel temp reparatio
hanno consentito di calcolare una media ponderale, che nell'esempio degli scavi del Teatro
53
CURINA 1983, p. 204. 54
ibidem, p. 207. 55
CALLEGHER 1998, p. 35. 56
MORELLI 2001, p. 560. 57
ERCOLANI COCCHI 1986, p. 215. 58
CALLEGHER 1998, p. 36.
31
Sociale di Trento si aggira intorno a 1,74 g59, in confronto al peso teorico di 2,25 g circa. E'
probabile che dopo il 355 questo nominale sia andato incontro ad una progressiva
diminuzione di peso. Le monete di questo periodo distinguibili con certezza provenienti dal
pozzo 2 nord sono tre; una del tipo felix temporis reparatio60, datata 350-361 per prudenza
viste le cattive condizioni, le altre due monete sono datate 355-361. Il peso medio di queste
monete si aggira intorno a 1,50 g, alimentando l'ipotesi di svalutazione di questi nuovi AE3
dopo il 355. Le monete che più circolavano furono anche le più imitate; (questo fenomeno
imitativo si riscontra già dagli inizi del IV secolo), interessando soprattutto alcuni tipi: i folles
dell'esemplare costantinopolis (Vittoria su prua), urbs roma (lupa con gemelli), e gloria
exercitus (due soldati e una insegna), tutti e tre i tipi ci sono pervenuto dal condotto61. Il
fenomeno imitativo si diffonde, come si è visto, soprattutto dopo l'immissione sul mercato del
tipo fel temp reparatio. FH.3, del 355; le imitazioni di questo tipo sono presenti in diversi
contesti del Nord Italia, come in località Salto del Lupo62: sono 84 gli esemplari pervenuti,
pochi si avvicinano al peso originario, la maggior parte oscilla tra 1,10 e 1,90 g. Anche dall'Agro
Decimano provengono otto monete del tipo fel temp reparatio datate 354-361 (zecca di Roma,
Aquileia, Siscia ?)63 oscillati tra 1,80 e 2,20 g, probabilmente questo tipo monetario è il più
diffuso in questo periodo. Per il periodo che va invece dal 361 al 364 non sono state
identificati nominali provenienti dal condotto idrico; il contributo dato alla circolazione nei
regni di Giuliano e poi Gioviano sembra modesto64. Successivamente dal pozzo 2 nord
proviene una sola moneta datata 364-367 attribuibile a Valentiniano I o a Valente, del tipo
restitutor reip; quattro è possibile siano gloria romanorum 8 datate per sicurezza 364-38765.
Solo su un esemplare gloria romanorum è possibile riconoscere il marchio della zecca di
Aquileia (SMA[...]). Il tipo restitutor reip ha un peso di 2.25 g, mentre le altre hanno un peso
medio di 1.83 g66. Il pozzo 8 sud invece ha restituito un nominale datato 363-392; presenta il
tipo della Vittoria con corona e palma, sempre del pozzo proviene una moneta datata 388-
59
ibidem, p. 38. 60
La moneta è abbastanza consunta, il peso di questa è di 1,49 g ed ha un tipo al rovescio abbastanza stilizzato, potrebbe essere un imitazione seppur mantiene un diametro di 16 mm. 61
ORLANDONI 1991, pp. 615-616. 62
ERCOLANI COCCHI 1986, p. 215. 63
ERCOLANI COCCHI 2006, p. 60. 64
CALLEGHER 1998, p. 44. 65
C'è la possibilità che siano del tipo gloria romanorum 6 (383-387) o del tipo 8 (364-378). 66
Due monete hanno un sovrappeso per via delle incrostazioni.
32
402, del tipo Victoria Avggg; anch'essa con Vittoria tenente corona e palma67. La prima
moneta pesa 2,76 g, la seconda 1,54 g. Il periodo storico in questione, dopo la breve parentesi
del 361-364, vede protagonisti gli imperatori Valentiniano I e Valente che procedettero a
nuove emissioni di bronzo intervenendo soprattutto sulla lega. I tondelli ormai erano solo di
bronzo e del tutto privi di qualsiasi quantità d'argento, metallo che era presente nelle
precedenti coniazioni, pur con percentuali modestissime68. Il peso teorico di questi AE3
dovrebbe essere circa 2,49/2,47 g; più pesante dei nominali precedenti di Giuliano e Gioviano.
Il numero di esemplari riferiti a questo lasso di tempo sembra aumentare: dagli scavi di Classe
proviene un nucleo consistente di monete databili 364-378. Le monete riconoscibili sono
quattro esemplari di Valentiniano I (364-375): uno del tipo securitas reipublicae della zecca di
Siscia, tre del tipo gloria romanorum, uno da Siscia. Il peso medio di queste monete di è di 1,72
g; simile alla media di 1,83 g dei nominali dello stesso periodo provenienti dal condotto idrico.
Un'altra presenta il tipo securitas reipublicae, datato 364-378, e pesa 2,41 g69. Dal tesoretto di
Salto del Lupo aumentano le monete datate dal 364 al 378: 202 esemplari presentano la
Vittoria alata del tipo securitas reipublicae; l'imperatore più rappresentato è Valente, seguito
da Valentiniano I. Il loro peso oscilla tra 0,80 g e 2, 20 g; le più leggere spesso sono imitazioni o
semplicemente consunte. La zecca più rappresentata in questi anni è quella di Roma, seguita
da Arelate, Aquileia, in oriente Cizico e Antiochia. A Salto del lupo il secondo gruppo in ordine
di consistenza per questo periodo è rappresentato dal tipo gloria romanorum con ben 83
esemplari. I tipi gloria romanorum sono distribuiti in due archi di tempo: 364-375 e 383-387;
sono riconoscibili gli imperatori Valente, Valentiniano I, Teodosio e Graziano. Il loro peso
oscilla tra 1,11 g e 2, 20 g; sono presenti imitazioni anche di questi tipi. Le zecche più
rappresentate sono Roma e Antiochia, seguite da Aquileia, Siscia, Costantinopoli, Tessalonica
e Cizico70. Il materiale di tardo IV secolo è cospicuo anche dagli scavi di Villa Clelia (Imola), le
monete riconoscibili sono tutti AE3: una con il tipo restitutor reip di Valentiniano I e Valente
364-365 da Eraclea, due securitas reipublicae del 364-378 con Vittoria alata, inoltre è presente
una moneta di Valente (364-378) da Lugdunum, una di Valentiniano I (364-375) da Siscia,
infine è attestata anche la zecca di Nicomedia in una moneta datata 364-367. I pesi di questi
67
Datazioni larghe per via delle condizioni degli esemplari e del tipo molto diffuso. 68
CALLEGHER 1998, p. 44. 69
CURINA 1983, pp. 205-206. 70
ERCOLANI COCCHI 1986, p. 216.
33
tondelli oscillano tra 1,60 g e 2,20 g. Dall'Agro Decimano a sud di Ravenna proviene un AE3
gloria romanorum (364-378) della zecca di Tessalonica (1,05 g), due AE3 securitas reipublicae
(364-375), uno di Valente (2,20 g), uno di Valentiniano I (1,80 g), il primo della zecca di Roma71.
I dati ricavati, nel complesso, indicano in modo inequivocabile una predominanza dei tipi
gloria romanorum e securitas reipublicae nell'area romagnola, confermando questo trend
generale osservato nel Nord-Est della penisola italiana72.
Condotto idrico
di Classe
Classe, scavi
1975-1982
Tesoretto di
Salto del lupo
Scavi di Villa
Clelia
Rinvenimenti
dall'Agro
Decimano
securitas
reipublicae
- 2 202 2 2
gloria
romanorum
4(?) 3 83 - 1
restitutor reip 1 - - 1 -
Tabella 1. Tipi monetali identificati, 364-378 d.C.
I tipi in circolazione quindi sono più o meno gli stessi e provengono con qualche eccezione in
maggioranza dalla zecca di Roma, seguita da Siscia e Aquileia che prendono definitivamente il
posto delle zecche galliche, protagoniste nella prima parte del secolo. L'afflusso di moneta sul
mercato già da Valentiniano I, tende ad aumentare, in concomitanza della diminuzione
ponderale, infatti, si nota nei rinvenimenti citati una discrepanza con il peso teorico. Questo fa
ipotizzare una svalutazione intrinseca degli stessi tipi nelle serie coniate più tardi, pur
considerando la consunzione dovuta alla loro circolazione. Le differenze negli standard
ponderali e i volumi di emissioni continuano, spesso aumentando. Tra il 383 e il 387 sono
ancora presenti gli AE2 e gli AE3, ma diventano sempre più rari; nello stesso tempo le
emissioni degli AE4 hanno un andamento ponderale molto instabile. Per la prima volta le
coniazioni iniziano a diversificarsi a seconda delle zecche, mentre nella parte Occidentale
dell'impero prevalse la diffusione degli AE4, le zecche Orientali preferirono coniare AE2 e AE3.
71
ERCOLANI COCCHI 2006, p. 60. 72
CALLEGHER 1998, pp. 44-51.
34
La disponibilità di monete di peso maggiore diminuì in Occidente, la tendenza
all'immobilizzazione di queste ultime aumentò e il protagonista degli scambi quotidiani era
l'AE4 nei suoi tipi più diffusi. Con l'imperatore Teodosio il peso medio degli AE4 era di circa
1,10/1,20 g con tendenza a decrescere e misurava tra i 12 e i 14 mm di diametro. Questa
moneta spicciola in Occidente tra 383 e 388 era ormai prodotta quasi esclusivamente dalla
zecca di Roma e da quella di Aquileia. Il fenomeno delle imitazioni non si interruppe anzi ebbe
una tendenza ad aumentare in tutto l'impero73. Le monete del tipo gloria romanorum
provenienti dal pozzo 2 nord del condotto idrico sono sei: due sono del tipo gloria romanorum
6, datate 383-387, altre quattro sono incerte (è possibile che siano anche gloria romanorum 8,
364-378), quindi datate più prudentemente 364-387. Due sono le monete provenienti dal
pozzo 8 sud, una datata 363-392 con Vittoria al rovescio, un'altra è del tipo victoria auggg,
datata 388-402. Purtroppo la loro parziale illeggibilità non permette una datazione più precisa
e soprattutto perché il tipo con la Vittoria è uno tra i più comuni. Le monete verso la fine del IV
secolo tendono ad aumentare anche negli scavi di Villa Clelia; la concentrazione maggiore si
attesta dal 388 al 42374.
Periodo Condotto idrico Villa
Clelia
(Imola)
Agro
Decimano
Salto del Lupo
(gruzzolo)
363-392 1
378-383 1
383-387 2 4(?) 350
387-388 2 257
383-392 1 Presenti
383-402 1
388-395 1
388-402 1 1
388-408 4
408-423 8 1
Tabella 2.
73
CALLEGHER 1998, pp. 51-60. 74
ERCOLANI COCCHI 1982, p. 370.
35
Le zecche più attestate in area romagnola nell'ultimo ventennio del IV secolo e agli inizi del V
continuano ad essere Roma ed Aquileia, affiancate da rare emissioni di Siscia e Milano75. Sono
presenti anche monete degli usurpatori Magno Massimo e Flavio Vittore del 387-388,
provenienti dal gruzzolo di Salto del Lupo: 257 monete da Roma e Aquileia76. Stando ai dati del
gruzzolo, la zecca più sfruttata da Magno Massimo fu Roma seguita da Aquileia, invece per
Flavio Vittore sono presenti solo emissioni di Aquileia. Rare sono le emissioni dalle zecche
galliche di Arelate e Lugdunum a nome di Magno Massimo e Flavio Vittore, ma sono presenti
al Museo Archeologico Nazionale di Ravenna77; probabilmente si rifanno al periodo in cui
questi usurpatori si impadronirono dei territori gallici. L'aumento di nominali e soprattutto
degli AE4 tra i regno di Teodosio e Onorio è testimoniato anche da altri scavi nel territorio
ravennate (tabella 3). Al fianco dell'aumento delle monete ufficiale aumentarono anche le
imitazioni degli AE4 che spesso sono in maggioranza numerica sulle prime. La causa che portò
alla diffusione di queste monete forse va ricercata nell'editto di Arcadio/Onorio del 395,
mediante il quale si vietava l'uso nel commercio delle monete bronzee di buon peso, emesse
in precedenza e ancora in circolazione (gli AE2 a 1/60 di libbra)78. Di conseguenza i nominali in
circolazione furono l'AE3, battuto però in quantità ridotta, e l'AE4 largamente monetato, che si
andò a collocare nel livello più basso degli scambi. Un'altra causa più probabile potrebbe
essere la legge del 39679 che incise sulla grande circolazione della moneta bronzea. Questo
provvedimento impose il tasso di cambio di un solido d'oro a 25 libbre di bronzo. La volontà
imperiale era di ostacolare la rivalutazione dell'AE2 sugli altri nominali; forse non riuscendo a
bloccare questo fenomeno, l'anno successivo decise di stabilire in modo più rigido il cambio
oro/bronzo evitando che il bronzo venisse rivalutato. Le monete di buon peso logicamente
iniziarono ad essere tesaurizzate, incidendo sulla circolazione. La penuria monetale fu
l'occasione per l'inserimento delle imitazioni che andavano a tamponare questa mancanza;
questo fenomeno continuò anche nel V secolo80. L'aumento della massa circolante nella zona
di Classe ha un'ennesima motivazione; nel 402 infatti, la corte imperiale si sposta a Ravenna,
75
ERCOLANI COCCHI 1988, pp. 57-65. 76
ERCOLANI COCCHI 1986, pp.216-217. 77
ERCOLANI COCCHI 1988, pp. 57-65. 78
MOMMSEN, MEYER 1905: Codex Theodosianus, IX, 23,2. 79
ibidem, XI, 21,2. 80
CALLEGHER 1998, pp. 72-73.
36
dando inizio ad un periodo di espansione e fioritura della città, con la nascita della nuova zecca
imperiale.
AUTORITA'/
PERIODO
NOMINALE S.APOLLINARE
(materiale
sporadico)
S.CROCE
(materiale
sporadico)
CLASSE-
abitato
(materiale
sporadico)
CLASSE-zona
portuale (nuclei
omogenei)
TEODOSIO I
379-395
AE3
AE4
1
3
1
MAGNO MASSIMO
383-388
AE4 3
FLAVIO VITTORE
387-388
AE4 1
ARCADIO
383-408
AE4 1
ONORIO
393-423
TREMISSE
SILIQUAE
AE3
AE4
34
3
1
6
1
3
20
EUGENIO
392-394
AE4 1
Tabella 3. Monete da Teodosio a Onorio dagli scavi di Ravenna e Classe.
37
Fig. 19. Località dei rinvenimenti trattati. 1) Classe, 2) Ravenna, 3) Agro Decimano, 4) Imola,
5) Loc. Salto del Lupo.
38
Roma Aquileia Ravenna Milano Siscia Lugdunum Arelate
TEODOSIO
Solido
AE2
AE3
AE4
1
1
1
1
ELIA FLACCILLA
AE2
1
MAGNO
MASSIMO
Siliqua
AE2
AE4
4
1
1
FLAVIO
VITTORE
Siliqua
AE4
1
1
ONORIO
Solido
Tremisse
Siliqua
AE3
AE4
1
18
2
6
3
1
1
1
1
ARCADIO
Solido
AE2
AE3
AE4
1
1
39
ARCADIO,
ONORIO
AE4
Roma
Aquileia
1
Ravenna Milano Siscia Lugdunum Arelate
Tabella 4. Monete dal Museo Archeologico Nazionale di Ravenna
40
Tessalonica Costantinopoli Cizico Nicomedia Antiochia Zecca
irriconoscibile
TEODOSIO
AE2
AE3
AE4
2
1
1
1
2
1
1
2
3
ELIA FLACCILLA
AE2
1
ONORIO
Solido
AE3
2
1
1
1
24
ARCADIO
Solido
AE2
AE3
AE4
1
1
4
1
1
1
1
1
1
4
ARCADIO,ONORIO
AE3
1
EUDOSSIA
AE3
1
Tabella 5. Monete dal Museo Archeologico Nazionale di Ravenna.
41
Fig. 18. Rinvenimenti di moneta di IV secolo d.C. da contesti archeologici ravennati.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
324-337 337-364 364-393 393-423
Classe-zona portuale (nuclei omogenei)
Classe-abitato (materiale sporadico)
Santa Croce (materiale sporadico)
S. Apollinare In Classe (materiale sporadico)
42
I dati desunti dai siti archeologici ci mostrano la diffusione di alcuni tipi monetali a scapito di
altri dal 378 al 423 (tabella 6). Il tipo gloria romanorum con un prigioniero è il più diffuso in
assoluto anche se c'è da considerare che venne battuto nell'arco cronologico esaminato
almeno due volte: dal 383 al 387 con Teodosio I e dal 408 al 423 con Onorio. Ben 23 AE3 di
Onorio di questo tipo, sono datati 410-423; 21 provengono dagli scavi di S. Apollinare in
Classe81, 2 dagli scavi di S. Croce a Ravenna82.
Tabella 6. Gli AE3 e AE4 più diffusi dal 378 al 423 d.C.83
81
ERCOLANI COCCHI 1988, p. 63. 82
ibidem 83
Alcuni tipi dal Museo Nazionale non sono stati inseriti perchè non rilevasti ai fini statistici.
Tipo Nominale Classe,
zona
portuale
Scavi di Villa
Clelia
Museo
Archeol.
Nazionale
di
Ravenna
Agro
Decimano
Condotto
idrico di
Classe
spes
romanorum
AE4 ** *****
gloria
romanorum
AE3 *** ******** ********
********
********
********
********
***
* ******
vot x mult xx AE4 * ****
salus
reipublicae
AE4 **** ********
*******
**
victoria auccc AE4 **** * *
concordia
auccc
AE3 ****
43
Questa diffusione ravennate degli AE3 contrasta apparentemente con le legge monetaria del
39684, in realtà bisogna considerare che i contesti in cui sono stati rinvenuti sono elitari85, per
di più in quella che era la città sede della corte imperiale. Di conseguenza potrebbe essere
fuorviante trarre conclusioni generali prendendo alla lettera i dati provenienti da una realtà
particolare come la Ravenna del V secolo, che va in totale controtendenza con le altre realtà
territoriali dell'impero. Lo spostamento della corte imperiale da Milano a Ravenna, appunto,
appare una diretta conseguenza della crisi che attraversava l'impero alla fine del IV secolo. La
zecca di Aquileia pur rimanendo attiva fino al 42586, ridimensionò le proprie emissioni a favore
della nuova zecca di Ravenna; a farne le spese fu anche la zecca di Milano che però restò
attiva, con qualche interruzione, per tutto il V secolo. La zecca ravennate raggiunse già con
Onorio i massimi livelli, emettendo moneta in grande quantità, fino al 455 con Valentiniano III.
Nel periodo successivo, fino all'arrivo di Odoacre, Ravenna emise, con qualche interruzione,
sempre moneta in oro e argento. La produzione ravennate era specializzata appunto nei due
metalli nobili, la zecca di Roma invece, riforniva il mercato dell'Italia settentrionale di moneta
bronzea87. Dopo il 455, l'unico tentativo di proporre grosse quantità di nummi bronzei dalla
zecca di Ravenna, fu effettuato da Maggioriano (457-461). Questo imperatore proponeva una
moneta divisionale di buon peso per cercare di contrastare i gravi fenomeni imitativi. Il
periodo più fiorente per la diffusione della moneta ravennate fu dal 415 al 455, soppiantando
nei numeri Aquileia, Milano, e in parte Roma; come si è accennato in precedenza, più tardi
tornò a dominare sul mercato del bronzo la zecca di Roma, seguita da quella di Milano. Per
quanto riguarda i rinvenimenti; solo il pozzo 8 sud ha restituito monete riconoscibili datate
dopo il regno di Onorio. Un AE4 del regno di Valentiniano III (425-455) reca il tipo victoria
augg, da Villa Clelia sono due gli AE4 assegnati a quest'imperatore, recanti anch'essi il tipo
victoria aug(g?) e provenienti dalla zecca di Roma88. Anche gli scavi di S. Croce a Ravenna
hanno restituito tre nominali di questo imperatore mentre uno proviene da S. Apollinare in
Classe89. Le monete bronzee di questo periodo presenti nel museo archeologico nazionale di
Ravenna, non sono tante; due AE4 di Teodosio II (425-450) uno da Costantinopoli, uno da
84
Cambio di un solido d'oro a 25 libbre di bronzo, ciò portò alla diffusione degli AE4. 85
Chiese di S. Croce e S. Apollinare in Classe. 86
ERCOLANI COCCHI 2007, pp. 51-52. 87
ARSLAN 2004, pp. 191-201. 88
ERCOLANI COCCHI 1982, p. 389. 89
MORELLI 2001, p. 560.
44
Cizico e un AE4 di Teodosio II o Valentiniano III (425-455)90. Il pozzo 8 sud ha restituito cinque
AE3 del periodo successivo, assegnati a Maggioriano (457-461), recanti tutte il tipo della
victoria augg[?]. Quattro delle monete di Maggioriano sono state assegnate alla zecca di
Ravenna, una a quella di Milano. Molto interessanti sono altre due AE4 del pozzo 8 sud; due di
queste hanno impresso il monogramma di Ricimero (457-467). Gli altri siti che hanno restituito
monete di Maggioriano in bronzo sono: Villa Clelia91 (2), S. Croce92 (1) e due sono conservate al
museo di Ravenna93. Anche questi esemplari sono del tipo con la Vittoria; ormai diventato uno
dei tipi più diffusi, anche per il valore simbolico. Solo da qualche anno si sta facendo luce sulla
monetazione di Maggioriano e soprattutto di Ricimero, grazie anche al ritrovamento di un
grosso gruzzolo di bronzi a Falerii Novi94. La presenza dal pozzo 8 di queste monete, piuttosto
rare, potrebbe indicare un occultamento non lontano dal periodo della loro emissione.
Contemplando l'ipotesi che il pozzo del condotto idrico in cui fu ritrovato un gruzzolo negli
anni '80, si tratti dell'8 sud, è possibile che abbia delle analogie con il tesoretto ritrovato in una
fornace, durante gli scavi del porto di Classe95. E' possibile datare il gruzzolo di Classe tra la fine
del V e il VI secolo; analogamente il consistente numero di monete provenienti dal pozzo 8,
sono datate tra la seconda metà del V e gli inizi del VI secolo96. Purtroppo non è stato possibile
individuare dal pozzo 8 monete che vanno oltre le coniazioni di Ricimero. La presenza di un
buon numero di imitazioni, soprattutto del tipo con la croce greca97, fa protendere verso una
perdita o occultamento del gruzzolo verso la fine del V, inizi VI secolo (nel caso si trattasse
appunto di un gruzzolo unitario). Il ritrovamento sopra citato dalla fornace di Classe è
composto da 42 esemplari con il tipo victoria aucc (tre dalla zecca di Roma), ma solo su due di
essi si è potuta leggere l'autorità emittente, ovvero Valentiniano III in un caso, e Maggioriano
nell'altro. Il tipo con la Vittoria venne coniato anche in Oriente, ed è possibile che tra le
victoria aucc illeggibili siano presenti monete di Leone I (457-474); nel gruzzolo infatti è
presente un esemplare con il tipo del leone (Costantinopoli) assegnato proprio a
quest'imperatore. Non è improbabile anche che lo stesso Maggioriano abbia emesso a
90
ERCOLANI COCCHI 1983, pp. 67-69. 91
ERCOLANI COCCHI 1982, p. 389. 92
MORELLI 2001, p. 560. 93
ERCOLANI COCCHI 1983, p. 69. 94
ASOLATI 2005, pp. 26-38. 95
ERCOLANI COCCHI 1988, p. 287. 96
Le monete sono spesso illeggibili e frammentate; sono state datate in base al loro peso e diametro. 97
ASOLATI 2006, pp. 144-146.
45
Ravenna, tipi con la Vittoria a nome dell'imperatore della Pars Orientis: Leone I. Altre 12
monete presentano il tipo della Vittoria ma non hanno il marchio di zecca in campo, 4 di esse
hanno un diametro inferiore e sono interpretabili come imitazioni. Non ci furono mai emissioni
bronzee dalla zecca di Ravenna, prima di quelle a nome di Maggiorano; fatta eccezione per il
rinvenimento ad Altino di una moneta di Giovanni (423-425)98. Come abbiamo visto
Maggioriano per frenare il fenomeno imitativo coniò AE3 pesanti, infatti, le monete di questo
tipo rinvenute dal pozzo 8 oscillano tra 1,13 e 1,89 g; un peso simile ai riferimenti di Villa
Clelia, di S. Croce e del museo. Nel 445 una costituzione dell'imperatore Valentiniano III infatti,
aveva fissato il valore del solido aureo a 7000-7200 nummi in bronzo99. ll tentativo di
Maggioriano però non andò a buon fine, tanto che dopo il suo regno la moneta bronzea tornò
a svalutarsi. La circolazione delle monete di Maggioriano si estende anche verso sud; sono
attestate 15 monete di questo imperatore dal tesoretto di Falerii Novi (50 km da Roma), la
loro media ponderale è di 1,41 g100, anche questo dato conferma un effettivo aumento di peso
dei nominali bronzei sotto Maggioriano.
98
ASOLATI 2005, p. 26. 99
ROVELLI 2001, p. 203. 100
ASOLATI 2005, pp. 86-87.
46
V. Le emissioni di Ricimero
Guy Lacam è lo studioso che più di qualunque altro si è occupato della monetazione di
Ricimero. Egli divide in due gruppi le emissioni degli AE4 con il monogramma: il primo è
attribuito al periodo di interregno che intercorse tra 465 e il 467 alla morte dell'imperatore
Libio Severo, la zecca di emissione sarebbe stata principalmente Roma, insieme a Milano ed
una zecca militare. Il secondo gruppo che reca al dritto un busto reso in modo più grezzo e
raffigurante lo stesso Ricimero con i capelli raccolti in una coda, sarebbe stato battuto nel 472
dopo la definitiva rottura tra Antemio e Ricimero. Questo secondo gruppo sarebbe
caratterizzato da peso e diametro maggiori rispetto a quelli dell'emissione precedente (10 mm
contro 8/10 e ca. 2 g contro una media di 0,91 g)101. Ad oggi questa tesi è stata oggetto di
critiche, soprattutto alla luce di nuovi ritrovamenti. In primis l'attribuzione a zecche differenti
da quella di Roma avrebbe comportato la presenza di marchi di zecca che non compaiono su
nessun esemplare, le monete più pesanti invece potrebbero essere frutto di imitazioni coeve,
infine la collocazione di queste emissioni interamente dopo la morte di Libio Severo è stata
rigettata, seppur è sembrato accettabile includere nel periodo dell'interregno una parte di
esse. Lo studio del ritrovamento di un gruzzolo a Falerii Novi102, ha aperto nuove e più chiare
prospettive nei confronti della monetazione di Ricimero: si annoverano tra le monete
rinvenute ben 298 esemplari recanti il monogramma di Ricimero, si tratta del rinvenimento
conosciuto più cospicuo di queste monete ad oggi. Su tre monete al dritto è stato riconosciuto
grazie alla legenda il busto di Valentiniano III, al rovescio il solito monogramma. Queste tre
monete vengono collocate da Asolati prima di Libio Severo, tra il 457 e il 461103. In questo
periodo lo studioso propone la coesistenza sia delle emissioni di Maggioriano che di Ricimero;
il primo gestiva le zecche di Ravenna e Milano, il secondo quella di Roma. Per evitare di
avocarsi prerogative prettamente imperiali, Ricimero che al tempo era aveva la carica di
patricius, decise di dedicare le sue monete ad un imperatore defunto; Valentiniano III aveva
segnato la storia degli ultimi trent'anni dell'impero, dopo di lui ci fu Petronio Massimo che
aveva rappresentato un episodio insignificante nella successione imperiale, infine Avito fu
sconfitto proprio da Ricimero; di conseguenza la scelta di emettere monete a nome di
101
LACAM 1988, 288-302. 102
ASOLATI 2005. 103
ibidem, pp. 28-32.
47
Valentiniano sembra quasi obbligata. Successivamente a queste emissioni vengono quelle a
nome di Libio Severo e il monogramma di Ricimero al rovescio. Queste emissioni sono datate
al 461-465, quando Ricimero ormai magister militum deteneva effettivamente le redini della
parte occidentale dell'impero. L'imperatore Libio Severo sembra essere destituito all'atto
pratico di ogni potere, nonostante ciò Ricimero non poteva ancora permettersi di battere
moneta solo a suo nome. Si ritiene che l'emissione con legenda dedicata a Libio Severo sia
stata emessa già durante il regno di quest'ultimo, perché esiste un esemplare proveniente da
Falerii Novi, il cui dritto è anepigrafe, e reca solo il busto imperiale entro un bordo perlinato104.
Questo tipo si tende ad assegnarlo al periodo di interregno intercorso tra il 465 e il 467, non
oltre l'inizio del regno di Antemio; unico periodo in cui Ricimero si sarebbe potuto sentire
svincolato da qualunque autorità imperiale, legittimando di conseguenza le sue emissioni
omettendo il nome dell'imperatore. In alternativa potrebbe ritenersi un'emissione affrettata,
in cui è presente un errore di conio; non è da escludere che si tratti di un imitazione, ma in
linea generale si tende ad escluderlo per via della buona resa sia del busto che del
monogramma. Un solo esemplare non rappresenta una prova decisiva a sostegno della tesi
dell'interregno, ma altri nummi dello stesso tipo potrebbero essere presenti tra quelli con il
dritto illeggibile. Un altro esemplare del gruzzolo di Falerii Novi presenta al dritto una legenda
a nome di Antemio; questo esemplare fino ad ora inedito potrebbe essere assegnato al 467,
data della nomina del nuovo imperatore; periodo in cui Ricimero probabilmente tentò di
imporre la sua tutela al nuovo imperatore, come aveva già fatto in passato.
Tabella 7. Proposta di datazione delle emissioni con monogramma di Ricimero.
Si protende a datare questa emissione a nome di Antemio; tra il 25 marzo (data della nomina a
Cesare) e il 12 aprile 467 (data dell'acclamazione imperiale), o al massimo fino all'autunno
104
ASOLATI 2005, p. 37.
CRONOLOGIA EMISSIONI CON MONOGRAMMA DI RICIMERO
457-461 a nome di Valentiniano III defunto
461-465 a nome di Libio Severo
465-467 senza legenda al dritto (busto entro bordo perlinato)
467 a nome di Antemio
48
dello stesso anno, periodo in cui Ricimero e lo stesso imperatore entrarono in rotta105. Il
gruzzolo di Faleii Novi ha restituito monete con il tipi di monogrammi di Ricimero già
conosciuti ed altri inediti (fig. 19). I più interessanti sono quelli con la lettera P, S, T, (fig. 20)
interpretati da Asolati come segni di officina: P = prima, S = seconda, T = terza; ad ulteriore
conferma della provenienza di queste monete dalla zecca di Roma106. La prassi di inserire il
segno di officina omettendo quello di zecca è riscontrata anche durante il regno di
Valentiniano III sulle monete della zecca di Roma. Altre varianti del monogramma di Ricimero
potrebbero essere considerate imitazioni; anche se su molti esemplari la resa dello stesso
appare buona. Queste varianti spesso mancano della lettera C in alto e/o pongono le lettere in
modo speculare (fig. 21).
Fig. 19. Monogrammi di Ricimero (da ASOLATI 2005).
Fig. 20. Monogrammi con segni di officina (da ASOLATI 2005).
Fig. 21. Monogramma speculare e monogramma con "E" speculare raddoppiata a sinistra (da ASOLATI 2005).
105
ASOLATI 2005, p. 38. 106
ibidem, pp. 34-36.
49
Le molte varianti del monogramma di Ricimero e la presenza di imitazioni, portano a riflettere
sull'impatto che ebbero sulla circolazione. Molto probabilmente le emissioni di Ricimero, fino
a poco tempo fa considerate quasi marginali, furono multiple e prolungate nel tempo107.
L'attività della stessa zecca di Roma va rivalutata, alla luce del gruzzolo di Falerii Novi; in
passato si pensava ad un declino della zecca di Roma nel numero delle emissioni dopo il 435 e
soprattutto dopo il 455. La realtà dei nuovi dati tende a rivalutare la zecca di Roma dopo
questo periodo. Gli scavi archeologici effettuati nella città di Roma e nel suburbio hanno
restituito la maggiore quantità di monete di Ricimero, rispetto ai rari rinvenimenti nel resto
dell'Italia, nei Balcani e in Oriente. La destinazione delle monete di Ricimero evidentemente
privilegiava il territorio dell'Italia centrale, non lontano dalla zecca di emissione108.
Roma e dintorni
1. un esemplare dall'agro veiente109;
2. un esemplare dalla necropoli di S. Ciriaco sulla via Ostiense110;
3. otto esemplari da contesti stratigrafici della seconda metà del V - inizi VI secolo d.C.
individuati nel sopraterra della basilica paleocristiana di Generosa111;
4. tre esemplari dalle stratificazioni di abbandono individuate in un quartiere abitativo del
Celio112;
5. un esemplare dall'Aventino113;
6. un esemplare da Pianabella (Ostia)114;
7. oltre una dozzina di esemplari dalla catacomba di Albano Laziale115;
8. gruzzolo monetale con 298 monete di Ricimero da Falerii Novi (Civita Castellana)116.
Italia
9. un esemplare da Milano117;
107
ASOLATI 2005, p. 38. 108
MUNZI 1995, pp. 431-432. 109
CESANO 1913, pp. 544-546. 110
CESANO 1918, p. 99. 111
MUNZI 1995, p. 431. 112
Ibidem. 113
Ibidem. 114
SPAGNOLI 1993, p. 249. 115
FIOCCHI NICOLAI, MARTORELLI, CHIARUCCI, SPERA, DI MARCO, BARBINI, pp. 90-95. 116
ASOLATI 2005. 117
MUNZI 1995, p. 431.
50
10. un esemplare da Angera118;
11. un esemplare da Calvatone119;
12. un esemplare da Capua120;
13. otto esemplari da un ripostiglio rinvenuto a Ordona121.
Dalmazia
14. tre esemplari da un ripostiglio rinvenuto in località ignota122.
Grecia
15. un esemplare dallo scavo dell'Agorà di Atene123;
16. un esemplare da un ripostiglio rinvenuto in località incerta124;
17. quattro esemplari da un ripostiglio acquistato a Volo, Tessaglia125;
18. un esemplare da un ripostiglio rinvenuto a Corinto126.
Siria
19. un esemplare da un ripostiglio proveniente dalla Siria settentrionale127.
Fig. 22. Distribuzione geografica dei ritrovamenti conosciuti di monete con monogramma di Ricimero.
118
GRASSI 1988, p. 133. 119
MUNZI 2005, p. 431. 120
ARTHUR, KING, 1987, p. 522. 121
LALLEMAND 1967, pp. 24 e 29. 122
PEARCE, WOOD 1934, p. 275. 123
THOMPSON 1954, p. 63. 124
ADELSON, KUSTAS 1960, p. 187. 125
ADELSON, KUSTAS 1962, p. 88. 126
BENDALL 1977, p. 82. 127
SEEGER 1976, p. 59.
51
A questi ritrovamenti si aggiungono le due monete con monogramma di Ricimero provenienti
dal pozzo 8 sud del condotto idrico di Classe (fig. 22, n°20).
Fig. 24. AE4 con monogramma di Ricimero del primo tipo (dal pozzo 8 sud di Classe).
Fig. 25. AE4 con monogramma di Ricimero del secondo tipo (dal pozzo 8 sud di Classe).
La prima moneta presenta il tipico monogramma con attaccatura alta dell'ultimo tratto della
M (fig. 24), databile genericamente 457-467 per via dell'illeggibilità del dritto. La seconda
moneta potrebbe essere datata al periodo dell'interregno (465-467), infatti al dritto è visibile
un bordo perlinato (fig. 25); elemento distinguibile della variante anepigrafe128. Il dritto della
seconda moneta è molto rovinato ma sembra non presentare una legenda almeno nella parte
visibile vicino al bordo perlinato. Entrambe le monete sono molto consunte, la seconda è in
parte frammentata, inoltre sembrano essere state battute da un conio più ampio del tondello
usato. La prima pesa 1,10 g, per un diametro di 9 mm, la seconda pesa 0,62 g, per un diametro
128
ASOLATI 2005, p. 37.
52
di 10 mm. I due tondelli sono coerenti con la maggioranza delle altre emissioni di Ricimero che
si mantengono con un peso quasi sempre intorno al grammo e con un diametro di 8/11 mm129.
VI. Le imitazioni di V secolo d.C.
Il tema delle monete di imitazione è molto dibattuto tra i numismatici; non esiste un metodo
preciso per poter attribuire una moneta ad un emissione ufficiale o meno. Di solito viene
interpretata come moneta imitativa, quella moneta che tende a mostrare nei suoi tipi, una
scarsa organicità, disarticolazione dei tratti, stilizzazione del tipo, lettere della legenda
speculari, scritte male o mancanti, ecc. L'individuazione di monete imitative diventa più
difficile in età tardo antica e soprattutto nel V secolo d.C., perché anche le coniazioni ufficiali
tendono ad essere più trascurate nella resa dei tipi e nel peso. Di conseguenza in questo
periodo il limite che divide l'emissione ufficiale da quella imitativa diventa sempre più labile e
si corre il rischio di commettere degli errori. Le emissioni imitative più diffuse in Italia per il V
secolo sono quella con il tipo della croce130, e con il guerriero/imperatore con asta. Sono 22 le
monete con il tipo della croce rinvenute nel pozzo 8 sud e rappresentano il gruppo più
numeroso con lo stesso tipo; su una moneta invece è chiaramente visibile un personaggio che
tiene un asta. Le altre monete che presentano accenni di figure sono molto consunte e di
difficile interpretazione; seppur quasi sicuramente sono ascrivibili a delle imitazioni. Questi ed
altri tipi imitativi furono proposti da Wroth come vandalici131; questa definizione oggi è in
parte superata. Un ipotesi di Arslan vuole che i tipi con la croce siano datati al VI secolo132; per
via dei ritrovamenti da stratigrafie archeologiche di questo periodo, è possibile però che
questo tipo abbia circolato anche per lungo tempo. Alla luce di nuovi ritrovamenti sorgono
alcuni dubbi riguardo alla matrice africana e longobarda dei tipi con la croce. I ritrovamenti di
queste monete provengono soprattutto dal centro-nord Italia (soprattutto tesoretti), altri tipi
protovandali (D, stella, N, cristogramma) provengono in prevalenza dalle regioni centro-
meridionali e dalle isole; ed è raro trovarli accoppiati col tipo della croce nei contesti
settentrionali. I tipi con la croce sono stati rinvenuti dai tesoretti di Padova-Canton del Gallo,
129
ASOLATI 2005, pp. 89-96. 130
Croce (spesso potenziata), entro cerchio semplice, perlinato o corona. 131
WROTH 1911, plate III-IV. 132
ARSLAN 2002, pp. 293-298
53
Concordia, Camporegio, Falerii Novi, avvallando così l'ipotesi che si tratti di produzioni
imitative di origine italiana. Di questi quattro tesoretti solo a Camporegio e a Falerii Novi
ricorre un unico esemplare protovandalo133. A Camporegio è presente una coppia di esemplari
con croce potenziata in cerchio perlinato, uscita dal medesimo abbinamento di coni, e ben tre
casi di coppie di monete che presentano lo stesso conio di dritto ed al rovescio varianti sul
tema della croce greca potenziata134; in quello di Falerii Novi, invece, si può documentare
l'esistenza di due esemplari che condividono un uguale punzone di dritto , mentre al rovescio
presentano rispettivamente una croce potenziata entro doppio cerchio perlinato e una figura
stante, forse un guerriero, con croce astile135. Questi dati permettono di supporre che queste
monete furono tesaurizzate in un luogo non lontano da quello dove furono prodotte. Si
possono leggere parti di legenda su alcune monete con croce del ripostiglio di Camporegio che
alludono probabilmente a Valentiniano III; è possibile quindi che il prototipo imitativo fosse
proprio quello con la croce emesso da questo imperatore verso la fine del suo regno. La
coniazione del tipo con croce di Valentiniano III è assegnata alla zecca di Roma e nasce in
concomitanza con la contrazione di emissioni dei piccoli bronzetti dalla città. E' ragionevole
pensare che le imitazioni si vadano quindi ad inserire in questo contesto per sopperire alla
penuria monetale che dovette affrontare l'Italia. Una o più fabbriche imitative quindi
dovettero nascere in Italia, probabilmente centrale, dopo il periodo di questa emissione che va
dal 440 al 455. Dopo la metà del V secolo quindi sarebbe plausibile datare queste monete; in
supporto a questa datazione vi sono i gruzzoli sopra citati, infatti, queste emissioni vanno a
chiudere a livello temporale il gruzzolo di Camporegio, Concordia e Padova-Canton del Gallo, il
gruzzolo di Falerii Novii si chiude invece con emissioni di Antemio-Leone I, similmente a quello
di Lipari che pure presenta monete con croce e altre imitazioni136. Il tipo con il guerriero con
asta può essere assimilabile si a livello temporale che di produzione con il tipo con la croce;
spesso sono presenti negli stessi rinvenimenti, altre volte i due tipi sono presenti sullo stesso
tondello, uno al dritto e l'altro al rovescio137. Anche il pozzo 8 sud del ha restituito monete che
sembrano avere lo stesso tipo sia al dritto che al rovescio (n°180), oppure la croce da un lato e
un altro tipo dall'altro; quindi con due rovesci (n°181 e n°182). Purtroppo è difficile identificare 133
ASOLATI 2005, p. 46. 134
ASOLATI 2006, pp. 158-159. 135
ASOLATI 2005, p. 114. 136
ORSI 1910, pp. 353-359. 137
ASOLATI 2005, p. 48.
54
dei tipi specifici per via della forte consunzione e frammentarietà dei pezzi. Sempre dal pozzo
8 provengono altre 21 monete considerate imitazioni, oltre a quelle con il tipo con la croce;
molte presentano tratti indistinguibili su uno o su entrambi i lati e in alcuni casi almeno un lato
sembra non essere stato battuto (n°154 e n°162). La maggiore concentrazione di imitazioni di
tipi non individuati e di altre monete illeggibili si attesta tra gli 11 e i 7 mm, con un peso
inferiore al grammo; ovvero lo stesso peso e metrologia individuata per i tipi con la croce. Di
conseguenza si può proporre la medesima datazione alla metà del V secolo. Alcune delle
emissioni imitative con la croce e con il guerriero possono essere attribuite a una o più zecche
clandestine presenti in Italia (forse centrale), non escludendo la possibilità che ce ne fossero
anche in ambito africano, in un periodo di contrazione delle emissioni delle zecche occidentali
e in particolare quella di Roma c'è da chiedersi se queste produzioni imitative siano state
tollerate o addirittura incoraggiate dalle autorità imperiali. Il risultato dei vari decreti
imperiali, che tendevano progressivamente ad inflazionare la moneta in bronzo, fu lo scambio
a peso della stessa; infatti anche per piccoli acquisti giornalieri ormai c'era bisogno di un buon
numero di nummi in bronzo. La fine del valore nominale dei tondelli ufficiali fu la causa
principale del grande successo di cui dovette godere il mercato imitativo che per questa
ragione immetteva in circolazione emissioni di qualità sempre più scadente; al punto di
arrivare a non coniare più i tondelli e addirittura all'uso del piombo al posto del bronzo.
55
Conclusioni
Le monete oggetto dello studio hanno attestato una frequentazione dell'area in esame almeno
dal I secolo d.C. Le monete rinvenute sono sia ufficiali che risultato di imitazioni. Nel pozzo 2
nord la concentrazione maggiore di nominali si ha alla fine del IV secolo, nel pozzo 8 sud
invece la maggioranza delle monete si data dopo la metà del V secolo. A questo periodo
appartengono le monete imitative con il tipo della croce greca e con quello del
"guerriero/imperatore". Nel pozzo 8 sud le monete imitative di V secolo d.C. sono presenti in
maggior numero, rispetto a quelle ufficiali; è interessante la presenza del nummo con
monogramma di Ricimero, mai rinvenuto in quest'area. L'area di circolazione che interessa
questo tipo tende ad estendersi alla luce dei nuovi ritrovamenti; soprattutto verso il Nord
Italia. I tipi monetali di IV-V secolo invece presentano quasi sempre analogie con gli altri
ritrovamenti dell'area romagnola, questo succede anche per le zecche più rappresentate. Le
monete del pozzo 2 nord sono distribuite abbastanza omogeneamente per tutta l'età
imperiale, fino al V secolo; il materiale numismatico del pozzo 8 sud invece è databile
interamente tra la fine del IV e il V secolo, con un picco di presenze dopo la metà del V.
Un'ipotesi plausibile è l'esistenza di un gruzzolo monetale in questo secondo pozzo, occultato
o smarrito almeno dopo la metà del V secolo d.C.
56
CATALOGO
Pozzo 2 nord
1. Vespasiano 69-79 d.C.
Denario, zecca di Roma.
D/ IMP[---]S AVC, busto laureato a d.
R/ [---]TR P COS, Vittoria a s. tiene ramo di palma nella
mano s. e corona nella d.
PB argentato, 2.57 g, 18 mm.
RIC II.
foto 173.
2. Faustina I, 138-140 d.C.
Asse, zecca di Roma.
D/ [---], busto dell'imperatrice a d.
R/ [---], figura stante al centro.
AE, 8.21 g, 25 mm.
RIC III.
foto 128.
3. Antonino Pio, Faustina I, 138-161 d.C.
Denario suberato, zecca di Roma.
D/ [---]NIN[---], busto laureato a d.
R/ [---], figura stante al centro con asta.
AR, 2.57 g, 16 mm.
RIC III.
foto 161.
4. Antonino Pio, 145-161 d.C.
Denario suberato? zecca di Roma.
D/ [---]ONINVS AVG[---], testa laureata a d.
R/ COS IIII, Fortuna stante a d., tiene timone su globo e
cornucopia.
AR?, 2.51 g, 20 mm.
RIC III, n°132.
foto 175.
57
5. Faustina II, 147-175 d.C.
Asse zecca di Roma.
D/ Busto dell'imperatrice a d.
R/ Illeggibile.
AE, 5.13 g, 23 mm.
RIC III.
foto 159.
6. Faustina II, 147-175 d.C.
Asse, zecca di Roma.
D/ [---]AVGVSTA, busto dell'imperatrice a d.
R/ [---]T[---], Letitia al centro con asta?
AE, 10.80 g, 24 mm.
RIC III.
foto 160.
7. Marco Aurelio, 161-180 d.C.
Asse, zecca di Roma.
D/ Busto laureato e barbato a d.
R/ Figura stante al centro con asta.
AE, 7.88 g, 24 mm.
RIC III.
foto 186.
8. Commodo, 177-192 d.C.
Denario suberato, zecca di Roma.
D/ [---], busto laureato a d.
R/ [---], figura al centro a d. con asta.
AR, 3.08 g, 20 mm.
RIC III.
n. (Classe lott. C.M.C. pozzo 2 nord ("), foto 172.
9. Commodo, 186-189 d. C.
Asse, zecca di Roma
D/ [---], testa laureata a d.
R/ S.P.Q.R. [---]TITIAE [---], in corona d'alloro.
AE, 7.88 g, 23 mm.
RIC III, n°554.
foto 158.
58
10. Gordiano III, 242-244 d.C.
Antoniniano, (con rovescio di Filippo l'Arabo).
Zecca di Antiochia.
D/ [---]GOR[---]FEL[---], busto radiato, drappeggiato e
corazzato a d.
R/ AEQV[---]S AVGG, Aequitas stante a s., tiene bilancia
e cornucopia.
BIL, 1.88 g, 21 mm.
RIC IV, parte III, n°230.
foto 157.
11. Gallieno, 253-268 d.C.
Antoniniano, zecca?
D/ [---], busto radiato a d.
R/ [---], figura stante al centro con asta?
BIL, 1.59 g, 20 mm.
RIC V, vol. A.
foto 176.
12. Gallieno, 253-268 d.C.
Antoniniano, zecca ?
D/ [---]LLIENVS[---], busto radiato a d.
R/ illeggibile.
BIL, 1.23 g, 20 mm.
RIC V vol. A, esemplare frammentato.
foto 177.
13. Costantino, 314 d.C.
Follis, zecca di Roma (terza officina).
D/ IMP CONSTANTINVS PF AVG, busto laureato,
drappeggiato e corazzato a d.
R/ SOLI INVICTO COMITI R F R* T, Sol radiato stante a s.,
solleva la mano d., globo nella s., clamide attraversa
spalla s.
AE, 2.76 g, 20 mm.
RIC VII, n° 19.
foto 179.
59
14. Costantino I, o per i Costantinidi, 330-335 d.C.
Follis, zecca?
D/ [---]VL CO[---]BC, busto laureato a d.
R/ [---]AE[---], due soldati stanti con asta e scudo, due
insegne al centro tra i soldati.
AE, 1.28 g, 17 mm.
RIC VII, p. 336, 329, (e simili).
foto 127.
15. Costantino, 330-337 d. C.
Follis, zecca di Roma.
D/ VRBS ROMA, Testa di Roma elmata a s.,.
R/ No legenda, lupa a s. allatta i due gemelli sotto due
stelle, (esergo illeggibile).
AE, 1.07 g, 16 mm.
RIC VII, n° 331 (e simili), esemplare consunto.
foto 193.
16. Costantino, 330-337 d. C.
Follis, zecca?
D/ CONSTAN TINOPOLIS, Costantinopoli con elmo
laureato a s., indossa mantello imperiale, lancia
rovesciata.
R/ No legenda, vittoria alata a s. su prua di nave, tiene
lancia nella mano d., mano s. su scudo, esergo
illeggibile.
AE, 2.35 g, 17 mm.
RIC VII, pag. 697 n°114 (e simili).
foto 125.
17. Costantino II con Magnenzio, con Gallo, con Giuliano
Cesare, 350-361 d.C.
AE4, zecca?.
D/ [---], busto laureato a d.
R/ [---], imperatore trafigge cavaliere caduto.
AE, 1.49g, 16 mm.
LRBC 424, 2625.
n. (Classe Lott ? Fognone pozzetto ?), foto 113.
60
18. Costanzo II con Giuliano Cesare, 355-361 d.C.
AE4, zecca ?
D/ [---]NSTAN[---], busto diademato a d.
R/ [---], Virtus elmata a d., tiene globo e lancia.
AE, 1.29 g, 14 mm.
LRBC 2504.
foto 143.
19. Costanzo II con Giuliano Cesare, 355-361 d.C.
AE4, zecca?
D/ illeggibile.
R/ [---], Virtus con lancia.
AE, 1.56 g, 15 mm.
LRBC 2504.
foto 130.
20. Valentiniano I e Valente, 364-367 d.C.
AE3, zecca?
D/ [---], busto a d.
R/ [---], imperatore stante, testa a d., tiene victoriola
con la s.
AE, 2.25 g, 19 mm.
LRBC 1702.
foto 126.
21. Valentiniano I, Valente, Graziano, Valentiniano II,
Teodosio e Arcadio, 364-378, 383-387 d.C.
AE3, zecca?
D/ [---]PF AVG, busto diademato e drappeggiato a d.
R/GLO[---], imperatore con mano d. su prigioniero
inginocchiato a s., mano s. tiene labaro.
AE, 1.72 g, 17 mm.
LRBC 338(6, 8).
foto 129.
61
22. Valentiniano I, Valente, Graziano, Valentiniano II,
Teodosio I e Arcadio, 364-378, 383-387 d.C.
AE3, zecca?
D/ [---], busto diademato a d.
R/ [---]RO[---], imperatore con mano d. su prigioniero
inginocchiato a s., mano s. tiene labaro.
AE, 1.30 g, 16 mm.
LRBC 388(6, 8).
foto 132.
23. Valentiniano I, Valente, Graziano, Valentiniano II,
Teodosio e Arcadio, 364-378, 383-387 d.C.
AE3, zecca ?
D/ illeggibile.
R/ [---], imperatore con mano d. su prigioniero
inginocchiato a s., mano s. tiene labaro con chi rho.
AE, 1.80 g, 17 mm.
LRBC 388(6, 8).
foto 148.
24. Valentiniano I, Valente, Graziano, Valentiniano II,
Teodosio e Arcadio, 364-378, 383-387 d.C.
AE3, zecca di Aquileia.
D/ illeggibile.
R/ [---]SMA, parte delle gambe dell'imperatore, labaro.
AE, 2.50 g, 17 mm.
LRBC 388(6, 8), peso alterato dalle incrostazioni.
foto 203.
25. Valentiniano II, Teodosio I e Arcadio, 383-387 d.C.
AE3, zecca occidentale?
D/ illeggibile.
R/ [---], imperatore con mano d. su prigioniero
inginocchiato a s., mano s. tiene labaro con chi rho.
AE, 2.15 g, 18 mm.
LRBC 388(6), peso alterato dalle incrostazioni.
foto 190.
62
26. Valentiniano II, Teodosio I e Arcadio, 383-387 d.C.
AE3, zecca occidentale?
D/ [---]VS PF[---], busto diademato a d.
R/ [---], imperatore con mano d. su prigioniero
inginocchiato a s., mano s. tiene labaro.
AE, 1.93 g, 17 mm.
LRBC 388(6).
foto 136.
Monete di autorità indeterminata
27. I-III sec.
Asse? illeggibile.
AE, 6.95g, 22 mm.
foto 187.
28. I-III sec.
Asse, illeggibile.
AE, 6.36 g, 22 mm.
foto 189.
29. I-III sec.
Asse o semisse? Illeggibile.
AE, 4.02 g, 18 mm.
foto 165.
30. I-III sec.
Asse o semisse? Illeggibile.
AE, 3.10 g, 20 mm, frammentato.
foto 199.
31. I-III sec.
Asse?
Illeggibile.
AE, 4.99 g, 23 mm, incrostazioni.
n. (Classe Fogna C.M.C. pozzo B/2nord), foto 114.
63
32. I-III sec.
Sesterzio.
D/ Illeggibile.
R/ Figura verticale al centro.
AE, 10.86 g, 29 mm.
foto 124.
33. I-III sec.
Sesterzio.
D/ Busto laureato? a d.
R/ Illeggibile.
AE, 13.15 g, 26 mm.
n. (Classe C.M.C. (pod. Minguzzi) b/2 nord), foto 110.
34. I-III sec.
Asse o semisse?.
Illeggibile.
AE, 3.58 g, 19 mm.
foto 168.
35. I-III sec.
Asse o semisse?
Illeggibile.
AE, 3.23 g, 18 mm.
foto 166.
36. I sec.
Asse, zecca di Roma.
D/ [---], busto a d.
R/ Illeggibile.
AE, 9.33 g, 25 mm.
n. (2 nord), foto 184.
37. II inizi III sec.
Denario?
Illeggibile.
AR, 1.72 g, 18 mm, frammentato.
foto 170.
64
38. Fine II, inizi III sec.
Sesterzio, zecca di Roma.
D/ [---], busto a d.
R/ [---], figura al centro.
AE, 20.00 g, 26 mm.
foto 185.
39. Inizi III sec.
Denario suberato, zecca ?
D/ [---], busto laureato a d.
R/ [---], imperatore con scudo?
AR, 0.88 g, 18 mm, esemplare spezzato.
foto 174.
40. Inizi IV sec.
Follis.
D/ Resti di legenda illeggibili, busto diademato a d.
R/ Resti di legenda illeggibile.
AE, 1.63 g, 18 mm, frammentato.
foto 134.
41. IV sec.
Illeggibile.
AE, 2.21 g, 18 mm.
foto 197.
42. IV sec.
D/ Resti di legenda, busto a d.
R/ Illeggibile.
AE, 2.07 g, 18 mm.
foto 133.
43. IV sec.
D/ Busto diademato a d.
R/ Illeggibile.
AE, 1.98 g, 18 mm.
foto 153.
44. IV sec.
Illeggibile.
AE, 1.95 g, 18 mm.
foto 152.
65
45. IV sec.
Illeggibile.
AE, 1.84 g, 18 mm.
foto 195.
46. IV sec.
Illeggibile.
Resti di cerchio.
AE, 1.62 g, 18 mm.
foto 131.
47. IV sec.
Illeggibile.
AE, 1.62 g, 19 mm.
foto 196.
48.IV-V sec.
Illeggibile.
AE, 2.43 g, 17 mm.
foto 192.
49. IV-V
D/ Resti di legenda, busto a d.
R/ Illeggibile.
AE, 2.25 g, 17 mm, incrostazioni.
foto 137.
50. IV-V sec.
D/ Busto? Resti di legenda.
R/ Illeggibile.
AE, 2.21 g, 16 mm.
foto 118.
51. IV-V sec.
Illeggibile.
AE, 2.18 g, 17 mm.
foto 205.
52. IV-V sec.
Illeggibile.
AE, 2.17 g, 15 mm, incrostazioni.
foto 188.
66
53. IV-V sec.
Illeggibile.
AE, 2.09 g, 16 mm, incrostazioni.
foto 191.
54. IV-V sec.
Illeggibile.
AE, 1.96 g, 15 mm.
n. (2 nord, C.M.C. 3 p.), foto 178.
55. IV-V sec.
Illeggibile.
AE, 1.88 g, 15 mm.
foto 120.
56. IV-V sec.
Illeggibile.
AE, 1.83 g, 16 mm.
foto 202.
57. IV-V sec.
Illeggibile.
AE, 1.78 g, 15 mm.
foto 201.
58. IV-V sec.
D/ Busto diademato a d.
R/ Illeggibile.
AE, 1.77 g, 15 mm.
foto 155.
59. IV-V sec.
D/ Busto a d.
R/ Illeggibile.
AE, 1.74 g, 15 mm.
foto 147.
60. IV-V sec.
D/ Busto diademato a d.
R/ Illeggibile.
AE, 1.64 g, 16 mm.
foto 156.
67
61. IV-V sec.
Illeggibile.
AE, 1.61 g, 17 mm.
foto 164.
62. IV-V sec.
Illeggibile.
AE, 1.54 g, 17 mm.
foto 151.
63. IV-V sec.
Illeggibile.
AE, 1.48 g, 15 mm.
foto 119.
64. IV-V sec.
Illeggibile.
AE, 1.46 g, 14 mm.
foto 146.
65. IV-V sec.
Illeggibile.
AE, 1.45 g, 15 mm.
foto 154.
66. IV-V sec.
(tagliato a grandezza AE4).
Illeggibile.
AE, 1.45 g, 14 mm.
foto 183.
67. IV-V sec.
Illeggibile.
AE, 1.44 g, 16 mm, incrostazioni.
foto 204.
68. IV-V sec.
D/ Resti di cerchio.
R/ Elementi indistinguibili entro resti di cerchio.
AE, 1.44 g, 16 mm.
foto 123.
68
69. IV- V sec.
Illeggibile.
AE, 1.39 g, 14 mm.
foto 142.
70. IV-V sec.
Illeggibile.
AE, 1.37 g, 14 mm, incrostazioni.
foto 140.
71. IV-V sec.
Illeggibile.
AE, 1.37 g, 15 mm, frammentato.
foto 135.
72. IV-V sec.
D/ Busto (?)
R/ Illeggibile.
AE, 1.37 g, 15 mm.
foto 117.
73. IV-V sec.
Illeggibile.
AE, 1.27 g, 14 mm.
foto 141.
74. IV-V sec. d. C.
Illeggibile.
AE, 1.21 g, 16 mm, incrostazioni.
foto 200.
75. IV-V sec.
D/ Busto.
R/ Illeggibile.
AE, 1.20 g, 16 mm.
foto 182.
76. IV-V sec.
Illeggibile.
AE, 1.10 g, 14 mm, frammentato.
foto 169.
69
77. IV-V sec. d. C.
Illeggibile.
AE, 1.06 g, 16 mm, frammentato.
foto 122.
78. IV-V sec.
Illeggibile.
AE, 1.04 g, 13 mm.
foto 121.
79. IV-V sec.
D/ Busto (?)
R/ Resti di figura con asta (?)
AE, 0.98 g, 14 mm, frammentato.
foto 144.
80. IV-V sec.
Illeggibile.
AE, 0.80 g, 14 mm.
foto 145.
81. V sec.
D/ Ghirlanda (?).
R/ Ghirlanda (?)
AE, 0.74 g, 9 mm.
foto 181.
82. V sec.
D/ [---]AVG, busto a d.
R/ Resti di Cerchio.
AE, 0.56 g, 10 mm.
foto 171.
83. V sec.
Illeggibile.
AE, 0.44 g, 9 mm.
foto 180.
84. V-VI sec.
D/ Busto (?)
R/ Due figure stanti (?)
AE, 0.98 g, 11 mm.
foto 138.
70
85. V-VI sec.
Illeggibile.
AE, 0.82 g, 12 mm.
n. (Classe lott. C.M.C. pozzo 2 nord, fognone pozzo B).
foto 162.
86. V-VI sec.
Illeggibile.
AE, 0.73 g, 11 mm.
foto 139.
87. V-VI sec.
Illeggibile.
AE, 0.73 g, 12 mm, incrostazioni.
foto 198.
88. V-VI sec.
D/ Illeggibile.
R/ Resti di figure indistinguibili.
AE, 0.56 g, 12 mm.
foto 150.
89. V-VI sec.
Illeggibile.
AE, 0.27 g, 12 mm, frammentato.
foto 149.
Altro
90.
Pezzo monetiforme fuso, resti di figura.
AE, 3.11 g, 15 mm.
foto 167.
91.
Pezzo monetiforme,
AE, 3.55 g, 24 mm, tondello molto liscio, di colore verde
chiaro, (è possibile anche che sia una moneta moderna).
foto 163.
71
Pozzo 8 sud
92. Gioviano, Valentiniano I, Graziano,
Valentiniano II, 363-392 d. C.
AE4, zecca indefinita.
D/ [---]ANVS AVGG, busto diademato a d.
R/ [---], Vittoria con corona e palma a s.
AE, 2.76 g, 14 mm.
RIC IX.
foto 98.
93. Valentiniano II, Teodosio I, Eugenio, Arcadio, Onorio,
388-402 d.C.
AE4, zecca occidentale?
D/ [...]PF AVG, busto diademato e drappeggiato a d.
R/ VICTORI-AAVGGG, Vittoria a s., tiene corona e palma.
AE, 1.54 g, 9 mm.
LRBC 389.
foto 23.
94. Valentiniano III, 425-455 d.C., (con Teodosio II e
Galla Placidia fino al 450, con Marciano fino al 455).
AE4, zecca occidentale.
D/ [---]S PF AVG, busto diademato e drappeggiato a d.
R/ [---]AVGG, Vittoria a s., tiene corona e palma, entro
bordo perlinato.
AE, 1.49 g, 12 mm.
LRBC 863.
foto 99.
95. Ricimero, emissione postuma a nome di
Valentiniano III, Libio Severo, Ricimero (interregno 465-
467), Antemio, 457-467 d.C.
AE4, zecca di Roma.
D/ Illeggibile.
R/ Monogramma di Ricimero.
Monogramma in RIC, X: 1
Monogramma in Asolati 2005: n°826
AE, 1.10 g, 9 mm.
Asolati 2005, n°615, 826.
foto 21.
72
96. Ricimero (interregno), 465-467 d.C. (?)
AE4, zecca di Roma.
D/ Bordo perlinato (senza legenda del dritto).
R/ Resti di Monogramma.
Monogramma in RIC, X: 1
Asolati 2005, n°845.
AE, 0.62g, 10 mm.
foto 31.
97. Maggioriano, 28 dic. 457 al 2 agosto 461 d. C.
AE3, zecca di Ravenna.
D/[---]PF[---], busto diademato e drappeggiato a d.
R/ [---], Vittoria stante a s., tiene corona e ramo di
palma, elemento circolare in basso a d.
AE, 1.13 g, 11 mm.
RIC X, n°2516.
foto 101.
98. Maggioriano, 28 dic. 457 al 2 agosto 461 d. C.
AE3, zecca di Ravenna.
D/ DN M[---], busto drappeggiato, con diadema
perlinato a d.
R/ [---]TORI[---], Vittoria a s., tiene corona e ramo di
palma.
AE, 1.25 g, 11 mm.
RIC X, n°2617, in parte fuori tondello.
foto 106.
99. Maggioriano, 28 dic. 457 al 2 agosto 461 d. C.
AE3, zecca di Milano.
D/ [---], busto drappeggiato a d., con diadema perlinato
a pendenti finali.
R/ [---]AVGG[---], vittoria a s., tiene corona e ramo di
palma.
AE, 1.26 g, 13 mm.
RIC X, n°2646.
foto 102.
73
100. Maggioriano, 28 dic. 457 al 2 agosto 461 d. C.
AE3, zecca di Ravenna.
D/ [---], busto diademato e drappeggiato a d.
R/ VICTORI[---], Vittoria (frontale?), tiene corona a s.
AE, 1.83 g, 11 mm.
RIC X, n°2618, in parte fuori tondello.
foto 100.
101. Maggioriano, 28 dic. 457 al 2 agosto 461 d. C.
AE3, zecca di Ravenna.
D/ [---], busto diademato a d., entro bordo perlinato.
R/ [---]TORI[---], vittoria a s. con corona.
AE, 1.89 g, 12 mm.
RIC X, n°2617.
foto 104.
Monete di autorità indeterminata
102. Moneta moderna, I-III sec. (?)
Asse, dupondio, 1 centesimo (?)
D/ Busto (?)
R/ Illeggibile.
AE, 4.51 g, 25 mm.
foto 11.
103. IV-V sec.
AE4.
Illeggibile.
AE, 2.48 g, 12 mm, fusa, tondello non coniato (?).
foto 103.
104. IV-V sec.
AE4.
Illeggibile.
AE, 2.27 g, 13 mm, frammentato.
foto 13.
74
105. IV-V sec.
AE4.
Illeggibile.
AE, 1.84 g, 14 mm.
foto 19.
106. IV-V sec.
AE3.
Illeggibile.
AE, 1.39 g, 17 mm.
foto 26.
107. IV-V sec.
AE4.
Resti di legenda.
Illeggibile.
AE, 1.21 g, 14 mm, frammentato.
foto 108.
108. IV-V sec.
AE4.
Illeggibile.
AE, 1.05 g, 13 mm, incrostazioni.
foto 12.
109. V sec.
AE4, (fuso?)
Illeggibile.
AE, 1.22 g, 11 mm.
foto 15.
110. V sec.
AE4, (fuso?).
Illeggibile.
AE, 1.18 g, 11 mm.
foto 27.
111. V sec.
AE4.
Illeggibile.
AE, 0.95 g, 11 mm.
foto 105.
75
112. V sec.
AE4, (non coniato?).
Illeggibile.
AE, 0.85 g, 10 mm.
foto 55.
113. V sec.
AE4.
Illeggibile.
AE, 0.77 g, 9 mm.
foto 16.
114. V sec.
AE4.
Illeggibile.
AE, 0.76 g, 10 mm.
foto 33.
115. V sec.
AE4.
Illeggibile.
AE, 0.68 g, 9 mm.
foto 18.
116. V sec.
AE4.
Illeggibile.
AE, 0.64 g, 11 mm.
foto 39.
117. V sec.
AE4.
Illeggibile.
AE, 0.61 g, 10 mm.
foto 52.
118. V sec.
AE4.
Illeggibile.
AE, 0.45 g, 9 mm.
foto 96.
76
119. V sec.
AE4.
Tondello non coniato (?)
AE, 0.45 g, 10 mm.
foto 68.
120. V sec.
AE4.
Illeggibile.
AE, 0.44 g, 10 mm.
foto 36.
121. V sec.
AE4.
Tondello non coniato (?)
AE, 0.39 g, 8 mm.
foto 62.
122. V sec.
AE4.
Illeggibile.
Tratti su un lato.
AE, 0.34 g, 8 mm.
foto 95.
123. V sec.
AE4.
Tondello non coniato.
AE, 0.33 g, 8 mm.
foto 63.
124. V sec.
AE4.
Tondello non coniato.
AE, 0.32 g, 9 mm.
foto 59.
125. V sec.
AE4.
Illeggibile.
AE, 0.30 g, 9 mm.
foto 44.
77
126. V sec.
AE4.
Illeggibile.
AE, 0.29 g, 7 mm, frammentato.
foto 28.
127. V sec.
AE4.
Illeggibile.
AE, 0.26 g, 7 mm.
foto 48.
128. V sec.
AE4.
D/ Illeggibile.
R/ Tracce di cerchio.
AE, 0.25 g, 8 mm.
foto 58.
129. V sec.
AE4.
Illeggibile.
AE, 0.23 g, 10 mm, frammentato.
foto 69.
130. V sec.
AE4.
D/ Resti di legenda (?)
R/ Illeggibile.
AE, 0.23 g, 7 mm.
foto 94.
131. V sec.
AE4.
Illeggibile.
AE, 0.21 g, 9 mm, frammentato.
foto 43.
132. V sec.
AE4.
Tondello non coniato.
AE, 0.19 g, 7 mm.
foto 92.
78
133. V sec.
AE4.
Tondello non coniato.
AE, 0.18 g, 8 mm.
foto 78.
134. V sec.
AE4.
Illeggibile.
AE, 0.17 g, 9 mm.
foto 49.
135. V sec.
AE4.
Illeggibile.
AE, 0.16 g, 8 mm.
foto 87.
136. V sec.
AE4.
Tondello non coniato.
AE, 0.15 g, 8 mm.
foto 56.
137. V sec.
AE4.
Illeggibile.
Asta?
AE, 0.15 g, 7 mm, frammentato.
foto 17.
138. V sec.
AE4.
Illeggibile.
AE, 0.14 g, 8 mm, frammentato.
foto 79.
139. V sec.
AE4.
Tondello non coniato (?)
AE, 0.12 g, 8 mm.
foto 88.
79
140. V sec.
AE4.
Illeggibile.
AE, 0.11 g, 7 mm, frammentato.
foto 45.
141. V sec.
AE4.
Illeggibile.
AE, 0.08 g, 8 mm, frammentato.
foto 29.
Imitazioni con figura con asta e altri tipi indistinguibili.
142. IV-V sec.
AE4.
D/ Illeggibile.
R/Porta del campo (?).
AE, 2.08 g, 12 mm.
foto 14.
143. IV-V sec.
AE4.
D/ Busto (?)
R/ Asta (?)
AE, 1.89g, 13 mm.
foto 22.
144. IV-V sec.
AE4.
D/ Busto con resti di legenda (?)
R/ Elementi indistinguibili.
AE, 1.06 g, 12 mm.
foto 37.
145. V sec.
AE4.
D/ Illeggibile.
R/ Personaggio stante con asta, (figura imperiale).
AE, 1.01 g, 9 mm.
foto 38.
80
146. V sec.
AE4.
D/ Busto?
R/ Elementi indistinguibili.
AE, 0.76 g, 9 mm.
foto 35.
147. V sec.
AE4.
D/ Illeggibile.
R/ Guerriero (?) entro corona stilizzata.
AE, 0.59 g, 11 mm.
foto 32.
148. V sec.
AE4.
Segni indistinguibili su entrambi i lati.
AE, 0.57 g, 10 mm, frammentato.
foto 25.
149. V sec.
AE4.
D/ Illeggibile.
R/ Monogramma (?).
AE, 0.57 g, 9 mm.
foto 66.
150. V sec.
AE4.
D/ Busto imperiale (?)
R/ Cerchio, (battuta in parte fuori tondello).
AE, 0.34 g, 9 mm.
foto 40.
151. V sec.
AE4.
D/ Illeggibile.
R/ Tratti indistinguibili.
AE, 0.25 g, 8 mm.
foto 85.
81
152. V sec.
AE4.
D/ Illeggibile.
R/ Stella (?) Entro bordo perlinato (o corona).
AE, 0.24 g, 9 mm.
foto 54.
153. V sec.
AE4.
D/ Bordo perlinato.
R/ Figure indistinguibili.
AE, 0.21 g, 9 mm.
foto 93.
154. V sec.
AE4.
D/ Tondello non coniato (?)
R/ Monogramma (?).
AE, 0.20 g, 8 mm.
foto 89.
155. V sec.
AE4.
D/ Tratti stilizzati.
R/ Resti di monogramma.
AE, 0.20 g, 10 mm, frammentato.
foto 47.
156. V sec.
AE4.
D/ Busto stilizzato (?) con puntini.
R/ Vuoto (?)
AE, 0.19 g, 7 mm.
foto 57.
157. V sec.
AE4.
D/ Bordo perlinato.
R/ Elementi indistinguibili.
AE, 0.17 g, 8 mm.
foto 34.
82
158. V sec.
AE4.
D/ Illeggibile.
R/ Personaggio con asta (?)
AE, 0.17 g, 8 mm.
foto 74.
159. V sec.
AE4.
D/ Illeggibile.
R/ Elementi indistinguibili.
AE, 0.16 g, 8 mm.
foto 46.
160. V sec.
AE4.
D/ Vuoto (o illeggibile).
R/ Figura stilizzata antropomorfa,
entro bordo perlinato.
AE, 0.13 g, 7 mm.
Asolati 2006, n°61.
foto 73.
161. V sec.
AE4.
D/ Illeggibile.
R/ Figura antropomorfa stante (?)
AE, 0.11g, 7 mm.
foto 70.
162. V sec.
AE4.
D/ Tondello non coniato su un lato (?)
R/ Tratti lineari su un lato (porta ?)
AE, 0.09 g,7 mm, frammentato.
foto 82.
163. V sec.
AE4.
D/ Illeggibile.
R/ Resti di monogramma (?)
AE, 0.03 g, 7 mm, frammentato.
foto 84.
83
Imitazioni di AE4 con il tipo della croce
164.
D/ Illeggibile.
R/ Croce greca potenziata entro cerchio.
AE, 0.51 g, 9 mm.
foto 60.
165.
D/ Illeggibile.
R/ Croce greca.
AE, 0.48 g, 9 mm.
foto 97.
166.
D/ Elementi indistinguibili.
R/ Croce entro doppio cerchio.
AE, 0.40 g, 8 mm.
foto 81.
167.
D/ Elementi circolari indistinguibili.
R/ Croce greca potenziata entro cerchio (o corona).
AE,0.38 g, 10 mm.
foto 77.
168.
D/ Illeggibile (o vuoto).
R/ Croce greca potenziata entro corona.
AE, 0.37 g, 10 mm.
foto 71.
169.
D/ Illeggibile (o vuoto).
R/ Croce greca potenziata?
AE, 0.31 g, 8 mm.
foto 75.
84
170.
D/ Busto imperiale a d.?
R/ Croce greca potenziata (entro resti di cerchio o
corona).
AE, 0.31 g, 9 mm.
foto 42.
171.
D/ Illeggibile.
R/ Croce greca potenziata entro cerchio.
AE, 0.31 g, 9 mm.
foto 64.
172.
D/ Porta del campo?
R/ Croce greca potenziata entro corona.
AE, 0.30 g, 9 mm.
foto 41.
173.
D/ Illeggibile (o vuoto).
R/ Croce entro cerchio (o corona).
AE, 0.30 g, 9 mm.
foto 51.
174.
D/ Elementi lineari, pseudo epigrafici?
R/ Croce greca potenziata entro cerchio (o più cerchi).
AE, 0.27 g, 9 mm, esemplare frammentato.
foto 91.
175.
D/ Illeggibile.
R/ Croce greca potenziata.
AE, 0.25 g, 7 mm.
foto 65.
176.
D/ Vuoto (o illeggibile).
R/ Croce entro cerchio (o corona).
AE, 0.21 g, 8 mm.
foto 53.
85
177.
D/ Piccolo elemento semicircolare indistinguibile.
R/ Croce greca potenziata.
AE, 0.21 g, 8 mm.
foto 67.
178.
D/ Tratti lineari indistinguibili.
R/ Croce greca potenziata entro cerchio (o corona).
AE, 0.20 g, 8 mm.
Arslan 2002, p. 296, fig. C.
foto 61.
179.
D/ Illeggibile.
R/ Croce entro corona (?)
AE, 0.16 g, 9 mm.
foto 50.
180.
D/ Croce (?)
R/ Croce greca potenziata.
AE, 0.14 g, 8 mm.
foto 80.
181.
D/ Tratti indistinguibili..
R/ Croce (?)
AE, 0.14 g, 8 mm, esemplare frammentato.
foto 76.
182.
D/ Porta del campo (?)
R/ Croce (?)
AE, 0.14 g, 6 mm, esemplare frammentato o tagliato.
foto 86.
183.
D/ Illeggibile.
R/ Croce potenziata entro cerchio.
AE, 0.12 g, 8 mm, esemplare frammentato.
foto 83.
86
184.
D/ Elementi indistinguibili.
R/ Croce (?)
AE, 0.11 g, 8 mm, esemplare frammentato.
foto 72.
185.
D/ Tratti lineari e curvilinei.
R/ Croce greca potenziata.
AE, 0.09 g, 7 mm, esemplare tagliato o frammentato.
foto 90.
Altro
186. IV-V sec.
AE3 (?), tagliato a peso di AE4.
Illeggibile.
AE, 0.97 g, 13 mm, (tondello spezzato a metà).
foto 107.
187. IV-V sec.
AE3 (?), tagliato a peso di AE4.
Illeggibile.
AE, 0.50 g, 8 mm, tondello spezzato in quattro parti.
foto 109.
188. V sec.
AE4.
Illeggibile.
AE, 0.70 g, 8 mm, tondello spezzato a metà.
foto 30.
189. V sec.
Pezzo monetiforme.
AE, 0.64 g, 11 mm.
foto 24.
87
Moneta di età moderna
190. Napoleone, Re d'Italia, 1805-1814 d. C.
1 centesimo, zecca di Milano (?)
D/ [---]O[---]E[---], Busto a s.
R/ [---]SIMO in basso, corona ferrea radiata in campo.
CU, 1.98 g, 18 mm.
CNI V, pp. 419-431.
foto 20.
Abbreviazioni:
AE: aes, bronzo
AR: argento
BIL: biglione
CU: rame
PB: Piombo
CNI : Corpus nummorum italicorum
LRBC: Late roman bronze coinage
RIC: Roman imperial coinage
D/: dritto
R/: rovescio
[---]: legenda non visibile
n. : note documentazione scavo
d. C.: dopo Cristo
88
Bibliografia
ADELSON, KUSTAS 1960: Adelson H. L., Kustas G. L.; A bronze hoard of the period of Leo I, in Museum Notes
9, New York 1960.
ADELSON, KUSTAS 1962: Adelson H., Kustas L.; A bronze hoard of the period of Zeno I, in Museum Notes
and Monographs 148, New York 1962.
AMANDRY GAUTIER: Amandry Gautier M.; Le tresor de Bazarnes, in Tresor Monetaires, VII, Parigi 1985.
ARSLAN 2000: E. A. Arslan; Vandali, in Enciclopedia dell'Arte Medievale XI, Roma 2000.
ARSLAN 2002: E. A. Arslan; La moneta in rame nell'Italia longobarda, in Humana Sapit, Turnhout 2002.
ARSLAN 2003: E. A. Arslan; Problemi ponderali di V secolo: verso la riforma del Nummus. Il depisito di
Cafarnao, in Revue Numismatique, Parigi 2003.
ARSLAN 2005: E. A. Arslan; La zecca e la circolazione monetale, Ravenna da capitale imperiale a capitale
esarcale: atti del 17° congresso internazionale di studio sull'alto medioevo: Ravenna, 6-12 giugno 2004,
Spoleto 2005.
ARSLAN 2007: E. A. Arslan; Ancora sulla questione della cosiddetta "moneta in rame nell'Italia longobarda".
Una replica e problemi di metodo, in Rivista italiana di numismatica 108, Milano 2007.
ARTHUR, KING 1987: Arthur P., King A.; Scavi in località Carriello S.M.C.V.: contributo per una conoscenza di
Capua tardoantica, in Archeologia Medievale 14, Firenze 1987.
ASOLATI 2005: Asolati M.; Il tesoro di Falerii Novi, nuovi contributi sulla monetazione italica in bronzo degli
anni di Ricimero (457-472 d.C.), Padova 2005.ASOLATI 2006: Asolati M.; Il ripostiglio di Camporegio
(Grosseto). Note sulle imitazioni bronzee di V sec. d.C. e sulla questione della cosiddetta "moneta in rame
nell'Italia longobarda", in Rivista italiana di numismatica e scienze affini, Milano 2006.
89
AUGENTI, CIRELLI 2012: Augenti A., Cirelli E.; From suburb to port: the rise (and fall) of Class as a centre of
trade and redistribution, in Rome, Portus and the Mediterranean, London 2012.
BENDALL 1977: Bendall S.; Bizantine hoards, in Coin Hoards 3, New York 1977.
BRENOT-MORRISSON 1983: Brenot C., Morrisson C.; La circulation du bronze en Cèsarienne occidentale à la
fin du Vᵉ siècle: la trouvaille de Rebelais-ain-Merane, in NAC XII, Lugano 1983.
CALLEGHER 1998: Callegher B.; Trento-Teatro Sociale: scavi 1990-1992. Le monete repubblicane, imperiali e
medievali: analisi critica e catalogo del complesso numismatico, in Materiali per la storia urbana di
Tridentum. II. Ritrovamenti monetali, Trento 1998.
CARLA' 2007: Carlà F.; Il sistema monetario in età tardoantica: spunti per una revisione, in Annali
dell'Istituto Italiano di Numismatica LII, Roma 2007.
CASTRIZIO 2005: Castrizio D.; L'eredità del tardo-antico e il nuovo impero romano cristiano, in Manuale di
numismatica medievale, Reggio Calabria 2005.
CESANO 1913: Cesano L.; Della moneta corrente in Italia nell'ultima età imperiale romana e sotto i re
Ostrogoti, in Rivista italiana di numismatica 26, Milano 1913.
CESANO 1918: Cesano L.; Ancora della moneta enea corrente in Italia nel V e VI secolo d.C., in Rivista
italiana di numismatica 31, Milano 1918.
CIRELLI 2013: Cirelli E.; Roma sul mare e il porto augusteo di Classe, in Ravenna e l'Adriatico dalle origini
all'età romana, Bologna 2013.
CORTESI, NARDINI 2009: Cortesi S., Nardini C.; Classe, in Un lungo viaggio fra avventura, storia ed
archeologia 1984-2009, gruppo ravennate archeologico, Imola 2009.
COSENTINO 2008: Cosentino S.; La Moneta, in Storia dell'Italia bizantina (VI-XI secolo), da Giustiniano ai
Normanni, Bologna 2008.
90
CURINA 1983: Curina R.; Le monete, in Ravenna e il porto di Classe, venti anni di ricerche archeologiche tra
Ravenna e Classe, Bologna 1983.
ERCOLANI COCCHI 1982: Ercolani Cocchi E.; La circolazione monetale fra tardo antico e alto medioevo: dagli
scavi di Villa Clelia, in Studi Romagnoli, Bologna 1982.
ERCOLANI COCCHI 1983: Ercolani Cocchi E.; Catalogo, in Imperi romano e bizantino, regni barbarici in Italia
attraverso le monete del Museo Nazionale di Ravenna, Ravenna 1983.
ERCOLANI COCCHI 1986: Ercolani Cocchi E.; Il tesoretto monetale di Salto del Lupo, in La civiltà comacchiese
e pomposiana: dalle origini preistoriche al tardo medioevo: atti del convegno nazionale di studi storici:
Comacchio 17-19 maggio 1984, Bologna 1986.
ERCOLANI COCCHI 1988: Ercolani Cocchi E.; Il circolante divisionale, a Ravenna, fra la fine del V e gli inizi del
VI sec. d.C., in Studia numismatica Labacensia, Ljubljana 1988.
ERCOLANI COCCHI 2007: Ercolani Cocchi E.; Le tre stagioni della zecca di Ravenna, in Felix Ravenna. La
croce, la spada, la vela, Milano 2007.
ERCOLANI COCCHI 2008: Ercolani Cocchi E.; La moneta racconta la storia del Decimano, in Orme nei campi:
archeologia a sud di Ravenna: atti della giornata di studi sui recenti rinvenimenti archeologici nel territorio
Decimano (San Pietro in Campiano, Ravenna, 2 aprile 2006), Firenze 2008.
ESTIOT 1995: Estiot S.; La monetazione, in Il ripostiglio della Venèra, nuovo catalogo illustrato, Aureliano
II/1, Roma 1995.
ESTIOT-AMANDRY-BOMPAIRE 1993: Estiot S., Amandry M., Bompaire M.; Le tresor de Sainte Pallaye
(Yonne): 8, 864 antoniniani de Valèrien a Carin, in Trèsors Monètaires 14, Parigi 1993.
FIOCCHI NICOLAI, MARTORELLI, CHIARUCCI, SPERA, DI MARCO, BARBINI 1992: Fiocchi Nicolai V., Martorelli
R., Chiarucci G., Spera L., Di Marco P., Barbini P. M.; Scavi nella catacomba di Albano Laziale, in Rivista di
Archeologia Cristiana 68, Roma 1992.
91
GIARD 1995: Giard J. B.; Regno e monetazione di Aureliano, in Il ripostiglio della Venèra, nuovo catalogo
illustrato, Aureliano II/1, Roma 1995.
GRASSI 1988: Grassi M. T.; Rinvenimenti monetali da Angera (Varese), scavi 1980-1984, Bollettino di
numismatica 11, Milano 1988.
GRIERSON 1999: Greirson P.; Byzantine Coinage, Washington, D. C. 1999.
HUGO-JONES 1999: Hugo A., Jones M.; Il tardo impero romano, 284-602 d. C., in I luoghi della moneta: le
sedi delle zecche dall'antichità all'età moderna. Atti del convegno internazionale 22-23 ottobre 1999,
Milano 1999.
LACAM 1988: Lacam G.; Le monnayage de Ricimer, in Studia numismatica Labacensia, Ljubljana 1988.
LALLEMAND 1967: Lallemand J.; Trèsor des monnaies romaines en bronze: Costance II à Zenon, in Ordona II,
Rapport provisoire sur le travaux de la mission belge en 1964/65 et 1965/66, Roma-Bruxelles 1967.
MAIOLI 1989-1990: Maioli M. G.; Un condotto fognario romano nella zona archeologica di Classe (RA):
l'esplorazione e i materiali. Relazione preliminare, in Studi e documenti di archeologia VI, Bologna 1989-
1990.
MASTELLONI 1993: Mastelloni M. A.; Monete e imitazioni in un piccolo ripostiglio tardoantico , in
Rivista Italiana di Numismatica, XCV, Milano 1993.
MOMMSEN, MEYER 1905: Mommsen T., Meyer P. M.; Codex Theodosianus: Theodosiani libri XVI cum
Constitutionibus Sirmodianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes, Berlin 1905.
MORELLI 2001: Morelli A. L.; Rinvenimenti numismatici di età tardo-antica da contesti archeologici
ravennati, in L'archeologia dell'Adriatico dalla Preistoria al Medioevo, Atti del convegno internazionale,
Ravenna, 7-8-9 giugno 2001, Ravenna 2001.
MORRISSON 2011: Morrisson C.; Le zecche nell'Italia bizantina: un quadro d'insieme, in Le zecche italiane
fino all'Unità, Roma 2011.
92
MOSTECKY 1993: Mostecky H.; Ein spa "tantiker Mu" nzschatz aus Sassari, Sardinien (2. Ha Ifte des. 5
Jhdts), in Rassegna di Studi del Civico Museo Archeologico e del Civico Gabinetto Numismatico di Milano, LI-
LII, Milano 1993.
MUNZI 1995: Munzi M.; I nummi di Ricimero, in Annotazioni numismatiche 20, Milano 1995.
ORLANDONI 1991: Orlandoni M.; Imitazioni di monete romane in bronzo emesse fra il IV ed il V secolo d.C.
rinvenute negli scavi archeologici in Valle d'Aosta, in Studia Dicata III, Milano 1991.
ORSI 1910: Orsi P.; Ripostiglio monetale del basso impero rinvenuto a Lipari, in Rivista italiana di
numismatica, Milano 1910.
PEARCE, WOOD 1934: Pearce J. W. E., Wood M. E.; A late roman hoard from Dalmatia, in Numismatic
Chronicle 5 ser., 14, London 1934.
PELLICIONI GOLINELLI 1993: Righini V., Biordi M., Pellicioni Golinelli M. T.; I bolli laterizi romani nella
regione Cispadana (Emilia e Romagna), in I laterizi di età romana nell'area nord-adriatica, Roma 1993.
ROVELLI 2001: Rovelli A.; La circolazione monetaria a Roma nell'alto medioevo: un riesame alla luce dei
recenti dati archeologici, in Roma dall'antichità al medioevo I, Archeologia e storia del Museo nazionale
romano, Crypta Balbi, Milano 2001.
SEEGER 1976: Seeger J. A.; A hoard of late roman bronze coins, in Coin Hoards 2, New York 1976.
SPAGNOLI 1993: Spagnoli E.; Alcune riflessioni sulla circolazione monetaria in epoca tardoantica a Ostia
(Pianabella) e a Porto: i rinvenimenti dagli scavi 1988-1991, in La storia economica di Roma nell'alto
Medioevo alla luce dei recenti scavi archeologici. Atti del Seminario (Roma, 2-3 aprile 1992), Firenze 1993.
STOPPIONI 1986: Stoppioni M. L.; Un gruzzolo di monete imperiali romane dal pozzo di S. Croce (Ravenna),
in Felix Ravenna 131-132, Ravenna 1986.
THOMPSON 1954: Thompson M.; The Atenian Agorà 2, Coins, Princeton 1954.
93
Repertori:
CNI: AA. VV.; Corpus nummorum italicorum vol. V Lombardia (Milano), Roma 1914.
LRBC: Kent J. P. C., Hill P. V., Carson R. A. G.; Late roman bronze coinage A.D. 324-498, London 1978.
MEC: Grierson P., Blackburn M.; Medieval european coinage 1. The early middle ages (5th-10th centuries),
Cambridge 1986.
RIC: Sutherland C. H. V., Mattingly H., Sydenham E. A., Webb P. H., Bruun P. M., Kent J. P. C., Pearce J. W. E.,
The Roman Imperial Coinage, vol. I-X, London 1930-1994.
WROTH 1911: Wroth W.; Catalogue of the coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards and of the
empire of Thessalonica, Nicea and Trebizond in the British museum, London 1911.