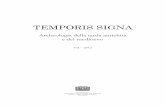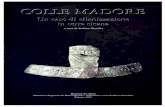Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004 ...
Gli usi della scrittura dipinta nel mondo romano, in Storie di cultura scritta. Studi per Francesco...
Transcript of Gli usi della scrittura dipinta nel mondo romano, in Storie di cultura scritta. Studi per Francesco...
STORIE DI CULTURA SCRITTAStudi per Francesco Magistrale
a cura di
PAOLO FIORETTI
con la collaborazione di
ANNANGELA GERMANO e MARCO ANTONIO SICILIANI
TOMO PRIMO
2012
FONDAZIONE
CENTRO ITALIANO DI STUDISULL’ALTO MEDIOEVO
SPOLETO
PAOLO FIORETTI
GLI USI DELLA SCRITTURA DIPINTANEL MONDO ROMANO
Di tutte le tecniche scrittorie adoperate in età antica soltantoquelle incise e quelle ad inchiostro risultano adeguatamente stu-diate: esse, in verità, sono le due tecniche più diffuse nel medio-evo e perciò può accadere che i paleografi, medievisti per tradi-zione, siano portati inconsapevolmente a trasferirne anche nelmondo antico l’importanza, il rilievo o addirittura l’esclusività. In-vece la modalità di scrittura a pennello era una delle più frequen-temente adoperate e di certo una di quelle con cui i romani ave-vano maggiore familiarità, sebbene le sue testimonianze siano an-date quasi del tutto perdute perché veicoli di messaggi affidati asupporti deperibili e a basso costo (legno, intonaco delle pareti,tessuto) per i quali non si prevedeva una esistenza duratura 1. Siintende offrire, in questa sede, una rassegna degli ambiti d’impie-go della scrittura dipinta nel mondo romano e delle funzioni daessa svolte, anticipando alcuni risultati di una più ampia ricercasull’argomento, attualmente in via di completamento 2.
Con ogni probabilità la cultura romana ha ereditato la tradi-zione della scrittura dipinta dalla civiltà etrusca, la quale faceva ri-
1. E. M. CATICH, The Origin of the Serif: Brush Writing and Roman Letters, Daven-port, 1968; H. SOLIN, Le iscrizioni parietali, in Pompei 79. Raccolta di studi per il decimo nonocentenario dell’eruzione vesuviana, a cura di F. ZEVI, Napoli, 1979, pp. 278-288; A. DONATI,Scrivere col pennello, in Romana pictura. La pittura romana dalle origini all’età bizantina, acura di A. DONATI, Rimini, 1998, pp. 98-102; T. KEMP, Formal Brush Writing, Oxford,1999.
2. Si tratta di uno studio dedicato alle morfologie della capitale antica e all’originedella cosiddetta ‘rustica’, nel quale si proporrà anche un’analisi delle caratteristiche grafi-che di tituli picti di età romana.
PAOLO FIORETTI410
corso al pennello sia per le iscrizioni parietali 3 sia per stenderesul lino testi rituali 4. A fronte del vuoto assoluto di testimonian-ze direttamente conservatesi, non sono poche le attestazioni lette-rarie sulla diffusione di libri lintei nel mondo romano per testi dicontenuto sacro (ad esempio i cosiddetti libri sibillini) e per elen-chi di individui investiti di alte cariche pubbliche 5. Ma a diffe-renza dei libri lintei, dalla forte valenza simbolica e certamente nondestinati ad una vera e propria circolazione, bensì alla conserva-zione e, forse, ad un uso limitato ad occasioni particolari, altreespressioni grafiche dipinte conoscevano nel mondo romano unadiffusione ed un impatto sociale affatto diversi.
Erano realizzati a pennello, ad esempio, avvisi temporanei ecartigli mobili quali i vessilli diffusi presso l’esercito o i tituli espo-sti nei trionfi, nell’esecuzione delle damnationes, durante le proces-sioni funebri e in altre occasioni di vita collettiva: soprattutto fuo-ri d’Egitto, dove si preferiva a tal fine il papiro 6, questi testi si
3. Si ricordi, più in generale, che scrivere sui muri con il pennello era una praticadiffusa anche in altre civiltà antiche, quali l’egizia, la cartaginese e la greca: DONATI, Scri-vere col pennello cit. (nota 1), p. 98.
4. L’unico liber linteus noto è etrusco, reca un lungo testo rituale e sopravvive graziead una circostanza eccezionale: prodotto negli anni compresi tra la fine del III ed il IIsecolo a. C., esso giunse in qualche modo in Egitto, dove fu reimpiegato nel bendaggiodi una mummia: F. RONCALLI, Osservazioni sui libri lintei etruschi, in Rendiconti della Ponti-ficia Accademia di Archeologia, III ser., LI-LII (1978-1980), pp. 3-21; ID., « Carbasinis volu-minibus implicati libri ». Osservazioni sul liber linteus di Zagabria, in Jahrbuch des DeutschenArchäologischen Institut, XCV (1980), pp. 227-264; Scrivere etrusco. Dalla leggenda alla cono-scenza. Scrittura e letteratura nei massimi documenti della lingua etrusca, Milano, 1985, pp. 17-64; L. B. VAN DER MEER, Liber linteus Zagabriensis. The Linen Book of Zagreb. A Com-ment on the Longest Etruscan Text, Leuven, 2007 (Monographs on Antiquity, 4); V. BEL-FIORE, Il liber linteus di Zagabria: testualità e contenuto, Pisa-Roma, 2010 (Biblioteca di« Studi Etruschi », 50). Più in generale, si ricordi che i libri lintei erano diffusi presso leantiche popolazioni italiche, come documentato dalle fonti letterarie: H. BLANCK, Il libronel mondo antico, edizione rivista e aggiornata a cura di R. OTRANTO, Bari, 2008 (Parado-sis, 15), p. 73.
5. Ad esempio LIV. 4, 7, 12; 10, 38, 6; 20, 8; 39, 16, 8; FRONT. ad M. Caes. 4, 4. Sui li-bri lintei romani si vedano almeno G. PICCALUGA, La specificità dei libri lintei romani, in Scritturae civiltà, 18 (1994), pp. 5-22; G. CAVALLO, Libro e cultura scritta, in Storia di Roma, dir. da A.SCHIAVONE, IV, Caratteri e morfologie, a cura di E. GABBA, A. SCHIAVONE, Torino, 1989, pp.693-734: 703-704; BLANCK, Il libro nel mondo antico cit. (nota 4), pp. 73-77.
6. Si veda, ad esempio, POxy XLI 2950 (ChLA XLVII 1414), dedica a Dioclezianoe Massimiano da parte di alcune unità militari, risalente alla fine del III secolo: E. HAR-LEY, J. HAWKES, M. HENIG, F. MEE, Constantine the Great. York’s Roman Emperor, York,
GLI USI DELLA SCRITTURA DIPINTA NEL MONDO ROMANO 411
devono immaginare tracciati il più delle volte su altri supporti 7.Sempre nell’esercito, inoltre, come informa Polibio 8, gli ordinimilitari ed altri tipi di informazioni erano riportati a pennello sutavole lignee dealbate.
Gli ambienti sacri e funerari offrivano ulteriori occasioni diesposizione di scritte dipinte. A Roma, ad esempio, nel colomba-rio di Villa Doria Pamphilj, risalente agli anni 30-20 a. C., in uncontesto di raffinata decorazione pittorica parietale ogni nicchiaappare accompagnata da una tabula ansata dipinta nella quale trovacollocazione il nome del defunto, graffito o il più delle volte trac-ciato anch’esso a pennello con vernice rossa o nera 9. L’uso fune-
2006, pp. 116-117; sul papiro si leggano anche i recenti commenti di L. DEL CORSO,Cultura scritta e scritture esposte: le iscrizioni di Leptis Magna dall’età dei Severi al tardoantico,in Leptis Magna. Una città e le sue iscrizioni in epoca tardoromana, a cura di I. TANTILLO, F.BIGI, Cassino, 2010, pp. 205-218: 206 e fig. 6.1, e S. AMMIRATI, Per una storia del libro la-tino antico: i papiri latini di contenuto letterario dal I sec. a. C. al Iex.-IIin. d. C., in Scripta, 3(2010), pp. 29-45: 35-36. Sul versante greco un termine di paragone utile può essere in-dividuato in PSaqqara inv. 1972 GP3, ordine di ambito militare riferibile agli anni com-presi tra il 331 e il 323 a. C.: E. TURNER, Greek Manuscripts of the Ancient World, Lon-don, 1987, nr. 79; R. SEIDER, Paläographie der griechischen Papyri, III.2, Urkundenschrift, I,Stuttgart, 1990, II 4, pp. 131-134.
7. Su funzione, diffusione e tipologia delle scritte ‘temporanee’ nel mondo romanocfr. G. SUSINI, Le scritture esposte, in Lo spazio letterario di Roma antica. II. La circolazionedel testo, dir. G. CAVALLO, P. FEDELI, A. GIARDINA, Roma, 1989, pp. 271-305: 274-275.Non vale la pena soffermarsi su ovvie considerazioni circa i motivi d’ordine materiale eculturale ai quali imputare la perdita pressoché totale di queste « scritture vulnerabili »,ma non è inutile rammentare che siffatta modalità di comunicazione doveva essere mol-to frequente nel mondo antico (e in quello romano in particolar modo): occorre imma-ginarla legata ad una pluralità di contesti e necessità, oltre che veicolata da supporti dinatura diversa (legno, muro, papiro, tessuto). L’espressione « scritture vulnerabili » è trat-ta da CATICH, The Origin of the Serif cit. (nota 1), p. 108. Più in generale, sul rapportoquotidiano tra società romana e comunicazione scritta si leggano almeno G. CAVALLO,Gli usi della cultura scritta nel mondo romano, in Princeps urbium. Cultura e vita sociale del-l’Italia romana, Milano, 1991, pp. 171-251, e M. CORBIER, Donner à voir, donner à lire.Mémoire et communication dans la Rome ancienne, Paris, 2006.
8. POLYB. 6, 34-35.9. Sulla struttura e sulla decorazione del colombario di Villa Doria Pamphilj riman-
do alla scheda contenuta nel recente catalogo Roma. La pittura di un Impero, a cura di E.LA ROCCA, S. ENSOLI, S. TORTORELLA, M. PAPINI, Milano, 2009, nr. I.1, pp. 264-265,figg. alle pp. 152-154. Si trattava con tutta probabilità di un colombario a carattere ‘im-prenditoriale’, nel quale erano venduti spazi per la deposizione di olle in terracotta conle ceneri dei defunti; talvolta un’unica nicchia accoglieva più di un’olla, sicché nella me-desima tabula ansata poteva trovare posto più di un nome. Le differenze grafiche eviden-
PAOLO FIORETTI412
rario della scrittura dipinta conosce poi una continuità di tradizio-ne nella cultura paleocristiana, come dimostrano alcune catacombeche ripropongono il medesimo modello di esposizione grafica 10.Scritture parietali a pennello collocate in ambienti sacri sono atte-state anche nelle province: i muri interni del complesso sacro del-la Cueva Negra, un luogo di culto pagano situato nel sud-est dellapenisola iberica, durante il periodo compreso tra la metà del I se-colo d. C. e la fine del II sono stati fittamente ricoperti da epigra-fi votive dipinte con la menzione di divinità e cariche religiose,molte delle quali probabilmente commissionate dai visitatori ascriptores di mestiere in servizio presso il santuario 11.
Ma erano soprattutto le strade delle città, in particolar modoquelle interessate da un più intenso traffico di passanti, ad offrireallo sguardo dei romani il repertorio più vasto di scritte realizzatea pennello. Tituli picti, infatti, campeggiavano sulle pareti di edifici
ti nei tituli, oscillanti tra espressioni formalizzate e calligrafiche ed altre informali e di-messe, lasciano supporre che presso il colombario lavorassero scriptores incaricati di realiz-zare scritte funerarie per chi desiderava commissionarle – ed evidentemente poteva per-metterselo –, mentre alcuni provvedevano a tracciare da sé i nomi dei propri caridefunti.
10. D. NUZZO, A. ROCCO, Caratteri e modalità d’uso delle iscrizioni dipinte in età tardoantica, in 13th International Congress of Greek and Latin Epigraphy (Oxford, 2-7 september2007), consultabile online al link [ciegl.classics.ox.ac.uk/html/webposters/59—Nuzzo-Rocco.pdf]; C. CARLETTI, Epigrafia dei cristiani in occidente dal III al VII secolo. Ideologia eprassi, Bari, 2008 (Inscriptiones Christianae Italiae. Subsidia, VI), pp. 113-114.
11. Il complesso sacro della Cueva Negra è stato identificato come un santuario delleacque, in prossimità del quale sorgevano bagni termali: A. GONZÁLEZ BLANCO, Los textosde la Cueva Negra. Del descubrimiento a su lectura y estudio, in La Cueva Negra de FortunaMurcia y sus tituli picti. Un santuario de época romana. Homenaje al prof. D. Sebastián Mari-nez Bigorra, eds. A. GONZÁLEZ BLANCO, M. MAYER, A. U. STILOW, Murcia, 1987 (Mono-grafías histpricas sobre la Antigüedad Tardía, 4), pp. 15-27; A. U. STILOW, M. MAYER,Los títuli e la Cueva Negra. Lectura y comentarios literario y paleográfico, ibid., pp. 191-235,rist. in El balneario Romano y la Cueva Negra de Fortuna, Murcia, 1996; S. MONTERO, Inte-gracipn y mezcla en el s.e. de la península Ibérica: la Cueva Negra (Fortuna, Murcia), in Inte-grazione mescolanza rifiuto. Incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall’Antichità all’Uma-nesimo, a cura di G. URSO, Roma, 2001 (Centro ricerche e documentazione sull’antichi-tà classica. Monografie, 22), pp. 169-182; P. CUGUSI, Culto e letteratura nei testi della Cue-va Negra de Fortuna (Murcia), in Invigilata Lucernis, 24 (2002), pp. 61-81. Tra le testimo-nianze antiche di tituli a pennello ricordo anche le stele funerarie di Lilibeo, pur trattan-dosi di iscrizioni greche (III a. C.): tra esse, infatti, si annovera una scritta dipinta in ca-ratteri latini, ma in lingua greca, riferibile al tornante tra I a. C. e I d. C.: M. VENTO, Lestele dipinte di Lilibeo, Marsala, 2000, pp. 106-108, tav. LXXVII.
GLI USI DELLA SCRITTURA DIPINTA NEL MONDO ROMANO 413
pubblici e privati: si pensi alle tabulae dealbatae, pannelli lignei im-biancati sui quali erano vergati a pennello testi ‘ufficiali’ di variogenere, solitamente prodotti da figure istituzionali e volti ad in-formare i cives. Anche in questo caso alla totale assenza di repertisopperiscono in qualche misura altre fonti (letterarie ed epigrafi-che), dalle quali apprendiamo che le tabulae dealbatae, sin dalle piùantiche attestazioni, si rivelano una modalità di espressione dellascrittura intimamente legata alla vita politica e istituzionale dellecittà 12. Ad esse è associato uno dei primi tentativi di sottrarre,mediante l’esposizione grafica, la gestione dell’ordinamento giuri-dico alla detenzione esclusiva ed arbitraria da parte dell’élite ari-stocratica che faceva riferimento al collegio dei pontefici: all’iniziodel IV secolo a. C., nel contesto dei laceranti conflitti politici esociali che segnarono la prima età repubblicana, Gneo Flavio, scri-ba degli edili, eletto lui stesso alla carica di edile, civile ius, reposi-tum in penetralibus pontificum, evolgavit fastosque circa forum in alboproposuit, ut quando lege agi posset sciretur 13. Su pannelli lignei di-pinti, inoltre, i cittadini potevano leggere gli annali dei pontefici(un’antica forma di memoria civica in cui si registravano, annoper anno, la menzione di avvenimenti notevoli e la successionedelle più importanti cariche pubbliche) 14, ma anche liste di sena-
12. LIV. 1, 32, 2; CASS. DIO. 53, 3. J. SCHMIDT, s.v. Album, in RE, I, 1 (1940), coll.1332-1326; P. DEGNI, Usi delle tavolette lignee e cerate nel mondo greco e romano, Messina,1998 (Ricerca papirologica, 4), pp. 33-35 e 68-69 (in cui si fa riferimento anche alle te-stimonianze greche di tabulae dealbatae); E. A. MEYER, Legitimacy and Law in the RomanWorld. Tabulae in Roman Belief and Practice, Cambridge, 2004.
13. LIV. 9, 46. Per un commento al passo liviano rimando a P. FIORETTI, Storie discribae romani, in Storia della scrittura e altre storie, a cura di D. BIANCONI, Roma, 2012,i.c.s.
14. CIC. de orat., 2, 12, 51-53; SERV. ad Aen., 1, 373. E. PERUZZI, Origini di Roma. II.Le lettere, Bologna, 1973, pp. 175-207; B. W. FRIER, Libri Annales Pontificum Maximo-rum: the Origins of the Annalistic Tradition, Roma, 1979 (Papers and Monographs of theAmerican Academy in Rome, XXVII), pp. 83-105. Peruzzi e Frier suggeriscono di di-stinguere da un lato le informazioni sintetiche riportate dai pontefici su tabulae dealbataeaffinché fossero rese note ai cittadini e dall’altro una stesura degli stessi testi in forma piùestesa e particolareggiata destinata alla conservazione (le fonti parlano in questi casi dicommentarii), forse redatta su tabulae lignee ad inchiostro. Sull’argomento si consultinoanche: E. KORNEMANN, Die altäste Form der Pontifikalannalen, in Klio, XI (1911), pp. 245-257; CAVALLO, Libro e cultura scritta cit. (nota 5), p. 701; ID., Le tavolette come supporto dellascrittura: qualche testimonianza indiretta, in Les tablettes à écrire de l’Antiquité à l’Époque Mo-derne. Actes du Colloque International du CNRS (Paris, 10-11 octobre 1990), éd. par E.
PAOLO FIORETTI414
tori, rogationes, senatusconsulta, verbali ufficiali di assemblee e sedu-te del senato, foedera ed altri testi per i quali si prevedeva un’espo-sizione più o meno prolungata nel tempo, come l’editto del pre-tore o ancora, in età imperiale, le constitutiones dei principes e le di-sposizioni dei governatori provinciali 15. Collocate solitamente neiluoghi maggiormente frequentati delle città, sui muri esterni diedifici pubblici, le tabulae dealbatae sono espressioni fondamentalidel ‘diritto esposto’ 16, ossia degli acta pubblici e, più in generale,di tutti i testi che si imponevano all’attenzione dei cittadini per illoro contenuto informativo e di pubblica utilità 17. Esse costituiva-no il fulcro del rapporto tra diritto e scrittura poiché conferivanoal primo i requisiti fondamentali (pubblicità e conoscibilità) chene garantivano la certezza rendendo altresì possibile, in alcuni casi,la partecipazione cittadina al processo di formazione e di gestionedelle leges 18.
LALOU, Turnhout, 1992 (Bibliologia, 12), pp. 97-104; R. MARICHAL, Les tablettes à écriredans le monde roman, ibid., pp. 165-185; A. RODRIGUEZ-MAYOREAS, Annales Maximi:Writing, Memory, and Religious Performance in the Roman Republic, in Sacred Words: Oralityand Literacy in the Ancient World, VIII, ed. by A. P. M. H. LARDINOIS, J. H. BLOK, M. G.M. VAN DER POEL, Leiden-Boston, 2011 (Mnemosyne. Supplements, 332), pp. 235-254.
15. Si vedano CAVALLO, Libro e cultura scritta cit. (nota 5), p. 701; M. BATS, Les débutsde l’information politique officielle à Rome au premier siècle avant J.-C., in La mémoire perdue.À la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique, éd. par S. DE-MOUGIN, Paris, 1994 (Histoire ancienne et médiévale, 30), pp. 19-43; O. LICANDRO, Il« diritto inciso ». Lineamenti di epigrafia giuridica romana, Catania, 2002 (Materiali del Labo-ratorio di epigrafia e di papirologia giuridica, 1), pp. 60-67; A. LOVATO, Elementi di epi-grafia giuridica romana, Bari, 2006, pp. 20-21 e 27.
16. Si fa riferimento, qui, ad una definizione di Orazio Licandro (« diritto inciso »)modificandola tuttavia parzialmente allo scopo di comprendervi anche la tradizione deitesti dipinti: LICANDRO, Il « diritto inciso » cit. (nota 15).
17. Il nesso tra l’uso di tavole lignee – cerate o dealbate – e dimensione pubblica nelmondo romano è messo in opportuna evidenza in DEGNI, Usi delle tavolette cit. (nota 12),pp. 33-59.
18. Sull’argomento si consulti almeno il classico G. ROTONDI, Leges publicae populiRomani. Elenco cronologico con una introduzione sull’attività legislativa dei comizi romani,estratto dalla Enciclopedia Giuridica Italiana, Milano, 19222, rist. Hildesheim-Zürich-NewYork, 1990, pp. 167-174. Un obbligo di pubblicazione, un trinundinum prima della datastabilita per le assemblee, riguardava l’affissione dell’ordine del giorno, dei testi delle leg-gi, delle liste dei candidati e delle sentenze: M. PANI, E. TODISCO, Società e istituzioni diRoma antica, Roma, 2005 (Università. Studi Storici, 697), pp. 67-68. Ma occorre ricor-dare che il più delle volte l’esposizione pubblica non era prescritta come atto formaleindispensabile a sancire l’entrata in vigore di un provvedimento, risultando funzionalesoltanto alla diffusione di informazioni. In alcuni casi precise indicazioni sulla necessità e
GLI USI DELLA SCRITTURA DIPINTA NEL MONDO ROMANO 415
Nessuna tabula dealbata, s’è detto, è sopravvissuta ai secoli; tuttaviafra le scritture parietali a pennello rinvenute a Pompei ed Ercolanotre testimonianze, sebbene frammentarie, risultano di estremo interes-se. Esse sono riferibili rispettivamente ad un probabile statuto di uncollegio cui appartenevano uomini e donne (Fig. 1) 19, ad un albo
sulle modalità di esposizione sono contenute in clausole previste dagli stessi testi: periscrizioni in cui si fa esplicito riferimento alla esposizione su tabulae dealbatae si vedano,ad esempio, il frammento tarantino di una lex repetundarum, fine II a. C. (M. H. CRAW-FORD, Roman Statutes, London, 1996, I, nr. 15), la lex Acilia repetundarum, ca. 123 a. C.(CRAWFORD, nr. 1), la Tabula di Heraclea, età cesariana (CRAWFORD, nr. 24), la lex Rubriade Gallia Cisalpina, 49-41 a. C. (CRAWFORD, nr. 28), la lex coloniae Genetivae Iuliae, etàcesariana o fine I a. C. (CRAWFORD, nr. 25), nonché CIL VI 33885, frammento di unostatuto di collegio di negotiatores eborarii e citriarii, riferibile all’età adrianea. Sull’esposizio-ne di documenti pubblici nel mondo romano e, più in generale, sul rapporto tra scrittu-ra e diritto rimando a: J. SCHWIND, Zur Frage der Publikation in römischen Recht. Mit Au-sblicken in das altgriechische und tolemäiche Rechtsgebiet, München, 1911 (Münchener beiträ-ge zur papyrusforschung und antiken Rechtgeschichte, 31); A. SCHIAVONE, Ius. L’inven-zione del diritto in Occidente, Torino, 2005 (Biblioteca di Cultura Storica, 254); LICANDRO,Il « diritto inciso » cit. (nota 15); M. W. FREDERIKSEN, The Republican Municipal Laws: Er-rors and Drafts, in Journal of Roman Studies, 55 (1965), pp. 183-198; J.-L. FERRARY, La gra-vure de documents publics de la Rome républicaine et ses motivations, in Selbstdarstellung undKommunication: Die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der römi-schen Welt, hrsg. von R. HAENSCH, München, 2009 (Vestigia, 61), pp. 59-74. Nulla im-pedisce di ipotizzare, inoltre, che alcune tabulae dealbatae fossero depositate negli archividopo aver esaurito la propria funzione espositiva. Sugli archivi in Roma antica si rinviaa T. MOMMSEN, Sui modi usati da’ Romani nel conservare e pubblicare le leggi e i senatusconsul-ti, in Gesammelte Schriften. Juristischen Schriften, III, rist. Berlin-Dublin-Zurigo, 1962 [=1858], pp. 290-313; G. CENCETTI, Gli archivi dell’antica Roma nell’età repubblicana, in ID.,Scritti archivistici, Roma, 1970 (Fonti e studi, 3), pp. 171-220; E. POSNER, Archives in theAncient World, Cambridge (Mass.), 1972, part. pp. 160-185; P. CULHAM, Archives and Al-ternatives in Republican Rome, in Classical Philology, 84/2 (Apr. 1989), pp. 100-115; A.DONATI, Epigrafia romana. La comunicazione nell’antichità, Bologna, 2002 (Itinerari. Storia),pp. 48-50; R. HAENSCH, Das Statthalterarchiv, in Zeitschrift der Savigny Stiftung, 109 (1992),pp. 209-317; La mémoire perdue cit. (nota 15); C. WILLIAMSON, The Display of Law andArchival Practice in Rome, in Acta Colloqui Epigraphici Latini Helsingiae (Helsinki, 3-6 sep-tember 1991), ed. H. SOLIN, O. SALOMIES, U. M. LIERTZ, Helsinki, 1995 (Commentationeshumanarum litterarum, 104), pp. 239-252; DEGNI, Usi delle tavolette cit. (nota 12), pp. 36-40 e 44-50.
19. CIL IV 9934a (Pompei): Titulorum pictorum Pompeianorum qui in CIL vol. IV collec-ti sunt imagines, recensuit, recognovit et contulit A. VARONE, schedas ad imprimendumcomposuit, in ordinem topographicum adduxit et indices struxit G. STEFANI, Roma,2009 (Studi della Soprintendenza Archeologica di Pompei, 29), d’ora in poi TPP, p.511. Tutti gli individui nominati hanno il cognomen, sicché è probabile che la scritta nonrisalga a prima dell’inizio del I secolo d. C. Sembra, inoltre, che la lista sia stata redattain più fasi, poiché mi pare di riconoscere l’intervento di almeno due mani differenti, la
PAOLO FIORETTI416
dei magistri vici (Fig. 2) 20 e ad un editto in materia di igiene pub-blica (Fig. 3) 21 – questi ultimi due, in particolare, risultano com-presi all’interno di un riquadro dal fondo bianco e dipinti conl’ausilio di uno schema di rigatura tracciato a secco nell’intonaco.Si tratta, a mio avviso, di vere e proprie tabulae dealbate realizzatenon su pannelli lignei, bensì direttamente sul muro secondo unaprassi, evidentemente diffusa nelle città romane, che si basava sol-tanto sull’effetto ottico di una tabula e non sulla reale presenza diun supporto mobile.
Direttamente dipinti in rosso e nero sul marmo, invece, eranoin età tardorepubblicana e augustea alcuni calendari e fasti, in de-roga ad una consuetudine che faceva solitamente ricorso, per que-sto genere di testi, a tabulae dealbatae 22. Tra le attestazioni giuntesino a noi, sia pur in frammenti, sono quelle dei cosiddetti fastiAntiates maiores, portati a compimento in più riprese verosimil-mente negli anni compresi all’incirca tra il 67 e il 55 a. C. (Fig.4), e dei fasti Plateae Manfredo Fanti, redatti ante diem 12 ottobredel 19 a. C. 23. Fasti e calendari costituivano una preziosa risorsarivolta all’attenzione dei cives poiché risultavano fondamentali per
seconda delle quali, pur sforzandosi di uniformarsi alla precedente, adopera un modulopiù piccolo e stretto.
20. CIL IV 7807 = I2 2984a (Pompei): TPP, p. 382. L’iscrizione è riferibile al perio-do tardorepubblicano o alla prima età augustea: H. SOLIN, rec. a TPP, in Arctos, 44(2010), p. 324.
21. CIL IV 10489 (Ercolano): TPP, p. 521 e tav. XLVIII. La scritta è databile intor-no al 61 d. C.: G. CAMODECA, La ricostruzione dell’élite municipale ercolanese degli anni 50-70: problemi di metodo e risultati preliminari, in Cahiers du Centre Gustave Glotz, 7 (1996),pp. 167-178: 175.
22. Dizionario di antichità classiche, s. v. fasti; LICANDRO, Il « diritto inciso » cit. (nota15), pp. 191-194 sui calendari, 197-198 sui fasti; da ultimo si veda J. RÜPKE, The RomanCalendar from Numa to Constantine. Time, History and the Fasti, Boston, 2011. Sul legametra fasti e scrittura a pennello rinvio a OV. Fasti, I 7-12; sul passo A. FRASCHETTI, Roma eil principe, Roma-Bari, 2005 (Biblioteca Universale, 571), pp. 28-30. Una attestazionedella persistenza di questa tradizione in età tardoantica è riconoscibile nel calendario di-pinto dell’Esquilino: F. MAGI, Il calendario dipinto sotto Santa Maria Maggiore, in Memoriedella Pontificia Accademia di Archeologia, XI/1 (1972), pp. 3-48; M. R. SALZMAN, New Evi-dence for the Dating of the Calendar at Santa Maria Maggiore in Rome, in TAPhA, 111(1981), pp. 215-227.
23. I fasti Antiates maiores sono l’unico calendario pre-cesariano sopravvissuto: Inscr.It., XIII/II, 1, tavv. I-III; A. FRASCHETTI, Le feste, il circo, i calendari, in Storia di Roma, IVcit. (nota 5), pp. 609-627: 617-618 (e n. 19); ID., Roma e il principe cit. (nota 22), p. 11.Per i fasti Plateae Manfredo Fanti cfr. Inscr. It., XIII/II, 4, tav. XII.
GLI USI DELLA SCRITTURA DIPINTA NEL MONDO ROMANO 417
il computo cronologico e per la regolamentazione delle attivitàlegate alla vita cittadina in una società, come quella romana, incui la scansione del tempo pubblico aveva un valore politico-isti-tuzionale. Nei fasti ora ricordati, inoltre, è possibile riconoscereuna modalità espositiva ‘di transizione’ collocabile tra l’antica abi-tudine di dipingere tali testi su tabulae dealbatae e quella, invalsa trala tarda repubblica e l’età augustea, di inciderli nel marmo, comeattestano ad esempio i fasti cosiddetti Ostienses, redatti in più ri-prese a cominciare dalla metà circa del I a. C. sino almeno al 175d. C. 24, e Praenestini, composti in gran parte tra il 6 e il 10 d. C.(con alcune aggiunte di età tiberiana) 25. La scelta del marmo inluogo del legno dealbato deve ricondursi da un lato ad un influssodelle pratiche greche, che prevedevano quasi sempre l’uso dellapietra anche per le iscrizioni legate alla vita civica, dall’altro – e,forse, soprattutto – ad un cambiamento di statuto e di funzionedei calendari, che a partire da quest’epoca divennero un efficacestrumento di propaganda politica e di costruzione ideologica delpotere: è plausibile, pertanto, che dal punto di vista della produ-zione epigrafica essi fossero assimilati alle iscrizioni ufficiali di con-tenuto celebrativo ed onorifico. Si osservi, inoltre, che anchequando si passò ad inciderli nel marmo, fasti e calendari esposti, inesplicita continuità con la tradizione che li voleva realizzati a pen-nello, continuavano a basarsi anche sull’effetto cromatico, essendole lettere ripassate a colore (numerose tracce del quale sono anco-ra visibili, ad esempio, nei solchi dei Praenestini).
Ancor più che dai documenti esposti ‘ufficiali’, concentrati neipressi dei più importanti edifici pubblici, l’orizzonte visivo del cit-tadino romano doveva essere dominato dai tituli picti di strada re-canti messaggi di molteplice natura, i quali si susseguivano conuna frequenza ed una varietà di soluzioni non dissimili da quelleche caratterizzano, con potente capacità comunicativa, gli ininter-rotti percorsi pubblicitari di esposizione grafica (e iconografica)negli spazi cittadini contemporanei. Paragonate ai coevi graffiti,
24. Inscr. It., XIII/II, 16, tav. XXXII; B. BARGAGLI, C. GROSSO, I Fasti Ostienses do-cumento della storia di Ostia, Roma, 1997 (Itinerari ostiensi, VIII), pp. 9-12.
25. Insc. It., XIII/II, 17, tav. XXXIV. Sui fasti Praenestini si veda da ultima E. TODI-SCO, La res publica restituta e i Fasti Praenestini, in Epigrafia e territorio. Politica e società.Temi di antichità romane, VIII, a cura di M. PANI, Bari, 2007, pp. 341-358, in cui si pro-pone anche una nuova integrazione al testo.
PAOLO FIORETTI418
dal punto di vista del contenuto le scritte murali a pennello di etàromana mostrano una gamma tipologica certamente più povera:non si tratta, infatti, di espressioni grafiche estemporanee, giacchéper la loro realizzazione era necessario l’uso di strumenti e mate-riali – pennello e vernice – non abitualmente a portata immediatadi un passante 26. Com’è noto Pompei ed Ercolano, vere e pro-prie ‘città parlanti’ i cui muri erano letteralmente invasi da scrittegraffite e dipinte, rendono in qualche modo l’idea di come dove-vano mostrarsi le vie urbane nel mondo romano 27. Nel repertorioofferto dai tituli picti 28 occorre distinguere tra testimonianze rea-lizzate da scriptores di mestiere e testimonianze di mani occasionalipiù o meno dotate di una qualche esperienza grafica. Tra i primi,costituenti un unico gruppo di artifices della scrittura dipinta, vannoconsiderati sia individui in servizio presso magistrati locali sia profes-sionisti che prestavano a pagamento la propria abilità su commissionedi privati cittadini o degli stessi magistrati: ad essi si devono soprattut-to scritte di carattere ‘pubblico’ quali albi di cariche istituzionali 29,editti 30, statuti di collegi 31, annunci di spettacoli 32 e manifesti di
26. Il colore preferibilmente impiegato nel mondo romano per realizzare scritte di-pinte è il rosso, ma non mancano esempi in cui si ricorre al nero o al bianco (in questocaso su sfondo scuro).
27. Le scritte a pennello (e graffite) non risparmiavano neppure i sepolcri, com’è at-testato direttamente a Pompei, sui monumenti funebri fuori Porta Nocera, e come pro-vano pure alcune iscrizioni rivolte esplicitamente agli scriptores di programmi elettorali:Parce opus hoc scriptor, tituli quod luctibus urgent, sic tua praetores saepe manus referat (CIL X6193 = CLE 1466, da Formia); l’iscrizione è ricordata in I. DI STEFANO MANZELLA, Me-stiere di epigrafista. Guida alla schedatura del materiale epigrafico lapideo, Roma, 1987 (Vetera,1), p. 142 e n. 342. Un’altra epigrafe dal simile tenore, CIL XI 4126 = CLE 194, pro-veniente da Narni, è ricordata in DONATI, Scrivere col pennello cit. (nota 1), p. 101. Unaparticolareggiata disamina dei luoghi preferiti per l’esposizione di tituli picti nella città diPompei è proposta in C. CHIAVIA, Programmata. Manifesti elettorali nella colonia romana diPompei, Torino, 2002, pp. 90-92.
28. Sulle tipologie testuali proposte dai tituli picti romani si vedano DONATI, Scriverecol pennello cit. (nota 1); SOLIN, Le iscrizioni parietali cit. (nota 1); CHIAVIA, Programmatacit. (nota 27), pp. 25-26.
29. CIL IV 7807: cfr. supra n. 18.30. CIL IV 10489: cfr. supra n. 19.31. CIL IV 9934a: cfr. supra n. 17.32. CIL IV 7994, 9969, 9972, 9980. I tituli sono riprodotti in TPP rispettivamente al-
le pp. 260-261, 501-503, 485-486, 506, ed editi anche in P. SABBATINI TUMOLESI, Gladia-torium Paria. Annunci di spettacoli gladiatori a Pompei, Roma, 1980, rispettivamente nrr.
GLI USI DELLA SCRITTURA DIPINTA NEL MONDO ROMANO 419
propaganda elettorale (Fig. 5) 33. Alle seconde – che, forse per esi-genze di risparmio, si organizzavano in qualche modo per realiz-zare da sé le scritte – rimandano espressioni di propaganda politi-ca 34, annunci di locazione 35, avvisi di vendita di materiale edili-zio 36, richieste relative a oggetti smarriti 37, pubblicità e insegnedi bottega 38, proibizioni e imprecazioni contro i maleducati e gliincivili 39, saluti 40, oscenità 41. Accadeva, tuttavia, che per alcunespecifiche necessità, soprattutto in relazione a scritte di tenorecommerciale, un cittadino si rivolgesse comunque a scriptoresesperti affinché il risultato finale fosse connotato da una più effica-
74, 77, 64, 3, e M. FORA, I munera gladiatoria in Italia. Considerazioni sulla loro documen-tazione epigrafica, Napoli, 1996, rispettivamente nrr. 100, 103, 90, 26.
33. Se ne contano circa 3000: TPP, p. 9; CHIAVIA, Programmata cit. (nota 27), p. 26.Solitamente, almeno per quanto riguarda Pompei, si tende ad identificare tout court lescritte a pennello con i programmi elettorali, che in effetti dal punto di vista numericosoverchiano i tituli d’altro tipo. Tuttavia parallelamente a quanto avviene nelle nostrecittà in periodi di campagna elettorale, quando i manifesti propagandistici tendono adinvadere l’orizzonte visivo dei passanti e permangono anche svariate settimane dopo leelezioni, è lecito pensare che a Pompei i programmi relativi alle competizioni elettoralidel 79 d. C., svoltesi qualche mese prima dell’eruzione del Vesuvio, avessero ricopertouna parte considerevole delle altre scritte murali a pennello esistenti.
34. Non mancano, infatti, programmi elettorali che paiono realizzati da mani nonprofessionali (o comunque inesperte): CIL IV 1137 (TPP pp. 212-213); CIL IV 1144(TPP p. 211); CIL IV 7691 (TPP pp. 264-265), fig. 6; CIL IV 7796 (TPP p. 288); CILIV 7788 (TPP p. 289); CIL IV 7789 (TPP p. 289). Per Ercolano si veda AE 1987, 262:M. PAGANO, Una iscrizione elettorale da Ercolano, in Cronache Ercolanesi, 17 (1987), pp.151-152.
35. CIL IV 138 = ILS 6035 (disegno in TPP p. 531); CIL IV 807 = ILS 6036; CILIV 1136 = ILS 5723 (TPP pp. 213-213).
36. CIL IV 7124 = I2 3145 = ILLRP 1121 (TPP pp. 288 e 290), fig. 7.37. CIL IV 64 (p. 191) = I2 1680 (p. 1017) = ILLRP 1122 (TPP p. 372); CIL IV
3864.38. CIL IV 806; CIL IV 807 = ILS 6036; CIL IV 3779; CIL IV 9839a (TPP p. 167),
fig. 8; CIL IV 9839b (TPP p. 168); CIL IV 9839c (TPP p. 168).39. CLA IV 3832 (TPP pp. 415-416); CLA IV 7038 = CLE 1934 (TPP p. 307), fig.
9; CLA IV 7574? (TPP p. 207); CLA IV 7715 (TPP 276).40. CIL IV 7755 (TPP p. 284), fig. 10, sembra realizzato su commissione da uno
scriptor professionale, il che non desta meraviglia in quanto consiste in un amichevolemessaggio di saluto rivolto agli abitanti di Pompei da parte di Poliaeus cubicularius Augusti(Nerone?) in visita presso la città campana.
41. CIL IV 10030 (TPP p. 169); la scritta, in realtà, è vergata da una mano certa-mente esperta, probabilmente uno scriptor professionale lasciatosi andare (in una pausa dellavoro?) ad una espressione personale estemporanea.
PAOLO FIORETTI420
ce resa grafico-visiva 42. Una menzione a sé meritano le didascaliee i motti, talvolta in versi, leggibili a corredo delle pitture muraliche adornano alcune case di Pompei: con tali testimonianze lascrittura a pennello entrava nelle abitazioni dei cittadini, adattandouna pratica di esposizione grafica civica all’uso privato per il deco-ro domestico 43.
S’è detto di iscrizioni su pietra tracciate a pennello anzichéscolpite; tuttavia in alcune occasioni accadeva anche che scritte di-pinte affiancassero le epigrafi incise in conformità ad una praticain uso sin dall’età repubblicana, come dimostra il sepolcro degliScipioni, in cui in due casi i nomi dei defunti (Lucio CornelioScipione Barbato, console nel 298 a. C., e suo figlio Lucio Cor-nelio Scipione, console nel 259 a. C.) sono dipinti in rosso sui co-perchi dei rispettivi sarcofagi, mentre un testo estratto dalle lauda-tiones funebri, riferito ai momenti salienti della loro vita, è incisosul prospetto principale delle due tombe 44. Inoltre scritture dipin-te, non più visibili, potevano completare testi incisi che oggi ri-sultano apparentemente incompleti: è il caso, ad esempio, di alcu-ni miliari in cui l’indicazione della distanza dalla località più vicinaera forse riportata a pennello 45.
42. CIL IV 7384 (TPP p. 171). Si veda anche l’insegna di una bottega vinaria rinve-nuta ad Ercolano, in cui la réclame realizzata da un pictor di professione si compone diuna scritta pubblicitaria e di un affresco raffigurante una divinità minore garante dei giu-ramenti e della buona fede negli affari: M. PAGANO, Semo Sancus in una insegna di bottegaad Ercolano, in Cronache Ercolanesi, 18 (1988), pp. 209-214.
43. CIL IV 6635 = CLE 2048 (TPP pp. 303-304); CIL IV 7698a = CLE 2054 (TPPp. 266), fig. 11; CIL IV 7698b = CLE 2054 (TPP p. 267); CIL IV 7698c = CLE 2054(TPP p. 268).
44. Per Lucio Cornelio Scipione Barbato CIL I2 6 e 7 = VI 1284 e 1285 = ILS 1 =ILLRP 309 (ILLRP Imagines nrr. 132-133); per Lucio Cornelio Scipione CIL I2 8 e 9 =VI 1286 e 1287 = ILS 2 e 3 = ILLRP 310a e 310b. Sul monumento e le sue epigrafi sivedano almeno: F. COARELLI, Il sepolcro degli Scipioni, in Dialoghi di Archeologia, 6 (1972),pp. 36-105; A. PETRUCCI, Le scritture ultime. Ideologia della morte e strategie dello scrivere nellatradizione occidentale, Torino, 1995 (Saggi, 798), pp. 23-24; S. GIORCELLI BERSANI, Epigrafiae storia di Roma, Roma, 2004 (Università. Studi Storici, 616), p. 146. Si consideri che leepigrafi incise dovrebbero essere più di poco più tarde rispetto a quelle dipinte e risalireforse all’inizio del II secolo a. C.
45. DONATI, Scrivere col pennello cit. (nota 1), p. 98. Si può pensare che i miliari relati-vi ad una strada fossero prodotti in serie presso un’officina epigrafica in cui si prestasseattenzione ad incidere soltanto le parti invariabili del testo, mentre il compito di com-pletare (a pennello) quest’ultimo con l’indicazione relativa alla distanza, sempre diversa
GLI USI DELLA SCRITTURA DIPINTA NEL MONDO ROMANO 421
Ma il nesso tra scrittura dipinta e incisa non si esaurisce negliaspetti sin qui ricordati. Sembra ormai comunemente accettata, adesempio, l’idea che i solchi delle iscrizioni fossero di frequente ri-passati a pennello e colmati di colore, così come accadeva per ibassorilievi e le statue 46. Ma v’è di più: il tracciato morbido e on-dulato delle lettere osservabile in numerose epigrafi induce a sup-porre che vi sia stata una fase preliminare all’incisione eseguitacon il pennello per conferire ai segni un aspetto particolarmentecurato ed elegante; in questi casi i lapicidi devono aver rispettatocon assoluta fedeltà la traccia dipinta, riproducendone nei solchi lamorbidezza e la sinuosità 47. Escluderei la possibilità di una vera e
da un miliario all’altro, fosse lasciato al personale incaricato di collocare i signacoli lungola via.
46. G. SUSINI, Il lapicida romano. Introduzione all’epigrafia latina, Roma, 1966, pp. 40-41, e ID., Le scritture esposte cit. (nota 7), p. 285, non nasconde la propria perplessità sul-l’eventualità che le iscrizioni incise fossero frequentemente colorate; di diverso avviso,invece, sono DONATI, Epigrafia romana cit. (nota 18), p. 70; L. KEPPIE, Understanding Ro-man Inscription, London, 2001, p. 15; DI STEFANO MANZELLA, Mestiere di epigrafista cit.(nota 27), pp. 158-159; V. GRAEVE, titolo saggio in Dialoghi di Archeologia, (1984), pp. 89-113; DONATI, Scrivere col pennello cit. (nota 1), p. 98. In sostegno a questa ipotesi si puòcitare PLIN. nat., 33, 122: minium in voluminum quoque scriptura usurpatur clarioresque litterasvel in muro vel in marmore etiam in sepulchris facit (dove l’espressione in muro fa certamenteriferimento ai tituli picti). CATICH, The Origin of the Serif cit. (nota 1), pp. 63-64, sostienecon fermezza che il rilievo cromatico fosse una componente fondamentale delle epigrafiromane e giunge ad ipotizzare che il solco a sezione triangolare sia stato introdotto an-che per proteggere meglio il colore dall’azione delle intemperie.
47. DONATI, Epigrafia romana cit. (nota 18), p. 70, e Scrivere col pennello cit. (nota 1),pp. 98-99, ricorda CIL V 6421 tra gli esempi di epigrafi miste (incise e dipinte): si trattadi una base onoraria da Pavia risalente forse agli anni 270-274 d. C., in cui il nome el’epiteto relativi all’onorato sono incisi, mentre la carica e la formula dedicatoria sonodipinte in rosso, con lettere che riproducono quasi alla perfezione i segni incisi. Que-st’ultima circostanza induce la studiosa a dubitare dell’autenticità dell’iscrizione; tuttavianon è da escludere che le lettere dipinte costituiscano le tracce residue di una fase preli-minare che per qualche motivo non è stata più scalpellata. Per alcuni esempi di iscrizio-ni per le quali, su base paleografica, è ipotizzabile un tracciato preventivo dipinto ri-mando a ILLRP Imagines nrr. 179 (dalla base di una statua di M. Emilio Lepido, 37/36a. C.), 230 (dalla base di una statua relativa ad un magistrato, ca. metà I a. C.), 258(iscrizione sepolcrale di un cavaliere romano, ca. metà I a. C.), 261 (lapide commemo-rativa legata all’ambito magistratuale, ca. metà I a. C.), 301 (parte di un’urna contenentele ceneri di un aruspice, I a. C.), 330 (iscrizione sepolcrale di un bambino, forse metà Ia. C.). J. MALLON, Paléographie romaine, Madrid, 1952 (Scripturae. Monumenta et studia,III), pp. 58-59, mostra chiaramente lo stretto legame esistente tra la forma di certe capi-tali epigrafiche da un lato e gli strumenti e i modelli grafici di riferimento al momento
PAOLO FIORETTI422
propria ordinatio dipinta, giacché si sarebbe rivelata poco funziona-le al confronto con altri sistemi più facilmente modificabili e per-fezionabili in corso d’opera; sarei piuttosto propenso a ritenereche il pennello o la pennellessa (a punta piatta, più o meno larga)fossero talvolta adoperati per ribadire e fissare la traccia dell’ordina-tio conferendo alle lettere, sino a quel momento soltanto accenna-te (con o senza l’ausilio di strumenti di precisione quali riga ecompasso), un disegno ben definito, poi fedelmente osservato infase di incisione 48. La fortunata attestazione di un tracciato pre-ventivo dipinto che è restato tale senza essere più inciso è forsericonoscibile in alcuni frammenti marmorei rinvenuti ad Ercola-no, in prossimità di importanti edifici pubblici che sorgevano suldecumano massimo, e appartenenti con tutta probabilità ad un al-bo del collegio cittadino di Augustales 49. Del medesimo albo siconoscevano già altri frammenti marmorei di maggiore estensione,ma questa volta incisi, i quali si riferiscono a più lastre che, giu-stapposte l’una all’altra in senso sia orizzontale sia verticale, forma-vano un unico grande pannello espositivo in cui i nomi degli ap-partenenti al collegio erano disposti in colonne 50. Come spessoaccadeva, per testi di tal genere si prevedeva una redazione ‘aper-ta’, che poteva svolgersi in fieri anche nel corso di più anni. Unaconferma in tal senso è offerta dalla circostanza che i frammentiincisi superstiti sono riferibili a mani diverse (almeno tre), tutte at-tente, però, ad uniformarsi al medesimo modello grafico 51. È pos-
dell’ordinatio dall’altro; nella medesima direzione DI STEFANO MANZELLA, Mestiere di epi-grafista cit. (nota 27), p. 127.
48. Giancarlo Susini, del resto, aveva osservato che la formazione delle apicature nel-la scrittura epigrafica poteva spiegarsi con l’influenza non soltanto dei modelli greci,bensì anche delle lettere dipinte: Epigrafia romana, Roma, 1982 (Guide allo studio dellaciviltà romana, X, 1, Epigrafia romana), p. 89. Allo stesso modo è plausibile che altrecaratteristiche grafiche di certe scritture incise, come ad esempio l’ombreggiatura (un ef-fetto ricercato, venuto in uso a partire dalla metà del I secolo a. C., dato dalla modificagraduale dello spessore dei tratti curvi, più sottili alle estremità e larghi al centro), sianoriferibili ad un tracciato preventivo a pennellessa.
49. M. PAGANO, Nuovi frammenti di albi ad Ercolano, in Cronache Ercolanesi, 22 (1992),pp. 189-195.
50. G. GUADAGNO, Frammenti inediti di albi degli Augustali, in Cronache Ercolanesi, 7(1977), pp. 114-123.
51. La scrittura è una capitale ‘rustica’ connotata da un peso visibile anche se pocomarcato, morbida nel tracciato, dotata di empattements ondulati alle estremità dei tratti. Sideve osservare che il contrasto modulare tra lettere larghe e strette varia di mano in ma-
GLI USI DELLA SCRITTURA DIPINTA NEL MONDO ROMANO 423
sibile quindi che i frammenti dipinti fossero destinati ad essere in-cisi e a completare l’albo esposto con l’aggiunta di nomi relativi alperiodo immediatamente precedente l’eruzione del 79 d. C. eche, tuttavia, non vi siano stati tempo e modo di portarne a ter-mine la realizzazione 52. A sostegno di tale ipotesi si consideri chel’impostazione grafica dei frammenti dipinti (forma e dimensionidelle lettere, disposizione del testo) è perfettamente coerente conquella dei frammenti incisi; inoltre, per motivazioni di ordineestetico si sarebbe indotti ad escludere che l’albo degli Augustalesfosse redatto mediante due differenti tecniche, risultando in parteinciso e in parte dipinto 53.
Una notevole diffusione sociale della scrittura a pennello, infi-ne, era garantita dai traffici commerciali. Di solito le anfore roma-ne recano sulla superficie un complesso di scritte che poteva ac-crescersi progressivamente in momenti diversi (in occasione dellaproduzione del recipiente, del riempimento del prodotto, dellefasi di controllo amministrativo espletate alla spedizione o all’arri-vo della merce, del deposito presso magazzini e così via). Ai finidel discorso qui condotto può risultare interessante osservare chenella realizzazione di questo articolato apparato epigrafico si ten-deva a scegliere lo strumento scrittorio e la tipologia grafica nonin modo casuale, ma secondo la natura dell’informazione: per leparti più propriamente ‘pubblicitarie’, relative alla tipologia e alpeso del contenuto, al luogo di produzione del prodotto, even-tualmente al nome del produttore nonché al destinatario dellamerce, si faceva sistematicamente ricorso al pennello e a vernicirosse o nere 54. Non v’è motivo di dubitare che l’uso di apporre
no, presentandosi più o meno accentuato. L’altezza dei segni grafici corrisponde a ca.11-13 mm.
52. Aveva intuito questa possibilità PAGANO, Nuovi frammenti di albi cit. (nota 49).53. Si potrebbe obiettare che i frammenti in questione appartenessero a lastre ricon-
ducibili alla medesima tipologia attestata, ad esempio, dai fasti Antiates maiores (cfr. suprapp. 8-9), ossia testi dipinti sul marmo non in funzione di una successiva incisione, maperché fossero così esposti; tuttavia, come già sostenuto, ritengo che testimonianze co-me quella degli Antiates siano riferibili ad una fase di transizione – collocabile grossomo-do intorno alla metà del I secolo a. C. – verso l’uso, invalso a partire dall’età tardore-pubblicana, di incidere questi testi nel marmo: cfr. supra p. 9.
54. Le anfore del tipo nominato Dressel 20, accumulate in immense quantità a Ro-ma nel cosiddetto Monte Testaccio e contenenti in origine olio della Betica destinatoall’approvvigionamento della città, offrono da questo punto di vista un caso di studio di
PAOLO FIORETTI424
informazioni scritte (dipinte o anche vergate ad inchiostro) suicontenitori di alimenti o di prodotti diversi destinati al commer-cio interessasse anche altre tipologie, oltre alle anfore, sfuggitepurtroppo ad una qualche forma di conservazione; un fortunatocaso di sopravvivenza è costituito da un sacchetto di cuoio che inorigine doveva contenere orzo 55.
A conclusione della sintetica rassegna qui proposta si deve am-mettere che nella cultura romana la scrittura dipinta occupa unposto importante quale quello delle scritture incise e a inchiostroe, dunque, va ‘contestualizzata’ nella prospettiva di influenze escambi reciproci in funzione di una visione più integrata dei feno-
notevole interesse perché mostrano l’uso di un complesso sistema grafico codificato, incui ogni elemento si presenta connotato sempre dalle medesime caratteristiche (posizio-ne, modulo, tipologia grafica – a sua volta condizionata dalla scelta di un determinatostrumento scrittorio –, colore) agevolando così una immediata riconoscibilità ed unapiena intelligibilità delle informazioni: E. RODRÍGUEZ ALMEIDA, Los tituli picti de las ánfo-ras olearias de la Bética, I, Tituli picti de los Severos y la Ratio Fisci, Madrid, 1989, part.pp. 25-31; Estudies sobre el Monte Testaccio (Roma), I, eds. J. Ma BLÁZQUET MARTÍNEZ, J.REMESAL RODRÍGUEZ, Barcelona, 1999; J. REMESAL RODRÍGUEZ, Las ánforas Dressel 20 y susistema epigráfico, in Epigrafia anfprica, Barcelona, 2004, pp. 127-148; A. AGUILERA MARTÍN,Evolucipn de los tituli picti d de las ánforas Dressel 20 entre mediados del siglo I y mediados delsiglo III, in XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae (Barcelona, 3-8Septembris 2002), Barcelona, 2007, pp. 15-22.
55. PCair inv. 39513 (ChLA XLI 1191). Il sacchetto, contenente un campione d’or-zo (exemplar hordei) spedito dalla capitale del Nomos Memphites, era stato affidato al ti-moniere (gubernator) Chaeremon figlio di Anubion. Su base paleografica il reperto è rife-rito dall’editore delle Chartae genericamente al I-II secolo. Che si tratti di un’annotazio-ne di ambito commerciale e non di natura privata si evince non soltanto dal contenuto(forse si tratta della spedizione dell’exemplar d’orzo indirizzata ad un acquirente che do-veva valutare la qualità della merce prima di ordinarne un’intera partita?), ma anche dal-la scrittura: in un contesto domestico difficilmente si sarebbe fatto ricorso ad una scrittu-ra speciale, d’apparato, quale la ‘rustica’, poiché una mano ‘comune’ avrebbe senz’altroadoperato la scrittura tipica dell’uso quotidiano e avrebbe impiegato uno strumentoscrittorio affatto differente. Si veda, a titolo esemplificativo, una decorazione parietalepompeiana di età neroniana raffigurante una natura morta nella quale si distingue, pog-giato sulla mensola di uno scaffale da dispensa, un sacchetto chiuso da un laccetto – for-se contenente monete – sul cui corpo è visibile un’annotazione indicante il contenutovergata, per quanto è possibile riscontrare, in una scrittura che richiama le forme corsi-ve: Roma cit. (nota 9), nr. V.1, p. 300, fig. a p. 238. Il sacchetto d’orzo, invece, apparevergato con notevole perizia mediante un calamo a punta larga o da un commercianteo, più verosimilmente, da un professionista della scrittura (un suo schiavo addetto anchea mansioni di questo tipo? Uno scriptor di mestiere?).
GLI USI DELLA SCRITTURA DIPINTA NEL MONDO ROMANO 425
meni grafici. Sarebbe fuorviante, infatti, concepire la cosiddetta‘unità grafica romana’ come un blocco monolitico, statico; essa, alcontrario, presuppone e a sua volta favorisce una continua intera-zione tra differenti ambiti e modalità di scrittura, a prescinderedalle tecniche, dai supporti e dagli strumenti adoperati nonché daicontesti di produzione e d’uso. Non bisogna temere, dunque, dilivellare ed annullare le differenze esistenti, che vanno certamenteosservate e messe in risalto, ma occorre sforzarsi soprattutto dicomprendere le reciproche influenze tra le componenti che costi-tuiscono tale sistema. La quantità e la varietà di scritte dipinte quiconsiderate, a questo punto, richiedono che se ne indaghino lediverse morfologie, correlandole alle rispettive funzioni ogni voltache tal rapporto emerga. Il discorso, tuttavia, come s’è detto, èrinviato ad altra sede.
TAV. IP. FIORETTI
Fig.1 - Albo di un collegio (da Pompei).
Fig. 2 - Albo dei magistri vici (da Pompei).
P. FIORETTITAV. II
Fig. 3 - Editto in materia di igiene pubblica (da Ercolano).
Fig. 4 - Fasti Antiates maiores (dettaglio).
P. FIORETTI TAV. III
Fig. 5 - Programmi elettorali (da Pompei).
Fig. 6 - Programmi elettorali (da Pompei).
P. FIORETTITAV. IV
Fig. 7 - Avviso di vendita di materiale edilizio,parzialmente visibile sotto lo strato d’intonaco (da Pompei).
Fig. 8 - Pubblicità (da Pompei).






























![con F. M. TOMMASI, Ceramica dipinta tardoromana dagli scavi nelle Catacombe di san Sebastiano sull'Appia [Roma]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631ed6b1dc32ad07f307c80a/con-f-m-tommasi-ceramica-dipinta-tardoromana-dagli-scavi-nelle-catacombe-di-san.jpg)