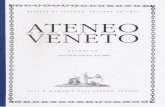IL FONDO DEI CAMPELLO DI SPOLETO: AUTOGRAFI OTTOBONIANI E ALTRI TESTI PER MUSICA
-
Upload
conservatoriosantacecilia -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of IL FONDO DEI CAMPELLO DI SPOLETO: AUTOGRAFI OTTOBONIANI E ALTRI TESTI PER MUSICA
IL FONDO DEI CAMPELLO DI SPOLETO: AUTOGRAFI OTTOBONIANI E ALTRI TESTI PER MUSICA di Teresa Chirico (Roma) Giace oggi presso l’Archivio di Stato di Spoleto il fondo dei conti spoletini Campello, studiato molti anni fa e solo in minima parte da alcuni storici (tra cui Paolo Campello della Spina, discendente di quella famiglia)1, ma mai portato all’attenzione di studi musicologici. La sua scoperta, del tutto casua-le, ha fatto emergere dei testi per musica di primaria importanza, in partico-lare per la storia del teatro a Roma tra la fine del Seicento e il primo venten-nio del secolo successivo, nonché per altri generi come cantate e oratori anche in Umbria.
Il fondo è esclusivamente formato da manoscritti e comprende testi per musica individuati come provenienti prevalentemente dalla biblioteca ro-mana del cardinale Pietro Ottoboni; inoltre, vi si trovano vario materiale documentario, nonché opere storiche e letterarie che riguardano anche le attività dell’Accademia dell’Arcadia sin dalle sue origini, come testimonia-no alcune poesie scritte addirittura per la nascita di quel movimento.
1 Paolo CAMPELLO DELLA SPINA, Il Castello di Campello: memorie storiche e biografiche,
Roma – Torino – Firenze 1889. Paolo CAMPELLO DELLA SPINA, Storia documentata aned-dotica di una famiglia umbra, parte II, vol. I: Spoleto nel Settecento e sotto il dominio francese, Città di Castello 1899. Angela DILLON BUSSI, Campello, Bernardino Francesco di Solone, in: Dizionario Biografico degli Italiani (d’ora in poi DBI), Roma 1974, vol. 17, pp. 475–478. Giovanna PITASSIO, Campello, Francesco Maria di Solone Maria, in: DBI, Roma 1974, vol. 17, pp. 482s. Ometto indicazioni sugli studi relativi ad altri componenti della famiglia Campello vissuti al di fuori del periodo storico qui trattato (inizi del diciassettesimo secolo – primo ventennio del diciottesimo).
Ogni documento cit. nel presente articolo, tranne diversa indicazione, è conservato presso l’Archivio di Stato di Spoleto (d’ora in poi ASS) nell’Archivio Campello. Ringra-zio sentitamente tutto il personale dell’Archivio di Stato di Spoleto per la rara gentilezza e disponibilità dimostratemi nel corso della mia ricerca.
Desidero ringraziare inoltre: Warren Kirkendale, Arnaldo Morelli, Juliane Riepe, Claudio Annibaldi e il personale della Biblioteca dell’Istituto Storico Germanico di Ro-ma, Sezione Storia della Musica, soprattutto nella persona del direttore, Dr. Markus En-gelhardt.
Teresa Chirico 86
Moltissime delle opere appartenute alla famiglia (a parte quelle che recano la firma di alcuni Campello e di altri personaggi coevi) sono adespote. La loro identificazione, oggi quasi totale, è frutto di un lungo e meticoloso la-voro, basato su uno studio incrociato di documenti dello stesso fondo e sulla consultazione di repertori, opere letterarie coeve e studi di recente pubblica-zione. Di qualche aiuto si sono dimostrati gli scritti del già citato Paolo Campello della Spina, nonostante alcune imprecisioni e dubbi che sono e-mersi alla verifica delle notizie riguardanti le opere del fondo.
Dall’identificazione dei testi del fondo Campello è sortito un quadro di grande importanza. Nel presente studio compaiono ottantotto testi per musi-ca o con musica (drammi, oratori, cantate, tragedie, ecc.), sessantatrè dei quali risultano essere unica: si tratta di opere ritenute perdute nel corso del tempo, oppure di testi completamente sconosciuti.
Si individuano nel fondo due aree, la prima delle quali abbraccia la mag-gior parte delle opere:
1. Area ›romana‹. Il nucleo più interessante è costituito da opere ricono-sciute come del cardinale Pietro Ottoboni, alcune delle quali autografe e fino ad oggi ritenute perdute; sono presenti anche opere di Antonio Ottoboni e di personaggi facenti parte della cerchia del cardinale nonché arcadi, tra cui i conti Campello che furono lungamente attivi a Roma. Inoltre, si trova-no opere promosse dallo stesso Pietro Ottoboni (vedi il caso della rarissima Agrippina [12.2], da considerare unicum).
In quest’area si inscrivono anche melodrammi nati in epoca precedente a quella del cardinale ma che evidentemente furono posseduti e in qualche caso riallestiti dal cardinale stesso (vedi il caso de Il martirio [2] di Dome-nico Mazzocchi); non è però da escludere che alcuni testi di quest’epoca siano stati originariamente posseduti dai Campello.
2. Area ›spoletina‹. Costituita per la maggior parte da oratori che recano saltuariamente indicazioni di autore, luogo, data. È legittimo chiedersi come le opere di matrice ottoboniana, alcune addirittu-ra in fase di abbozzo, siano passate in possesso dei Campello. Di questo non si ha alcuna testimonianza certa, ma è altamente probabile che alla morte del cardinale molti dei testi della sua biblioteca fossero stati acquisiti dal letterato e avvocato Francesco Maria Campello (del quale dirò più avanti),
Il fondo dei Campello di Spoleto 87
personaggio vicino al cardinale e molto in vista nella Roma letteraria dell’epoca. Il presente studio intende fornire anzitutto delle sintetiche notizie sui perso-naggi più significativi della famiglia Campello.
Si passa poi alle opere del fondo, considerando i testi antecedenti al 1689, anno di ›cesura‹ per diversi accadimenti importanti: la morte di Cri-stina di Svezia, l’inizio del cardinalato di Pietro Ottoboni, l’imminente na-scita dell’Arcadia (1690). Le opere di Paolo Campello e Girolamo Gigli, anche antecedenti al 1689, vengono trattate a parte.
Si considerano poi gli scritti di Antonio e Pietro Ottoboni, le opere pro-mosse a Roma da quest’ultimo e l’attività di Francesco Maria Campello.
In Appendice si riportano la descrizione dei testi (vedi p. 143) e la crono-logia delle opere (pp. 172–178); nel corpo dell’articolo e nella cronologia il titolo delle opere è seguito dal numero d’ordine che rimanda alla descrizio-ne dei testi. I CAMPELLO Come è già stato accennato, la storia dei conti Campello di Spoleto è desc-ritta, alla fine dell’Ottocento, dal discendente Paolo Campello della Spina.2 I Campello, di probabile origine francese, si stabilirono a Spoleto in epoca incerta come conti e signori della Spina presso una terra alle fonti del Cli-tunno, dove sarebbe sorto il castello della famiglia.3 Diversi componenti di quest’ultima furono dediti alla musica e alla letteratura, e al contempo ri-coprirono importanti incarichi diplomatici e politici, tenendo contatti con i personaggi più in vista della loro epoca.
2 Cfr. nota 1. 3 CAMPELLO DELLA SPINA, Il Castello di Campello, pp. 8s.
Teresa Chirico 88
Da Bernardino (vissuto tra il 1594 e il 1676)4 e dalla nobile Vittoria Pagani nacquero dieci figli: il primogenito fu Solone (nato nel 1641) giureconsulto ed erudito, segretario di monsignore Giovan Battista Rubini (pronipote del futuro papa Alessandro VIII); nel fondo si conserva di lui Trionfo d’amore in maschera (4).5 Secondogenito delle nozze sopra citate fu Paolo6 (1643–1713), autore di molti testi per musica oggi conservati nel fondo e arcade con il nome di Egilo Cineteo. Paolo ricoprì numerosi importanti incarichi politici in varie città, tra cui quello di auditore per la S. Sede della Nunziatu-ra di Spagna. Chiamato a Roma al tempo di papa Alessandro VIII, fece suc-cessivamente parte del seguito del cardinale Ottoboni risultando nei Rolli della famiglia del cardinale almeno dal 1699.7 Frequentò i personaggi più in vista della propria epoca e fece parte di varie Accademie d’Italia: Apatisti a Firenze, Gelati a Bologna, Umoristi, Infecondi, Pastori Arcadi, del Disegno a Roma. Conosceva bene la musica e si esercitava nel ballo; dopo molti
4 Per Bernardino vedi nota 1. Questi, dottore in legge, aveva ricoperto importanti cariche
politiche grazie anche al favore del papa Urbano VIII. Bernardino scrisse una Storia di Spoleti giudicata positivamente da Ludovico Antonio Muratori, nonché più opere lettera-rie, tra cui la tragedia Albesinda, stampata nel 1623 a Venezia, della quale esistono due manoscritti nel fondo Campello. Inoltre, La presa del Messico (F. ms. n. 60), poema epi-co in ottave, la Gerusalemme cattiva, l’Edipo (F. ms. n. 145) e la tragedia autografa Teo-dora (F. ms. n. 137) del 1° ottobre 1629, dedicata al cardinale Antonio Barberini e ritenu-ta perduta. Le due tragedie, più la Gerusalemme cattiva, si trovano anche in F. ms. n. 58. Non possiamo escludere che questi testi – nei quali compaiono uno o più cori – avessero delle parti in musica. Bernardino fece parte della spoletina Accademia degli Ottusi, che si occupò dei festeggiamenti per il passaggio della regina Cristina di Svezia a Spoleto; vedi la tesi di laurea di Isa LOPA, La vita musicale a Spoleto dalla fondazione della cappella del Duomo (1561) alla metà del XVIII secolo, Univ. Perugia, a. acc. 1969/70, p. 106 (ap-profitto per ringraziare la dott.ssa Isa Lopa Luchetti che mi ha gentilmente favorito la consultazione della sua tesi di laurea), e CAMPELLO DELLA SPINA, Storia documentata (v. nota 1).
5 Solone scrisse anche un componimento poetico sopra Porta Fuga, posto in musica forse da Francesco Vannarelli ed eseguito in una riunione degli Ottusi a Spoleto il 26 aprile 1663, cit. in LOPA, La vita musicale a Spoleto, p. 86. Inoltre, non per musica, F. ms. n. 143, Bellezza della morte (»operetta di Solone di Bernardino / Campello«).
6 Vedi quanto dice Fulvio Leonio su Paolo in: Giovanni Mario CRESCIMBENI, Notizie isto-riche degli Arcadi morti, Roma 1720, vol. I, pp. 370–376.
7 I-Rvat, Comp. Ottoboni, vol. 32, n. int. 2, gennaio 1699.
Il fondo dei Campello di Spoleto 89
viaggi, tornò a Spoleto nell’Accademia degli Ottusi, all’epoca pare molto decaduta, che soleva riunirsi nel suo palazzo.8
Una figura importante per molti aspetti fu il nipote di Paolo, Francesco Maria (1665–1759),9 figlio del già citato Solone e di Nicola Campello. Si addottorò a Urbino nel 1684 in Diritto, dove insegnò per due anni; rientrato poi in Umbria, si trasferì successivamente a Roma dove esercitò la profes-sione di avvocato. La sua importante attività di giureconsulto e avvocato di Curia andò di pari passo all’attività di letterato, avvantaggiato anche dal fatto che i Campello erano fortemente legati da tempo agli Ottoboni. Fran-cesco fu aiutante di studio del cardinale Pietro, e lo assistette come primo conclavista durante il conclave del 1700 che portò all’elezione di Clemente XI.
Francesco Maria morì a novantatrè anni e fu seppellito a Roma a Santa Maria in Via; ai suoi funerali accorse una gran massa di gente, non solo per la sua fama di letterato, ma anche per la curiosità di vedere il cadavere di un uomo vecchissimo.10 Fu arcade con il nome di Logisto Nemeo.
Il suo nome compare in diverse opere del Crescimbeni – come si dirà – tra cui i Comentarj, dove lo stesso è testimone autorevole dell’apprez-zamento che la regina Cristina di Svezia aveva dimostrato nei confronti dell’opera L’onestà degli amori di Giovanni Filippo Bernini; il »gentilissi-mo e dottissimo« conte aveva infatto personalmente visto una copia a stam-pa de L’onestà postillata dalla regina come »opera buona«.11
Rimangono oggi due sue caricature disegnate da Pier Leone Ghezzi ne Il mondo nuovo, conservate presso la Biblioteca Apostolica Vaticana.12 Nella
8 CAMPELLO DELLA SPINA, Il Castello di Campello (v. nota 1), p. 25; si parla di una convo-
cazione degli Ottusi da parte di Paolo nella sala più grande del proprio palazzo il 3 gen-naio 1701; concerti strumentali e vocali si alternavano ad esercizi accademici.
9 Ibid., pp. 3s., 6, 40, 77. 10 Ibid., p. 77. 11 Giovanni Mario CRESCIMBENI, Comentarj del Canonico Giovanni Mario Crescimbeni
Custode d’Arcadia intorno alla sua Istoria della Volgar Poesia, Roma 1711, vol. 4, p. 155 (v. Saverio FRANCHI, Drammaturgia romana: Repertorio bibliografico cronologi-co dei testi drammatici pubblicati a Roma e nel Lazio, secolo XVII, Roma 1988, p. 529).
12 I-Rvat, risp. Ottob. Lat. 3114, p. 99 e Ottob. Lat. 3117, p. 117. In entrambi i ritratti Fran-cesco Maria appare di statura minuta; in particolare nel secondo risulta essere molto più basso dell’interlocutore e communque di statura inferiore alla normalità. C’è anche da ri-levare però che il Ghezzi, nel ritrarre due figure, tendeva spesso ad accentuare la diffe-
Teresa Chirico 90
prima, del 1722, il Campello è ritratto da solo: »Avvocato Campelli cavalier spoletino e famoso letterato, mà altrettanto filosofo fatto da mè Cav.e Ghez-zi a di 8 maggio 1722«. La seconda ritrae il nostro personaggio diciassette anni dopo, »Cavaliere Poeta Arcade« insieme all’»Abbate Santori Poeta e Basso Cam.[erier]e di Papa Clemente XII« »fatti da me Cav. Ghezzi il dì 11 febraro 1739«.
Un altro Campello, Bernardino Francesco di Solone (in Arcadia Verindo Tueboate) fratello minore di Francesco, scrisse testi per musica da eseguirsi nelle riunioni degli Ottusi di Spoleto: il 14 marzo del 1718 fu eseguito un suo dialogo tra il Tevere e il Clitunno per la vittoria di Eugenio di Savoia contro i Turchi13 e nel 1748 una cantata in lode di San Ponziano.14 Il Cam-pello della Spina a lui attribuisce, come si dirà, l’oratorio L’Assalonne (28.7), forse invece opera del fratello Francesco Maria.
I Campello, come già detto, ebbero importanti legami con l’Arcadia e con circoli di poeti prearcadici; nel loro fondo si trovano oggi manoscritti di storica importanza per la nascita di quel movimento, raccolti tra fine Seicen-to e primi anni del secolo successivo, tra cui quelli appartenuti alla bibliote-ca del letterato e giurista di origine spoletina Vincenzo Leonio (in Arcadia Uranio Tegeo15) ceduta a Francesco Maria Campello.16
renza di statura e per questo motivo non è detto che il Campello fosse affetto da una qualche patologia.
13 LOPA, La vita musicale a Spoleto (v. nota 4), pp. 93ss., e 160s.; il testo della cantata, a stampa, è segnalato nella Biblioteca Comunale di Spoleto. Notizia riportata anche in CAMPELLO DELLA SPINA, Storia documentata (v. nota 1), p. 50. Le sue nozze con la nobi-le Eleonora Fani di Viterbo vennero festeggiate dagli Ottusi nel 1725 con la declamazio-ne di vari componimenti letterari creati per l’occasione e con la cantata del romano Igna-zio De Bonis Il trionfo del Clitunno con i personaggi Clitunno e Amore.
14 LOPA, La vita musicale a Spoleto. 15 Maria Teresa ACQUARO GRAZIOSI, L’Arcadia. Trecento anni di storia, Roma 1991,
pp. 14s. Il Leonio nacque a Spoleto nel 1650 e morì a Roma nel 1720; fece parte di nu-merose accademie (cfr. FRANCHI, Drammaturgia romana [v. nota 11], p. 863).
16 CAMPELLO DELLA SPINA, Storia documentata (v. nota 1), p. 24 in nota.
Il fondo dei Campello di Spoleto 91
I TESTI DEL FONDO CAMPELLO TRA IL 1606 E IL 1689 Tra i testi per musica più antichi del fondo troviamo il Tirinto (1) di Gio-vanni Capponi del 1606, Il martirio de’ Santi Abundio prete Abundantio diacono Marciano, e Giovanni (2) del 1641 di Ottavio Tronsarelli musicato da Domenico Mazzocchi e il libretto adespoto de La Datira (3) che reca la data del 1647.17
Non sappiamo se il Tirinto (1) abbia anche fatto parte della biblioteca del cardinale, o se sia originariamente appartenuto ad un Campello, forse il primo Solone sopra citato. È anche possibile che il prezioso esemplare del Tirinto, forse autografo, sia stato acquisito da un arcade allo scopo di studia-re le antiche favole pastorali (vedi il già citato caso dello spoletino Vincenzo Leonio, i cui manoscritti vennero inglobati nella biblioteca dei Campello) e poi sia passato di proprietà dei nobili spoletini.
L’autore del testo del Tirinto, Giovanni Capponi (nato nel 1586 a Porret-ta e morto nel 1628 a Bologna) fu colto letterato e medico;18 a Bologna ave-va fondato l’Accademia dei Selvaggi, con sede in casa di Giovanni Filippo Certani, »Palustre Accademico Selvaggio«, al quale fu dedicato Il Tirinto. La dedica riporta le scuse per la favola, dal Capponi definita »pianta d’ingegno infecondo, nata nello spazio di pochi giorni, come V.S. può farne fede«.
17 Tutti questi testi meritano una trattazione particolare, tanto da poter costituire singolar-
mente oggetto di ampio studio. Per quanto riguarda Il martirio, vedi Teresa CHIRICO, »Il martirio de’ Santi Abundio prete, Abundantio diacono Marciano, e Giovanni«. Una sco-nosciuta fonte librettistica, in: Analecta musicologia 36, S. 294–313). Mi riprometto al-tresì di pubblicare al più presto uno studio degli altri due testi citati.
18 Claudio MUTINI, Capponi, Giovanni in: DBI, Roma 1976, vol. 19, pp. 55ss. Il Capponi fu amico e sostenitore di Giovan Battista Marino; scrisse drammi per musica, rappresentati rispettivamente a Venezia nel 1615 (Orsilia) e a Bologna nel 1628 (Cleopatra), opere delle quali rimangono i libretti (cfr. Claudio SARTORI, I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800, Cuneo 1990–1994, risp. n. 17565 e n. 5842), più un Arione, allestito nel 1618 per le nozze del principe Vittorio Amedeo di Savoia con Maria Cristina di Borbo-ne-Francia. Il Capponi fece anche parte dell’Accademia dei Gelati; nel 1628 si diedero suoi Intermedi posti in musica da Domenico Benedetti musico della Signoria di Bologna per il martirio di S. Orsola (MUTINI, Capponi).
Teresa Chirico 92
Il libretto a stampa dell’opera uscì a Bologna nel 160719; vi si dice che la favola fu »rappresentata presso l’Accademia dei Selvaggi in Bologna l’anno 1607«. Il libretto manoscritto del fondo Campello risulta essere antecedente, recando la data 17 giugno 1606. È molto curato e riporta un sonetto del de-dicatario Certani; lo stesso sonetto è presente nel libretto a stampa insieme a diversi altri, scritti da membri della stessa Accademia. Sul frontespizio dell’opera a stampa si omette, in riferimento all’autore, »di Bologna«; inol-tre, sempre nella stampa, il personaggio Orrillo satiro fu sostituito da Aron-te.
Nulla indica esplicitamente il concorso della musica nella favola, ma tut-to fa pensare che il testo fosse completamente o in parte musicato, visto anche il già citato sonetto del Certani riportato alla fine del Tirinto20, nel quale è evidente il riferimento alla musica e in particolare alla celebre favola d’Orfeo.
Per quanto riguarda Il martirio de’ Santi Abundio prete Abundantio dia-cono Marciano, e Giovanni (2), c’è da dire che la stesura del testo venne fatta almeno un cinquantennio dopo la sua prima rappresentazione. Fu infat-ti probabilmente oggetto di riallestimento da parte del cardinale Pietro Otto-boni (1667–1740), come è dimostrato dalla grafia del testo da attribuire sen-za dubbio allo stesso Ottoboni, e dalle numerose aggiunte rispetto al testo a stampa. Per questo motivo ne parlerò nel paragrafo che riguarda le opere di Pietro Ottoboni.
Del 1647 è il libretto adespoto de La Datira (3) che reca purtroppo poche indicazioni, limitandosi a descrivere nelle prime pagine l’argomento. L’ope-ra fu recitata nel »nuovo Teatro di Siena«, da identificarsi, come sede, nella
19 Che io sappia, l’unico esemplare a stampa sopravvissuto è quello oggi conservato presso
I-Rn (cfr. Appendice). 20 »Del Palustre Academico Selvaggio / Felici selve e fortunati orrori / ove in sì dolci e sì
soavi note / Armindo il Pastorel l’aura percote, / ch’intenerisce i più indurati cori. / Io veggio mille in voi Ninfe, e Pastori / fermarsi al canto per dolcezza immoti, al canto ch’arrestar l’eterne rote, e placar può d’Averno anco i furori. / E quel vegg’io fra più su-blimi unirsi, / onde ’l bosco sonar lieto, e giocondo / per Titiro, e Carin sincero e Tirsi. / Ma s’avverrà, che ’l chiaro stil facondo / deggia fuor de le selve un giorno udirsi, / fia che l’ammiri alor l’Italia, e ’l mondo.«
Il fondo dei Campello di Spoleto 93
sala del Palazzo pubblico di Siena, già sede del Teatro degli Intronati, che proprio in quell’anno passava d’uso ai Filomati.21
Tale Datira è probabilmente da identificarsi con l’omonima opera di Giulio Rospigliosi, della cui rappresentazione non si hanno notizie certe. L’opera è citata in un testo di Giovanni Antonio Bianchi, De i vizj, e dei difetti del moderno Teatro, in un Ragionamento nel quale intervengono Lo-gisto Nemeo (Francesco Maria Campello) e Girolamo Teodoli (Audalgo Toledermio); viene definita »dramma cristiano« e si dice che non fu mai stampata, ma che si poteva trovare »scritta a penna« in molte copie presso le biblioteche di diversi signori romani.22 L’assenza del testo accertato della Datira ci impedisce ogni verifica, ma l’ipotesi è confortata dalla presenza di un altro libretto del Rospigliosi nell’archivio Campello, La strage degli in-nocenti (35.11) (se ne riparlerà più avanti). È molto probabile che anche La Datira sia appartenuta a Pietro Ottoboni; sappiamo che nella biblioteca del cardinale si conservavano opere del Rospigliosi in più volumi23 e che oggi in un codice ottoboniano è presente l’opera L’innocenza difesa del 1641.24
La nostra Datira fu rappresentata nel periodo in cui Rospigliosi si trova-va in Spagna quale Nunzio apostolico presso Filippo IV (1644–1653); è possibile però che il futuro papa Clemente IX avesse fatto pervenire nello stesso periodo il testo in Toscana. Il »dramma eroico« è d’argomento storico e per l’epoca rappresentò per tale motivo una scelta ›di tendenza‹; si basava sulla guerra tra Svezia e Norvegia, argomento tratto dalle Historie de’ Goti di Giovanni Magno, e si chiudeva con il lieto fine. I personaggi erano venti-cinque, più tre cori, accompagnature e balli; ebbe un allestimento molto
21 Michele CORDARO, Echi dell’Architettura teatrale romana nel Palazzo Pubblico di Sie-
na, in: Il teatro a Roma nel Settecento, a cura del Servizio Attività Culturali dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1989 (Biblioteca internazionale di cultura 21), vol. 1, p. 161.
22 Giovanni Antonio BIANCHI, De i vizj, e de i difetti del moderno Teatro e del modo di corregergli, e d’emendarli: Ragionamenti VI di Lauriso Tragiense pastore arcade, Roma 1753, p. 78, in nota. Nello stesso Ragionamento si nominavano le opere di Bernardino Campello, nonno di Logisto, come esempio di teatro cristianamente e moralmente im-peccabile (ibid., p. 76, nota b).
23 Francesco Severio QUADRIO, Della storia e della ragione d’ogni poesia, Milano 1744, vol. II, parte II, dist. IV, p. 474.
24 I-Rvat, Ottob. Lat. N. 2444, p. 89.
Teresa Chirico 94
fastoso, come testimoniano i numerosi mutamenti di scene raffiguranti un porto, un bosco, una sala regia, la città di Colmar, ecc.
Non si sa a che data risalgono i Trionfi d’amore in maschera (4) (presu-mibilmente a non prima del 1660) del già citato Solone Campello che si conservano in una miscellanea. Nei Trionfi si avvicendano celebri coppie della mitologia (Aci e Galatea, Titiro e Amarilli, ecc.); il testo si conclude con un coro di settenari e endecasillabi. È molto probabile che tali Trionfi fossero tutti musicati. Nello stesso volume25 si trovano diverse poesie scritte per l’entrata dell’autore nell’Accademia degli Umoristi in Roma, per la principessa Olimpia Aldobrandini (che reca la data 1673), per l’elezione a papa di Alessandro Ludovisi Gregorio XV (risalente quindi al 1623), più una satira contro le donne, dove si sosteneva che il vero dono di Plutone a Orfeo, come gratitudine per il suo canto, non fosse stato quello di restituirgli Euridice, ma di avergliene facilitato la perdita.
Un testo del 1675 è L’amore in maschera (5) di tale Sebastiano Zacca-gnini »Gentilhuomo Cortonese«, forse rappresentato presso l’Accademia degli Umorosi di Cortona; il testo, come risulta dal frontespizio, fu d’uso di Francesco Maria Campello. Purtroppo non ci sono altre notizie dell’opera; la vicenda ha carattere di commedia, come è evidente dal nome dei perso-naggi (Spaccanocchia, Mestolino).
Non conosciamo né luogo né data di rappresentazione della »favola mo-rale« di Fabrizio Hon de Dei Virginità (6), che ritengo sia anteriore al 1680 circa per diversi motivi: la presenza di numerosi personaggi (ventitré), la commistione tra personaggi divini (Iddio, Angelo), mitologici (Plutone, Proserpina) e simbolici (Virginità, Astinenza). Sullo stesso manoscritto, all’inizio, troviamo »Frater Caesar Masinus«, probabilmente l’autore della musica; non escluderei una relazione di parentela con Antonio Masini, vir-tuoso di Cristina di Svezia e autore di oratori eseguiti nell’Anno Santo 1675 presso l’Oratorio della Pietà in San Giovanni dei Fiorentini in Roma.26 Si-gnificativa è la conclusione edificante di un sonetto riportato all’inizio della
25 F. ms. n. 14. 26 Raffaele CASIMIRI, Oratorii del Masini, Bernabei, Melani, Di Pio, Pasquini e Stradella,
in Roma, nell’Anno Santo 1675, in: Note d’Archivio per la storia musicale, Anno XIII, Settembre – Dicembre 1936, pp. 157–169.
Il fondo dei Campello di Spoleto 95
favola, che recita: »[…] E qual mostro è maggior che fra gl’amori / veder Virginità sovra le scene / Partorir plausi, e generar stupori?«.
Ad un periodo anteriore al 1689 risalgono diversi oratori del fondo di o-rigine romana.
Del già citato oratorio di Rospigliosi, La strage degli innocenti (35.11), si parlerà più avanti, perché si tratta a mio parere di una copia appartenuta a Pietro Ottoboni. Fu rimaneggiata ed è possibile che sia stata allestita parec-chio tempo dopo la sua prima comparsa, della quale non si conosce la data.
Altri oratori sono La conversione di S. Agostino (7) di Cesare Mazzei che sappiamo fu musicato da Giovanni Bicilli e rappresentato per la prima volta a Roma ai Filippini nel 167127 e Didimo e Teodora (8) di Pietro Filip-po Bernini che fu scritto entro il 1677.28
Cito anche l’oratorio Santa Beatrice d’Este (9) del 1689, »Da cantarsi / Alla presenza / Dell’Eminentissimo / Sig.r Cardinale D’Este […] / In Ro-ma«. Non è chiaro se il testo dell’opera sia stato scritto dallo stesso Bene-detto Pamphilj oppure da Giulio Cesare Grazzini; fu musicato da Giovanni Lulier con parti di Arcangelo Corelli.29 Il cardinale d’Este citato nel testo manoscritto era Rinaldo e il luogo fu Palazzo Pamphilj. Suonava l’organo Bernardo Pasquini; precedette l’oratorio una introduzione con un vasto or-ganico che comprendeva due trombe.30
Una cantata (10) adespota, senza titolo e incompleta appartiene proba-bilmente all’area umbra; è possibile che sia stata scritta tra gli anni 1688–1701 in onore di Giacomo II Stuart. Comprende i personaggi Ninfa del Ta-migi e Clitumno e farebbe ipotizzare un omaggio allo stesso re, sicuramente
27 Arnaldo MORELLI, Il »Theatro spirituale« ed altre raccolte di testi per oratorio romani
del Seicento, in: Rivista italiana di musicologia XXI, 1986, pp. 61–143: 65. Cesare Maz-zei (1613–1687), padre filippino, fu autore dei testi di molti oratori.
28 MORELLI, Il »Theatro spirituale«, p. 65. Bernini (1641 ca.–1698) era figlio del celebre Gian Lorenzo; l’oratorio è contenuto in un’antologia manoscritta del 1677.
29 La data è confermata dal libretto a stampa (cfr. SARTORI, I libretti [v. nota 18], n. 20758). 30 Franco PIPERNO, Le orchestre di Arcangelo Corelli. Pratiche musicali romane. Lettura
dei documenti., in: 4° Festival Vivaldi, programmi delle manifestazioni, L’Invenzione del gusto: Corelli e Vivaldi, mutazioni culturali a Roma e Venezia nel periodo post-barocco, Milano 1982, pp. 42–48: 46s.
Teresa Chirico 96
in occasione di una riunione dell’Accademia degli Ottusi; questi erano infat-ti usi a scrivere componimenti in cui compariva il personaggio Clitumno.31 I TESTI DI PAOLO CAMPELLO Nell’archivio Campello i testi di Paolo vanno dal 1643 ai primi anni del diciottesimo secolo. Nella voce a lui relativa nell’opera di Crescimbeni No-tizie istoriche degli Arcadi morti, Fulvio Leonio annoverava tra le sue opere otto drammi, tre commedie »in prosa« rappresentate nel teatro romano della duchessa di Zagarolo32 e in parte a Spoleto, un oratorio sopra S. Antonio da Padova e altre composizioni »delle quali fatiche però quasi niuna uscì alla luce delle stampe, avendolo egli vietato, per essere stato suo particolare sen-timento, che i frutti dell’ingegno collo stamparsi perdon di pregio«.33 Il Le-onio ci fornisce così una preziosa indicazione sui motivi che determinarono la mancata stampa di molte delle opere di Paolo Campello – o la stampa in forma adespota, come si dirà – motivi estensibili con ogni probabilità ad altre opere dello stesso fondo che costituiscono testimonianze uniche.
Gli scritti di Paolo Campello oggi presenti a Spoleto constano di rari testi di rappresentazioni per musica e con musica, uno dei quali di argomento comico, come La gelosia non è buona guardiana (23) (definito »giocoso«); sono inoltre presenti il citato oratorio e varie cantate.
Probabilmente il primo testo scritto da Paolo, a vent’anni, come accade-mico ottuso, fu Clomiri (11); anche se il libretto non reca data, sappiamo che fu rappresentato a Spoleto il 5 febbraio 1663 in una riunione della stessa Accademia insieme al dramma musicale Egeria, il cui testo era stato scritto da Domenico Monti, nell’occasione principe dell’Accademia. Clomiri è
31 Per alcune delle composizioni dell’Accademia degli Ottusi nelle quali compare il Cli-
tumno (cfr. LOPA, La vita musicale [v. nota 4], p. 92). 32 CRESCIMBENI, Notizie istoriche (v. nota 6), pp. 374s. Vedi quanto detto più avanti sui
Rospigliosi e le opere di Paolo rappresentate nel loro teatro. Una commedia in prosa si trova oggi in F. ms. n. 112: »La costanza vince la sorte / Comedia / Del Cav.r Paolo di Campello«.
33 CRESCIMBENI, op. cit., pp. 374s. Altri mss. di Paolo sono oggi conservati presso I-Ra, ms. 7–9.
Il fondo dei Campello di Spoleto 97
definito »commedia« e non è chiaro quanto concorso avesse la musica nella rappresentazione; il testo non sembrerebbe destinato alla musica.34
Paolo Campello, come si vedrà, usò in tutta la sua vita rimaneggiare i suoi drammi, persino a distanza di molti anni, presentandoli in diverse occa-sioni con titoli e personaggi variati. Anche Clomiri non si sottrasse a tale destino: costituì infatti materiale di base per il dramma I successori di Ales-sandro (opera con parti in musica) rappresentato molto tempo dopo al Col-legio Clementino nel carnevale del 1692. Il libretto a stampa di tale dram-ma, che si presenta adespoto, è evidentemente da attribuirsi (come si dirà più avanti) allo stesso Campello.
A Clomiri successe il Demetrio (12), che vide la luce a Spoleto il 4 no-vembre 1667. È uno dei pochissimi testi che reca data, firma e dedica dell’autore a un personaggio, »V.[ostra] A.[ltezza]«, del quale non si rivela il nome; il pronipote Paolo sostiene che si trattasse del principe ereditario di Toscana,35 dunque Ferdinando II de’ Medici, morto nel 1670. Nella dedica si trova il parallelismo principe sfortunato (Demetrio) – principe fortunato (Ferdinando II).36 Il Campello – non sappiamo quando – riprese in seguito lo stesso testo: cambiò il nome del protagonista da Demetrio in Seleuco, variò di poco il nome di un paio di personaggi e lo intitolò il Seleuco ò vero L’odio d’amore (13).37
34 LOPA, La vita musicale a Spoleto (v. nota 4), p. 85. 35 CAMPELLO DELLA SPINA, Storia documentata (v. nota 1), p. 21. 36 Dedica di Paolo Campelli (cc. [1–2]): »se dall’operationi de[lli huomini, cancellato]
grandi, prende la norma al suo vivere il mondo tutto, grande esemplare nella persona di V.A. ci ha dato l’eterna providenza, adornandola di tutte quelle virtù, che possono far pa-rere bella l’umanità; ma poiché la somma prudenza del Ser.mo Padre di V.A., unita a quella de’ suoi gloriosi Antecessori, gli hanno costituito un felicissimo stato, con ben ferma tranquillità, onde siam resi certi, di non veder mai posta in atto nell’A.V. la virtù della sofferenza alle cose annesse, le porgo nel presente Dramma, l’idea di un Prencipe altrettanto agitato dalla contraria sorte, quanto costante in soffrirla, acciò che noi tutti, e da V.A., e dalle cose a lei appartenenti possiamo haver l’esempio nell’una e nell’altra fortuna. Se questo è motivo bastante a pensare il mio ardire, imploro dall.A.V. il gradi-mento, se troppo fievole, la tolleranza, et in ogni altro caso la benignità. Così mi rendo certo dando motivo a V.A. di esercitar le virtù, havere il merito, et il vantaggio ch’altri possa imitarle, e con profondissimo inchino le rassegno il mio divotissimo, et humilissi-mo ossequio.«
37 Il pronipote Paolo Campello della Spina – che non accenna a questa successiva elabora-zione – diceva che il Demetrio era composto da undici personaggi che alternavano »brevi recitativi« a strofe »che dovevano essere musicate«; il giudizio che ne dava era negativo,
Teresa Chirico 98
Tornando al dramma I successori di Alessandro rappresentato al Clementi-no, che fu probabilmente musicato per gli intermezzi da Francesco Gaspari-ni,38 c’è da dire che la sua ›filiazione‹ da Clomiri (11) è dimostrata dalle numerose concordanze tra i personaggi,39 anche se le due opere risultano sostanzialmente diverse. Allo stesso tempo, nel fondo spoletino esistono due versioni di un’opera intitolata I successori di Alessandro (14) (due esempla-ri completi per versione), più un quinto esemplare (peraltro non segnalato nell’inventario) in altra collocazione, mutilo e danneggiato dal fuoco, con indicazioni di regìa. Un esemplare reca la dicitura »[…] opera scenica Reci-tata nel / Corrente Carnevale nel Collegio / Clementino 1692 / Del Sig.r Cav.re Paolo Campelli« e un altro »drama per musica«. Confrontando la versione manoscritta che si dice rappresentata al Clementino con l’opera a stampa che riporta per esteso solo le parti in musica, si nota una quasi totale coincidenza dei personaggi, anche se le due opere sono difformi.
Alcuni personaggi del libretto a stampa de I successori di Alessandro si ritrovano in altri drammi di Paolo Campello40 e addirittura in un dramma del nipote di Paolo, Francesco Maria, intitolato Arsace re de’ Parti (52).41 È
a causa della sdolcinatezza tra amanti senza vigore e passione, e di alcuni personaggi (Aristea nutrice di Matilde regina d’Egitto e il paggio Rodrino) che avrebbero dovuto su-scitare l’ilarità del pubblico, ma che facevano invece cadere il tutto dal sublime al ridico-lo (cfr. CAMPELLO DELLA SPINA, Storia documentata, p. 21).
38 Libretto a stampa conservato in I-Rn, 35.4.k.23.1. Da segnalare che in Lowell LINDGREN, Le opere drammatiche »romane« di Francesco Gasparini (1689–1699) in: Quaderni del-la Rivista di musicologia, Francesco Gasparini (1661–1727), Atti del Primo Convegno Internazionale (Camaiore 29 settembre– 1 ottobre 1978) a cura di Fabrizio Della Seta e Franco Piperno, Firenze 1981, pp. 172s., la collocazione del libretto è data erratamente come 35.4.H.23.1bis; errore presente anche nello schedario cartaceo della stessa Bibliote-ca e in SBN musica. La collocazione corretta è invece data in: FRANCHI, Drammaturgia romana (v. nota 11), p. 648. Lindgren (op. cit., pp. 172s.) sostiene che il compositore del-la musica fosse stato verosimilmente Francesco Gasparini.
39 Vedi ad esempio la protagonista Edelinda principessa di Frigia che in Clomiri era Ede-rinda principessa d’Inghilterra, Giro che derivava da Girello, Pantinea da Pantinca, Leon-te da Liconte, mentre quattro personaggi rimanevano identici (Clomiri, Arbante, Florin-do, Endemiro).
40 Un Endemiro compare nei già citati Demetrio (12) – Seleuco (13), un Arbante e un Leon-te ne Il Radamisto (17). Paolo Campello utilizzò anche in altri drammi gli stessi perso-naggi: ad esempio un Radamisto ne Il Radamisto (17) e in Clomiri (11). Come si dirà più avanti, un Radamisto c’è ancora negli intermezzi de Il Tiridate (15); Mitridate e Arbante si trovano in Radamisto (17) e in Mitridate (21), probabile testo del Campello.
41 Mindori e Clomiri, quest’ultimo, come già accennato, anche in Clomiri di Paolo.
Il fondo dei Campello di Spoleto 99
evidente che l’imprestito e l’autoimprestito dei soggetti, nonchè il ›riciclag-gio‹ dei testi era consuetudine per tali letterati. Ciò non stupisce affatto, se si pensa all’intensa vita politica e sociale dei due Campello ed alla conseguen-te limitata disponibilità di tempo per lo scrivere.
Segnalo al proposito Il Tiridate overo Il Re da scena nel gioco della for-tuna (15) che reca intermezzi in musica. Ricordo che tale opera – della qua-le rimane il libretto a stampa – fu dedicata a Pietro Ottoboni e recitata pres-so il Seminario Romano nel carnevale del 1695.42 Argomento e fonte (XII libro degli Annali di Tacito) degli intermezzi in musica coincidono con quelli dell’opera Radamisto (17) di Paolo Campello, cosa che comporta la paternità dello stesso riguardo agli intermezzi. A rafforzare l’ipotesi è il già citato caso de I successori di Alessandro (14), opera con intermezzi scritta anch’essa per un collegio pochi anni prima del Tiridate.
Anche di Paolo potrebbe essere un Mitridate (21) che presenta due per-sonaggi presenti ne Il Radamisto (17) e fu originariamente conservato ac-canto a I successori di Alessandro (14).
Troviamo poi testi del fondo spoletino adespoti e senza data da attribuire con certezza a Paolo Campello.
È il caso di Male ha chi male opra ovvero Pandolfo (16), che sappiamo fu rappresentato con grande successo nel carnevale del 1695 presso il teatro del palazzo romano del duca di Zagarolo Giovan Battista Rospigliosi.43 Il testo del dramma, oggi conservato anche presso la Biblioteca Apostolica Vaticana,44 risulta presente negli inventari della biblioteca della famiglia
42 FRANCHI, Drammaturgia romana (v. nota 11), p. 690, Prologo e 5 atti, intermedi con
quattro interlocutori »musici«, I-Rli 170.E.11 (26). Autore di un Tiridate rappresentato anni prima (1691) a Parigi fu Jean Galbert de Campistron; l’argomento differisce total-mente da quello della rappresentazione romana.
43 I-Rvat, Ottob. Lat. 3359, Avvisi di Roma, ff. 31–31v: »Roma, 12 febbraio 1695 […] In Casa del Sig.r Duca di Zagarola Ruspigliosi si è rappresentato il Bellissimo drama com-posto dal S.r Cav.re Paulo Campelli da Spoleti, e presentem.e M.ro di Camera del Sig.r Card.le Rubbini intitolato Mal ha chi mal opra, con applauso universale« (cit. CAMPELLO DELLA SPINA, Storia documentata [v. nota 1], p. 23, errato il n. dell’Ottob. Lat. [3363]).
44 I-Rvat, Vat. Lat. 13349, Ms. [autogr.], s. d., 46 cc. (42, IV), 4°. Il libretto entrò in I-Rvat il 29 aprile 1929 come opera di Giulio Rospigliosi (cfr. I-Rvat, Arch. Bibl. 131, ff. 5–13). Il Campello della Spina giudicava perduto Male ha, chi male opra (CAMPELLO DELLA SPINA, Storia documentata, p. 22).
Teresa Chirico 100
Rospigliosi in varie date.45 Il libretto è adespoto, ma si presenta con la grafìa di Paolo Campello e rappresenta l’unico caso al momento conosciuto di opera di quell’autore sopravvissuta al di fuori dell’archivio della famiglia spoletina.
Il libretto di Male ha chi male opra del fondo Campello si presenta in due versioni diverse. È probabile che una di queste, successivamente al 1695, fosse destinata al teatro di Ottoboni.
I Rospigliosi tenevano in gran considerazione i due Campello (vedi più avanti la cantata [25.11]), come è dimostrato da una lettera del 1696 scritta da Francesco Maria e inviata da Zagarolo a Giovanni Mario Crescimbeni,46 dove si parlava di un’imminente rappresentazione (»l’Orsa«) nel teatro degli stessi duchi in quella cittadina; non è chiaro se ci fosse un qualche coinvol-gimento dei Campello in tale rappresentazione.
Anche il »drammetto per musica« Amor vuol gioventù (20) di Paolo fu rappresentato in un teatro di casa Rospigliosi (quello situato nel palazzo romano o nelle terre di Zagarolo?), come è testimoniato da un sonetto dello stesso Paolo Campello, contenuto sempre nella raccolta (25), dal titolo »Al-la Sig.ra Anna Maddalena, virtuosa della / Sig.ra duchessa di Zagarolo che nell’operina / Amor vuol gioventù del Autore cantava l’aria / T’odio, ti a-mo«47. Da tale indicazione si desume che Amor vuol gioventù (20) fu scritta dopo il 1670, data del matrimonio della dama genovese Maria Camilla Pal-lavicini48 con Giovan Battista Rospigliosi. A mio parere, però, l’opera sa-rebbe nata molto più in là, negli ultimi anni del secolo, visto che è citata
45 I-Rvat, Vat. Lat. 13620, Inventario della libreria dell’Ecc.ma casa Rospigliosi e Pallavi-
cini fatto nell’anno MDCCXXXIII 1733, p. 36: »Drama intitolato Mal ha chi mal opra M.tto in quarto S.S.« e Vat. Lat. 13630, Indice delle due Librarie dell’Ecc.me Case Pal-lavicini, e Rospigliosi, f. 80: »Male ha chi male opera, Dramma, 4° mss. R [Rospigliosi] – [scudi] 30«, inventario del 1790.
46 I-Ra, Ms. Arcadia n. 21, f. 90, Lettera di Logisto indirizzata a Crescimbeni (f. 91v): »Mi trovo a Zagarolo, dove mio zio riceve tante gratie e favori da questi Sig.ri Pren.i, che a voluto anche me à presso. Domenica sera si farà l’Orsa indi se venite vi vedrò […] Saba-to ritorna in qua Mons. Baruchieri«.
47 F. ms. n. 76, p. 38. In indice: »Anna Madalena cantando l’Aria T’odio, ti amo/ Giovane della Sig.ra Duchessa Rospigliosi«. Su costola: »Poesie«; in: Inventario (d’ora in poi Inv.): »Raccolta di poesie, 1702, Paolo di Campello«. Alla stessa virtuosa fu dedicato al-tro sonetto »mentre in un’opera fingea di piangere« (idem, p. 46).
48 FRANCHI, Drammaturgia (v. nota 11), p. 886. La dama, cultrice e promotrice di attività musicali, morì a Roma nel 1714.
Il fondo dei Campello di Spoleto 101
come ben conosciuta – e quindi recente – ne La bellezza della volgar poesia di Crescimbeni, Dialogo VI49 (sulla commedia e le »sorte d’alterazioni che fanno i poeti delle cose«) del 1700. Nel dialogo citato intervenivano France-sco Maria Campello (Logisto Nemeo) e Malatesta Strinati (Licida Orcome-nio); Logisto non voleva per evidenti motivi di modestia esprimere un giu-dizio sullo zio Paolo, ma questi veniva definito dagli altri »il migliore tra i compositori dei drammi eroicogiocosi«.50 Amor vuol gioventù (20) voleva esaltare i valori della castità; prevedeva tre mutazioni di scene per atto.51
Ne La bellezza si nominavano anche altre opere di Paolo Campello, quali il già citato Pandolfo (16), Mario in Cartagine52 (18), e un altro in via di composizione sulla storia di Atanaide (che si sarebbe poi intitolato Il batte-simo di Atanaide [19]), tutte opere presenti nel nostro fondo che si presenta-no oggi in forma adespota. In particolare, credo che Il battesimo di Atanaide fosse stato scritto su commissione del cardinale, visto che il Campello (co-me già detto) era al servizio dello stesso almeno dal 1699.
Riguardo ad altre opere di Paolo che nel fondo spoletino si presentano adespote, il Campello della Spina cita Il Radamisto (17) (forse il dramma del 1696, dubbiamente attribuito al Pasquini53) e La gelosia non è buona
49 Giovanni Mario CRESCIMBENI, La Bellezza della volgar Poesia, Roma 1700, p. 142. 50 Ibidem. 51 A f. 3: »Antefatto. Il Drammetto suppone il famoso incendio del gran Tempio di Diana in
Efeso, dopo il quale si dispersero riandando per lo più alle proprie case le ministre di quello. Queste cingevano un cinto di pudicizia, al quale erano affisse alcune Leggi di quella Dea della Castità, che si vanno spiegando nell’Operetta. Il sopradetto Cinto era so-lito portarsi, e donarsi ad onor di Diana: così habbiamo in [fonte]«. A f.1: »Mutationi. Atto P.o: Bosco. / Androne di Casino di Villa con Porta in faccia / Stanza di Poristene. Bosco. Seguendo un cignale, che persevito urta lo stesso Alidoro, il quale cade tramorti-to. Atto 2°. Giardino / Stanza di Celinda / Boschetto con Ara, e simulacro di Giunone. Atto 3°. Cortile / Sala / Galleria pretiosa con specchi, stipetti, et altre ricchezze; con ve-duta in faccia della campagna.«
52 Mario in Cartagine (41) viene citato anche dal Campello della Spina come un dramma più che decoroso, dove l’azione procedeva in maniera chiara e dove si destava l’interesse dello spettatore; l’opera avrebbe potuto avere successo, soprattutto se coadiuvata da buo-ne scene e buona musica (cfr. CAMPELLO DELLA SPINA, Storia documentata [v. nota 1], p. 22).
53 Alberto IESUÈ, Pasquini, Bernardo, in: Dizionario Enciclopedico Universale della Musi-ca e dei Musicisti, Le Biografie, (d’ora in poi DEUMM–B), vol. V, 1988, p. 592, rappre-sentazione del 1696 non accertata. Pasquini aveva musicato anche un testo di cantata di Paolo Campello, come si dirà più avanti.
Teresa Chirico 102
guardiana (23) »dramma cittadino giocoso« che era, secondo lo stesso, di buon livello per la novità dell’intreccio e »facete sentenze satiriche«. Di quest’ultimo abbiamo più di una versione, una delle quali, credo, non per musica.54
E ancora nel fondo troviamo un dramma del quale non rimangono noti-zie, non datato: Il casino dell’antica Treja (24), che reca sul frontespizio »Di Paolo Campello che presta« di argomento comico. L’attribuzione al Campello è dubbia, visto che la grafìa non corrisponde a quella dell’arcade spoletino. Il testo, inoltre, reca ogni tanto delle frasi alquanto spinte;55 ciò contrasta vivamente con l’immagine di un letterato intento a ridare dignità al genere della commedia scrivendo drammi »eroicogiocosi«, come si defi-niscono nella citata opera del Crescimbeni. La dicitura del frontespizio sa-rebbe forse da ritenere come nota possessoria; non è però escluso che il te-sto fosse un prodotto ›segreto‹ del Campello, da non pubblicizzare, ovvia-mente, come propria opera.
Da attribuire a Paolo Campello è il »drammetto« adespoto Daliso (22), costituito da due soli personaggi, che si presenta con la scrittura dell’arcade spoletino con la segnalazione di fonti, indicazioni di regìa e di balli.56 Sopra il titolo compare, con diversa grafìa, la raccomandazione che il personaggio Daliso, contralto, avesse »le corde comode tra csolfaut e Csolfaut« e che la musica si potesse »cantare con gli stromenti e senza«.57 Evidentemente, il cantante che avrebbe dovuto interpretare la parte di Daliso aveva un’esten-sione vocale piuttosto limitata. Quelle segnalazioni, evidentemente rivolte al compositore che avrebbe dovuto musicare il testo, denunciano una commit-tenza attribuibile, a mio parere, al cardinale Ottoboni. Il Daliso era proba-bilmente destinato ad un teatro in miniatura, quale quello di burattini del cardinale.
Nella produzione di Paolo Campello, come già detto, è citato da Fulvio Leonio l’oratorio La Fede trionfante / Per l’Eresia soggiogata da S. Anto-nio / da Padova (25.8). Fu allestito scenicamente, come è dimostrato da
54 CAMPELLO DELLA SPINA, Storia documentata, p. 22. La versione non per musica è in F.
ms. N.S., cart. C, fasc. 4/5. 55 »Che vadan a farsi fottere«, f. s. n. 56 C.[3]: »Si pone a sonar cantando le seguenti arie«; c. [3v]: »Prende la cetra lasciata da
Celinda e si pone a cantare«. Fine del 2° atto: »Ballo di soldati e schiavi liberati«. 57 A f. 1, in alto.
Il fondo dei Campello di Spoleto 103
numerose indicazioni nel testo: esordisce infatti con una sinfonia che rap-presenta una tempesta di mare e »due cori di naviganti nella stessa tempe-sta«. Inoltre, alla fine del testo, il Campello aggiunse un’»Arietta per i Ma-rinari che partono« per la scena di commiato tra gli stessi e S. Antonio.58
Tale particolarità, invero molto rara per quel genere, ricorda l’oratorio Sant’Eustachio di Pietro Ottoboni, musicato da Flavio Carlo Lanciani, che ebbe allestimento scenico e balli alla Cancelleria il 26 febbraio 1690.59 È altamente probabile che anche la Fede trionfante fosse stato allestito con il patrocinio di Pietro Ottoboni; della sua rappresentazione in Cancelleria non ho trovato traccia, ma è probabile che l’oratorio fosse stato accolto in un’altra sede, ad esempio in un Collegio ›protetto‹ dall’Ottoboni. Inoltre, non è escluso che lo stesso oratorio fosse stato dato a Spoleto il 21 gennaio 1703 nella chiesa francescana di S. Simone60 (considerata ›familiare‹ dei Campello, sita accanto al loro palazzo), durante le celebrazioni per lo scam-pato pericolo dal terremoto del 14 gennaio dello stesso anno.61 L’oratorio allestito per tale celebrazione fu cantato da dodici musici, alcuni dei quali »valentissimi fatti venire da fuori« e durò fino alle due della notte, con una straordinaria presenza di popolo.62
Un oratorio adepoto, Niceta (27), sarebbe da attribuire a Paolo Campello in quanto si presenta nella seconda parte con la scrittura dell’arcade spoleti-no. Il testo si configura come una sorta di bozza, forse ancora da perfeziona- 58 F. ms. n. 76, pp. 252 e 235. 59 Gloria STAFFIERI, Colligite fragmenta: la vita musicale romana negli »Avvisi Marescotti«
(1683–1707), Lucca 1990, pp. 17, 232, 235, 247. L’oratorio fu replicato al Collegio Na-zareno nel 1694 (cfr. anche ID., L’Arcadia e il progetto drammaturgico di Pietro Ottobo-ni presentato nel Convegno Le Arti in gara. Roma nel Settecento [Roma 18 – 22 settem-bre 2000], p. 3, tav. 1, di prossima pubbl. Ringrazio vivamente l’autrice per avermi favo-rito la consultazione della relazione in questione).
60 LOPA, La vita musicale (v. nota 4), p. 148. Per gli allestimenti di oratori a S. Simone cfr. SARTORI, I libretti (v. nota 18), Indici, p. 175 che riporta quattro libretti tra il 1716 e il 1729, e LOPA, op. cit., pp. 171s., che riporta in più La caduta di Gezabele musicato da Domenico Balami, maestro della cattedrale di Spoleto e pubblicato a Spoleto nel 1739.
61 Nella stessa chiesa era stata esposta una parte del cranio di S. Antonio da Padova, con-cessa per l’occasione dalla principessa Olimpia Barberini Giustiniani. In S. Simone furo-no seppelliti i genitori di Paolo; i Campello vi avevano lo ius patronato, l’altare maggiore (da loro fatto splendidamente dorare e che fu poi distrutto) ed erano proprietari del gran-de organo. La reliquia fu accolta da una deputazione della quale faceva parte Paolo Cam-pello (cfr. CAMPELLO DELLA SPINA, Storia documentaria [v. nota 1], p. 29).
62 CAMPELLO DELLA SPINA, Storia documentaria, p. 29.
Teresa Chirico 104
re; reca molte correzioni (vedi ad esempio i registri vocali dei personaggi, più volte cambiati).
Un altro oratorio adespoto, che si presenta con grafìa sconosciuta, è at-tribuito a Paolo Campello nell’inventario del fondo omonimo. Si tratta di un Giuseppe (26).
Non siamo in grado, al momento, di datare le opere citate. Sappiamo pe-rò che dal 1703 in poi, a causa di un forte terremoto, Clemente XI proibì le rappresentazioni profane per cinque anni; tali proibizioni si inasprirono quando nel 1707 le truppe austriache del conte di Daun arrivarono alle porte di Roma. In conseguenza a tale situazione si incrementarono la produzione e l’allestimento di oratori sia a Spoleto63 che a Roma. A proposito di quel catastrofico evento, troviamo un sonetto di Paolo Campello contenuto nel-l’antologia (25): Le scosse de’ terremuoti ci insegnano a cantar cose mora-li.64
Più o meno a quell’epoca appartengono oratori che si presentano nell’an-tologia (28) adespoti e senza luogo di allestimento, alcuni dei quali sono scritti di pugno dell’arcade spoletino; non è però automatica l’attribuzione dei testi al Campello, poiché è probabile che lo stesso abbia solo copiato quelle opere.
Tra gli oratori in questione, La costanza vittoriosa (28.1) in particolare potrebbe essere un prodotto di Paolo Campello, visto che reca delle interes-santi notizie65 alla fine del testo, compatibili con le sue vicende biografiche.
63 Il terremoto a Spoleto impedì per molti anni le attività dell’Accademia degli Ottusi e del
teatro (cfr. LOPA, La vita musicale [v. nota 4], pp. 90s.). I libretti a stampa di oratori a Spoleto conosciuti sono pochissimi sino al primo ventennio del XVIII secolo. Per l’argo-mento cfr. Galliano CILIBERTI, Documenti per una storia dell’oratorio musicale a Spole-to nei secoli XVII–XVIII: una cronologia dai libretti, in: Spoletium XXXIII–XXXIV, 1992, pp. 83–86, e SARTORI, I libretti, Indici, p. 175.
64 F. ms. n. 76, p. 79. 65 F. [1]: »S. Giuliano M. Alessandrino era talmente maltrattato dalla Podagra che non
poteva ne’ partire ne’ stare in nessun luogo; fattosi […] portare in sedia da i servi s’offerse in tal modo al Giudice, uno de’ quali servi negò la Fede, l’altro per nome Euno stiede […] con S. Giuliano nella Confessione della Fede di Christo, tutti […] furono por-tati per tutta la città inumanamente frustandoli, e finalmente accesa una fornace […] fu-rono abruciati vivi.« Alla fine del testo: »Questi gloriosi santi vennero in cognitione del Auttore in Roma dove dimorava in tempo che il Pontefice Clemente Undecimo ne’ primi anni del suo Pontificato fece risarcire l’antichissima Chiesa in Campo Vaccino di S. Teodoro e dove il Sig.r Cardinale Spinola S. Cesareo genovese già pativa molto di po-
Il fondo dei Campello di Spoleto 105
Come si dice nelle citate note, l’autore dell’oratorio aveva conosciuto la storia dei santi Giuliano Alessandrino ed Euno nel periodo in cui lo stesso dimorava in Roma durante i primi anni del pontificato di Clemente XI, e in particolare quando lo stesso papa aveva ordinato il restauro della Chiesa di S. Teodoro »in Campo Vaccino« (attualmente esistente). Oggi sappiamo che il restauro fu ordinato nel 1702 e operato da Carlo Fontana. Nelle stesse note si nominava poi il »Baciccia« (il pittore Giovan Battista Gaulli) che aveva dipinto un quadro raffigurante S. Giuliano per conto del cardinale Spinola San Cesareo.66 In base a quanto detto, è possibile che l’oratorio La costanza vittoriosa (28.1) fosse stato scritto dal 1702 in poi; non sappiamo dove avesse trovato allestimento, se a Roma – forse in casa dello Spinola, situata in Campo Marzio, che ospitava oratori nei primissimi anni del XVIII secolo67 – o a Spoleto, visto che la raccolta citata (28) denuncia nella mag-gioranza dei casi allestimenti umbri. Ovviamente, è anche possibile che l’opera fosse stata data più volte e in più luoghi. Nella stessa antologia tro-viamo L’occisione di Abel (28.8) di Benedetto Pamphilj, musicato da Felice Mercuriali, che reca la dicitura: »da cantarsi nella Chiesa Nuova l’anno 1708«. L’opera era stata allestita a Roma da Pietro Ottoboni al Palazzo della Cancelleria nella Quaresima del 1708;68 ritengo che a distanza di poco tem-po L’occisione fosse stata nuovamente allestita nella Chiesa Nuova.
Gli altri oratori adespoti che si presentano con la grafìa di Paolo Campel-lo sono: Il Trionfo della Verginità (28.6), La Gloria dell’Umbria (28.9) dato a Spoleto, Il Trionfo della Divina Gratia (28.10). Di tali oratori non si tro-vano, al momento, altre notizie.
dagra et havendo gran avvocato detto S. Giuliano protettore de’ podagrosi, d.o Sig.r Car-dinale vi fece fare in detta chiesa in uno de laterali altari de’ 2 che sono il quadro ad ho-nor di detto santo nel atto che si presenta al giudice portato a lui dinanzi, come dice l’historia in una sedia a mano e dal [sic] quadro fu fatto dal famoso Baciccia pittore.«
66 Il cardinale era Giovan Battista, patrizio genovese, che fu governatore di Roma tra il 1691 e il 1695; morì a Roma il 19 marzo 1719 (cfr. FRANCHI, Drammaturgia [v. nota 11], p. 918). Oggi sappiamo che lo stesso quadro fu tolto dalla chiesa nel 1765. Alcuni oratori eseguiti in casa di Spinola non ebbero libretto a stampa (cfr. Francesco VALESIO, Diario di Roma, vol. I, Milano 1977, p. 566).
67 Laura CAIRO, Rappresentazioni sceniche nei palazzi della Roma settecentesca, in: Il teatro a Roma, (v. nota 21), vol. 2, pp. 783–791: 785.
68 Arnaldo MORELLI, Il »Theatro spirituale« (v. nota 27), p. 88, n. 104.
Teresa Chirico 106
Se l’attribuzione dei citati testi a Paolo Campello è incerta, è invece eviden-te che lo stesso si fosse procurato dei testi di oratori da fare allestire a Spole-to, in particolare a S. Simone. È il caso di Santa Clotilde (28.2), copiato da Paolo e dato il 13 giugno 1711 a S. Simone, come si segnala sul manoscrit-to: l’opera è da identificarsi nel testo di Giovan Battista Taroni, musicato da Flavio Carlo Lanciani e già, sembra, allestito a Roma nel 1700.69
Anche se altri oratori della stessa raccolta risultano di altra grafìa, è pro-babile che gli stessi fossero stati raccolti da Paolo sempre per allestimenti a sua cura. È il caso de L’Ape industriosa in S. Cecilia (28.3 e 28.5) su libret-to di Giovanni Nicolò Benedetti e musica di Quirino Colombani che – come risulta da una dicitura nel testo – fu cantato dai musici della città di Spoleto in cattedrale nel 1707.70
Dalle notizie riportate nel manoscritto di Santa Dimpna principessa d’Irlanda (28.4) su testo di Carlo Doni e musica di Pietro Jacopo Bacci, sappiamo che l’oratorio fu allestito sempre a San Simone il 5 maggio del 1711 e che circolò in Umbria e oltre, come è confermato da fonti a stampa.
71
È legittimo pensare – come già detto – che sia stato Paolo Campello a raccogliere tutti questi oratori nella stessa antologia, occupandosi, negli ul-timi anni della sua vita, di allestimenti di oratori a Spoleto. Infatti, altri testi di questo genere appartenenti al fondo spoletino furono copiati da Paolo: la Giuditta (29) detta »di Cambridge« di Antonio Ottoboni (probabilmente data nel marzo 1695)72 e Santa Beatrice d’Este (9).
69 Arnaldo MORELLI, La circolazione dell’oratorio italiano nel Seicento, in: Studi musicali
XXVI, 1997/1, pp. 105–128: 168, n. 159. Tale oratorio era probabilmente lo stesso dato nel 1700 a Roma con il titolo Le vittorie della fede in Clodoveo re di Francia e replicato a Perugia nell’oratorio di S. Filippo Neri il 22 novembre del 1704. La S. Clotilde aveva avuto un notevole successo a Bologna, dove vide vari allestimenti nel 1700, 1702, 1703, 1704. Lowell LINDGREN, Lanciani, Flavio Carlo, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians (d’ora in poi NG), a cura di Stanley Sadie, London 2001, vol. 14, pp. 206s. La Santa Clotilde (28.2) continuava dunque la tradizione di oratori a S. Simone per il giorno di S. Antonio da Padova.
70 L’oratorio era già stato dato a Perugia nel 1705 nell’Oratorio di S. Filippo Neri, (cfr. SARTORI, I libretti [v. nota 18], n. 2232).
71 Vedi quanto riportato nel ms. (28.4): dato a Trevi, Collegiata, il 28 gennaio 1708; a Spo-leto, Oratorio di S. Filippo Neri il 29 maggio 1712. Inoltre Perugia, Oratorio di S. Filippo Neri, 22 novembre 1707; Recanati, Sala Priorale 15 giugno 1708 (cfr. SARTORI, I libretti, risp. nn. 20807 e 20808).
72 STAFFIERI, Colligite fragmenta (v. nota 59), p. 251.
Il fondo dei Campello di Spoleto 107
Riguardo a cantate e generi affini scritti da Paolo, faccio riferimento alla già citata antologia (28), molto interessante, che racchiude anche sonetti dedica-ti a Benedetto Pamphilj, Carlo di Lorena, Clemente XI, nonchè »All’Organo impresa de Sig.ri Accademici di Livorno«, »Alla Signora Elena Passarelli famosa cantatrice Rappresentante l’Argia in Cipro«73, da identificarsi con l’Argìa in Cipro di Cesti, dedicata ad Alessandro Contarini e rappresentata a Venezia in occasione dell’abiura di Cristina di Svezia, nota per il virtuosi-smo vocale che caratterizzava la parte della protagonista.74
Alcuni sonetti dell’antologia (25) recano talvolta date, comprese tra l’ul-timo ventennio del XVII secolo e il 1710. Le cantate sono di varia lunghez-za con l’indicazione del da capo nelle arie. Citerò qui solo le cantate che recano l’autore della musica o nomi di personaggi dell’epoca nell’ordine di sistemazione dell’antologia; per le altre rimando all’Appendice.
Infedeltà in amore è doverosa“ (25.2) fu »posta in musica dal Sig.r Fre-schi«, da identificarsi con Giovan Domenico (1625–1710), autore di alcune cantate eseguite a Piazzola nel 1685.75
Altre furono musicate da Aurelio Paolini, come Tempesta Amorosa (25.3), Bacio (25.4) e Lontananza medicina d’Amore“ (25.6). Del Paolini nulla si sa; sarebbe probabilmente da identificarsi con un omonimo autore di sonate a tre.76
Particolarmente interessante è Sdegno Amoroso (25.7), cantata che reca il nome di Bernardo Pasquini77 ed è al momento sconosciuta.
Paolo Campello, non si sa in che data, scrisse una Serenata a tre / Primo e Secondo Amante et il Sonno / Fatta per la Sig.ra Principessa Pallavicini 73 F. ms. n. 76, risp. pp. 26, 32, 49, 43, 30, 34. Riguardo alla Passarelli, in indice: »detta la
Tiepola«. 74 Francesco BUSSI, Cesti, Antonio, in: DEUMM–B, vol. II, 1985, 183s. 75 Sub Voce in DEUMM–B, vol. III, 1986, p. 26. Le cantate, eseguite a Piazzola, sono
ritenute perdute. Per le attività musicali a Piazzola sul Brenta, il mecenatismo di Marco Contarini e l’ideale continuazione di tale mecenatismo in Pietro Ottoboni (entrambi pro-curatori di San Marco), vedi quanto detto da Mercedes VIALE FERRERO, Antonio e Pietro Ottoboni e alcuni melodrammi da loro ideati o promossi a Roma, in: Venezia e il melo-dramma nel Settecento, a cura di Maria Teresa Muraro, vol. I, Firenze 1978, p. 271–294: 281.
76 Angela LEPORE, La Sonata a tre in ambito corelliano, in: Intorno a Locatelli, Studi in occasione del tricentenario della nascita di Pietro Antonio Locatelli (1695–1764), a cura di Albert Dunning, Lucca 1995 (Speculum Musicae I), vol. I, p. 527–599: 596.
77 John HARPER e Lowell LINDGREN, Pasquini, Bernardo, in: NG, vol. 19, p. 189.
Teresa Chirico 108
(25.11); la principessa è a mio parere da identificarsi con la già citata Maria Camilla Pallavicini, moglie, dal 1670, di Giovan Battista Rospigliosi duca di Zagarolo. Poiché la Pallavicini viene definita in altri manoscritti come »duchessa di Zagarolo«, ritengo che la Serenata sia – anche di poco – ante-riore al matrimonio della stessa con Rospigliosi.
Per il 27 maggio 1675, data in cui Clemente X ordinò cardinale Galeazzo Marescotti78, fu evidentemente scritta la Cantata / Per l’Eminentissimo Sig.r Cardinale Marescotti tornando dalla / Nuntiatura di Spagna Fatto Cardina-le da N.S. / Papa Clemente Decimo (25.12). Fu musicata da Tommaso Tizi79 e comprendeva tre personaggi: Virtù, Honore, Roma. Il cardinale Galeazzo Marescotti, figlio di Sforza Vicino, fu anche vescovo di Tivoli; morì a Ro-ma nel 1726.80
Fu dedicata Alle glorie del Sig.r Cardinale Pietro Ottoboni (25.13) la cantata in cui intervengono due personaggi (Fama e Fortuna) e che potrem-mo datare al 1689, anno in cui inizia il cardinalato dell’Ottoboni, come la-scerebbe suggerire il contenuto del testo (Fama: »[…] Del giovinetto Piero / Spandi i meriti augusti / Suona mia tromba, e narra al mondo il vero […]«).
Forse per una riunione dell’Arcadia Paolo compose Fatti e non parole (25.14)81 a tre (Eurillo, Clori, Filli), che reca: La scena in Arcadia / Bosca-reccia. Non è l’unico caso di cantata scenica del fondo che fa riferimento all’Arcadia; si trovano affinità con un’altra cantata scenica a tre personaggi, La forza d’Amore (46.1), attribuibile a Pietro Ottoboni e con il dramma pa-storale Amore vince amore (53) di Logisto Nemeo (Francesco Maria Cam-pello) che riporta gli stessi personaggi della cantata di Paolo (Eurillo, Clori, Fille).
Tutti i testi82 per musica di Paolo Campello presenti nel fondo spoletino, tranne Male ha chi male opra (16), sono da considerarsi unica.
78 Hierarchia Catholica Medii et Recentoris Aevi, Patavii, a cura di Remigius RITZLER e
Pirminus SEFRIN, vol. V (1667–1730), Monaco 1952, p. 173. 79 Tale autore è presente nella raccolta »Aggiunta al Teatro spirituale […] Tomo 5°« del
1679 (cit. in MORELLI, Il »Theatro spirituale« [v. nota 27], p. 92, II). 80 FRANCHI, Drammaturgia (v. nota 11), p. 870; nel 1685 allo stesso, come vescovo di
Tivoli, furono dedicate alcune poesie liriche da parte del padre Gabriel Maria Meloncelli Barnabita (ibid. pp. 568s.).
81 Altra copia in F. ms. N.S., cart. B, fasc. 3/5. 82 Altri componimenti non per musica di Paolo, scritti per l’Arcadia, sono conservati in I-
Ra, Ms. Arcadia: n 7, f. 25; n. 8, f. 145; n. 9, ff. 14s.
Il fondo dei Campello di Spoleto 109
TESTI DI GIROLAMO GIGLI Nel fondo spoletino si trovano quattro testi accertati di Girolamo Gigli, e cioè Santa Geneviefa (29), Il Leone di Giuda ovvero Il Gioas (30.1), Giudit-ta (30.2) e La Dirindina (31).
L’opera più antica di quelle citate è il dramma Santa Geneviefa (29) che sappiamo fu rappresentato per la prima volta il 1 febbraio 1685 con musica di Giuseppe Fabbrini per l’inaugurazione del teatrino del Collegio Tolomei di Siena; il dramma ebbe un secondo allestimento, con uguale testo, a di-stanza di pochi giorni.83 Il libretto manoscritto è, per alcuni aspetti, diverso dalla versione a stampa dei due libretti, sia nel testo (ha addirittura un incipit diverso) che nei personaggi.84 Non è purtroppo al momento possibile stabili-re per quale occasione sia stata approntata la versione del fondo Campello.
Il secondo testo di Gigli in ordine di tempo è il dramma sacro Il Leone di Giuda ovvero Il Gioas (30.1), che fu pubblicato a Venezia nel 1704 insieme ad altre opere dello stesso autore.85 Il testo del fondo Campello reca una dedica a Leopoldo I d’Austria in data 25 dicembre 1696 da Siena. Da ciò che si dice nella dedica sembra che il dramma fosse stato commissionato dallo stesso imperatore;86 purtroppo non si accenna all’autore della musica. Il Leone di Giuda risentì probabilmente dell’influenza della Athalie di Raci-ne, scritta nel 1691.87 Non è escluso che il dramma sacro fosse stato allestito presso il Collegio Tolomei di Siena, dove lavorava l’autore.
83 Risp. SARTORI (v. nota 18), I libretti, n. 11508: Collegio Tolomei »nell’aprimento del
loro nuovo teatro«, libr. in I-Rc, Comm. 317, e SARTORI, I libretti, n. 11509, I-Rsc, G.CS.3.C.26; quest’ultimo libretto è contenuto in: Girolamo GIGLI, Poesie drammatiche 1700, Venezia e Padova, s. d.
84 Nelle versioni a stampa il fratello di Geneviefa si chiama Romildo invece che Eurindo; inoltre è presente Scuotemondo, mentre nella versione ms. si trovano Rogilda e Zamira.
85 Opere nuove del signor Girolamo Gigli, Accademico Acceso, cioè il Leone di Giuda in ombra, overo il Gioasso […], Venezia 1704.
86 A p. [1]: »Comparisce à piè del vostro soglio Augustissimo Serenissimo il principe Gio-asso […] tanta grazia gli toglie in questa sua seconda comparsa l’esser nato di padre così oscuro. […] la mi natural fiacchezza non mi permette di sollevarmi sì con l’ambitione di l’aver l’obbedito, che più non senta arrestarmi dalla confusione d’haver male obbedito […]. Siena 25 dicembre 1696, Umilissimo Girolamo Gigli.«
87 Vedi quanto detto in Arnaldo MORELLI, Oratorii ovvero sacre musicali tragedie? in: Mozart, Padova e la Betulia liberata, a cura di Paolo Pinamonti, Firenze 1991, pp. 285–
Teresa Chirico 110
Altro libretto è la Giuditta (30.2), dedicato alla duchessa Rospigliosi di Za-garolo, cioè Maria Camilla Pallavicini Rospigliosi, il 22 maggio 1699. L’oratorio fu dato per la prima volta a Firenze tra il 1692 e il 169488 e a Sie-na due volte con musica di Giuseppe Fabbrini: la prima nel 1693 con dedica a Maria Lucrezia e Maria Candida Rospigliosi, e la seconda nel 1697, dedi-cata a Ottavio Grimaldi.89
Molto interessante è il testo de La Dirindina (31)90, opera musicata da Domenico Scarlatti, formata da due intermezzi che avrebbero dovuto essere rappresentati nel Carnevale 1715 presso il teatro Capranica di Roma con l’opera seria Ambleto dello stesso compositore, su testo di Apostolo Zeno e Pietro Pariati. Come è noto, però, La Dirindina non fu rappresentata perché bloccata dalla censura. La Dirindina (31) del fondo Campello si avvicina particolarmente alle prime versioni del testo: lo studio sulle varianti mette in luce differenze significative rispetto ai testi conosciuti.91
Un caso che pone alcuni dubbi è La pugna d’Amore contro Amore (32), che viene descritto come un oratorio a tre ne La madre de’ i Maccabei, tito-lo, quest’ultimo, che richiama l’omonimo libretto del Gigli dato a Siena presso il Collegio Tolomei nel 1688 con musica di Giuseppe Fabbrini. Lo stesso oratorio fu dato a Roma tra il 1701 e il 1703 nell’Oratorio di San Fi-lippo Neri con musica di Felice Mercuriali, all’epoca organista della Chiesa
287, sull’influsso che le tragedie di Racine e Corneille avrebbero avuto su autori italiani anche successivi come Metastasio.
88 MORELLI, La circolazione (v. nota 69), p. 145 n. 55, Firenze 1692–1694, Compagnia dell’Arcangiolo Raffaello detta La Scala.
89 SARTORI, I libretti (v. nota 18), risp. n. 12113, Siena 1693, ded. a M. Lucrezia e M. Can-dida Rospigliosi e n. 12117, Siena 1697, ded. Ottavio Grimaldi. Da aggiungere che sem-pre nel 1699 e nel teatro della Rospigliosi, era stata rappresentata l’opera L’amore fra gli impossibili di Gigli, con musica di tale Carlo Campello; non ho però prove che il Cam-pello in questione appartenesse alla nostra famiglia spoletina.
90 Su tale testo del fondo Campello, vedi Teresa CHIRICO, Uno sconosciuto libretto de »La Dirindina«, in: CIDIM 7, 2002 (Le fonti musicali in Italia), pp. 19–29. Per le varianti del testo citate e le vicende, non sempre chiare, delle rappresentazioni de La Dirindina, Do-menico SCARLATTI, La Dirindina, ed. critica a cura di Francesco Degrada, Milano 1985, risp. pp. 132 e IXss.
91 CHIRICO, op. cit., pp. 21s. Ad esempio, nel primo intermezzo, all’inizio, quando Don Carissimo tenta di svilire la figura del castrato Liscione agli occhi di Dirindina: tra i versi »Non va al gisolreutte« e »Gli puzzan di castrato le mani, il viso, il fiato« troviamo un aggiunta a lato del testo, f. 2 del libretto: »Ha di scimia il mostaccio, voce di gallinac-cio«, assente in altri testi.
Il fondo dei Campello di Spoleto 111
Nuova;92 è possibile che La pugna d’Amore contro Amore (32) fosse stato allestito in quell’occasione. A mio parere, potrebbe trattarsi di un prodotto di Pietro Ottoboni, come si dirà nel paragrafo a lui dedicato. TESTI DI ANTONIO OTTOBONI Nel fondo Campello troviamo due opere di Antonio Ottoboni: si tratta del noto oratorio Giuditta (33), detta »La Giuditta di Cambridge«, che si pre-senta in forma adespota, e di uno sconosciuto Heraclio (34), che reca il no-me dell’autore, attualmente da considerare unicum.
La Giuditta (33) fu musicata da Alessandro Scarlatti93 e rappresentata a Roma, probabilmente per la prima volta il 13 marzo del 1695 alla Cancelle-ria.94 La copia del fondo spoletino risulta, come già detto, di mano di Paolo Campello.
»Heraclio / Imperatore d’Oriente Tragedia / Tradotta da Pietro Cornelio / et / Accomodata all’uso delli Teatri / Musicali di Venezia / dal N.H.M. / Antonio Otthoboni Cavaliere e / Procurator di S. Marco / L’anno MDCCVIII (34)« è completamente sconosciuto. Il libretto trovava un pre-cedente nell’omonima tragedia data al Clementino di Roma nel Carnevale del 1699 e dedicata al protettore dello stesso Collegio, il cardinale Benedet-to Pamphilj;95 l’Heraclio di Ottoboni ricalcava l’opera citata. Antonio Otto-
92 Cfr. i libretti de La madre de’ Maccabei in I–Rc, risp. vol. misc. 2488/16, Siena 1688, e
Vol. misc. 1335/10, Roma, s. d. [1701–1703], per datazione MORELLI, La circolazione (v. nota 69), p. 149, n. 76.
93 Michael TALBOT – Colin TIMMS, Music and poetry of Antonio Ottoboni (1646–1720) in: Händel e gli Scarlatti a Roma, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Roma, 12–14 giugno 1985, a cura di Nino Pirrotta e Agostino Ziino, Firenze 1987, pp. 367–438: 401.
94 L’oratorio fu replicato il 16 dello stesso mese presso la casa della marchesa Buongiovan-ni e il 10 marzo 1697 in casa Vidman con musici e sonatori del cardinale Ottoboni (STAFFIERI, Colligite Fragmenta [v. nota 59], pp. 251 e 259).
95 Libretto in I–Rn 35.10.H.12.5: Eraclio / Tragedia / Di / M. Pietro Cornelio / Tradotta, e rappresentata Dà Signori Cavalieri / Del Collegio Clementino / in Roma / nel Carnevale 1699 / Dedicata dà Medesimi / All’Eminentiss. E Reverendiss. Sig. / Card. Benedetto Panfilio / Protettore dello stesso Collegio, Roma, Chracas, 1699 incipit: »Pur troppo è ve-ro« (cit. FRANCHI, Drammaturgia [v. nota 11], p. 740, dove si dice che la libera traduzio-ne anonima era del padre Filippo Merelli). L’opera di Antonio Ottoboni precedeva a sua volta un altro Eraclio del 1712 su testo del Bernardoni con musiche di Francesco Gaspa-
Teresa Chirico 112
boni dice ›modestamente‹ di avere prodotto un esemplare »imperfetto« da un esemplare »perfettissimo«, e che il traduttore meritava »di esser compati-to, perché compone per semplice suo diletto, et il Compositore s’è già ac-quistato l’applauso e l’ammirazione di tutta la letteraria Repubblica. Basta il nome di Pietro Cornelio per lodar almeno il buon gusto di chi tradusse […]«96. È noto che Antonio Ottoboni avesse tradotto dal francese alcune tragedie, come risulta nella voce a lui relativa stesa da Campello in Notizie istoriche degli Arcadi morti; 97 tra quelle ci fu evidentemente anche l’Héraclius.
Purtroppo il nome del compositore dell’Heraclio veneziano è sconosciu-to. Nel testo sono frequenti le indicazioni delle arie, dei ›da capo‹, dei duetti e terzetti; alcune parti del testo che andavano declamate furono sottolineate. Le arie sono spesso segnate al lato del testo con un tratto di matita marro-ne.98
Da notare che l’Heraclio è in cinque atti. Tale sistemazione, diversa da quella in tre atti dell’usuale opera coeva italiana, potrebbe far pensare all’influenza della struttura della tragédie-lyrique, considerata anche l’attenzione degli intellettuali italiani dell’epoca nei confronti del teatro francese (riguardo alla sistemazione in cinque atti ritornerò più avanti nella trattazione di opere di Pietro Ottoboni). L’argomento sarebbe meritevole di una più ampia riflessione e rientrerebbe in un’indagine approfondita sullo sperimentalismo delle forme teatrali degli Ottoboni che purtroppo non può trovare spazio in questa sede. Mi limiterò a dire che da tale sperimentali-smo – che affondava le radici nel fertile terreno del mecenatismo e creatività di quella famiglia – nacquero evidentemente dei modelli che in gran parte non sarebbero sopravvissuti agli stessi autori che li avevano creati.
rini e del Pollaroli, forse rappresentato al Palazzo della Cancelleria (cfr. VIALE FERRERO, Antonio e Pietro Ottoboni [v. nota 75], p. 276).
96 A f. 2. 97 CRESCIMBENI, Notizie istoriche (v. nota 6), pp. 164–167. Che il Campello abbia steso la
voce in questione è stato messo in rilievo in TALBOT – TIMMS, Music and poetry (v. no-ta 93), p. 369.
98 F. ms. n. 105, cfr. ad es. arie e da capo: ff. [5v], [12 e 12v], [15]; a due ff. [10v].
Il fondo dei Campello di Spoleto 113
I LIBRETTI DI PIETRO OTTOBONI Presagio di felicità nell’entrare il nuovo anno 1699, sotto i faustissimi auspici dell’Em.mo Sig.r Card. Pietro Ottoboni
Apre à l’anno novello uscio d’argento di Pietro il nome à l’Iperboreo, al Moro; e nascerà con lucido portento da secoli di ferro, un anno d’oro. […]” Paolo Campello99 A te, che sì d’Arcadia semideo, Dell’Adria honore, e gloria de lo Munno, Uneco de vertute ò Gran Crateo. […][Giorgio Gizzarone?]100
L’archivio Campello ospita molte opere rarissime di Pietro Ottoboni,
101 sia
complete che in abbozzo; sembra che in passato fosse presente anche La Statira, attualmente irreperibile.102 I testi si presentano tutti in forma ade-spota; alcuni, a un confronto con autografi ottoboniani,103 risultano di pugno del cardinale. Di alcune di quelle opere sopravvivono le relative fonti a stampa; altri testi sono noti ma ritenuti perduti, altri assolutamente scono-sciuti ma attribuibili al cardinale. Inoltre, Ottoboni rimaneggiò testi di altri autori. Cito qui di seguito sinteticamente tali opere:
Testi dei quali riamangono oggi i libretti a stampa: Costantino Pio (38) (mutilo) e Teodosio il giovane (39).
Opere note, ritenute perdute: Adonia (35.10), Adonia (36) (mutilo), L’amor eroico frà Pastori (37), il Dialogo tra Amor Divino e la Fede (47) (le ultime due, a mio parere, autografe).
99 F. ms. 76, f. 43.
100 F. ms. 40, f. 51. Giorgio Gizzarone da Napoli, in Arcadia Oratino Boreatico (poi Evoe-tico), arcidiacono di Boiano, fu autore in Arcadia di diversi componimenti in napoleta-no (v. ad es. I-Ra, Ms. Arcadia, n. 7, f. 96, Il cimento).
101 Vedi a proposito della produzione di Pietro Ottoboni il già cit. interessante contributo di STAFFIERI, L’Arcadia (v. nota 59).
102 Cfr. Inventario nel quale compare l’opera in questione, F. ms. N.S., cart. C, s. n. 103 Testi autografi conservati in I-Rvat, Ottob. Lat. N. 2227: L’amante del suo nemico del
1698 e lettere di Pietro Ottoboni in Vat. Lat. 12190, in particolare ff. 214s. (lettera del 19 giugno 1691).
Teresa Chirico 114
Opere sconosciute e dubbie: la tragedia con parti in musica La Croce ricu-perata (45), l’oratorio La pugna d’Amore contro Amore (32), la cantata sce-nica La forza d’Amore (46.1), le opere La contessa di Megara (41), Climene ovvero Nell’incostanza la fede (40), Amore è sempre amore (43).
Opera rimaneggiata probabilmente da Pietro Ottoboni, a mio parere au-tografa: Il martirio de’ Santi Abundio prete Abundatio diacono, Marciano, e Giovanni (2) di Ottavio Tronsarelli.
Molti di questi libretti costituiscono testimonianze preziose per le indica-zioni di regìa, macchine sceniche, strumenti musicali. Lo studio di tali opere segue, per quanto è possibile, un’esposizione di tipo cronologico. ADONIA Un’opera ritenuta fino a questo momento perduta è Adonia, definita »trage-dia sacra« ne La bellezza della volgar poesia di Crescimbeni104 e »dramma per musica« nell’opera Della storia e della ragione d’ogni poesia di France-sco Saverio Quadrio, pubblicata nel 1744;105 anche il Morei ne parla come di tragedia che fu letta al cospetto dei primi personaggi di Roma.106
Ne La bellezza della volgar poesia, Adonia è citata a proposito della pos-sibilità di ricavare una tragedia da un testo, in questo caso il terzo Libro dei Re dalle Sacre Scritture, dove l’azione non si compia nell’arco di una gior-nata. Dopo lunghe discussioni, si arrivava alla conclusione che le unità ari-stoteliche potevano communque essere rispettate grazie alla licenza poetica di ridurre tutta l’azione in un limitato arco di tempo. Da notare che, tra colo-ro che conducevano il dialogo, c’era Logisto Nemeo, il quale dichiarava: »abbiam qui fatto onorata menzione di tal nobilissima tragedia [Adonia], la quale (come v’è noto) io ò avuto l’onore di veder nascere, e perfezionare […]«. È questa una testimonianza preziosa di come Francesco Maria Cam-pello fosse vicino al cardinale durante la gestazione dell’opera; è anche
104 CRESCIMBENI, La Bellezza (v. nota 49), Tomo V, Dialogo V, p. 126. 105 QUADRIO, Della storia ,vol. III, parte II, Dist. IV, p. 484. Mercedes Viale Ferrero la
identifica in base ai personaggi (cfr. VIALE FERRERO, Antonio e Pietro Ottoboni [v. no-ta 75], pp. 274, 289, 294).
106 Michele Giuseppe MOREI, Memorie istoriche dell’adunanza degli Arcadi, Roma 1761, p. 236.
Il fondo dei Campello di Spoleto 115
plausibile che Ottoboni si fosse avvalso dei consigli dell’avvocato spoletino per le sue creazioni letterarie.
C’è da dire, a questo punto, che nel fondo Campello sono presenti addi-rittura due testi sul soggetto in questione, adespoti e senza titolo (che chia-merò entrambi, per convenzione, Adonia), il (35.10) e il (36), basati entram-bi sulla vicenda della contesa tra Adonia e Salomone per la successione al trono di Davide. I testi sono però diversi tra di loro; alcuni personaggi va-riano.
Il testo (35.10) fa parte di un’antologia di chiara provenienza ottoboniana che raccoglie oratori (la Bersabea di Lulier su testo di Brugueres, La strage degli innocenti di Rospigliosi), la tragedia sacra Jefte »in forma d’oratorio« del Pollarolo su testo di Frigimelica Roberti, nonchè sette cantate (alcune su testo di De Totis, due musicate da Alessandro Scarlatti, una da Pasquini).
Questo testo di Adoni fu scritto per essere totalmente musicato, come è dimostrato nel testo dalla distinzione metrica in parti per arie e per recitativi. È in cinque atti, con indicazioni di regìa, cori, balli, e parti strumentali.
Il secondo testo citato (36) non è per musica; è in endecasillabi con in-termezzi in musica. Consta di una bozza mutila, smembrata e molto dan-neggiata, nonché di una ‘bella copia’ di tutta l’opera. Quest’ultima è in di-screte condizioni per i primi quattro atti (un fascicolo per ogni atto), mentre l’ultimo atto è mutilo, a fogli sciolti e deturpato dal fuoco; tutto il testo ri-sente dei danni dell’umidità. Questo manoscritto reca, come di consueto nelle opere del cardinale,107 delle annotazioni a margine che suggeriscono movimenti scenici, macchine, strumenti musicali e altro. Quel che rimane della bozza spesso non coincide con i versi della ›bella copia‹. È evidente che la tragedia fu più volte rimaneggiata.
Nello stesso fascicolo è conservato un altro manoscritto108 di diversa gra-fìa (sul primo foglio, in alto a sinistra, il nome »Menzini«) che riporta alcuni versi della bozza di Adonia e che propone delle correzioni che vengono spesso accolte nella ›bella copia‹; anch’esso è a fogli sparsi e danneggiato dal fuoco. Tale manoscritto è da attribuire a Benedetto Menzini (1646–1704), sacerdote, professore di eloquenza e poeta di origine fiorentina, noto
107 Per gli autografi della Statira e del Colombo cfr. STAFFIERI, L’Arcadia (v. nota 59),
p. 13, nota 30. 108 F. ms. N.S., cart. A, fasc.1/3, 10 cc. (9, I).
Teresa Chirico 116
per le sue istanze letterarie di rinnovamento in senso antibarocco. Menzini si era trasferito a Roma dal 1685 come segretario del cardinale di Polonia: scrisse nel 1680 Poesie liriche e le sue Satire uscirono postume nel 1718. Negli ultimi anni della sua vita fu accolto nella Badia di S. Paolo ad Albano, favorito »dalla generosa munificenza del Cardinale Pietro Ottoboni Vice-cancelliere«109. Il testo di Adonia (36) fu evidentemente sottoposto al giudi-zio di questo scrittore, come è testimoniato dalle righe conclusive del mano-scritto.110
A questo punto sono necessarie alcune considerazioni sui due testi di Adonia:
Il testo (35.10) è in cinque atti, con indicazioni di regìa, cori, balli, e parti strumentali. Tale testo (come già detto) fu scritto per essere totalmente mu-sicato, come è dimostrato dalla distinzione metrica in parti per arie e per recitativi.
Credo che questo Adonia (35.10) sia da identificare in un omonimo testo del 1695 citato in una nota di spese di casa Ottoboni del 25 novembre di quell’anno, a firma di Arcangelo Corelli, i cui personaggi corrispondono completamente con quelli del testo (35.10); l’autore del libretto non è di-chiarato. L’Adonia citata nelle spese viene definita come »L’Opera del Sig.r Pollarolo mandata da Venezia […]111« e sembra fosse stata messa totalmen-te in musica. Da tener presente che L’Adonia (35.10) fa parte di un’antolo-
109 CRESCIMBENI, Notizie istoriche (v. nota 6), I tomo, pp. 112ss., voce Benedetto Menzini. 110 »Or le cose che ho dette qui, forse erronee, e non confacevoli al fino giudicio di chi le
leggerà, io prego che sien compatite; che io non posso prometter di me se non una buo-na volontà, et un animo dispostissimo ora e sempre, ad ubbidire a chi con tanta genti-lezza ha voluto onorarmi de’ suoi comandi«, F ms. N.S., cart. A, fasc. 1/3, f. [8]. Inte-ressante anche un’osservazione nel »Poscritto«, f. [7v]: »non ho molta pratica dei lessi-ci, e Vocabolari, che per me i librari se gli posson friggere. Perché quando nello scrive-re io imbatto in qualche voce della quale io abbia dubbio, subito la lascio, e ne piglio un’altra; senza andar a perdere il tempo in rifrugare se stia bene o male«.
111 I-Rvat, Comp. Ottoboni, vol. 31, fasc. 62, f.s.n. [171], 25 nov. 1695: »L’opera del Sig.r Pollaroli mandata di Venetia e cavate tutte le parti. Prologo f. 5, Bersabea 10 ½, Ado-nia 11, Abisaghe 10 ½, Rosmada 6, Gionata 5 ½, Davide 5, Salomone 4, Natano 7 ½, Violini 22, Viole P.e 10, Viole 2 e 10. In tutto sono fogli trecentoquaranta importa à un giulio il foglio scudi trentaquattro. -34- Arcangelo Corelli« (cit. parzialmente in Maria Letizia VOLPICELLI, Il Teatro del cardinale Ottoboni al Palazzo della Cancelleria, in: Il teatro a Roma nel Settecento [v. nota 21], vol. 2, pp. 681–782: 710).
Il fondo dei Campello di Spoleto 117
gia in cui si trova un altro testo, Jefte (35.2) musicata anch’esso dal Pollaro-lo.
A mio parere, tale Adonia fu allestita in Cancelleria nei giorni intorno a Natale 1695 come »commedia spirituale con pupazzi«112.
L’Adonia (36) tragedia in endecasillabi con parti in musica, corrisponde-rebbe invece alla »Tragedia di Salomone« citata nelle spese di Casa Ottobo-ni a settembre del 1699 per la quale furono approntati cinque libri di musi-ca.113
In Dell’Istoria della Volgar Poesia, il Crescimbeni scriveva che la trage-dia, in cinque atti, era stata musicata da »[…] cinque de’ migliori Professori, che oggi abbia l’Italia, avendo ciascuno messo sotto le note uno de’ cinque atti, né quali ella è divisa […]«114. Il Crescimbeni si sarebbe forse così rife-rito, oltre che agli intermezzi, anche a un prologo o a una conclusione in musica; oggi possiamo solo fare delle ipotesi riguardo ai compositori cui Ottoboni affidò tale Adoni. La tragedia fu allestita probabilmente nel Palaz-zo della Cancelleria, non sappiamo se anche questa con pupazzi.
112 I-Rvat, Ottob. Lat. 3359, Avvisi di Roma, f. 85 v. 113 I-Rvat, Comp. Ottoboni, vol. 32, n. int. 36, ff. inserti n. 3, risp.: 1) »A dì 22 settembre 1699 cop. 12 di Tragedia intitolata l’Adonia dell’Ecc.mo
Sig.r Card. le Ottoboni, facciate duecentoquarantacinque per ciascuna copia sono in tutto s. 2940. Le quali a ragione di quatrini sette la facciata importano s. 4116 […] Se-bastiano Martini […]«.
2) »Io infr.tto ho ricevuto dall’E.mo Otthoboni per le mani del Sig.r Gregorio Portij scudi uno, e b. 50 m.a., sono per mia ricognitione d’havere copiato il quarto e quinto atto della Commedia intitolata l’Adonia tragedia per servitio di S.E. consistenti detti Atti in facciate Cento Sessanta in fede – q.to di 23 sett.re 1699
Per 1.50 Gio. Paolo Anguilla m° pp. … […]« 3) »Io infr.o ho rivevuto dal S.r Gregorio Portij Comp.e dell’E.mo e R.mo S. Card.
Ottoboni scudi tre moneta sono copia in stampatella del quarto, e quinto atto della A-donia copiato per servitio di S. E.
In Fede q.to dì 22 7bre 1699 Dom.co Falisi [?]« VOLPICELLI, op. cit., pp. 731s.: 731: »[…] per copie di dive parti della tragedia di Sa-
lomone […]«; p. 732: »[…] a 12 Settre cartoni fini n. 12 per legare cinque libri di Mu-sica della Tragedia«.
114 Giovanni Mario CRESCIMBENI, Dell’Istoria e della ragione della Volgar Poesia, Vene-zia, 1730, I, p. 296.
Teresa Chirico 118
Evidentemente il cardinale scrisse un primo testo di Adonia per musica nel 1695 e un secondo non per musica con intermezzi musicati nel 1699; d’altro canto, la ripresa degli stessi soggetti era consuetudine presso molti letterati. L’esistenza di due opere di genere diverso sullo stesso soggetto spiega an-che il perché delle diverse definizioni già citate del Crescimbeni (»tragedia sacra«) e del Quadrio (»dramma per musica«), che trovano corrispondenza nei conti citati di Casa Ottoboni.
Mi limiterò a questo punto a qualche segnalazione sul testo di Adonia (36), che reca molte interessanti notizie sull’allestimento.
Il primo atto, per diverse pagine, è esclusivamente in endecasillabi; non è possibile, per questo motivo, che tale testo fosse stato scritto per essere mu-sicato, mancando l’alternanza tra versi metricamente differenti. Vi si trova-no quattro intermezzi e, come già detto, macchine teatrali.115 Il testo reca diverse note di regìa, come ad esempio nella prima scena del terzo atto: »Resta la mutatione dell’intermezzo. Abisaghe in abito scomposto correndo verso Adonia che ancora sta sopra la macchina«. Subito dopo, Adonia scen-de dalla stessa macchina che rappresenta il proprio trionfo regale, richiama-to dalle acclamazioni del popolo a Salomone e allora »Si sente di dentro
115 »Primo intermezzo. Dove si vede il tabernacolo, che custodisce l’Ara. Campagna spa-
tiosa sotto il colle di Sion, con apparato di solenne sacrificio, e gran trono per David. Coro di Sacerdoti e Leviti d’intorno all’Arca. Coro di Popolo e coro di Vergini assi-stenti al sacrificio, che cantano, ballano, e spargono di fiori le vittime. David sul trono e Natan«. »Tutti i cori insieme«, »Una del coro delle vergini«, »Tutto il coro delle ver-gini replica la medesima aria ballando«.
»Secondo intermezzo. Campo d’Adonia schierato nelle vicinanze di Gerusalemme. Adonia vestito alla reale sopra gran machina militare in guisa di carro trionfale che à passo lento si avanza preceduto da Joab Generale dell’esercito. Coro di soldati che ac-compagnano col canto, ballo e giuochi la solenne pompa«.
»Terzo intermezzo. Campagna presso il fonte di Sion con altari accesi, e vittime pacifiche per l’assuntione al trono di Salomone in lontananza. Coro di popolo festante, che attende il solenne arrivo di Salomone«. »Coro, Uno del Coro«, »Coro«. »Preceduto da numeroso corteggio, al suono di trombe, accompagnato da Natan, Sadoc, e altri sa-cerdoti, e Leviti, comparisce a cavallo Salomone, che fermandosi nel mezzo alle turbe numerose riceve i tributi del Regno, et il giuramento di fedeltà del popolo«, »Coro«, »Uno del Coro«.
»Quarto intermezzo. Doppo soave concerto di Stromenti, che devono accompagna-re il sonno di Salomone, si aprirà il Cielo, e scenderà gran machina […] aperta farà ve-dere varij genij celesti disposti sopra nubi luminose. Machina del giardino, et in essa Salomone che dorme.« »Coro di geni«, »Un genio solo«, »Tutto il coro«.
Il fondo dei Campello di Spoleto 119
suono di trombe e l’esercito si pone in disordine, rompendosi la macchina in più parti«. La distruzione della macchina simboleggia la distruzione dello stesso Adonia e dunque l’essenza stessa della sconfitta. Il quarto intermezzo si conclude con l’incoronazione di Salomone, suggellata dal canto di un Genio che si alterna al Coro.
Una notevole similitudine si nota tra la macchina del quarto intermezzo che viene calata dal cielo, luminosa, dove si collocavano i geni celesti, e un’altra macchina di uno spettacolo ottoboniano molto più tardo (1728) alla Cancelleria per il Componimento drammatico per la festività del Natale, in cui ricomparivano le nuvole, i geni celesti e una reggia trasparente.116
Riguardo alla sistemazione in cinque atti dei due Adoni mi riferisco a quanto già detto a proposito dell’ Heraclio (34) di Antonio Ottoboni. Da notare in questo senso la similitudine tra Adoni (36), e l’adespota La Croce ricuperata (45) – molto probabilmente anch’essa opera dello stesso cardina-le – entrambe tragedie con parti in musica. L’AMORE EROICO FRÀ PASTORI L’Amore eroico frà Pastori / Favola pastorale / Per / Musica / Per / l’Anno 1696 / Dedicata alli Signori Accademici dell’Arcadia (37), fu rappresentata a carnevale117 di quell’anno presso il Palazzo della Cancelleria; che mi risul-ti, l’esemplare conservato a Spoleto è l’unico sopravvissuto.118 Il libretto,
116 VIALE FERRERO, Antonio e Pietro Ottoboni (v. nota 75), p. 285, nota 49. 117 STAFFIERI, Colligite fragmenta (v. nota 59), p. 124, avviso del 10 marzo 1696: »[…] è
stata molto piaciuta l’opera de burattini fatta rappresentare dal cardinale Ottoboni nel palazzo della Cancelleria con l’invito di cardinali, cavalieri e dame, havendo fatto di-spensare copiosi rinfreschi.«
118 Hans Joachim MARX, Die Musik am Hofe Pietro Kardinal Ottobonis unter Arcangelo Corelli, in: Analecta musicologica 5, 1968, pp. 104–121, trad. La musica alla corte del cardinale Pietro Ottoboni all’epoca di Corelli, in: La musica e il mondo. Mecenatismo e committenza musicale in Italia tra Quattro e Settecento a cura di Claudio Annibaldi, Bologna 1993, pp. 85–107, in part. p. 99, nota 74, si segnala il libretto ms. in I-Rvat, Ottob. Lat. 3361; in realtà il testo non è presente nel vol. segnalato. Neanche una ricer-ca nell’Inventario dei Codici Ottoboniani Latini (387, 2 voll.) ha dato esito positivo. Sempre in Marx (Die Musik am Hofe Pietro Kardinal Ottobonis, p. 99, nota 74) si cita-no le spese per copiatura dell’opera in I-Rvat, Comp. Ottoboni, vol. 34, int. 37.
Teresa Chirico 120
che non segnala autore, è sicuramente autografo119 e in buone condizioni di conservazione. Nel testo si trovano numerose correzioni, annotazioni e ag-giunte (a volte di altra mano) apportate spesso con l’ausilio di piccoli pezzi di carta incollati sulle pagine.
L’Amore eroico, come si legge in Rime degli Arcadi e come risulta nel libretto, fu dedicata all’Arcadia; l’Accademia ringraziò con l’egloga Vaga Dorinda, nella quale si esaltava il valore della favola e della musica, che con i suoi strumenti aveva avuto il potere di muovere a piacimento gli affet-ti: »Altro, che il suono di sampogne e pive«120. Per l’occasione, il cardinale aveva fatto apporre sopra l’arco di proscenio del teatro non il proprio stem-ma gentilizio, ma la siringa, insegna dell’adunanza degli Arcadi.121 Come si legge in un’egloga di Silvio Stampiglia, il teatro era pieno di meraviglie, e sul palcoscenico pendeva un sipario dorato.122
L’opera fu rappresentata »col mezzo di bellissime figurine, che con mi-rabile artifizio operavano al naturale«123. Si trattava di marionette prestate da Filippo Acciaioli; alcune furono fatte a spese di Ottoboni.124
L’Amore eroico non fu, d’altronde, l’unico caso di rappresentazione in Cancelleria con l’ausilio dei »popazzi«.125 In occasione della prima del-l’Amor eroico si distribuì il sonetto a stampa di un anonimo »Accademico
119 Confronto effettuato con testi autografi conservati presso I-Rvat, Ottob. Lat. 2227,
L’amante del suo nemico del 1698, e lettere di Pietro Ottoboni in Vat. Lat. 12190. 120 Rime degli Arcadi, II, Roma, de’ Rossi, 1716, pp. 381s., cit. anche in Fabrizio DELLA
SETA, La musica in Arcadia al tempo di Corelli, in: Nuovissimi studi corelliani, Atti del Terzo Congresso Internazionale, Fusignano 4–7 settembre 1980, a cura di Sergio Durante e Pierluigi Petrobelli, Quaderni della Rivista italiana di musicologia 7, Firenze 1982, p. 123–148: 135.
121 MOREI, Memorie istoriche (v. nota 106), p. 238. A proposito di quest’evento e per la sua valenza sociale (cfr. Gerardo GUCCINI, Teatro e società nel Bosco Parrasio, in: Il teatro a Roma [v. nota 21], vol. 1, pp. 445–486: 447s.).
122 Rime degli Arcadi, II, pp. 379ss. 123 Rime degli Arcadi, II, pp. 381s. 124 FRANCHI, Drammaturgia (v. nota 11), II, p. 28, nota 34. Alla morte di Acciaioli (1700)
i burattini rimasero a Ottoboni. Per la fattura dei burattini a spese di Ottoboni cfr. VOLPICELLI, Il Teatro del Cardinale Ottoboni, (v. nota 111), p. 724, doc. del 20 feb-braio 1696.
125 MARX, Die Musik am Hofe Pietro Kardinal Ottobonis (v. nota 118), p. 98. Per le spese riguardanti la fattura dei burattini e le macchine teatrali delle opere di questo periodo, compresa L’amore eroico, v. VOLPICELLI, Il Teatro del Cardinale Ottoboni (v. nota 111), in particolare pp. 683–685, 720, 724, ecc.
Il fondo dei Campello di Spoleto 121
Arcade« dedicato »Alla sublime idea dell’Auttore della Pastorale L’Amore eroico frà pastori«, che così recitava: »Qui alternan melodie cigni e sirene […] sembra animato il legno pinto e scolto / E per virtù d’industrioso inge-gno / Spira affetti dal seno, amor dal volto / Serve lo stupor nostro al gran dissegno: E all’attonite menti il senso è tolto, Perché dia spirto à tronchi, e voce al legno.«126
Lindgren corregge una falsa attribuzione della musica dell’opera a Fran-cesco Gasparini, chiarendo che i tre atti della rappresentazione del 1696 furono musicati rispettivamente da Carlo Cesarini, Giovanni Lulier e Gio-vanni Bononcini, come risulta da una raccolta di arie della British Li-brary.127 Sul libretto conservato a Spoleto non c’è purtroppo alcun cenno ai compositori della musica. Nella penultima scena (dodicesima) del secondo atto, un duetto tra Eurilla e Liso fu sostituito, nella revisione, da un’aria di Liso. Accanto a quella si trova la dicitura: »Aria nuova del Senesino in vece del Duetto«.128 Il Senesino sarebbe da identificarsi con un contralto il cui vero nome fu Francesco Bernardi (1680–1750 ca.) che fu scritturato a Lon-dra da Händel nel 1719 e successivamente da Porpora.129
L’amore eroico fu nuovamente allestito il 5 febbraio 1705 a Palazzo Ve-nezia con il titolo La pastorella.130 Come già accennato, la musica di tale rappresentazione subì dei rifacimenti da parte di Alessandro Scarlatti. L’opera fu successivamente rappresentata a Londra nel 1708 con il titolo Love’s Triumph.131
La fama di quest’opera andava di pari passo con la gelosia del cardinale per la stessa, come risulta da una lettera del 1712 da Firenze, nella quale la si chiedeva in prestito per farla rappresentare in un teatrino di burattini, si-tuato probabilmente dentro un collegio di religiosi. La richiesta, accompa-gnata da innumerevoli scuse, era considerata troppo ardita dallo stesso scri-
126 I-Rvat, Ottob. Lat. 3361, f [1]. 127 LINDGREN, Le opere drammatiche (v. nota 38), pp. 176s. 128 A f. 18. 129 Sub Voce in DEUMM-B, vol. I, 1985, p. 490. 130 LINDGREN, op. cit., p. 80; MARX, Die Musik am Hofe Pietro Kardinal Ottobonis
(v. nota 118), nota 69. 131 LINDGREN, op. cit., pp. 176 e 182.
Teresa Chirico 122
vente Tossi. La favola era evidentemente conosciuta come la »Serpetta«, poiché viene citata con tale nome, corrispondente a uno dei personaggi.132
Passo adesso alla descrizione del libretto. Nella dedica de L’amor eroico (37) si sminuisce, come di prassi, il valore della favola. L’amore eroico si finge in Arcadia;133 ha tre coppie di personaggi e due cori, uno di ninfe e l’altro di pastori. L’opera si conclude con un coro triplo. È in tre atti, con un totale di quarantuno scene (rispettivamente, per atto: quattordici, tredici, quattordici) e tre mutazioni di scene per atto.
Il primo atto si apre con un bosco con veduta di villaggio in lontananza; le altre scene sono ambientate in una grotta e in un bosco con mare e scoglio in mezzo. Il secondo atto comincia in una strada con vigne e fratte, poi compaiono una vigna e ancora un giardino; nel terzo, infine, l’azione è am-bientata in una capanna, poi si mutano le scene in montagne e in uno stra-done di alberi con festoni di fiori per il trionfo di Eurilla.
La vicenda si basa su vari intrecci amorosi e ha il fine edificante di esal-tare la fedeltà e la costanza in amore, tanto da poter definire addirittura »eroico« tale sentimento. Eurilla soffre per amore di Liso che invece ama l’incostante Licisca; Olindo ama Eurilla. Ci sono poi Serpetta, serva di Eu-rilla (donna piuttosto semplice e ritrosa all’amore) e Neralbo, servo di Liso, innamorato di lei. Il primo atto si sarebbe concluso, in una prima versione, con una scena piuttosto ricca: Serpetta e Neralbo si alternavano a due Pasto-ri e due Pastorelle che ballavano e cantavano e in conclusione tutti avrebbe-ro ballato e cantato.134 Tale parte venne poi cassata, e l’atto si concluse con un duetto tra Neralbo e Serpetta.135
Nel secondo atto Eurilla dimostra, nonostante il rifiuto di Liso, un grande e costante amore per lo stesso. Il pastore, in un primo momento infatuato dalla falsa Licisca – tanto da far perdere i sensi e la ragione a Eurilla – si sdegna poi della civetteria della stessa. Serpetta, riconoscendo le virtù mora-li di Neralbo, gli promette amore, nonostante lo sgradevole aspetto fisico di lui. Il secondo atto, in una prima stesura, prevedeva un duetto tra Neralbo e Serpetta e sucessivamente l’intermezzo della Caccia alla Civetta, nel quale 132 VOLPICELLI, Il Teatro del Cardinale Ottoboni (v. nota 111), pp. 752s. 133 A f. 1. 134 A f. 10v: »Due Pastori ballano e cantano«, »Due pastorelle come sopra«, »Tutti assie-
me ballano e cantano«. 135 A f. 10: »Fuggiam d’amore l’aspra catena«.
Il fondo dei Campello di Spoleto 123
un cacciatore veniva ghermito da un falcone e da questo portato via in volo. In tale scena – che venne poi cassata e sostituita da recitativo e aria di Olin-do – la civetta è simbolo dell’incostanza delle donne e allo stesso tempo trionfo del potere delle stesse.136
Il terzo atto si apre nella capanna d’Eurilla, che, priva di ragione, si crede agli Inferi; Olindo la corteggia invano e le fa credere che Liso ha una rela-zione con Licisca. La costanza di Eurilla viene intanto universalmente rico-nosciuta e tutta l’Arcadia la celebra. Olindo e Licisca, prima animati da sen-timenti di vendetta nei confronti di Eurilla e Liso, finiscono con l’amarsi reciprocamente e celebrare la fedeltà in amore. La favola si conclude con l’entrata di una macchina tirata da »quattro mostri selvaggi«137 (simbolo evidente degli istinti domati e messi al servizio della ragione e della virtù) al cospetto di tutti i personaggi e di cori di ninfe e pastori mentre si esegue una sinfonia. La macchina si apre poi lentamente al comando di Liso formando un anfiteatro che rappresenta l’amore costante. All’interno, sopra un alto trono, è posta Eurilla con il corteggio di molte pastorelle ai piedi; Liso la raggiunge al suono di tre cori che inneggiano alla costanza ed Eurilla pro-clama :»vegga a i nostri ardori / Hoggi l’Arcadia e il Mondo / Nato l’Amor Eroico frà Pastori«. Tale finale fu cambiato in un secondo tempo con una scena d’insieme in cui i personaggi e tutto il coro si alternavano con Eurilla.
Riguardo all’azione, molto interessanti sono le annotazioni a margine di tutto il testo che indicano, spesso meticolosamente, i movimenti dei perso-naggi e le danze.138 Diverse scene – come più volte accennato – sono taglia-te con un tratto di penna, e non sappiamo se fecero poi parte della favola in musica; alcune arie e scene d’insieme, ugualmente cassate, furono proba-bilmente sostituite da altre che compaiono a margine, anche di altra mano.
136 Risp., f. 19v: »Si nascondono Serpetta, e Neralbo, e segue per intermezzo la Caccia
della Civetta, doppo la quale da un gran falcone viene portato via per l’Aria il Caccia-tore.« e f. 18, alla fine dell’aria di Olindo: »Taglia 2.do Atto«.
137 »Macchina che raffigura la Reggia della Costanza«, p. 4. Atto 3°, scena 14: »Si vede spuntar dal fondo della scena gran machina. […].«
138 Ad es., f. 9: »Parte Licisca«; f. 8v: »verso Licisca / verso Neralbo«; f. 11v: »Eurilla s’avanza verso Licisca cantando quest’aria«, »Da sé a parte«, f. 12v: »[Eurilla] tenta sostenersi in piedi poi cade di novo«, »vengono ninfe e pastori a sostenere Eurilla«, »Spruzza d’acqua il viso d’Eurilla che rinviene«; f. 13: »Eurilla si va ricuperando«, »Parte Eurilla sostenuta da Pastori«, ecc.
Teresa Chirico 124
Riguardo ai pezzi chiusi desumibili dal testo possiamo notare la prevalenza delle arie, in particolare nella forma del da capo, sui pezzi d’insieme, come è evidente dalla seguente tabella:139
Aria Duetto Terzetto Quartetto Sestetto, Insieme con coro
Eurilla 9 (2) 1 O
1 Ls + 1 Ls (1 S, Ls, N) 1 i
Liso 4 + 2 1 O 3 Lc (1) 1 E + 1 E
(1 Lc, O) (1 E, S, N) 1 i
Licisca 7 (1) + 1 3 Ls (1) 3 O (1)
(1 Ls, O) 1 S, O, N 1 i
Olindo 5 + 1 1 Ls 1 E 3 Lc (1)
(1 Lc, Ls) 1 Lc, S, N 1 i
Serpetta 6 (2) 5 N (1) + 1 1 Lc, O, N (1 E, Ls, N)
(1 N, due p.relle, due p.ri) 1 i
Neralbo 1 5 S (1) + 1 1 Lc, S, O (1 E, S, Ls)
(1 S, due p.relle, due p.ri) 1 i
Da notare che nella versione originaria la distribuzione delle arie attribuite ai personaggi femminili decresceva a seconda dell’importanza degli stessi; dopo la revisione, Eurilla e Licisca mantennero sette arie e Serpetta solo quattro. Al contrario, fra le arie scritte per i personaggi maschili, quelle di Olindo (cinque) superavano originariamente anche quelle di Liso (quattro); successivamente si arrivò a un uguale numero di arie (sei), mentre Neralbo rimase sempre con un’unica aria. È evidente che nel rifacimento del testo si riequilibrò la differenza del numero di arie tra personaggi di diverso sesso.
Riguardo ai duetti, c’è da notare la netta separazione tra personaggi di diverso rango sociale: duettano rispettivamente fra di loro i personaggi ›alti‹ e i servi. Eurilla è il personaggio che ha meno duetti: inizialmente soltanto due (nella revisione tre), contro i cinque o addirittura sei degli altri. Il per- 139 I numeri tra parentesi indicano le parti espunte nella revisione; i numeri con + indicano
parti aggiunte nella revisione. Le lettere indicano i personaggi con i quali avvengono le scene d’insieme, E = Eurilla; Ls = Liso; Lc = Licisca; O = Olindo; S = Serpetta; N = Neralbo; p.relle = pastorelle, p.ri = pastori; i = pezzo d’insieme con coro.
Il fondo dei Campello di Spoleto 125
ché di tale economia è forse rintracciabile nella valenza del personaggio, talmente alto moralmente da collocarsi al di sopra di tutti gli altri e quindi difficilmente contaminabile per la propria onestà e perseveranza.
Nella versione rivista del testo tre duetti furono eliminati (Licisca – Li-so), (Licisca – Olindo), (Serpetta – Neralbo), così come anche l’unico ter-zetto, uno dei due quartetti, un sestetto di Serpetta e Neralbo con due pastori e due pastorelle e un coro in prossimità della fine del secondo atto.
Nel terzo atto, a metà circa, compare un coro; verso la conclusione del-l’opera canta un triplo coro seguito dal quartetto Licisca – Serpetta – Olin-do – Neralbo. Originariamente, la favola si concludeva con un’aria di Euril-la; nella revisione tale aria fu trasformata, ad un certo punto, in un duetto tra Eurilla e Liso e dall’insieme dei personaggi con »tutto il coro nell’inter-calare«140.
Non si capisce per quale motivo la fine dei primi due atti venne modifi-cata, con l’espunzione dei balli e dell’intermezzo della civetta; si rinunciava ad una ›spettacolarità‹ in favore dell’aria di un singolo personaggio e di un duetto, cosa piuttosto difficile da concepire in un teatro quale quello ottobo-niano. La mia ipotesi è che il libretto in questione, approntato originaria-mente per la prima rappresentazione, abbia fatto in seguito da canovaccio per una versione successiva nella quale gli emendamenti furono apportati, più che per il miglioramento della favola, soprattutto per carenza di mezzi. Delle parti ›spettacolari‹ e scene d’insieme si salvò infatti solo quella di conclusione dell’opera, con un coro triplo che peraltro era già comparso poco prima.
Consideriamo adesso, per quanto possibile, la forma dei pezzi chiusi de-sumibili dal testo.
Riguardo alle arie, la forma che prevale è quella con il da capo. Com-paiono peró altre forme, quali l’aria iniziale di Eurilla con ritornello141 nella quale le strofe sono diverse per il numero dei versi di metro vario. Un’aria dello stesso tipo, anche se più corta, viene cantata da Olindo nella scena settima del primo atto.142 Licisca invece, nella scena nona del terzo atto,143 140 A f. 29 e 30. 141 A f. 3, all’inizio e successivamente: »Un’Amante Pastorella chi soccorre per pietà«; per
altre due volte, »Un’Amante pastorella che per Liso errando va«. 142 A f. 5v. 143 A f. 25.
Teresa Chirico 126
dove si propone di darsi la morte, esegue un’aria senza da capo o ritornelli, in forma semplice, più simile ad un arioso che ad un’aria vera e propria.
Fra i duetti c’è da evidenziare quello tra Licisca e Liso nel primo atto, scena decima144: qui Liso innamorato si sente ferito e deriso dall’incostante Licisca. Il duetto si configura come un’aria con il da capo cantata dal perso-naggio femminile, seguita da tre versi di Liso di metro vario (che furono probabilmente musicati in stile di recitativo) e ancora da altra aria cantata da Licisca con schema metrico uguale alla prima parte, con parole simili. Tale duetto nella revisione fu trasformato in un’aria con il da capo di Licisca, espungendo la parte di Liso e la seconda parte del brano di Licisca. Tale duetto viene proposto ›al rovescio‹ nel terzo atto, scena quinta: la struttura e le parole sono uguali, ma la situazione è opposta: questa volta è Liso che canta l’›aria‹ esprimendo il rifiuto nei confronti di Licisca mentre questa si sente derisa. La revisione seguì anche qui gli stessi criteri già descritti.
Questi due duetti sono di grande importanza nella struttura drammaturgi-ca dell’opera. Si configurano come due colonne nell’architettura della favo-la, rappresentano i confini del ›prima‹ e del ›dopo‹, una cornice nella quale si svolgono gli eventi più importanti: il cambiamento emotivo dei personag-gi in conseguenza della virtù di Eurilla e dell’incostanza di Licisca. Il primo duetto individua, pur nella sua essenzialità, il carattere dei personaggi e la situazione; il secondo sancisce il cambiamento delle passioni e incanala gli eventi dirigendoli alla conclusione, verso il trionfo di Eurilla.
Volendo fare un raffronto tra la struttura de L’amore eroico e lo schema drammaturgico che sottende altri drammi di Ottoboni (La Statira, Il Console tutore, Il Colombo, Teodosio il giovane, ecc.), pur nella consapevolezza di paragonare tra di loro generi molto differenti quali drammi e favola pastora-le, è possibile trovare delle interessanti analogie.
A questo proposito, faccio riferimento a ciò che scrive Gloria Staffieri riguardo alla drammaturgia ottoboniana dei drammi,145 ordinati tutti in tre atti. Nel primo si trovano generalmente tre mutazioni sceniche (luogo natu-rale – luogo architettonico – luogo naturale o luogo architettonico) che cor-rispondono (vedi quanto già detto) alle mutazioni di scene de L’Amore eroi-co. Il primo atto – anche nel caso della favola – ha una funzione introduttiva
144 A f. 8. 145 STAFFIERI, L’Arcadia (v. nota 59).
Il fondo dei Campello di Spoleto 127
dei personaggi e della vicenda e crea i presupposti per mettere in moto l’azione.
Nei drammi ›storici‹, il secondo atto vede mutazioni di scene ambientate in luoghi architettonici, evidentemente difficilmente inseribili in un’ambien-tazione nella mitica Arcadia; e così qui le scene della favola sono costituite da luoghi nei quali compare in qualche modo l’azione dell’uomo: una stra-da, una vigna, un giardino. Se a questo punto nei drammi si riscontra, in seguito ad un evento scatenante, una forte passione dell’antagonista rivolta contro il protagonista, nella favola ciò non succede, ma analogamente è Eu-rilla che manifesta la sua inalienabile passione per Liso, ponendosi in con-trasto con Licisca e arrivando addirittura a perdere la ragione dopo il rifiuto di Liso.
Nel terzo atto dei drammi una scena è ambientata in luogo ‘orroroso’ come sotterranei o prigione; ciò può trovare corrispondenza nella capanna d’Eurilla che, pur non essendo in sé luogo angoscioso, viene vissuto come tale dalla protagonista che, priva di senno, si crede morta e agli inferi; allo stesso tempo la sua virtù, messa alla prova da Olindo, viene riconosciuta dallo stesso innamorato deluso e ciò porterà ad un serie di eventi positivi, tra cui l’interesse di Liso per Eurilla. Anche nei drammi, dalla scena ›sotterra-nea‹ scaturiscono chiarimenti, ravvedimenti, ecc., che preludono al lieto fine, suggellato da duplici o triplici matrimoni; e triplice matrimonio avvie-ne alla fine dell’Amor Eroico.
La fine, in tutti i casi, è sempre spettacolare con la comparsa di una mac-china scenica che simboleggia il trionfo del protagonista e delle sue virtù, quando non l’imponenza e il potere della famiglia Ottoboni.146
Tra i personaggi dei drammi ottoboniani c’è sempre una coppia di basso rango e di carattere comico, e così pure nella favola. Anche in questa sono rispettate le unità aristoteliche.
Questi parallelismi tra drammi e favola pastorale denunciano un intento ben preciso di Pietro Ottoboni: quello di dare al genere della favola pastora-le dignità pari a quella dei drammi storici. Se il nucleo principale di questi è costituito dall’esaltazione della virtù che tribola e vince contro il vizio in una lotta eroica, allo stesso tempo anche personaggi semplici, ma di costumi onesti, possono agire ugualmente in maniera virtuosa ed eroica. Ciò trova 146 VIALE FERRERO, Antonio e Pietro Ottoboni (v. nota 75).
Teresa Chirico 128
conferma negli scritti del Crescimbeni. L’amor Eroico è più volte citato in Istoria della volgar poesia, Rime degli Arcadi, Bellezza della volgar poesia (Dialogo V)147. In quest’ultima sede si discuteva se la favola pastorale fosse in grado, per il carattere di umiltà dei suoi personaggi (pastori e non nobili eroi) di accogliere argomenti eroici e di assurgere quindi alla stessa dignità della tragedia. La conclusione era affermativa: prova ne era la nuova favola dell’Ottoboni nella quale, anche se il linguaggio non poteva essere così ele-vato come tra gli eroi, pure i buoni costumi, i semplici e innocenti amori di Eurilla e Liso nobilitavano le azioni dei personaggi. Nel VI Dialogo148 poi, Logisto Nemeo portava ad esempio la stessa opera come la prima che aves-se ripreso le antiche regole aristoteliche, i cori »e varie altre appartenenze alla buona Comica«; insomma, il cardinale aveva riportato il buon gusto in Italia. Non sappiamo quanto di sincero ci fosse in tale giudizio, sicuramente influenzato dall’enorme potere del cardinale, tant’è che nello stesso Dialogo il Campello veniva rimbeccato con l’appellativo di »stitico« e di censore assoluto nei confronti di altri autori che non fossero il cardinale stesso; per difendersi, Francesco Maria Campello citava altri librettisti per i quali nutri-va stima, tra cui Girolamo Gigli.
L’amor Eroico fu comunque un’opera molto conosciuta nella sua epoca, tanto da avere suscitato emulazione in altri autori, o addirittura ispirato ope-re satiriche, come sembrerebbe da una sconosciuta opera dal titolo L’Eurillo ovvero La costanza negl’Amori frà pastori di Pintace de Trosis (Pietro de Sanctis?) musicata da Giuseppe Della Porta e rappresentata a Roma nel 1697.149
147 Risp. CRESCIMBENI, Dell’istoria della Volgar Poesia (v. nota 114), cit. anche in DELLA
SETA, La musica in Arcadia (v. nota 120), p. 135; CRESCIMBENI, La Bellezza (v. nota 49), pp. 111, anche in rist. del 1712, V, pp. 102s. Cfr. anche VIALE FERRERO, Antonio e Pietro Ottoboni, p. 294.
148 CRESCIMBENI, op. cit., VI, pp. 113–142. 149 STAFFIERI, Colligite fragmenta (nota 59), p. 257.
Il fondo dei Campello di Spoleto 129
DIALOGO TRA AMOR DIVINO E LA FEDE, COSTANTINO PIO, TEODOSIO IL GIOVANE E ALTRE OPERE SCONOSCIUTE O DUBBIE DI PIETRO OTTOBONI Ritengo che il Dialogo tra Amor Divino e la Fede (47) dedicato a Maria Casimira regina di Polonia (adespoto) sia da indentificarsi nella serenata patrocinata da Pietro Ottoboni e fatta eseguire il 9 agosto 1703 di fronte alla residenza di Maria Casimira a Trinità dei Monti.150 Il fatto che lo stesso Ot-toboni fosse l’autore del testo della cantata è comprovato dagli Avvisi di Roma del 18 agosto 1703, dove si legge che il cardinale aveva presentato le sue »doglianze« al papa e al governatore »per una canzone satirica contro di lui, e della sua serenata«.151 Tale testo è autografo, come risulta indiscuti-bilmente dalla grafia e dalle lettere P.O. intrecciate alla fine del componi-mento. La serenata fu musicata da Filippo Amadei, compositore e valente violoncellista nonché aiutante di camera dello stesso cardinale tra il 1700 e il 1711152, come risulta dai precitati Avvisi di Roma.153
Nella canzone satirica di cui sopra si nominava il lago di Bolsena; credo si alludesse al cantante Andrea Adami da Bolsena, per molto tempo al ser-vizio di Ottoboni e direttore dei suoi spettacoli musicali. Si nominavano poi due »delfini«, uno dei quali »avea sì poca lena/ non valea che doi quatrini«. Probabilmente tali »delfini« erano i due cantanti (la cantata è infatti a due voci); uno dei due aveva poca lena, dunque poca potenza vocale. 150 La serenata fu replicata l’indomani in una casa di proprietà di un ciambellano del Mar-
chese Francesco Maria Ruspoli vicino a Palazzo Venezia (Thomas Edward GRIFFIN, The late Baroque Serenata in Rome and Naples: a documentary study with emphasis on Alessandro Scarlatti, Ph. Diss. University of California, Los Angeles, UMI, Ann Arbor [Mich.], pp. 401s., 406, 412s., 416). Per Griffin, la musica era da attribuire ad Alessandro Scarlatti o »Filippo Mattei«, ovvero Filippo Amadei; in realtà, come si dirà, l’autore fu quest’ultimo.
151 VOLPICELLI, Il Teatro del Cardinale Ottoboni, vol. II, p. 738, in I-Rvat, Ottob. Lat. 2731.
152 Stefano LA VIA, Il cardinale Ottoboni e la musica: nuovi documenti (1700–1740), nuove lettere ed ipotesi, in Intorno a Locatelli (v. nota 76). Per l’attribuzione della mu-sica a Filippo Amadei cfr. Lowell LINDGREN, Amadei, Filippo, in: NG, vol. 1, pp. 438s.
153 L’autore fu conosciuto anche come »Pippo del violoncello«, »Pippo Amadio« o »Filip-po Mattei« (VOLPICELLI, Il Teatro del Cardinale Ottoboni, vol. II, p. 738, in I-Rvat, Ot-tob. Lat. 2731: »Per la serenata fatta dal Se Cardle Ottoboni Alla Regina di Polonia. Ot-toboni alla Regina volse far la serenata / […] / Pippo fu del violone che compose la cantata / Ed il tema assai coglione/ fece far questa fritata / […] Queste musiche sì ladre / non son buone per regina / ma più tosto per la madre / delle sue Tabbacarine«).
Teresa Chirico 130
La datazione al 1703 del dialogo (47) concorda anche con il fatto che tale testo a due personaggi di contenuto spirituale sarebbe nato proprio nel pe-riodo della proibizione da parte di papa Clemente XI (dal 1703 fino a cinque anni dopo) di rappresentare spettacoli profani e del conseguente ripiego, da parte della nobilità, su generi più austeri. È noto che molti nobili non rispet-tarono tale divieto e che la più ligia alle direttive papali pare fosse stata pro-prio Maria Casimira di Polonia che nella sua residenza di palazzo Zuccari fece dare, dal 1702, cantate, serenate, composizioni sceniche brevi con po-chi personaggi.154 I testi del Costantino Pio (38) e di Teodosio il giovane (39) si presentano ancora in forma adespota. Il primo dramma, che sappiamo fu rappresentato a Roma al Palazzo della Cancelleria il 21 gennaio del 1710 con musiche di Carlo Francesco Pollarolo, è presente nel fondo solo per il terzo atto e non reca, al contrario di altre opere di Ottoboni, indicazioni sull’allestimento.
Molto più interessante è invece il manoscritto di Teodosio il giovane (39) che si presenta senza titolo e reca note sull’allestimento non presenti nell’esemplare a stampa, dal quale differisce;155 numerose sono le correzioni nel testo. È noto che l’opera fu musicata da Filippo Amadei e rappresentata sempre alla Cancelleria nel 1711.156
Riguardo ad altre opere adespote del tutto sconosciute e non datate che si presentano spesso con numerose correzioni, cito tre drammi per musica: La contessa di Megara (41), scritta su lettere indirizzate allo stesso Pietro Otto-boni, Climene ovvero Nell’incostanza la fede (40), ambientato ad Efeso, che come argomento prendeva spunto dall’antico uso greco di compiere sacrifici umani ad alcune divinità, nonché Amore è sempre Amore (43), dramma trat-to dall’Orlando furioso dell’Ariosto, in cui agivano solo i personaggi di Angelica e Medoro, forse destinato al teatro di burattini. I tre testi sono ac-comunati dalla stessa grafia.
154 CAIRO, Rappresentazioni sceniche (v. nota 67), p. 783. 155 Cfr. f. [1]: Marciano »Nello scendere«; »Parte Ariena con gli schiavi, e parte dei solda-
ti«; f. [1v]: Marciano »Guardando verso la scena donde parte Acrisia«; f. [14]: »Co-minciano la Sinfonia e le Muse si alzano, e fanno il ballo«; f. [14v] »Si sente un tremo-to cadono le statue delle Muse in pezzi […]«, ecc. Cfr. esemplare a stampa per varianti, I-Rn, 35.6.B.17.
156 CRESCIMBENI, La Bellezza (v. nota 49), p. 275
Il fondo dei Campello di Spoleto 131
Altra opera dubbia del cardinale, o forse di Paolo Campello è un testo senza titolo (44) che trova collocazione insieme ad altri testi attribuiti al cardinale, ma che reca un personaggio (Arbante) che ricorre in più opere del Campel-lo.
Da segnalare poi due testi in prosa sullo stesso soggetto, Berengario, che richiamano un testo analogo presente in un Codice Ottoboniano.157
Un’opera adespota attribuibile con grandissima probabilità al cardinale, basata sulla vicenda di Eraclio imperatore cristiano, è La croce ricuperata (45). È una tragedia sacra in versi con parti in musica che presenta diverse dettagliate indicazioni di regìa e di interventi musicali. Fra gli »Interlocuto-ri« si trovavano ventiquattro personaggi, tra i quali tre che cantavano (L’Ambizione, l’Umiltà, l’Amore) più un »Coro di musici«; nel corso della tragedia comparivano altri personaggi, come un »Angelo in musica« e can-tanti segnalati semplicemente con il loro registro vocale (»Un Soprano«, »Un Basso«, »A due, in Musica«). Spesso tali solisti si alternavano al coro (si veda il primo atto, scena seconda) che ripeteva gli ultimi due versi da loro cantati. Erano prescritti degli squilli di tromba in momenti salienti dell’azione.158 Nella scena finale, dopo la frase di Eraclio: »Ma si palesi à gl’occhi nostri homai quil [sic] Sacro S.to Legno«, troviamo l’indicazione: »Qui si spacca la scena, e comparisce la Croce con lumi e trombe, le quali cessate Eraclio così l’adora inginocchiandosi«. Il testo enunciato da Eraclio veniva riproposto in musica da un soprano, seguito da un coro che riprende-va gli ultimi quattro versi dello stesso testo.159 Seguiva un soprano che invi-tava a contemplare e adorare la croce e poi l’indicazione, in parte cassata: »Replicano i Musici [come giudicherà meglio il Sig.r M.ro di Cappella] mirate, adorate«. Dopo l’intervento di alcuni solisti (»un soprano«, »un altro soprano«, »un basso«, »soprano«, »basso«) replicava tutto il coro in conclu-
157 F. ms. N.S. cart. C, s. n., personaggi: Berengario, Gesilda, Adalberto, Engario, Arnal-
do, Gerando, Armido, Flamerto, Cunimondo, Capitano delle guardie regie, Agilulfo, Ambasciatore di Pavia [?]; F. ms. n. 55/1, personaggi: Attone (o Ottone), Rodoalto, Be-rengario, Capitano, Adelaide, Landolfo, Ambasciatore, Teodoro, Gundeberto, Aspran-do, Duca. I-Rvat, Ottob. Lat. 2360, f. 136v, personaggi: Ottone, Adelinda, Berengario, Aristeo, Gelberga, Adalberto, Gesilla, Dorilche.
158 Ad es., »Qui suonano le trombe, s’inginocchia Adrasto«; »Adamasto, Erinta, […] che ritornano vittoriosi col suono delle trombe«.
159 »Humile io qui t’adoro / riaquistato tesoro / Croce sacrata, e pia / Tomba alla colpa mia«.
Teresa Chirico 132
sione dell’opera.160 Alla fine, la formula di congedo: »Il fine della Croce Ricuperata Gloria P.ri, et Filio, et Sp.ui S.to Amen«.
Credo che tale opera sia frutto del cardinale: il soggetto, la grandiosità, le macchine, le meticolose indicazioni di regìa, i suggerimenti al compositore, la presenza dei registri vocali, degli strumenti e quant’altro costituiscono praticamente una firma di quell’autore.161 Non sappiamo se La croce ricu-perata (45) fu mai messa in scena o se rimase in fase progettuale, così come ci è ignota la data e l’occasione per cui fu scritta. Per il genere e le similitu-dini, tale opera ricorda la più volte citata Adonia (36); ciò che colpisce è che quest’ultima, come già detto, fu più volte ricordata dai contemporanei, ma de La croce nulla si sa, cosa che farebbe propendere per un mancato alle-stimento della stessa.
Dai conti di casa Ottoboni sappiamo che una croce comparve in più alle-stimenti, come nel caso di un non ben identificato oratorio nel 1691 e di una macchina montata nella chiesa dei SS. Lorenzo e Damaso in occasione della festa delle Quarantore del 1692 che raffigurava l’apparizione della Croce a Costantino con disegni e modelli fatti dal pittore Domenico Paradisi.162 Considerato il fatto che più macchine teatrali furono ›riciclate‹ per spettacoli di patrocinio ottoboniano (come risulta sempre dalla Computisteria Ottobo-ni) è possibile che la croce dovesse servire nello stesso periodo anche per l’allestimento de La Croce ricuperata (45). E ancora, il fatto che di tale tra-gedia non rimane alcuna testimonianza potrebbe essere spiegato con un mancato allestimento; forse La Croce ricuperata fu scritta entro il carnevale del 1691, prima della morte di papa Alessandro VIII, in seguito alla quale il cardinale non fece dare spettacoli per un anno.
Riguardo al luogo di rappresentazione de La Croce ricuperata, possiamo ipotizzare che tale genere misto di recitazione e musica fosse destinato ad un collegio protetto dall’Ottoboni o ad un seminario. Ciò giustificherebbe il gran numero dei personaggi, che sarebbero stati interpretati da altrettanti convittori o seminaristi, i quali avrebbero anche potuto cantare in un coro
160 »Ogni Duce, ogni schiera / habbia l’alma rivolta / à riportar la Croce ove fu tolta«. 161 Si veda al proposito l’autografo ottoboniano della Statira in I-Rvat, Ottob. Lat. 2360. 162 I-Rvat, Comp. Ottoboni, vol. 26, n. 125, feb. 1693: »Conto delle pitture delli arazzi di
[…] Domenico Paradisi pittore Ristretto della nota delle spese fatte nell’Espositione delle quarant’Ore nella Chiesa di S. Lorenzo in Damaso nell’anno 1692 che laparitione della Croce a Costantino«.
Il fondo dei Campello di Spoleto 133
che aveva brevi e semplici interventi nella tragedia. Al contrario, le parti solistiche sarebbero state eseguite da cantori specialisti, al servizio stabile o temporaneo dell’Ottoboni.
Le fonti de La Croce ricuperata non sono segnalate, ma è molto probabi-le che il cardinale fosse stato ispirato dall’Héraclius di Pierre Corneille.163 Da notare che La Croce ricuperata è in cinque atti, come i due Adoni; anche in questo senso è possibile individuare un’influenza della struttura di trage-die francesi. La scelta di un soggetto storico edificante ben si inserisce nella produzione ottoboniana (si veda al proposito il Cristoforo Colombo).
Quale fu il compositore de La Croce ricuperata? Solo in base alla data-zione proposta (il 1691) si possono avanzare delle ipotesi, riferendoci ai compositori in quel momento preferiti dal cardinale: forse il Lulier, o Gio-vanni Bononcini? O Alessandro Scarlatti?
Fu forse riallestito tra gli ultimi anni del Seicento e i primi del Settecento Il martirio de’ Santi Abundio prete Abundantio diacono Marciano, e Gio-vanni (2) di Domenico Mazzocchi su testo di Ottavio Tronsarelli, la cui prima era avvenuta nel 1641 presso il Duomo di Civita Castellana. La grafìa è quella del cardinale Pietro, particolarmente vicina a quella del testo de L’Amor eroico frà pastori. Il testo manoscritto riporta numerose varianti e parti aggiunte rispetto al testo a stampa, ed è molto probabile che l’autore del rimaneggiamento sia stato proprio l’Ottoboni.
Il valore del libretto de Il martirio – considerato che la musica del dram-ma è sconosciuta – consiste soprattutto nell’indicazione dei registri vocali dei personaggi, degli strumenti, di forme musicali, movimenti scenici ed elementi di scenografìa. Vengono inoltre segnalati due intermezzi: »della Civetta« (identificata nella cantata del fratello di Domenico, Virgilio Maz-zocchi, per quattro soprani e basso continuo) e »del Pedante«, quest’ultimo a me sconosciuto. È plausibile che gli strumenti segnalati nel manoscritto fossero proprio quelli della musica originaria; al contrario, tra i cantanti compare un »baritono«, definizione più credibile per l’epoca di Ottoboni piuttosto che per quella di Mazzocchi; per inciso, lo stesso registro vocale compare, come già detto, nel già citato oratorio Niceta (27).
163 Sappiamo che tale tragedia fu rappresentata al Clementino di Roma nel Carnevale del
1699 in traduzione italiana (FRANCHI, Drammaturgia [vedi nota 11], p. 740).
Teresa Chirico 134
La pugna d’amore contro Amore/ nella Madre de i Maccabei/ Oratorio a/ tre (32), unicum – già citato nell’ambito delle opere di Gigli – è forse opera di Pietro Ottoboni. Si tratta di un caso molto particolare, cioè di un oratorio all’interno di un altro oratorio, paragonabile per questo agli intermezzi di un’opera seria. L’oratorio cui fu aggiunto La pugna d’amore contro Amore è La Madre dei Maccabei e, come già detto, credo sia da identificarsi con l'omonimo testo del Gigli musicato da Felice Mercuriali, dato a Roma tra il 1701 e il 1703 nell’Oratorio di San Filippo Neri.
La pugna d'Amore contro Amore (32), anche se definito »oratorio« è di modeste dimensioni; è diviso in due parti e vi agiscono tre personaggi, Ma-dre (soprano), Amor divino (alto), Amor profano (basso). È evidente, dal contenuto, che le due parti vennero rispettivamente collocate tra le due parti dell’oratorio principale e in conclusione. E’ molto probabile che nel pezzo finale, trionfante, con explicit »Vittoria, vittoria!« ci fossero una o due trombe concertanti, viste le allusioni del testo a questo strumento (»Trombe festive / Voci giulive / Echeggiate / Festeggiate«).
Possiamo solo fare delle ipotesi riguardo al compositore de La pugna d'Amore: considerato il lasso di tempo in cui fu probabilmente eseguito que-sto particolarissimo oratorio (1701–1703), la commissione potrebbe essere stata affidata a Filippo Amadei o ad Alessandro Scarlatti.
Tra le opere dubbie di Ottoboni si annoverano due cantate, una delle quali, già citata a proposito delle analogie con altre due opere dei Campello, è La forza d’amore (46.1). Si tratta di cantata scenica sicuramente allestita per una riunione dell’Arcadia, come è evidente dai personaggi (ninfe e un pastore), dall’ambientazione (»La scena rappresenta la Campagna di Roma vicino al mare con boschi et acque«) e dall’argomento amoroso-pastorale. La cantata richiama per il contenuto e la ›morale‹ (in amore vince la costan-za) l’opera L’Amore eroico frà Pastori (37); fu forse destinata al teatro dei burattini del cardinale.
Il fondo dei Campello di Spoleto 135
OPERE PROMOSSE DA PIETRO OTTOBONI Nel fondo spoletino sono presenti diverse opere che furono promosse dal mecenatismo del cardinale; alcune di quelle, fino a questo momento, sono state ritenute perdute. È il caso dell’Agrippina (46.2), testo di Giuseppe Domenico De Totis (letterato nonchè procuratore legale e poi uditore del cardinale Ottoboni164), che si presenta in forma adespota e senza titolo. L’opera, collocata nel fondo insieme alla Santa Rosa (46.3) dello stesso autore e alla cantata La forza d’amore (46.1), opera molto probabile di Pie-tro Ottoboni (vedi sopra), è da considerarsi come unicum.165 È noto che Ot-toboni nel 1691 avrebbe voluto far rappresentare tale Agrippina al Tordino-na, ma la stessa non fu messa in scena per la sopravvenuta morte del papa Alessandro VIII. L’opera fu musicata da Giovanni Lorenzo Lulier.166
Nel fondo Campello sono oggi presenti molti oratori e cantate fatti ese-guire da Pietro Ottoboni. Una raccolta molto interessante dove compaiono diversi autori di testi e musiche vicini a Pietro Ottoboni è l’antologia Trage-die e oratori (35); diversi testi dell’antologia furono musicati da autori di primo piano quali Alessandro Scarlatti, Giovanni Lorenzo Lulier, Bernardo Pasquini, Carlo Francesco Pollarolo, come risulta in alcuni casi dalle anno-tazioni manoscritte e in altri casi da collazione con altre fonti.
L’antologia, come già detto, contiene i già citati Adonia (35.10) del car-dinale e il raro oratorio di Clemente IX intitolato La strage degli innocenti (35.11) del quale esiste concordanza con un altro esemplare compilato nel 1670.167 È molto probabile che la copia del fondo Campello sia stata compi-
164 FRANCHI, Drammaturgia (v. nota 11), p. 835: De Totis nacque nel 1644 a Roma e vi
morì il 4 novembre 1707. Opere di Giuseppe Domenico De Totis sono segnalate in MORELLI, Il »Theatro spirituale« (v. nota 27), nn. 16, 23, 31, 90s., 105, 114, 136, 162, 171, 198, 215, 226, scritte tra il 1671 e 1678 (cfr. anche nota 45).
165 L’argomento è da me trattato nell’articolo di prossima pubblicazione su Studi musicali. 166 Alberto CAMETTI, Il teatro di Tordinona poi di Apollo, Tivoli 1938, 2 voll., II, p. 347. 167 MORELLI, La circolazione (v. nota 69), p. 152, n. 87, anno 1670 Roma, Filippini. Altra
copia dell’oratorio, dal titolo Oratorio de’ santi innocenti, è contenuta nella raccolta Il Theatro spirituale di Simone Orsini romano del 1677 (cfr. MORELLI, Il »Theatro spiri-tuale« [v. nota 27], pp. 65s., 76). I personaggi delle due fonti non coincidono però del tutto con quelli del testo del fondo Campello: in quest’ultimo non è presente la Terza Madre, e invece di Soldati è presente un solo Soldato. Si tratta evidentemente di un ri-maneggiamento del testo.
Teresa Chirico 136
lata dopo quest’ultima data; nella stessa antologia sono infatti presenti opere copiate anni dopo, come Jefte (35.2) (che in altra fonte reca la data del 1680), La Bersabea (35.1) il cui libretto uscì a stampa nel 1689, la cantata Pel ritorno di Giacomo II al Regno d’Inghilterra (35.6) del 1690, musicata da Alessandro Scarlatti (vedi più avanti).
La Bersabea (35.1), su testo di Michele Brugueres (come è segnalato nella fonte), godette all’epoca di una certa diffusione tanto da essere musi-cato nel corso del tempo da almeno quattro musicisti.
168 Sappiamo che a
Roma tale oratorio venne allestito nel 1692 con il patrocinio di Pietro Otto-boni presso il Palazzo della Cancelleria e che fu musicato da Giovanni Lo-renzo Lulier.
Jefte (35.2), tragedia sacra di Frigimelica Roberti su testo di Francesco Pollaroli,169 fu rappresentata a Venezia probabilmente una prima volta nel 1680, e replicata nel 1702 al cospetto dell’imperatore Leopoldo I.170
Numerose cantate di grande interesse sono presenti nella stessa raccolta (35), i cui testi si presentano in gran parte adespoti.
Due testi sconosciuti recano il nome di De Totis, da identificare con il più volte citato Giuseppe Domenico: L’Eco istrutta (35.3) e L’ucello in gabbia (35.4). Nel primo si fa riferimento ad un paesaggio agreste nel quale cammina il protagonista, circondato da antichità romane ormai in rovina; i suoi sospiri vengono ripetuti dall’eco. È probabile che tale cantata fosse stata allestita scenicamente.
Particolarmente interessante risulta il secondo testo per il suo contenuto: un uccello »musico alato« rinchiuso in una gabbia d’oro rimpiange i »sel-vaggi orrori«: infatti, mentre »in pendice remota« risuona l’eco, »Qui d’un grande c’articola accento / Lieti a schiere risponder io sento / Col rimbombo d’applauso mendace«. Si criticava la falsità delle reggie e l’impossibilità di essere sinceri: »Chi vuol parlar non può, chi può non vuole«. 168 Un autore della musica della Bersabea risulta essere d’Alessandri di Milano (SARTORI
[v. nota 18], I libretti, n. 3980), e MORELLI, Il »Theatro spirituale«, pp. 71 e 127; gli al-tri musicisti furono Gasparo Torelli, Giovanni Lulier, Paolo Petti.
169 Frigimelica Roberti e Pollarolo collaborarono per melodrammi eseguiti nella cerchia degli Ottoboni, vedi ad es. Irene, Venezia 1695 (SARTORI, I libretti, n. 13641), dedicata al cardinale Pietro.
170 Per il 1680, cfr. Appendice, Jefte (35.2). Olga ASCHER TERMINI, Carlo Francesco Pollarolo. His life, time and music with emphasis on the operas, Ph. Diss. Univ. of Southern California, 1970, pp. 326s.
Il fondo dei Campello di Spoleto 137
La cantata La Didone (35.5) è da identificarsi con un testo musicato da Pa-squini non conosciuto con il citato titolo, il cui incipit è: »Sovra un’accesa pira«171. La musica della cantata, per soprano, due violini, basso continuo, è conservata presso la Biblioteca del Conservatorio di Firenze172 e, che io sappia, è al momento da considerarsi come unicum. Non è improbabile che anche il testo de La Didone (35.5) sia del De Totis, visto che compare im-mediatamente dopo due testi dello stesso autore e considerato il fatto che Pasquini musicò varie opere di quel letterato, tra cui La caduta del regno delle Amazzoni nel 1690.
Da segnalare la cantata adespota Pel ritorno di Giacomo II al Regno d’Inghilterra (35.6), identificata in quella musicata da Alessandro Scarlatti per soprano, due violini e basso continuo il cui incipit è »Già lusingato ap-pieno«. Tale cantata non è normalmente conosciuta con il titolo presente nel testo del fondo spoletino e non è mai stata collegata con il re inglese. Il con-tenuto di tale cantata ci permette una datazione, il 1690. Si descrive infatti l’addio del re alla moglie e la partenza di quello per l’Inghilterra in occasio-ne del tentativo sfortunato di riconquistare il trono (1 luglio 1690). Nel testo si fa riferimento al figlio di Giacomo II, Giacomo Edoardo, nato nel 1688 (anno dell’esilio in Francia del re per l’intervento di Guglielmo d’Orange) dalla seconda moglie Maria Beatrice d’Este. Come è noto, per l’ascesa al trono dello stesso monarca era stata allestita presso il palazzo di Cristina di Svezia nel 1687 una fastosa accademia con musiche di Pasquini dirette da Corelli.173
Sempre nell’antologia (35) troviamo il testo Assiso sovra un sasso (35.7) di Pietro Bolis, autore riguardo al quale non ho trovato notizie. Seguono le cantate La Danae (35.8) e Il Leandro (35.9), quest’ultima identificata nella cantata musicata da Alessandro Scarlatti nel 1693.
Anche se non per tutti i testi che compaiono nel fondo è documentato il patrocinio di Ottoboni, è evidente che molti di questi furono approntati per il cardinale; tali opere sono infatti collocate insieme ad altre che godettero della protezione del cardinale.
171 Nella cantata del fondo Campello, »Sovra un’eccelsa pira«. 172 I–FIc, F.I.33 in antologia. Ringrazio Arnaldo Morelli per la cortese segnalazione e
Giovanni Carlo Clavorà Braulin per le notizie relative alla partitura. 173 Franco PIPERNO, Le orchestre di Arcangelo Corelli (v. nota 30), pp. 45, 49–60.
Teresa Chirico 138
È il caso del già citato oratorio Santa Rosa di Lima (46.3) (identificato in Santa Rosa del Perù del De Totis), che fu presumibilmente allestito per la prima volta in un oratorio romano intorno ai primi anni settanta del dicias-settesimo secolo.174 Il testo reca una nota possessoria riguardante Francesco Maria Campello, forse aggiunta di recente.
Tra gli altri oratori troviamo La pulcella d’Orleans (48) di Giovan Batti-sta Taroni, che sappiamo fu musicato da Pier Giuseppe Sandoni; l’oratorio fu copiato da Francesco Maria Campello, come risulta dalla grafìa. Non abbiamo testimonianze su un allestimento romano dello stesso, anche se risulta che La pulcella fu dato a Bologna e a Cento nel 1701;175 non è esclu-so che la copia fosse stata approntata dal Campello per uso di Ottoboni.
Di certo patrocinio ottoboniano fu invece Il convito di Baldasar (49) su testo di Pietro Alessandro Ginori musicato da Francesco Pollarolo che fu allestito nella quaresima del 1708 presso il Palazzo della Cancelleria.176
Nulla sappiamo di una S. Agnese (50), collocata insieme ad altri oratori (La conversione di Sant’Agostino [7], S. Didimo e S. Teodora [8]) e a testi attribuibili, come già detto, a Pietro Ottoboni, come La contessa di Megara (41).
Probabilmente fu eseguita a Roma la cantata (28.11) per il venerdì santo di Giovan Battista Grappelli, senza titolo, con i personaggi Maddalena e Giovanni. Grappelli, nato a Frosinone nel 1650, fu dottor di leggi, avvocato e poeta; fece parte di molte accademie, tra cui l’Arcadia.177 Tra le sue com-posizioni, alcuni oratori178 e un sonetto in una Corona poetica del 1710 de-dicata a Pietro Ottoboni per il Costantino Pio.179
174 MORELLI, Il »Theatro spirituale« (v. nota 27), pp. 98–104, in particolare p.101.
L’oratorio fa parte di una raccolta di oratori allestiti presso la Chiesa Nuova e S. Girolamo della Carità negli anni 1669–1672.
175 Il compositore non è segnalato sul manoscritto. Sandoni (1685–1748) fece dare lo stesso oratorio a Bologna, oltre che a Cento, sempre nel 1701 (cfr. DEUMM–B, vol. VI, 1988, p. 566).
176 ASCHER TERMINI, Carlo Francesco Pollarolo. (v. nota 170), p. 325. 177 FRANCHI, Drammaturgia (v. nota 11), p. 854. 178 Il Grappelli scrisse libretti di oratori rappresentati a Roma tra il 1702 e il 1706 (Costan-
tino, Tommaso Moro, Maria Stuarda) (cfr. MORELLI, Oratorii [v. nota 87], p. 281). 179 Franco PIPERNO, »Su le sponde del Tebro«: eventi, mecenati e istituzioni musicali a
Roma negli anni di Locatelli. Saggio di cronologia, in: Intorno a Locatelli (v. nota 76), pp. 793–877: 802s.
Il fondo dei Campello di Spoleto 139
Cito infine un dialogo pastorale (51) molto più tardo, scritto per la villeggia-tura a Trevi dei monsignori Lodovico Valenti e Filippo Valenti, quest’ultimo cameriere d’onore di Benedetto XIV; l’opera risale quindi agli anni 1740–1758, periodo del pontificato di quel papa.
Infine, ricordo che il mecenatismo di Pietro Ottoboni si estese anche all’Umbria: nel 1723 il cardinale Pietro Ottoboni fu eletto rettore dell’Acca-demia degli Ottusi di Spoleto e nel teatro di Foligno, ›protetto‹ dal cardinale Pietro, si rappresentò nel 1729 il Giulio Cesare del principe Antonio.180 FRANCESCO MARIA CAMPELLO Nel fondo Campello sono presenti alcuni testi del più volte citato nipote di Paolo, Francesco Maria. Due sono opere certe: Arsace re de’ Parti (52) e Amore vince amore (53). La prima reca la data del 1 marzo 1719; il Cam-pello si firmava con il nome arcadico (Logisto Nemeo) e rivolgeva la dedica a Audalgo Toledermio P.(astore) A.(rcade), ovvero il marchese Girolamo Teodoli181 di Roma, dichiarando che il soggetto del dramma era derivato da Agrippa di Quinault (»Quinò«), »[…] composto poi mentre nello scorso Carnevale ero da Voi favorito alle recite dell’Opera«182. Tra le fonti si cita-no le Istorie di Giustino.
Altra opera certa di Francesco Maria è il dramma pastorale Amore vince amore (53), che reca un sonetto dedicato a Crateo (Pietro Ottoboni) e che fu sicuramente eseguito in occasione di una riunione di arcadi, come il già cita-to Fatti e non parole (25.14) dello zio Paolo, ambientato nella mitica Arca-dia e animato dagli stessi personaggi (Eurillo, Clori, Filli).
180 Per la notizia sull’Accademia degli Ottusi cfr. LOPA, La vita musicale a Spoleto
(v. nota 4), pp. 92s., per il Giulio Cesare, VIALE FERRERO, Antonio e Pietro Ottoboni (v. nota 75), p. 283.
181 Anna Maria GIORGETTI VICHI, Gli Arcadi dal 1690 al 1800, Roma 1977, p. 39. Il Teo-doli fu l’architetto del teatro di Torre Argentina; i lavori iniziarono nel 1731 (cfr. FRANCHI, Drammaturgia [v. nota 11], p. LXI).
182 »Tale è questo drama, ch’io vi presento, concepito da me nell’udire il desiderio, che mi mostraste di vedere tradotta et all’uso dei teatri d’Italia, ridotta la Tragedia del sig.r di Quinò [Quinault] intitolata l’Agrippa, e composto poi mentre nello scorso Carnevale ero da Voi favorito alle recite dell’Opera«.
Teresa Chirico 140
Abbiamo poi delle altre opere di incerta attribuzione, come l’Assalonne (28.7), che rappresenta un caso controverso. Il frontespizio reca: »[…] Reci-tato, e stampati [sic] / in Terni, di Logisto Nemeo, Confondatore [sic] / e Decano dell’Accademia / Degli Arcadi di Roma«. Il Campello della Spina sostiene invece che l’autore dell’Assalonne sia stato Bernardino France-sco183 (in Arcadia Verindo Tueboate) fratello minore di Francesco Maria e che la musica sia stata di Giovan Battista Fronduti. L’oratorio, dedicato a Lucia Canali Castelli, sarebbe stato stampato a Terni da Giovan Battista Legnaioli »con pessimi tipi« nel 1712. Purtroppo la fonte a stampa è oggi introvabile.
E ancora, potrebbe essere un prodotto di Francesco Maria il già citato dramma adespoto Olimpia regina d’Epiro (42), che si trova in versione completa e in copia mutila. Quest’ultima, smembrata e danneggiata dal fuo-co, sembrerebbe scritta con la grafia dell’avvocato spoletino e presenta indi-cazioni di regia: »Si muta la scena, e si vede brugiar l’osteria in lontananza, e così un balletto di forastieri, che fuggono termina il primo Atto.«184 La particolarità di questa specie di bozza è che fu scritta su fogli già utilizzati come carta da lettera, indirizzati al cardinale Ottoboni e a Francesco Maria Campello.185
Francesco Campello fu anche autore di testi di cantate composte per al-cune particolari occasioni ed eseguite durante le riunioni degli Arcadi,186 Ottusi spoletini187, nonché per i Giochi Olimpici del 1707.188 La Pitassio
183 CAMPELLO DELLA SPINA, Storia documentata (v. nota 1), pp. 64s. Erroneamente Ber-
nardino è definito »Tubeate«. Di Bernardino si accenna in PITASSIO, Campello, Fran-cesco Maria di Solone Maria (v. nota 1), p. 483, quando si dice che Francesco Maria, nel 1723, avrebbe devoluto la propria eredità in favore del fratello Bernardino che era in procinto di sposarsi.
184 F. ms. N.S. Busta A, fasc. 1/1, n. 4, f. 17. 185 F. ms. N.S. Busta A, fasc. 1/1, n. 4, ff. 13, 16, 35: »Card. m. Otthobonum«; f. 26: »Av-
vocato Campelli«. 186 Vedi in I-Ra, ms.1, ms. 9, in particolare la Cantata per la nascita del Redentore messa
in musica da Filippo Amadei e recitata nel Palazzo Apostolico, stampata in Roma nel 1701.
187 LOPA, La vita musicale (v. nota 4), pp. 95s. Una cantata, stampata, fu dedicata alla contessa Flavia Theodoli Bolognesi per la sua visita a Spoleto, forse musicata dal mae-stro della cattedrale Giovan Battista Fronduti. Il 1° ottobre 1721, in una tornata dell’Accademia in onore di Innocenzo XIII, Francesco Maria scrisse un testo per musi-ca, LOPA, La vita musicale, p. 92.
Il fondo dei Campello di Spoleto 141
sostiene che nessuna opera teatrale di Francesco Maria fu mai pubblicata; lo stesso arcade fu però un rinomato regista teatrale, come ci informa il suo discendente.189 A questo proposito ci si chiede se il Campello avesse messo in scena alcune opere che oggi compaiono nel fondo della famiglia, conside-rando anche il fatto che molte di quelle, come più volte detto, recano note di regìa.
Alcuni manoscritti riportano note possessorie riferentesi al personaggio in questione, come l’oratorio Santa Rosa di Lima (46.3) e il già citato L’amore in maschera (5) del 1675. Nel primo caso si tratterebbe forse di un’annotazione relativamente recente.190 Nel secondo caso, in particolare, la data di quest’opera è significativa: il Campello aveva all’epoca solo dieci anni e dunque si tratterebbe di una copia tarda approntata per proprio studio o per un riallestimento.
Da rilevare il caso delle bozze dei testi scritti su lettere indirizzate a Francesco Maria e a Pietro Ottoboni, che testimonierebbero una genesi delle stesse opere vissuta quasi simbioticamente dai due personaggi, come dimo-stra la già citata frase pronunciata da Logisto in Bellezza della Volgar Poe-sia.191
In conclusione, credo sia superfluo sottolineare la grande importanza di questo (fino al momento) sconosciuto fondo spoletino che crea un impatto non indifferente sulle vicende dell’opera e del teatro in musica in generale, dell’oratorio e della cantata soprattutto a Roma a cavallo dei secoli dicias-settesimo e diciottesimo, a causa della massiccia presenza di opere scono-sciute o ritenute perdute.
In particolare, spicca il valore dei testi scritti da Pietro Ottoboni e da lui commissionati; uno studio che oggi si preoccupi di tracciare un ritratto del cardinale come autore, drammaturgo e committente non può prescindere dalla considerazione delle opere conservate nel fondo Campello.
188 DELLA SETA, La musica in Arcadia (v. nota 120), p. 127, nota 10. 189 CAMPELLO DELLA SPINA, Storia documentata (v. nota 1), pp. 78s.: »Possedette così
bene l’arte tragica e comica (siccome ne fanno fede le di lui opere manoscritte) che in Roma era uno dei più capaci direttori, a cui gli attori dovevano ricorrere nel rappresen-tare le opere nuove.«
190 »Di Francesco Maria / conte di Campello / sec.i XVII e XVIII«. 191 »[…] abbiam qui fatto onorata menzione di tal nobilissima tragedia [Adonia], la quale
(come v’è noto) io ò avuto l’onore di veder nascere, e perfezionare.«
Teresa Chirico 142
Innumerevoli sono le prospettive di ricerca che, a questo punto si aprono: l’approfondimento dei singoli testi, la loro valenza storica e sociale, il loro rapporto con la musica sopravvissuta, l’eventuale rilettura e riconsiderazio-ne delle fonti concordanti a stampa, gli sperimentalismi teatrali, gli aspetti della committenza e quelli riguardanti gli allestimenti, regìa, macchine tea-trali e altro ancora.
Insomma, le ›nuove‹ fonti del fondo Campello si configurano prevalen-temente come un insieme di microcosmi vissuti in un preciso contesto stori-co e sociale che oggi costituiscono un’imprescindibile testimonianza non solo per i loro contenuti testuali, ma anche per le ricche notizie e implica-zioni di cui sono referenti.
Il fondo dei Campello di Spoleto 143
APPENDICE DESCRIZIONE DEI TESTI Si elencano i testi per musica, tutti manoscritti, conservati presso l’ASS nell’Archivio Campello. Laddove non si ha alcuna indicazione d’anno nella fonte, si riporta fra parentesi quadre la data del primo allestimento conosciu-to dell’opera o date desunte da eventi storici, da notizie biografiche degli autori dei testi e delle musiche, dei copisti, ecc.
Le schede sono articolate nel seguente modo: Collocazione; titolo (originale o desunto da altre fonti); genere (nei casi
dubbi); eventuale dedica. Autore del testo, autore della musica. Personaggi e voci (quando segnalate); numero degli atti dei melodrammi
(gli oratori sono, tranne diversa indicazione, divisi in due parti). Note (eventuale autografo, epoca del ms, luogo, bibliografia, eventuali
fonti storiche segnalate, note possessorie, ecc.). Eventuale segnalazione di unicum.
Incipit. Eventuali concordanze (quando il libretto è manoscritto lo si segnala,
ms.). Per le biblioteche e fondi musicali si usano le abbreviazioni del RISM. ABBREVIAZIONI A = alto; B = basso; b.c. = basso continuo; Br = baritono; c = carta; C = canto; cart. = cartella; coll. = collocazione; comp. = composizione /i; d. = dedica; ds. = destra; F.= Fondo; f. = foglio; fasc. = fascicolo; front. = fronte-spizio; ident. = identificazione; intr.= introduzione; l.= libretto; m. = musi-ca; ms. = manoscritto; partit. = partitura; S = soprano; sinf. = sinfonia; sn. = sinistra; t. = testo; T = tenore; U = unicum; v = voce /i; vl = violino.
Teresa Chirico 144
LE FONTI (1) F. ms. n. 128.
Tirinto / favola pastorale / di Giovanni Capponi / Porrettano / l’Animo-so / Accademico Selvaggio / di / Bologna, d. a Giovanni Filippo Certani »il Palustre Accademico Selvaggio«.
t.: Giovanni Capponi. Crepuscolo, Tirreno, Aurillo, Amalteo, Orintio, Flora, Lucilla, Orrillo,
Armindo, Merinda, Leucippo, Meri, Varisco, Nunzio, Cori. Prologo e 5 atti. Autogr. ? 17 giugno 1606, [Bologna]. Data a c.[1v]. Fasc. rilegato in per-gamena. A c. 4: »La scena si finge in Citera«. Alla fine: »Alle nobilissime dame bolognesi nel rappresentarsi il Tirinto«, sonetto.
»Benchè fanciullo alato«. I-Rn 35.5.A.3 in miscellanea, Il Tirinto […], Bologna, Giovanni Battista
Bellagamba, 1607. »Rappresentata presso l’Accademia dei Selvaggi in Bo-logna l’anno 1607«. Su front. si omette »di Bologna«; personaggio Aronte satiro al posto di Orrillo; si riportano diversi sonetti degli accademici, tra cui quello del Certani presente nel ms. (2) F. ms. n. 13.
Il / martirio / de’ Santi / Abundio prete / Abundantio diacono / Marcia-no, e Giovanni / suo figliolo / Cavalieri Romani / Dramma / del Signor Ot-tavio Tronsarelli, posto in / musica / da Domenico Mazzocchi / Et in Civita Castellana li 16 di Sett.re / giorno festivo di questi Santi / rappresentato / nell’anno 1641, d. a Paolo Borghese principe di Rossano.
t.: Ottavio Tronsarelli; m.: Domenico Mazzocchi. 2 Furie (SS), Diocletiano (B), Giudice (Br), Prefetto (A), Abundio (T),
Abundantio (A), Marciano (T), Giovanni (C), Teodora (C), Due fedeli, Cu-stode de’ campi di Teodora (A), Angelo (C), Choro di soldati (a 5), Choro di demoni (3 B), Choro di christiani (a 5, ultimo a 11), Ballarini. Prologo e 3 atti. Intermedi: I della Civetta [Virgilio Mazzocchi]; II del Pedante.
[1690–1740; Roma ?]. Grafia di Pietro Ottoboni. Il testo, rispetto al li-bretto del 1641, presenta delle parti aggiunte (probabile autore Pietro Otto-boni).
»Sì sì, stragi e furori«.
Il fondo dei Campello di Spoleto 145
SARTORI192, n. 14919: I-Rc, I-Rn, I-Rvat. (3) F. ms. n. 126.
La Datira / Dramma eroico rappresentato in musica / nel nuovo Teatro di Siena il 26 / Maggio 1647.
t.: [Giulio Rospigliosi ?] Sveno, Datira, Altea, Guntero, Lutolfo, Retingho, Baldano, Rolano, Si-
grita, Gotilda, Ruteno, Valandio, Sinaldo, Alao, Pescatore, Coro di soldati danesi, Coro di soldati svetesi, Coro di cacciatori, Accompagnature. Prologo e 3 atti.
26 maggio 1647; Siena, nuovo Teatro. A c. [4]: »Si muta dodici volte, come a suo luogo si vede«. BIANCHI193, p. 78 in nota. Fonte del l: Giovanni Magno, Historie de’ Goti. U
»Dall’empirea magion su questa scena«. (4) F. ms. n. 14.
Trionfo d’amore in maschera. t.: Solone Campello. Aci e Galatea, coppia I. Titiro e Amarilli, II. Leandro e Ero, III. La cop-
pia d’Arimino, IV. Choro. [1661–1680 ?; Spoleto ?]. Su front.: »Solone Campello / di Bernardi-
no«. U »Aci pietoso Amore«.
(5) F. ms. n. 133.
L’amore in maschera / o vero / Gl’affetti confusi / del Signor Sebastiano Zaccagnini / Gentilhuomo Cortonese / del 1675.
t.: Sebastiano Zaccagnini. Venere e Himeneo (per il prologo). Licaonte, Solidea, Celidaura, Ferin-
do, Filimoro, Roselmina, Spaccanocchia, Mestolino, Perillo, Elindo. Prolo-go e 3 atti.
1675; [Cortona ?]. Su front., di altra mano: »Ad usum Franci. de Comiti-bus« [Francesco Campello]. U
192 SARTORI, I libretti (v. nota 18). 193 BIANCHI, De i vizj (v. nota 22)
Teresa Chirico 146
»Sì, sì, sì ch’al fin saranno«. (6) F. ms. n. 79.
Virginità Favola morale del Signor Fabrizio / Hon De Dei. t.: Fabrizio Hon de Dei; m.: [Cesare Masino ?] Plutone e Proserpina (per il prologo), Virginità ninfa, Astinenza tutrice
della Virginità, Honore famiglio di detta Virginità, Fortezza, Grazia celeste, Inspiration celeste, Mondo monarca, Errore figlio del Mondo giovine inna-morato, Inganno, Maldesiderio, Diletto, Sensualità ninfa attempata, Voce, Furia che fa un Intermedio, Imago ne fa un altro, Mosè et Compagno, Fara-one et Compagno, Angelo, Iddio. 5 atti.
[1660–1680 ?; Roma ?]. A c. [1]: »Frater Caesar Masinus«. A c. [4]: »Sonetto all’Autore«, endecasillabi: »Ciò Fabrizio per te vanta Ippocrene / fatto mostra di mostri, e d’ai maggiori / de’ teatri più bei l’honor conviene. / E qual mostro è maggior che fra gl’amori / veder Virginità sovra le scene / Partorir plausi, e generar stupori?«. U
»Dalle sulfuree vene«. (7). F. ms. N.S., cart. B, fasc. 15.
La conversione di S. Agostino oratorio di padre Mazzei. t.: Cesare Mazzei, m.: [Giovanni Bicilli]. Verità, Vanità, S.Agostino, Penitenza, Piacere. [1671; Roma, Oratorio dei Filippini]. MORELLI194, nn. 10, 129, 209, e
MORELLI195, p. 153, nota 92. »Con voi parlo o mortali«. I-Ras, Cartari-Febei 212 e I-Rv, P.1.
(8) F. ms. N.S., cart. B, fasc. 3/s. n. interno
S. Didimo e S. Teodora / Oratorio di Mons. Bernini. t.: [Pietro Filippo] Bernini. Testo, Tiranno, S. Teodora, S. Didimo, Custode, Castità, Coro di soldati. [1660–1677; Roma]. MORELLI196, p. 76, e MORELLI197, nota 225.
194 MORELLI, Il »Theatro spirituale« (v. nota 27). 195 MORELLI, La circolazione (v. nota 69). 196 MORELLI, Il »Theatro spirituale«.
Il fondo dei Campello di Spoleto 147
»Ne l’arene d’Egitto«. (9) F. ms. N.S., cart. A, fasc. 1, s. n.
Oratorio / Di / Santa Beatrice / d’Este / Da cantarsi / Alla presenza / Dell’Eminentissimo / Sig.r Cardinale D’Este / Beatrice fu annumerata fra le Sante / onde di poi hebbe il nome di Beata / Vedi il Pigna Lib.2 / pag. / 138 / In Roma MDCLXXXIX.
t.: [Benedetto Pamphilj o Giulio Cesare Grazzini], m. [Giovanni Lulier; introduzione e sinfonia Arcangelo Corelli].
Santa Beatrice, Consigliero, S. Giuliana, Ezzelino Tiranno, Angelo. [1689; Roma, Palazzo Pamphilj]. A f. [4]: »Duetto«; c. [6]: »Aria«. Gra-
fìa di Paolo Campello. MORELLI198, p. 168, n.158. »Beatrice, i tuoi pregi«. SARTORI199, nn. 20758 e 20759, intr. e sinf. di Arcangelo Corelli.
(10) F. ms. N.S., cart. A, fasc. 1/7.
Senza titolo [cantata]. t.: ? Ninfa del Tamigi, Clitumno. [1687–1701 ?; Spoleto ?] Scritta forse in omaggio di Giacomo II Stuart.
Incompleto. U »Al fatidico Nume dell’illustre Clitunno, ov’ei si pregia«
(11) F. ms. N.S. cart. C, fasc. 4/7.
Clomiri di Paolo Campelli t.: Paolo Campello. Ederinda principessa d’Inghilterra, Isabella, Girello, Arbante, Pantinca,
Florindo, Odoardo, Clomiri, Calligone, Endemiro, Radamisto, Liconte. 3 atti.
Autogr. [5 febbraio 1663; Spoleto, Accademia degli Ottusi]. LOPA200, p. 85. U
197 MORELLI, La circolazione. 198 Ibidem. 199 SARTORI, I libretti (v. nota 18). 200 LOPA, La vita musicale a Spoleto (v. nota 4).
Teresa Chirico 148
»Chetatevi o miei pensieri / cessate di cruciare una infelice«. (12) F. ms. n. 69.
Il Demetrio. d. a »V. A.« [Principe ereditario di Toscana]. t.: Paolo Campello Demetrio, Erinto, Adraste, Leardo, Matilde, Aristea, Rodrino, Aterpe,
Endemiro, Rosana, Zufo. 3 atti. Autogr. 4 novembre 1667; Spoleto. Il dramma presenta lo stesso testo e
personaggi in gran parte uguali al Seleuco (13). U »Signor tu amante e con quai forze il Cielo«.
(13) F. ms. n. 16.
Il Seleuco / ò vero / L’Odio d’Amore. t.: [Paolo Campello]. Seleuco prencipe della Siria sotto nome di Emireno, Erinto, Adraste, Le-
pido mandato da Roma alla tutela de figli del morto re d’Egitto, Marilde regina d’Egitto, Aristea, Rodrigo, Aterpe, Endemiro prencipe di Cipro, Ro-sana principessa d’Egitto sorella di Marilde, Zufo pescatore. 3 atti.
Autogr. [1667–1713; Roma o Spoleto?]. A p. 1: »I fondamenti del Dramma sono presi da Giustino Istorico vedi l. 30, e 31. L’attione si rappre-senta in Sidone capitale della Finicia fino a dove in questi tempi si estese il dominio de i Re d’Egitto. Giusep. Ebr. l. 12 delle Antich.a Giud.« Copia in F. ms. n. 17. Altra versione in F. ms. N.S., cart. C, n. 4, erroneamente cata-logato sotto Arsace. Il dramma è uguale al Demetrio (12) dello stesso auto-re, con piccole varianti nei personaggi. U
»Signore tu amante? E con quai forze il Cielo«. (14) F. ms. N.S., cart. B, fasc. 3 /12.
I successori di Alessandro. 4 esemplari (2 copie + 2 copie). t.: Paolo Campello, m.: [Francesco Gasparini?] a) I successori di Alessandro / opera scenica Recitata nel / Corrente
Carnevale nel Collegio / Clementino 1692 / Del Sig.r Cav.re Paolo Campel-li.
Ederinda, Mindori, Arbante, Pantinea, Giro, Florindo, Demetrio, Clomi-ri, Antioco, Endemiro, Peneaste, Leonte. 3 atti.
Il fondo dei Campello di Spoleto 149
1692; Roma, Collegio Clementino. Indicazioni di regìa. Personaggi in gran parte presenti in Clomiri (11) dello stesso autore. U
»Ah, che facesti principessa Ederinda?« Rn 35.4.K.23.1-2; incipit »Care tende guerriere« non coincide; concor-
danza quasi totale dei personaggi. b) Drama per musica. Arideo, Periandro, Meleagro, Nearco, Barsinda, Arside, Oridice, com-
parse (guardie, soldati, paggi). 3 atti. Altra copia mutila con indicazioni di regìa, danneggiata dal fuoco in F.
ms. N.S., cart. A, fasc. I s. n. interno, non segnalata in inventario. Per il compositore cfr. LINDGREN201, pp. 172s. U
»Principi, ecco la gemma in cui morendo«. (15) F. ms. N.S. cart. C, fasc. 4/s. n.
Il Tiridate overo Il Re da scena nel gioco della fortuna t.: [per gli intermezzi Paolo Campello ?] Tiridate, Rosmondo, Filadelfo, Artemisia, Argete, Giulio, Tigrane, Alci-
demonte. Negli intermezzi: Radamisto, Zenobia, Rosindo, Silvano. 5 atti (in prosa con intermezzi in musica).
[Carnevale 1695; Roma, Seminario Romano]. FRANCHI202, p. 690, libr. a stampa d. a Pietro Ottoboni, rappr. a Roma, Seminario Romano, 1695, stamp. Roma, Francesco de’ Lazari figlio d’Ignatio, 1695. Fonte: Cornelio TACITO, Annali.
»Ho vinto nel sangue nemico«. SARTORI203, n. 21120. Prologo e 5 atti con intermedi quattro interlocutori
»musici«, Roma, Corsiniana 170.E.11 (26). (16) F. ms. n. 127. 2 versioni.
Il Pandolfo, overo / Mal ha chi mal opra / Scherzo drammatico. t.: [Paolo Campello]. Dina, Alinda, Ernesto Conte d’Altaripa, Adiberto fratello di Pandolfo,
Pandolfo Marchese d’Arasso, Lucilda. 3 atti.
201 LINDGREN, Le opere drammatiche (v. nota 38) 202 FRANCHI, Drammaturgia romana (v. nota 11). 203 SARTORI, I libretti (v. nota 18).
Teresa Chirico 150
Autogr. per una versione? [febbraio 1695; Roma, Teatro nel palazzo dei duchi Rospigliosi]. CAMPELLO204, p. 23 e CRESCIMBENI205, p. 131. Anche in F. ms. N.S., cart. A, fasc.1 /3, due versioni differenti con grafie diverse: un’opera completa (autogr.), una mutila del terzo atto. Note di regia, corre-zioni.
»Soccorretemi o Cieli«. I-Rvat, Cod. Vat. Lat. 13349, Ms. [autogr.], s. d., 46 cc. (42, IV), 4°.
(17) F. ms. n. 18.
Il Radamisto. t.: [Paolo Campello]; m.: [Bernardo Pasquini?] Radamisto re di Armenia, Ermete, Zenobia, Leonte, Arsinda, Mitridate,
Odoacre, Arbante, coro (non segnalato fra i personaggi, ma nel corpo del libr.). 3 atti.
Autogr. [1696 ?; Roma o Spoleto ?]. CAMPELLO206, p. 22. Fonte: Tacito, Annali, XII libro. »Ma quello di più, che in molti particolari vi avvenne, e che la voracità del Tempo non lasciò pervenire alla notizia di questo istorico [Tacito], né volumi eterni del gran Permesso più esattamente registrati da Calliope si son ritrovati, e nel presente Dramma si portano à la notizia co-mune«. Copia F. ms. n. 19. U
»A la caccia a la caccia«. (18) F. ms. n. 110.
Mario in Cartagine. t.: [Paolo Campello]. Mario, Celia, Fannia, Tarpilio, Metello, Lesba. 3 atti. Autogr. ? [1663–1700; Roma o Spoleto ?]. CRESCIMBENI207, p. 131;
CAMPELLO208, p. 22. U »Patria, amici, figli, impero«.
204 CAMPELLO, Storia documentata (v. nota 1). 205 CRESCIMBENI, La Bellezza (v. nota 49). 206 CAMPELLO, op. cit. 207 CRESCIMBENI, op. cit. 208 CAMPELLO, op. cit..
Il fondo dei Campello di Spoleto 151
(19) F. ms. N.S., Cart. A, fasc. 2/2. Il battesimo di Atanaide. t.: [Paolo Campello]. Teodosio imperatore giovanetto, Pulcheria, Paolindo, Leontio, Atanaide,
Erina. 3 atti. Autogr. [1700 c.ca; Roma ?]. CRESCIMBENI,209 p. 131. U »Sei già salvo signor / Sol tua mercede«.
(20) F. ms., n. 22.
Amor vuol gioventù / Drammetto per musica. t.: [Paolo Campello]. Alidoro, Celinda, Retimio padre di Alidoro, Poristene vecchia sorella di
Celinda. 3 atti. Autogr. [1690 ca. – 1700; Roma o Zagarolo?, Teatro dei duchi Rospi-
gliosi]. CRESCIMBENI210
, p. 131; cfr. sonetto in F. ms. n. 76, p. 38. Fonte: »Natal. di Conti Mytheolog. Lib.3° Cap. 116«. Su front., scritto recente a matita: »Francesco Maria Campello ?«.
»Ah, cruda fera, aih lasso«. (21) F. ms. N.S., cart. B, fasc. 3/13.
Il Mitridate. t.: [Paolo Campello ?] Mitridate, Arbante, Tamiri, Siface, Farnace, Monima, Coro. 3 atti. [1663–1713; Roma o Spoleto]. U »Movean pur barbara guerra / Nembi, Venti, Mare, Terra«.
(22) F. ms. N.S., cart. A, fasc. 1 /1.
Il Daliso / Piccolo dramma intrecciato di due sole persone / Daliso, e Celinda.
t.: [Paolo Campello ?] Celinda (S), Daliso (A). 3 atti. Autogr.? [1689–1713; Roma, Palazzo della Cancelleria]. Grafìa di Paolo
Campello; diverse indicazioni di regìa. Fonte: »si come si ha dalle tre Can-
209 CRESCIMBENI, La Bellezza. 210 Idem.
Teresa Chirico 152
zone famose del Co: Fulvio Testi, Sarà il soggetto della presente Cantata.« Copia in F. ms. N.S., cart. B, n. 10, erroneamente catalogato come Pasifo. U »Ruscelletto che non può«. (23) F. ms. n. 20.
La Gelosia non è buona / Guardiana / Dramma Cittadino Giocoso t.: Paolo Campello. Enrico, Eutichio, Rosalba, Minerva, Adalinda, Odoardo, Menghina. 3 at-
ti. Autogr. [1663–1713; Roma ?]. CAMPELLO211, p. 22. Anche in F. ms. n.
21 e F. ms. N.S., cart. C, fasc.4 /5, con alcuni personaggi variati, incipit: »Eccomi pur giunto a Poggio di Mirto«. Incipit diverso: »Cadde il fiero ne-mico«. U
»Se scintillano al Polo le stelle«. (24) F. ms. N.S. cart. C, fasc. 4/3.
Di Paolo Campello / che presta / Il casino dell’antica Treja / Dramma. t.: [Paolo Campello ?]. D. Pavonio Capo Priore […] e vanaglorioso, D. Vernaccia secondo Prio-
re bevitore, D. Pirata campione sparlatore, Il Segretario, Don Paolino, Zucca trombetta, Atri servi, e famigli. 3 atti.
[1663–1713; Roma o Spoleto?]. U »Olà sappia ciascuno / dei Trombetti e famigli«.
(25) F. ms. n. 76.
Raccolta di poesie. t.: Paolo Campello Autogr.[1663-1702; Roma o Spoleto?]. Della presente antologia si ripor-
tano solo i testi per musica. In inv.: 1702, Paolo di Campello. U
1. Amore improprio / Cantata pp. 159–164; p. 164, arietta aggiunta. »Quando l’Alba, lucida e bella«.
211 CAMPELLO, Storia documentata (v. nota 1).
Il fondo dei Campello di Spoleto 153
2. Infedeltà in amore è doverosa / Cantata / Posta in musica dal Sig.r / Freschi .
m.: [Giovan Domenico] Freschi. pp. 165–170. a 2v, p.169, »1 Più d’un amata« e »2 Più d’una bella«. »Mentre Febo al corso accinto«.
3. Tempesta amorosa / Cantata / Musica del Sig.r Don Aurelio Paolini
m.: Aurelio Paolini. pp. 171ss. »Vela bisogna intendere«.
4. Bacio / Cantata / musica del Sig.r Paolini.
m.: Aurelio Paolini. pp. 174–177. »Taci [...]! O’ questo no!«
5. Introduzione a Balletto / Filli.
pp. 207s. In indice: »Cantata«. A 2 v: p. 207: »1 O selve gradite« e »2 O fiori che date«.
»O selve gradite«. 6. Lontananza medicina / d’amore / Posta in musica dal Sig.r D. Aure-lio / Paolini.
m.: Aurelio Paolini. pp. 210s. »Chi mi addita, chi mi addita«.
7. Sdegno amoroso / Cantata / Posta in musica dal Sig.r Bernardo Pa-squini.
m.: Bernardo Pasquini. pp. 213s. [Roma ?] »Da quell’empia non voglio pietà«.
Teresa Chirico 154
8. La Fede Trionfante / Per l’Eresia soggiogata da S. Antonio / di Pado-va / Oratorio per l’istesso Santo.
1° coro, 2° coro, S. Antonio, Capitano della nave, Pluto, Coro di De-moni, Marinari, Eresia.
pp. 233–254; [Roma e Spoleto?]. A pp. 252ss., ariette aggiunte; p. 233: »Da principio all’Oratorio una Sinfonia che rappresenta una tem-pesta di mare e due cori di navigatori nella stessa tempesta.«
»All’erta nocchieri«. 9. Cantata a Tré / Per la Santiss.ma Concettione della Madre di Dio.
Lucifero, Natura Humana, Maria Vergine. pp. 255–259. Luc. »Ho vinto«, Nat.: »Cadei«.
10. Presagio di felicità nelle nozze de SSig.ri Fulvio Amidei, / e Colonna Baglioni ornato dalle loro insegne Gen= / tilizie, che sono del primo è una fascia d’oro in campo / rosso, dell’altra una sbarra gialla in campo turchino / Serenata a 3.
Arturo, Imeneo, Amore. pp. 273–278. »De la notte nel profondo«.
11. Serenata a tre / Primo e Secondo Amante et il Sonno / Fatta per la Sig.ra Principessa Pallavicini.
Primo Amante, Secondo Amante, Sonno. pp. 279–285. [1670–1702 ?; Roma ?]. La d. molto probabilmente era
diretta a Maria Camilla Pallavicini, dama genovese moglie dal 1670 di Giovan Battista Rospigliosi duca di Zagarolo, FRANCHI
212, p. 886.
»Vaghi lumi destatevi omai«. 12. Cantata / Per l’Eminentissimo Sig.r Cardinale Marescotti tornando dalla / Nuntiatura di Spagna Fatto Cardinale da N. S. / Papa Clemente Decimo
m.: [Tommaso] Tizi. 212 FRANCHI, Drammaturgia romana (v. nota 11).
Il fondo dei Campello di Spoleto 155
Virtù, Honore, Roma. pp. 286–289. [27 maggio 1675; Roma], data in cui Galeazzo Mare-
scotti diventa cardinale. A p. 286, sotto il titolo: »L’Arme di S.E. è un’Aquila con Gigli. La Virtù, l’Honore e Roma Applaudono le di lui Glorie. Posta in musica dal Titii Maestro della Cappella Pontificia e can-tata avanti il S. Collegio. A 3«.
»Riconduci più lucido il giorno«. 13. Cantata / Alle Glorie del Sig.r Card. Pietro Ottoboni
Fama, Fortuna. pp. 290ss. [1689] Data del cardinalato di Pietro Ottoboni, datazione
suggerita dal contenuto del testo. Sotto il titolo: »A 2. La Fama e la For-tuna«.
»Venticelli, che instabili e infidi«. 14. Fatti e non parole Cantata / Drammatica a tre
Eurillo, Clori, Filli. 3 »azioni«. pp.292–338. [1690–1713]. A p. 292: »La scena in Arcadia / Bosca-
reccia«, scritta probabilmente per una riunione dell’Arcadia. Si riporta il titolo che compare in indice. Altra copia in F. ms. N.S., cart. B, fasc. 3/5.
»Chi m’insegna come stia«.
(26) F. ms. n. 70. [Giuseppe]. Oratorio. Nilo, Abondanza, Penuria. t.: [Paolo Campello] [1663–1713; Roma o Spoleto?]. L’autore è segnalato nell’inv. del fondo.
A c. 1: »Prologo«. U »Tacete homai tacete«.
(27) F. ms. N.S. cart. A/6.
Niceta oratorio. t.:[Paolo Campello ?]. Niceta contralto, Il prefetto d’Egitto baritono, La madre del santo tenore,
La donna finta sposa del suddetto soprano.
Teresa Chirico 156
[1689–1713; Roma ?]. Grafìa della seconda parte di Paolo Campello. Il testo reca molte correzioni anche riguardo ai registri vocali. U
»Dunque prìa che adorare i nostri Die«. (28) F. ms. n. 65.
Raccolta di testi effettuata dopo il 1712.
1. La costanza vittoriosa rappresentato / nel Martirio di S. Giuliano M. Alesan- /drino / Oratorio / A 4 Voci.
t.: [Paolo Campello ?] Angelo, S. Giuliano, S. Euno, Giudice, Choro d’Angeli. Autogr. ? [1702 ca.;] Roma. Grafìa di Paolo Campello. Eusebio, »Hi-
storia lib. 6, Cap. 34, e Niceforo lib.5, Cap. 30 […] di Decio Imperato-re«.U
»Quanto grandi Euno sono«.
2. S. Clotilde Oratorio à 4 Voci / cantato nella Chiesa di S. Simone de / PP. Conventuali di Spoleti il giorno / della Festa di S. Antonio di Pado-va / Nel Anno 1711.
t.: [Giovan Battista Taroni]; m.: [Flavio Carlo Lanciani]. Clodoveo, S. Clotilde, S. Remigio, Aureliano. 13 giugno 1711; Spoleto, Chiesa di S. Simone. Grafìa di Paolo Cam-
pello. MORELLI213
, p. 168, n. 159. »Infelice quel momento«.
3. L’Ape industriosa in / S. Cecilia / Oratorio.
t.: [Giovanni Nicolò Benedetti]; m.: [Quirino Colombani]. S. Cecilia, S. Valeriano, S. Tiburtio, Almachio prefetto di Roma. [1700-1707 c.ca]. Cfr. altra copia in 28.5. »Contenti cessate«. SARTORI214, n. 2232, nella festa della Santa nell’Oratorio di S. Filippo
Neri a Perugia nel 1705. S. Cecilia (S), S. Valeriano (A), S. Tiburtio (T), Almachio (B).
213 MORELLI, La circolazione (v. nota 69). 214 SARTORI, I libretti (v. nota 18)
Il fondo dei Campello di Spoleto 157
4. S. Dimpna Principessa d’ / Irlanda V.M. Oratorio Sacro / a 4 voci cantato nella Collegiata / di Trevi per la festa di S. Emiliano / fu Vesco-vo e M. della Terra hora di / Trevi li 28 Gennaro 1708 Musica del / P. Bacci Filippino in Perugia / Parole del Signor Abbate Doni Perugino / Dedicato a Monsignor Giuseppe Fer- / rau Napolitano Presside del Um- / bria, e Governatore di Perugia.
t.: [Carlo] Doni; m.: [Pietro Jacopo] Bacci. Re d’Irlanda padre di S. Dimpna (A), Consigliero (T), Gerbeuno pa-
dre spirituale di S. Dimpna (B), S. Dimpna (C). 28 Gennaio 1708; Trevi, Collegiata. Inoltre: 5 maggio 1711; Spoleto,
Chiesa di S. Simone.»Detto oratorio fu recitato in Spoleti nella Chiesa di S. Simone de’ PP. Minori Conventuali alli 5 maggio 1711 con l’occasione di una congregazione annuale di detti PP. che fanno i Guar-diani. In [sic] medesimo oratorio di S. Dimpna si fece pure di nuovo da’ PP. del Oratorio di S. Filippo Nerij di detta Città l’anno 1712 alli 29 maggio per S. Filippo Nerij domenica sua [...] del Santo che si celebrò la sua Festa.« L’autore della musica Bacci è da identificarsi con Pietro Ja-copo, che aveva musicato due oratori dati a Perugia: Abigail (1691) e San Romualdo (1706), MORELLI215, p.133 n. 1, e p. 164, n. 143. Grafìa di Paolo Campello.
»Amor indegno amore«. SARTORI216, n. 20809, Trevi, 28 gennaio 1708, »poesia di N.N. Arca-
de Incognito«, molte concordanze con il presente front.; SARTORI, n. 20807: dato a Perugia nel 1707 per la festa di S. Cecilia nell’oratorio di S. Filippo Neri, testo di Cesennio Issunteo pastore Arcade (Carlo Doni); n. 20808: Recanati; Sala Priorale, 15 giugno 1708. 5. L’Ape industriosa in S. Cecilia / Oratorio da cantarsi nella Catedrale / di Spoleti per la Festa di S. Cecilia / da solennizarsi da Signori Musici della / medesima Città di Spoleti l’anno / 1707.
1707; Spoleto, Cattedrale. Grafìa di Paolo Campello. Cfr. copia in 28.3.
215 MORELLI, op. cit. 216 SARTORI, op. cit.
Teresa Chirico 158
6. Il Trionfo della Verginità / rapresentato nel Martirio di S. Lucia / Vergine Siracusana / Oratorio a 4 Voci.
t.: [Paolo Campello ?] S. Lucia, Pascasio, Fortezza, Humanità. Autogr. ? [1680–1713; Spoleto ?]. Grafìa di Paolo Campello. U »Infelice Humanità / Fortunata fortezza«.
7. L’Assalonne / Oratorio / A Quattro Voci / Recitato e Stampati [sic] in Terni. / Di Logisto Nemeo Confondatore [sic] / e Decano dell’Accademia / Degli Arcadi di Roma.
t.: [Francesco M. Campello o Bernardino Francesco Campello ?]. Assalonne, Jela, Davide, Joabbe. [1712 ?; Terni]. CAMPELLO217, pp. 64s., attribuisce l’oratorio a Ber-
nardino Francesco, dicendo che fu stampato a Terni da Legnaioli nel 1712 con d. a Lucia Canali Castelli. Grafìa di Francesco Maria Campel-lo. U
»Tu piangi, Iela, e d’Assalon l’amore«.
8. L’occisione di Abel / Oratorio / Posto in musica dal Signore Felice Mercuriali / da Cantarsi nella Chiesa Nuova l’anno / 1708.
t.: [Benedetto Pamphilj]; m.: Felice Mercuriali. Adamo, Eva, Abel, Caino.
1708; [Roma]. »Folle Adamo / Eva infelice«. Eseguito a Roma per la prima volta nella Chiesa Nuova con m. di A-
lessandro Melani, 1678 (Il sacrificio di Abel), MORELLI218, n. 104, n. 260, e MORELLI219, pp. 160s., n. 127. Inoltre, dato al Palazzo della Can-celleria a Roma nel 1708, SARTORI
220, n. 21 (Abelle).
217 CAMPELLO, Storia documentata (v. nota 1). 218 MORELLI, Il »Theatro spirituale« (v. nota 27). 219 MORELLI, La circolazione (v. nota 69). 220 SARTORI, op. cit.
Il fondo dei Campello di Spoleto 159
9. La Gloria dell’Umbria / rapresentata nel Martirio di S. Ponziano / Nobile Spoletino e’ Protettore Principale / della Città di Spoleti Capo della Umbria / Oratorio a 4 Voci.
t.: [Paolo Campello ?] S. Pontiano, Madre di S. Pontiano, Antonino Imperatore, Fabiano
Prefetto dell’Umbria. Autogr.? [1680–1713; Spoleto ?]. Grafìa di Paolo Campello. U »Figlio mio fiero cordoglio«.
10. Il Trionfo della Divina Gratia / rapresentato nella Penitenza di S. / Pelagia Antiochena stata / prima famosa Peccatrice / Oratorio a 4 Voci.
t.: [Paolo Campello ?] S. Pelagia, S. Nonno Vescovo di Eliopoli, Narciso Amante della San-
ta, Piacere, Choro di Penitenti. Autogr. ? [1680–1713; Spoleto ?]. Grafìa di Paolo Campello. U »Vuoi goder nel fior degli anni«.
11. Del Signor Giovan Battista Grappelli / Cantata per Musica in tempo di Passione s’intro- / duce Madalena e Giovanni che parlano.
t.: Giovan Battista Grappelli [1680–1713; Roma ?]. Ultimo f., altra scrittura: »Oratorio da mettersi
in musica per il Venerdì Santo«. U »Madalena / Giovanni / Tra martirij, e tra pene«.
(29) F. ms. N.S., cart. B, fasc.3/6.
S. Geneviefa. t.: [Girolamo Gigli]; m.: [Giuseppe Fabbrini] S. Geneviefa, Sifrido, Benoni, Eurindo, Rogilda, Zamira, Golo. 3 atti. [1685 ca.; Roma ?]. SARTORI221, n. 11508, I-Rc, Siena, Collegio Tolomei »nell’aprimento del
loro nuovo teatro«, 1° febbraio 1685; n. 11509, I-Rsc, G.CS.3.C.26. In Gi-gli, Poesie drammatiche 1700, Venezia e Padova, imprimatur 1699, incipit: »Figlio tu dormi, e io sospiro sempre«; i personaggi variano rispetto al testo ms. 221 Ibid.
Teresa Chirico 160
»Sommo Dio son questi fiori«. (30) F. ms. n. 130.
1. I [sic] leone di Giuda / in ombra / overo / Il Gioas / Drama [sic] sa-cro / Alla Sacra et Augustissima Maestà / di / Leopoldo / Imperatore, d. a Leopoldo I di Vienna.
t.: Girolamo Gigli. Gioasso, Gioad, Giosabetta, Attalia, Matan, Coro di Leviti e del po-
polo fedele, Coro di idolatri. [25 dicembre 1696; Siena] In: Opere nuove del signor Girolamo Gigli, Accademico Acceso, cioè
il Leone di Giuda in ombra, overo il Gioasso […], Venezia 1704. »Giosaba amata sposa, è ver, che i cieli«.
2. La Giuditta / Oratorio per musica / dedicato / [cancellato, d. a Du-chessa di Zagarolo].
t.: Girolamo Gigli; m.: [Giuseppe Fabbrini] Giuditta, Abra, Ozia, Oloferne, 2° capitano, Coro d’Ebrei, Coro
d’Assirij. [22 maggio 1699; Zagarolo?] Teatro Rospigliosi. In fondo alla d. »22
maggio 1699«. »Miei fidi, ecco Bettulia«. MORELLI222, p. 145, n. 55, Firenze 1692-1694, Compagnia dell’Ar-
cangiolo Raffaello detta La Scala. SARTORI223, n. 12113, Siena 1693, d. a M. Lucrezia e M. Candida Rospigliosi; n. 12117, Siena, 1697, ded. Otta-vio Grimaldi, n. 12105.
(31) F. ms. N.S., cart. B, fasc. 3 /4.
Dirindina farsa per gl’intermedi dell’Ambleto t.: [Girolamo Gigli]; m.: [Domenico Scarlatti]. Don Carissimo, Dirindina, Liscione.
222 MORELLI, op. cit. 223 SARTORI, op. cit.
Il fondo dei Campello di Spoleto 161
[febbraio 1715; Roma, Teatro Capranica, non rappresentata]. SCAR-LATTI224.
»Signora Dirindina«. (32) F. ms. N.S., cart. B, fasc. 3/3.
La pugna d’amore contro Amore / nella Madre de i Maccabei / Oratorio a / tre.
t.: [Pietro Ottoboni?] Madre (S), Amor divino (A), Amor profano (B), T. 2 parti. [1701–1703 ?; Roma ?]. Si tratta forse di una parte aggiunta (intermezzo
?) all’oratorio di Girolamo Gigli La Madre dei Maccabei dato a Roma tra il 1701 e il 1703 presso l’Oratorio di San Filippo Neri. MORELLI225, p. 149. U
»All’armi alla battaglia / pretende in un core«. (33) F. ms. N.S., cart. B, fasc. 3 /2.
Oratorio / Giuditta, Oloferne, Nutrice. t.: [Antonio Ottoboni]; m.: [Alessandro Scarlatti]. Giuditta, Oloferne, Nutrice. [13 marzo 1695; Roma, Palazzo della Cancelleria]. Grafìa di Paolo
Campello. L’oratorio fu replicato in casa Vidman il 10 marzo 1697 con mu-sici e sonatori del cardinale Ottoboni, STAFFIERI226, pp. 251, 259. TALBOT –TIMMS227, p. 401.
»Nutrice al fato Assiro«. (34) F. ms., n. 105.
Heraclio / Imperatore d’Oriente Tragedia / Tradotta da Pietro Cornelio / et / Accomodata all’uso delli Teatri / Musicali di Venezia / dal N.H.M. / Antonio Otthoboni Cavaliere e / Procurator di S. Marco / L’anno MDCCVIII.
t.: Antonio Ottoboni. Foca, Heraclio, Martiano, Pulcheria, Leontina, Eudone, Crispo, Exupero,
Aminta, un Paggio. 5 atti. 224 SCARLATTI, La Dirindina (v. nota 90). 225 MORELLI, La circolazione (v. nota 69). 226 STAFFIERI, Colligite Fragmenta (v. nota 59) 227 TALBOT – TIMMS, Music and poetry (v. nota 93).
Teresa Chirico 162
1708; Venezia. U »Crispo, pur troppo è vero«.
(35) F. ms. n. 55.
Si riportano solo i testi per musica. Senza cartulazione. Raccolta dei te-sti: 1695–1740.
1. La Bersabea. Oratorio / Del Sig. Michel Brugueres. t.: Michel Brugueres; m.: [Giovanni Lorenzo Lulier]. David, Uria, Bersabea, Consigliere, Profeta, Testo, Soldati. [1692; Roma, Palazzo della Cancelleria]. Prima rappr. ante 1678 a
Bologna con musica di Paolo Petti; in successive rappresentazioni m. probabilmente di Giuseppe Torelli e Giulio D’Alessandri. A Roma, Pa-lazzo della Cancelleria nel 1692 con patrocinio di Pietro Ottoboni, m. di Giovanni Lorenzo Lulier, MORELLI228, pp. 126s., 136.
»Era nella stagione / in cui varcato il cerchio«. SARTORI229, n. 3980: I-MOe, 1689, m. Giulio D’Alessandri di Mila-
no. MORELLI230: I-Rv, mss. nn. 106, 157; I-Ras, ms. n. 222; I-Rli, ms. n. 285.
2. Jefte / tragedia sacra per musica / Da recitarsi / in forma d’oratorio / del [manca].
t.: [Girolamo Frigimelica Roberti]; m.: [Carlo Francesco Pollarolo]. Jefte, Seila, Sartoria, Azaria, Manasse, Semsi, Coro. 5 atti. [1680–1702 ca.; Venezia o Roma ] »Mira, mira o Manasse« SARTORI
231, n. 14016: I-Rsc, Pollaroli »vice maestro della Cappella
ducale di S. Marco in Venezia«, s. d., su copertina, aggiunta a mano: »Venezia 1680«; qualche discordanza nei personaggi. SARTORI
232, n.
14017: B-Bc, 1702. Partit. in MS Codex 16 561, A-Wn **29. 228 MORELLI, op. cit. 229 SARTORI, I libretti (v. nota 18). 230 MORELLI, op. cit. 231 SARTORI, op. cit. 232 Idem.
Il fondo dei Campello di Spoleto 163
3. L’Eco istrutta [cantata]. t.: [Giuseppe Domenico ] De Totis. [1664–1707; Roma ?]. Accanto al titolo, in alto a sinistra: De Totis.
Accanto a »Se già vidde il Campidoglio«: »1«; idem, accanto a »Perché sparge ombra sì grata«: »2«. U
»Mentre per vie non trite«.
4. L’Ucello in gabbia [cantata]. t.: [Giuseppe Domenico ] De Totis. [1664–1707; Roma?]. Accanto al titolo: »De Totis«. U »In palagio regal da tetto d’oro«.
5. La Didone [cantata].
t.: [Giuseppe Domenico De Totis ?]; m.: [Bernardo Pasquini]. [1664–1707; Roma ?]. A f. [?], sopra di »La regina spogliata
d’onore«: »2«. Per S, 2 vl, b.c. »Sopra un’eccelsa pira«. Partit.: I-FIc, F.I.33 in antologia (»Sopra un’accesa pira«).
6. Pel ritorno di Giacomo II al Regno d’Inghilterra / Cantata.
t.: ?; m.: [Alessandro Scarlatti] [1690; Roma ?]. Per S, 2 vl, b.c. »Già lusingato appieno«. Partit.: D-Hs, MA /252, ff. 75–91v.
7. Senza titolo [cantata].
t.: Pietro Bolis. [1660–1710; Roma ?]. All’inizio del f.: »Pietro Bolis«. U »Assiso sovra un sasso«.
8. La Danae [cantata].
t.: ? [1660–1710; Roma ?]. Accanto al testo: »2«. U »Nel cor d’eccelsa Ione«.
Teresa Chirico 164
9. Il Leandro [cantata]. t.: ?; m.: [Alessandro Scarlatti] [1693; Roma?]. Accanto al testo: »2«. Per S e b.c. PAGANO –
ROSTIROLLA233, p. 440, catalogo a cura di G. Rostirolla, n. 633. »Su le sponde d’Abido«. Partit.: I-NAc e F-Pn.
10. [Adonia] [opera].
t.: [Pietro Ottoboni]; m.: [Carlo Francesco Pollarolo]. Abisaghe, Adonia, Gionata, Salomone, Rosmada, Natano, Davide,
Bersabea, Cori. 5 atti. [Novembre 1695; Roma, Palazzo della Cancelleria]. Alla fine del
terzo atto: »Il ballo del coro presente va fatto al tempo che movano gl’istrumenti sempre«. Varie indicazioni di regìa. Per concordanza con personaggi e data copiatura, VOLPICELLI
234, p. 710. U
»Deh frena l’ira, e ’l passo, ed ancor pensa«.
11. La strage degl’Innocenti / Oratorio di Clemente IX Rospigliosi. t.: [Giulio Rospigliosi]. Testo, Ragion di stato, Herode, Pietà, Soldato, Donna I, Donna II. [1670; Roma, Oratorio dei Filippini]. Copia tarda; nel testo si tro-
vano discordanze rispetto alle fonti conosciute; forse le modifiche fu-rono apportate da Pietro Ottoboni.
»Da i Re dell’Oriente«. MORELLI 235 , p. 152, n. 87, anno 1670 Roma, Filippini, e
MORELLI236, n. 1, anno 1677 (nelle due fonti i personaggi non coinci-dono totalmente). SARTORI237, n. 17138, stesso titolo in Oratori sacri […] nella chiesa di S. Maria Cortelandini nelle veglie del SS.mo Na-tale quest’anno 1694, Lucca.
233 Roberto PAGANO – Giancarlo ROSTIROLLA, Alessandro Scarlatti, Torino 1972 234 VOLPICELLI, Il Teatro del Cardinale Ottoboni (v. nota 111). 235 MORELLI, La circolazione (v. nota 69). 236 MORELLI, Il »Theatro spirituale« (v. nota 27). 237 SARTORI, I libretti (v. nota 18).
Il fondo dei Campello di Spoleto 165
(36) F. ms. N.S., cart. A, fasc.1 /3. Senza titolo [Adonia].
t.: [Pietro Ottoboni]. Adonia, Joab, Abisaghe, Davide, Bersabea, Salomone, Natan, Sadoc,
Lisia, Stamene, Cori, Geni. Tragedia in versi (endecasillabi) in 5 atti con intermezzi in musica.
[1699; Roma, Palazzo della Cancelleria ?], CRESCIMBENI238, p. 116. Nell’inv. si segnala come Adoni. L’ultimo atto è costituito da fogli sparsi e danneggiati dal fuoco. Per datazione, cfr. spese di copiatura (»Tragedia di Salomone«) in: VOLPICELLI
239, p.731s. Presenza di numerose indica-
zioni di regìa, macchine teatrali, intermezzi. U »Desta Adonia nel generoso petto«.
(37) F. ms. N.S., cart. A, fasc. 2/1.
L’Amore eroico frà Pastori / Favola pastorale / Per / Musica / Per / l’Anno 1696 / Dedicata alli Signori Accademici dell’Arcadia.
t.: [Pietro Ottoboni]; m.: [Carlo Cesarini, Giovanni Lulier, Giovanni Bononcini].
Eurilla, Liso, Licisca, Olindo, Serpetta, Neralbo, Choro di ninfe, Cho-ro di pastori. 3 atti.
Autogr. [carnevale 1696; Roma, Palazzo della Cancelleria]. STAFFIERI240, p. 124. CRESCIMBENI241, pp. 102, 103, 130. Molte corre-zioni e indicazioni di regìa; particelle di testo incollate sul testo origina-rio. U
»Un’amante pastorella chi soccorre per pietà«. (38) F. ms. N.S. cart. C, fasc. 4/11.
[Costantino Pio]. t.: [Pietro Ottoboni]; m.: [Carlo Francesco Pollarolo]. Costantino, Costanza, Planco, Massimiano, Fausta, Licinio, Drusilla,
Religione, Fama, Fede. [3 atti]
238 CRESCIMBENI, La Bellezza (v. nota 49). 239 VOLPICELLI, Il Teatro del Cardinale Ottoboni (v. nota 111) 240 STAFFIERI, Colligite Fragmenta (v. nota 59). 241 CRESCIMBENI, La Bellezza (v. nota 49).
Teresa Chirico 166
[21 gennaio 1710; Roma, Palazzo della Cancelleria]. Mutilo, è pre-sente solo il III atto. SARTORI242, p. 243, n. 6764.
(39) F. ms. N.S. cart. A, fasc. 1/4.
s. titolo [Teodosio il giovane]. t.: [Pietro Ottoboni], m.: [Filippo Amadei]. Teodosio, Pulcheria, Marciano, Atanaide, Acrisia, Varane, Eridione.
3 atti. [9 gennaio 1711; Roma, Palazzo della Cancelleria]. Diverse indica-
zioni di regìa. Presenta varianti rispetto all’esemplare a stampa. SARTORI243, n. 23045.
»Trombe invitte il suon guerriero«. (40) F. ms. N.S., cart. A, fasc. 1 /8.
La Climene overo Nell’Incostanza la fede Dramma per musica a 6. t.: [Pietro Ottoboni?] Climene principessa di Creta, Fidauro principe di Atene, Elimero
principe d’Efeso, Dalmira sua sorella, Bagoro re d’Efeso loro zio, Doril-la damigella di Dalmira. 3 atti.
[1689-1740; Roma ?] U »Empi fermate, oh Dio«.
(41) F. ms. N.S. cart. B, fasc. 3/16.
La contessa di Megara Dramma per musica. t.: [Pietro Ottoboni ?] Aldimiro, Temisto, Dorinda, Lesbia. 3 atti. [1690–1740; Roma ?]. Scritto su lettera indirizzata al cardinale Pietro
Ottoboni. Molte correzioni. U »Se cortesia luogo aver può«.
242 SARTORI, I libretti (v. nota 18). 243 Idem.
Il fondo dei Campello di Spoleto 167
(42) F. ms. N.S. cart. B, fasc. 3 /9. Olimpia regina d’Epiro. t.: [Francesco Maria Campello ?] Olimpia regina d’Epiro, Alicandro, Lidoro, Idalba, Pandolfo, Rolinda,
Coro. 3 atti. [1689–1740; Roma ?]. Altra copia mutila e s. titolo in F. ms. N.S. cart.
A, fasc. 1/4, una volta erroneamente catalogata sotto Pandolfo; frammenti scritti su lettere indirizzate all’avvocato [Francesco] Campello e al cardinale Ottoboni. Diverse indicazioni di regìa, es., c. [1]: »cantando da dentro«, F. ms. N.S. cart. C. U
»Onde fiere, onde spietate che al mio sol tomba già deste«. (43) F. ms. N.S., cart. B, fasc. 3 (8).
Amore è sempre Amore / Drama. t.: [Pietro Ottoboni ?] Angelica, Medoro. 3 atti. [1689–1740; Roma ?]. Fonti: »Si legge né celebri Poemi del Boiardo, e
dell’Ariosto è il soggetto«. U »Cieli non chieggio vita«.
(44) F. ms. N.S. cart. B, fasc. 3/s. n.
s. titolo. opera t.: [Paolo Campello ?, Pietro Ottoboni ?] Arbante, Quartilla, Irene, Daliso. 3 atti. [1689–1740 ?; Roma ?] U »È nata l’alba appena«.
(45) F. ms. n. 123.
La Croce ricuperata. Tragedia in versi con parti in musica. t.: [Pietro Ottoboni ?] Ambitione, Humiltà, Eraclio, Adamasto, Battrano, Triface, Enarto, Cali-
siro, Volturno, Alceste, Elisa, Evandro, Cosoroa, Sarbarasso, Armallo, A-drasto, Sciroe, Medrasan, Alvida, Clitia, Erinta, Anfimene, la Discordia, Amore in musica, Coro di musici. Prologo in musica (Ambitione, Humiltà) e 5 atti.
Teresa Chirico 168
[1691?; Roma] Molte indicazioni di regìa e sugli strumenti e registri vo-cali. U
»L’Ambitione son io«. (46) F. ms. n. 107.
1. La forza d’Amore / Cantata scenica / a due Soprani, / et Basso. t.: [Pietro Ottoboni ?] Silvio, Nise, Filli. [1689–1740; Roma ?]. A p. 2: »La scena rappresenta la campagna di
Roma vicino al mare con boschi, et acque«. U »Scuote l’Alba il ricco manto«. 2. s. titolo [Agrippina] Opera.
t.: [Giuseppe Domenico De Totis]; m.: [Giovanni Lorenzo Lulier]. Agrippina, Caligola, Germanico, Armilla, Giunio, Settimio, Orestilla,
Planco, Giulia. 3 atti. [Carnevale 1691; Roma, Tordinona, non rappresentata]. L’opera non
fu rappresentata per la sopravvenuta morte del papa Alessandro VIII, CAMETTI244, p. 347, MARX245, pp. 99s. Per anno esatto delle spese di co-piatura dell’opera, cfr. VOLPICELLI246, pp. 700s. Grafìa del secondo atto di Paolo Campello. U
»Tacete o là tacete«.
3. Santa Rosa di Lima. Oratorio. t.: [Giuseppe Domenico De Totis] Senso, Penitenza, S. Rosa, Padre, Madre. [1669–1672 ca.; Roma]. La grafìa è simile a quella presente
nell’oratorio di Rospigliosi (35.11); si tratta probabilmente di una copia tarda. Aggiunta recente a matita su c. [1]: »Di Francesco Maria / conte di Campello / sec.i XVII e XVIII«.
»A le gioie, a le gioie, al riso, al canto«.
244 CAMETTI, Il teatro di Tordinona (v. nota 166) 245 MARX, Die Musik am Hofe Pietro Kardinal Ottobonis (v. nota 118). 246 VOLPICELLI, Il Teatro del Cardinale Ottoboni (v. nota 111).
Il fondo dei Campello di Spoleto 169
MORELLI247, nn. 91, 171, 215 (S. Rosa del Perù). (47) F. ms. n. 40, misc, cc. [132–133v].
Dialogo tra Amor Divino e la Fede alla sacra maestà di Maria Casimira regina di Polonia.
t.: [Pietro Ottoboni] Amor Divino, Fede. [Autogr.] [9 agosto 1703, Roma, Trinità dei Monti]. Alla fine della can-
tata, sigla »P« e »O« intrecciate. GRIFFIN248, pp. 401s. U »Con face divina«.
(48) F. ms. N.S., cart. A, fasc.1 /2.
La Pulcella d’Orleans / Oratorio per Musica / di / Giovan Battista Ta-roni.
t.: Giovanni Battista Taroni; m.: [Pietro Giuseppe Sandoni] Giovanna d’Arco, Aspasio Capitano di Carlo VII, Giudice inglese, Capi-
tano inglese. [1700 ca.] U »Non ha cuore chi spreggia il cimento«. SARTORI249, n. 19313, Cento 1701, m. Pietro Giuseppe Sandoni, ded. agli
Accademici dell’Aurora. (49) F. ms. N.S. cart. C, fasc. 4 /2.
Convito di Baltasar / Oratorio a sei voci / Poesia di Pietro Alessandro / Ginori.
t.: Pietro Alessandro Ginori; m.: [Carlo Francesco Pollarolo] Baldassarre, Consigliere, Regina madre di Baldassarre, Daniele profeta,
Ciro re dei Persiani, Capitano di Ciro, Coro. [Quaresima 1708; Roma, Palazzo della Cancelleria]. Rappresentato an-
che a Foligno nel 1713. »Eccelsi eroi, del mio sublime impero«. SARTORI250, n. 6630.
247 MORELLI, Il »Theatro spirituale« (v. nota 27). 248 GRIFFIN, The late Baroque (v. nota 150). 249 SARTORI, I libretti (v. nota 18).
Teresa Chirico 170
(50) F. ms. N.S., cart. B, fasc. 14. S. Agnese oratorio a 4 voci. S.Agnese, Angelo, Flavio figlio del Prefetto di Roma, Lucio Vicario del
Prefetto di Roma. t.: ? [1689–1740; Roma ?]. U »Mio Giesù cuor del mio cuore«.
(51) F. ms. N.S. cart. C, fasc. 4 /1.
L’antichissima città di Trevi / Festeggiante per la villeggiatura / a cui in essa, loro Patria, s’ornan da Roma l’Ottobre i due Ill.mi e E.mi Monsignori Lodovico / Valenti promotor della Fede e Filippo Valenti Cameriere d’onore di nostro signore Benedetto XIV / Dialogo pastorale.
t.: ? Alessi, Elpino. [1740–1758; Trevi ?] (papato di Benedetto XIV). U »Piansi, o Elpin, come sai piansi quel giorno«.
(52) F. ms., n. 104.
Arsace / Re de’ Parti / Drama, d.a Audalgo Toledermio P. A. (Girolamo Teodoli).
t.: Logisto Nemeo (Francesco Maria Campello). Elmiro, Idreno, Aldimero, Tiferne, Clomiri, Mindori, Popolo (Coro). 3
atti. Autogr. 1° marzo 1719; [Roma]. Fonte: Giustino, Istorie, lib.12 e 41.
Due esemplari (stessa coll.), uno dei quali autogr. Altra copia, fasc. sciolti, in F. ms. N.S., cart. C, fasc. 4 /4. U
»O del Partico Mondo eroi guerrieri«. (53) F. ms. N.S., cart. B, fasc. 3 /11.
Amore vince amore. Dramma pastorale. t.: Logisto Nemeo (Francesco Maria Campello).
250 Idem.
Il fondo dei Campello di Spoleto 171
Eurillo pastore, Clori ninfa, Fille ninfa. 3 atti. [1690-1740; Roma]. Sonetto dedicato a Crateo (card. Pietro Ottoboni). Co-pia in F. ms. N.S., cart. C, fasc.4 /12. U
»Chi mi dice per pietà / come sta questo mio core«.
Teresa Chirico 172
CRONOLOGIA DEI TESTI PER MUSICA E CON MUSICA DEL FONDO CAMPELLO La data è quella che compare nella fonte; può non coincidere con la data di prima rappresentazione dell’opera. Data
Luogo Titolo Autore testo Autore musica
Dedica
17. 6. 1606
Bologna Tirinto (1) Giovanni Capponi
? Giovanni Fi-lippo Certani
16. 9. 1641
Civita Ca-stellana
Il martirio de’ Santi […] (2) Intermedi: I) La civetta II) Il pedante
Ottavio Tronsarelli
Domenico Mazzocchi [Virgilio Mazzocchi] ?
Paolo Borghese principe di Rossano
26. 5. 1647
Siena La Datira (3) [Giulio Ro-spigliosi ?]
?
[1660– 1677]
[Roma] S. Didimo e S. Teodora (8)
[Pietro Filip-po] Bernini
?
[1660– 1680 ca.]
[Roma ?] Virginità (6)
Fabrizio Hon De Dei
Cesare Masi-no
[1660– 1710]
[Roma ?] Assiso sovra un sasso (35.7)
Pietro Bolis ?
[1660– 1710]
[Roma ?] La Danae (35.8)
? ?
[1661– 1680 ?]
[Spoleto ?] Trionfo d'amore in maschera (4)
Solone Cam-pello
?
5. 2. 1663
[Spoleto, Accademia degli Ottusi]
Clomiri (11) Paolo Cam-pello
?
[1663– 1700]
[Roma ?] Mario in Carta-gine (18)
[Paolo Cam-pello]
?
[1663– 1702]
[Roma o Spoleto ?]
Amore improprio (25.1)
Paolo Cam-pello
?
[1663– 1702]
[Roma o Spoleto ?]
Infedeltà in amo-re è doverosa (25.2)
Paolo Cam-pello
Giovan Do-menico Fre-schi
Il fondo dei Campello di Spoleto 173
[1663– 1702]
[Roma o Spoleto ?]
Tempesta amoro-sa (25.3)
Paolo Cam-pello
Aurelio Pao-lini
[1663– 1702]
[Roma o Spoleto ?]
Bacio (25.4) Paolo Cam-pello
Aurelio Pao-lini
[1663– 1702]
[Roma o Spoleto ?]
Introduzione a Balletto. Filli (25.5)
Paolo Cam-pello
?
[1663– 1702]
[Roma ?] Lontananza medicina d'amo-re (25.6)
Paolo Cam-pello
Aurelio Pao-lini
[1663– 1702]
[Roma o Spoleto ?]
Sdegno amoroso (25.7)
Paolo Cam-pello
Bernardo Pasquini
[1663– 1702]
[Roma e/o Spoleto ?]
La Fede trion-fante per l’Eresia soggiogata da S. Antonio da Pa-dova (25.8)
Paolo Cam-pello
?
[1663– 1702]
? Cantata a tre per la Santissima Concettione della Madre di Dio (25.9)
Paolo Cam-pello
?
[1663– 1702]
[Roma o Spoleto ?]
Presagio di feli-cità […] (25.10)
Paolo Cam-pello
?
[1663– 1713]
[Roma o Spoleto]
Mitridate (21) [Paolo Cam-pello?]
?
[1663– 1713]
[Roma ?] La Gelosia non è buona Guardia-na (23)
[Paolo Cam-pello]
?
[1663–1713]
[Roma o Spoleto ?]
[Giuseppe] (26) [Paolo Cam-pello]
?
[1663– 1713]
[Roma o Spoleto ?]
Il casino dell’antica Treja (24)
[Paolo Cam-pello ?]
?
[1664– 1707]
[Roma ?] L’Eco istrutta (35.3)
[Giuseppe Domenico] De Totis
?
[1664– 1707]
[Roma ?] L’Ucello in gab-bia (35.4)
[Giuseppe Domenico] De Totis
?
[1664– 1707]
[Roma ?] La Didone (35.5)
[Giuseppe Domenico
[Bernardo Pasquini]
Teresa Chirico 174
De Totis ?] 4. 11. 1667
Spoleto Il Demetrio (12)
Paolo Cam-pello
? »V.A.« [Prin-cipe ereditario di Toscana]
[1667– 1713]
[Roma ? Spoleto ?]
Seleuco (13) [Paolo Cam-pello]
?
[1669– 1672 ca.]
[Roma] Santa Rosa di Lima (46.3)
[Giuseppe Domenico De Totis]
?
[1670] [Roma, Ora-torio dei Filippini]
La strage de-gl'innocenti (35.11)
Giulio Ro-spigliosi
?
[1670– 1702]
[Roma ?] Serenata a tre […] per la Sig.ra Principessa Pallavicini (25.11)
Paolo Cam-pello
?
[1671] [Roma, Ora-torio dei Filippini]
La conversione di S. Agostino (7)
Cesare Maz-zei
[Giovanni Bicilli]
[27. 5. 1675]
[Roma] Cantata Per l'Eminentissimo Sig.r Cardinale Marescotti […](25.12)
Paolo Cam-pello
[Tommaso] Tizi
[Galeazzo] Marescotti
1675 [Cortona ?] L’amore in ma-schera o vero Gl’affetti confusi (5)
Sebastiano Zaccagnini
?
[1680– 1702 ca.]
[Venezia o Roma]
Jefte (35.2) [Girolamo Frigimelica Roberti]
[Carlo Fran-cesco Polla-rolo]
[1680– 1713]
[Spoleto ?] Il trionfo della verginità (28.6)
[Paolo Cam-pello ?]
?
[1680– 1713]
[Spoleto ?] La gloria del-l'Umbria (28.9)
[Paolo Cam-pello ?]
?
[1680– 1713]
[Spoleto ?] Il trionfo della Divina Gratia (28.10)
[Paolo Cam-pello ?]
?
[1680– 1713]
[Roma ?] Cantata per Musica in tempo di Passione (28.11)
Giovan Bat-tista Grappel-li
?
[1685 [Roma ?] S. Geneviefa (29) [Girolamo [Giuseppe
Il fondo dei Campello di Spoleto 175
ca.] Gigli] Fabbrini] [1687– 1701 ?]
[Spoleto ?] Cantata s. titolo (10)
? ? [Giacomo II Stuart ?]
1689 Roma, [Pa-lazzo Pam-philj]
Oratorio di San-ta Beatrice d'E-ste (9)
[Benedetto Pamphilj o Giulio Cesa-re Grazzini]
[Giovanni Lulier; intro-duzione e sinfonia Arcangelo Corelli]
[1689] [Roma] Cantata alle glorie del sig.r cardinale Pietro Ottoboni (25.13)
Paolo Cam-pello
?
[1689– 1713]
[Roma, Pa-lazzo della Cancelle-ria ?]
Daliso (22)
[Paolo Cam-pello ?]
?
[1689– 1713]
[Roma] Niceta (27) [Paolo Cam-pello ?]
?
[1689– 1740]
[Roma] Amore è sempre Amore (43)
[Pietro Otto-boni ?]
?
[1689– 1740]
[Roma ?] La Climene ov-vero Nell’inco-stanza la fede (40)
[Pietro Otto-boni ?]
?
[1689– 1740]
[Roma] La contessa di Megara (41)
[Pietro Otto-boni ?]
?
[1689– 1740]
[Roma ?] Olimpia regina d’Epiro (42)
[Francesco Maria Cam-pello ?]
?
[1689– 1740]
[Roma ?] La forza d'amore (46.1)
[Pietro Otto-boni ?]
?
[1689– 1740]
[Roma ?] Sant’Agnese (50)
? ?
[1689– 1740 ?]
[Roma ?] Opera s. titolo (44)
[Paolo Cam-pello ? , Pietro Otto-boni ?]
?
[1690] [Roma ?] Pel ritorno di Giacomo II al Regno d’Inghil-terra (35.6)
? [Alessandro Scarlatti]
Teresa Chirico 176
[1690 ca. –1700]
[Roma o Zagarolo ?] Teatro Ro-spigliosi
Amor vuol gio-ventù (20)
Paolo Cam-pello
?
[1690–1713]
[Roma ?] Fatti e non paro-le (25.14)
Paolo Cam-pello
?
[1690– 1740]
[Roma] Amore vince amore (53)
Francesco Maria Cam-pello
? Pietro Ottoboni
[Carne-vale 1691]
Non rappre-sentata [Roma, Tea-tro di Tordi-nona]
[Agrippina] (46.2)
[Giuseppe Domenico De Totis]
[Giovanni Lorenzo Lulier]
[1691 ?] [Roma ?] La croce ricupe-rata (45)
[Pietro Otto-boni ?]
?
[Carne-vale 1692]
[Roma, Col-legio Cle-mentino ?]
I successori di Alessandro (14)
Paolo Cam-pello
[Francesco Gasparini ?]
[1692] [Roma, Pa-lazzo della Cancelleria]
Bersabea (35.1) Michel Bru-gueres
[Giovanni Lorenzo Lulier]
[1693] [Roma ?] Il Leandro (35.9) ? [Alessandro Scarlatti]
[feb-braio 1695]
[Roma, Tea-tro nel palaz-zo Rospiglio-si]
Pandolfo ovvero Male ha chi male opra (16)
[Paolo Cam-pello]
?
[carne-vale 1695]
[Roma, Se-minario Romano]
Il Tiridate ovvero Il Re da scena nel giuoco della fortuna (15)
[Paolo Cam-pello ? per gli intermez-zi]
? [Pietro Ottobo-ni]
[13. 3. 1695]
[Roma, Pa-lazzo della Cancelleria]
[Giuditta] (33) [Antonio Ottoboni]
[Alessandro Scarlatti]
[no-vembre 1695]
[Roma, Pa-lazzo della Cancelle-ria ?]
[Adoni] (35.10)
[Pietro Otto-boni ?]
[Carlo Fran-cesco Polla-rolo]
[carne-vale 1696]
[Roma, Pa-lazzo della Cancelleria]
L'Amore eroico frà Pastori (37)
[Pietro Otto-boni]
Carlo Cesa-rini, Giovan-ni Lulier, Giovanni Bononcini
Accademici dell'Arcadia
25. 12. Siena Il Leone di Giuda Girolamo ? Leopoldo I
Il fondo dei Campello di Spoleto 177
1696 (data dedica)
(luogo dedi-ca)
in ombra ovvero Il Gioas (30.1)
Gigli imperatore
[1696 ?] [Roma o Spoleto ?]
Radamisto (17) [Paolo Cam-pello]
[Bernardo Pasquini?]
22. 5. 1699 (data dedica)
[Zagarolo ?] Teatro Ro-spigliosi
La Giuditta (30.2)
Girolamo Gigli
[Giuseppe Fabbrini]
Duchessa di Zagarolo (can-cellato)
[1699] [Roma, Palazzo della Cancelle-ria ?]
[Adonia] (36) [Pietro Otto-boni]
?
[1700 ca.]
[Roma ?] Il battesimo di Atanaide (19)
[Paolo Cam-pello]
?
[1701– 1703]
[Roma ?] La pugna d'Amo-re contro Amore (32)
[Pietro Otto-boni ?]
?
[1700 ca.]
[Roma ?] La Pulcella d’Orleans (48)
Giovanni Battista Ta-roni
[Pietro Giu-seppe San-doni]
[1702 ca.]
Roma La costanza vittoriosa (28.1)
[Paolo Cam-pello ?]
?
[9. 8. 1703]
[Roma, Tri-nità dei Mon-ti]
Dialogo tra Amor Divino e la Fede (47)
[Pietro Otto-boni]
[Filippo Amadei]
Maria Casimira regina di Polo-nia
[1705] 1707
[Perugia] Spoleto, Cattedrale
L’Ape industrio-sa in / S. Cecilia (28.3)
[Giovanni Nicolò Be-nedetti]
[Quirino Colombani]
28. 1. 1708 5. 5. 1711 29. 5.
Trevi, Collegiata Spoleto, Chiesa di S. Simone de’ PP. Minori Conventuali Spoleto, Oratorio di S. Filippo Nerij
S. Dimpna Prin-cipessa d'Irlanda (28.4)
[Carlo] Doni [Pier Jacopo] Bacci
Giuseppe Fer-rau
Teresa Chirico 178
1712 [Quare-sima 1708]
[Roma, Pa-lazzo della Cancelleria]
Il convito di Baltasar (49)
Pietro Ales-sandro Gino-ri
[Carlo Fran-cesco Polla-rolo]
1708 [Roma], Chiesa Nuo-va
L'occisione di Abel (28.8)
[Benedetto Pamphilj]
Felice Mer-curiali
1708 Venezia Heraclio (34) Antonio Ottoboni
?
21.1. 1710
[Roma, Pa-lazzo della Cancelleria]
[Costantino Pio] (38) mutilo
[Pietro Otto-boni]
[Carlo Fran-cesco Polla-rolo]
9.1.1711 [Roma, Pa-lazzo della Cancelleria]
[Teodosio il giovane] (39)
[Pietro Otto-boni]
[Filippo Amadei]
13. 6. 1711
Spoleto, Chiesa di S. Simone
Santa Clotilde (28.2)
[Giovan Battista Ta-roni]
[Flavio Carlo Lanciani]
[1712 ?] [Terni] Assalonne (28.7)
[Francesco Maria Cam-pello o Ber-nardino Francesco Campello]
? [Lucia Canali Castelli ?]
[feb-braio 1715]
Non rappre-sentata [Roma, Tea-tro Caprani-ca]
La Dirindina (31)
[Girolamo Gigli]
[Domenico Scarlatti]
1.3.1719 [Roma] Arsace Re de’ Parti (52)
Francesco Maria Cam-pello
Audalgo Tole-dermio [mar-chese Girolamo Teodoli]
[1740– 1758]
[Trevi o Roma]
L’antichissima città di Trevi (51)
? ?