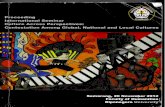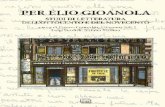Lo scontro di civiltà visto dagli altri: lo sguardo di Lakhous sull’Italia contemporanea, in...
-
Upload
univ-montp3 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Lo scontro di civiltà visto dagli altri: lo sguardo di Lakhous sull’Italia contemporanea, in...
3
P.I.E. Peter Lang
Bruxelles Bern Berlin Frankfurt am Main New York Oxford Wien
Dalla tragedia al giallo
Comico fuori posto e comico volontario
pages 1-6.p65 26/09/2012, 10:143
5
Costantino C. M. Maeder, Gian Paolo Giudicettie Amandine Mélan (a cura di)
Destini Incrociatin° 8
Dalla tragedia al giallo
Comico fuori posto e comico volontario
pages 1-6.p65 26/09/2012, 10:145
6
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelqueprocédé que ce soit, sans le consentement de l’éditeur ou de ses ayants droit,est illicite. Tous droits réservés.
© P.I.E. PETER LANG S.A.Éditions scientifiques internationales
Bruxelles, 20121 avenue Maurice, B-1050 Bruxelles, Belgiquewww.peterlang.com ; [email protected]
Imprimé en Allemagne
ISSN 2031-1311ISBN 978-90-5201-884-3
D/2012/5678/82
Information bibliographique publiée par « Die Deutsche Nationalbibliothek »« Die Deutsche Nationalbibliothek » répertorie cette publication dans la « DeutscheNationalbibliografie » ; les données bibliographiques détaillées sont disponibles sur le site<http://dnb.de>.
Ringraziamo il FNRS che ci ha permesso di organizzare duegiornate di studio sull’argomento, il Centro di studi italiani e ilDipartimento di studi romanzi dell’UCL che hanno contribuitoanche economicamente alla realizzazione di questo progetto, e inparticolare Paola Moreno (Université de Liège).
Un ultimo ringraziamento va a Stéphanie Delcroix, promettente
ricercatrice presso il nostro centro.
Il volume è stato sottoposto a una doppia revisione anonima(double blind peer review).
Publié avec le concours de la Fondation Universitaire de Belgique
pages 1-6.p65 26/09/2012, 10:146
7
Indice
Un’introduzione dislocata ..................................................................... 9
Costantino C. M. Maeder
Che cosa genera l’effetto comico?Fondamenti per un approccio semiotico............................................ 25
Harri Veivo
Per una semiotica del ridere ............................................................... 35
Alessandro Perissinotto
Il riso amaro della tragedia................................................................. 69
Valentina Gallo
Il teatro del Cinquecento tra il comico e l’ironico .......................... 101
Franco Musarra
“Tra le più savie teste d’Italia”Il riso di Francesco Guicciardini nelle pagine del carteggio .......... 121
Paola Moreno
La comicità (infantile) nell’Orlando Furioso ................................... 137
Gian Paolo Giudicetti
Il riso fra avventura e lacrime:la Trilogia dei moschettieri di Alexandre Dumas ........................... 157
Clotilde Bertoni
L’umorismo debordante di Achille Campanile.Spunti per una fenomenologia del comico fuori posto ................... 181
Pietro Benzoni
La solitudine dei satiri: Gadda e Flaiano ........................................ 203
Giuseppe Papponetti
Il giallo si tinge di comico .................................................................. 219
Inge Lanslots
Lo scontro di civiltà visto dagli altri:lo sguardo di Lakhous sull’Italia contemporanea .......................... 233
Daniele Comberiati
8
La fisiologia del sorriso in Ragazze che dovresti conoscere ........... 249
Monica Jansen
Il comico nella saggistica fra moderno e postmoderno:Svevo, Magris, Eco ............................................................................ 265
Ulla Musarra-Schrøder
Il comico nell’opera seria.Appunti su alcune strategie intermediali......................................... 283
Costantino C. M. Maeder
Ermanno Wolf-Ferrari e il comico goldonianosulla scena operistica italiana degli anni Trenta:La Vedova scaltra (1931) e Il Campiello (1936) .............................. 299
Walter Zidarič
Note biografiche................................................................................. 319
233
Lo scontro di civiltà visto dagli altri:lo sguardo di Lakhous sull’Italia contemporanea
Daniele COMBERIATI
Université libre de Bruxelles
La definizione di letteratura migrante è stata utilizzata per la primavolta in Italia da Armando Gnisci negli anni Novanta1 per designare leopere scritte in italiano da autori stranieri, provenienti per lo più dalflusso migratorio degli anni Ottanta. Durante la prima fase di tale storialetteraria, ci si è trovati di fronte a testi scritti a quattro mani, nei qualil’autore migrante veniva affiancato da uno scrittore o da un giornalistaitaliano. Questi primi scritti, generalmente autobiografici, una sorta direportage e di testimonianza sulle difficili condizioni di viaggio e diaccoglienza degli immigrati, hanno fatto registrare un acceso interesseda parte di case editrici importanti: la Garzanti ha pubblicato Io,venditore di elefanti del senegalese Pap Khouma, Theoria Immigrato delmarocchino Salah Methnani, De Agostini La promessa di Hamadi delsenegalese Saidou Moussa Ba e le edizioni e/o Volevo diventare biancadella francese di origine algerina Nassera Chohra.2 Gli scrittori migrantisono stati recepiti dalle case editrici e dal pubblico più come portatori diuna testimonianza e di un’esperienza particolare che come autori toutcourt, ed infatti sono stati gli stessi editori a rifiutare le seconde operedegli stessi, romanzi veri e propri o comunque testi in cui è la finzione aprendere il sopravvento sul reportage, scritti nella quasi totalità dei casisenza l’intervento del coautore italiano.
Ha inizio così la seconda fase della letteratura migrante: opere scritteinteramente in italiano da autori che si sono, per così dire, affrancati
1Cfr. A. GNISCI, La letteratura italiana della migrazione, Roma: Lilith, 1997.
2P. KHOUMA, Io, venditore di elefanti, a c. di O. PIVETTA, Milano: Garzanti, 1989;S. METHNANI, Immigrato, a c. di M. FORTUNATO, Roma, Theoria, 1990; S. MOUSSA
BA, La promessa di Hamadi, a c. di A. MICHELETTI, Novara: De Agostini, 1991;N. CHOHRA, Volevo diventare bianca, a c. di A. ATTI DI SARNO, Roma: Edizioni e/o,1993.
Daniele Comberiati
234
dallo scrittore o giornalista italiano e che pubblicano il loro secondoromanzo, ancora legato all’esperienza migratoria ma nonnecessariamente autobiografico, presso piccole case editrici oassociazioni culturali, al di fuori del circuito del grande pubblico. Nuoviautori si affacciano, attratti dalla possibilità di pubblicare piuttostofacilmente grazie a questo mercato culturale ridotto, dove spesso non visono vere e proprie strutture editoriali che controllano la qualità el’originalità delle opere: il panorama della letteratura migrante italofonadiventa così una costellazione di piccole o piccolissime case editrici, diautori di un solo libro, stranieri desiderosi di raccontare le proprieesperienze ad un (virtuale) pubblico italiano. Per alcuni autori, tale fasenon è mai finita: diverse sono tuttora le piccole pubblicazioni quasicompletamente al di fuori del mercato e autori occasionali continuano adapparire, per poi scomparire immediatamente, nella ormai imponentebibliografia di settore.3
Nel momento attuale, ci si trova di fronte a fenomeni nuovi: da unaparte emergono autori singoli (è il caso dell’iracheno Younis Tawfik,ma anche dello stesso Amara Lakhous) che sviluppano una propriapoetica a partire dall’esperienza migratoria, ma con riferimenti culturalipiù vasti, e possono essere apprezzati anche al di là del ristretto cerchiodegli studiosi del fenomeno; dall’altra ci troviamo di fronte a scrittori diseconda generazione, cittadini italiani nati da famiglie straniere o miste,per i quali la stessa definizione di “autori migranti” non appare del tuttoesatta. Un’ulteriore sezione è costituita inoltre dagli scrittori e dallescrittrici provenienti dalle antiche colonie italiane che stannoproponendo una nuova storia letteraria postcoloniale di espressioneitaliana.4
Amara Lakhous, l’autore di Scontro di civiltà per un ascensore apiazza Vittorio, appartiene a pieno diritto a tale fase. Giunto in Italiadall’Algeria nel 1995, ha pubblicato nel 1999 il suo primo romanzo, Lecimici e il pirata, che ha avuto non pochi problemi di censura in patria,poiché nella stessa pagina, a poche righe di distanza, l’autore avevainserito turpiloqui accanto a frammenti delle Sure del Corano. Il testo èstato così pubblicato in Italia bilingue arabo-italiano, tradotto da
3Cfr. per esempio le opere dello scrittore senegalese Mbacke Gadji, in particolareM. GADJI, Lo spirito delle sabbie gialle, Milano: Edizioni dell’Arco, 1999; Pap,Ngagne, Yatt e gli altri, Milano: Edizioni dell’Arco, 2000.
4Di grande interesse è a questo proposito il romanzo della scrittrice italo-somalaCristina Ubax Ali Farah, che in un elegante intreccio narrativo e linguistico tratta itemi della diaspora, della migrazione e della condizione femminile: C.U. ALI FARAH,Madre piccola, Milano: Frassinelli, 2007.
Lo scontro di civiltà visto dagli altri: lo sguardo di Lakhous sull’Italia
235
Francesco Leggio, per la casa editrice Arlem di Roma.5 È una sorta difalso romanzo di formazione, falso poiché l’ambientazione, l’Algeriacontemporanea, non consente realmente al personaggio principale diprogredire nella sua ricerca di un lavoro stabile e nella sua maturazioneinteriore, e la narrazione risponde ad una domanda incessante diLakhous: si può essere un uomo libero nell’Algeria contemporaneaoppure i suoi abitanti saranno costretti a vivere rimandandocontinuamente i propri sogni e camuffando le proprie reali aspettative?
Il secondo romanzo, dal titolo emblematico Kaifa tardaa min aldhiba duna an-taodak (in italiano letteralmente Come farsi allattaredalla lupa senza che ti morda), è stato inizialmente pubblicato in arabo,per le edizioni Al Ikhtilaf di Algeri.6 Da tale testo, senza l’aiuto di untraduttore, ma grazie ad un intenso lavoro di riscrittura, è nato ilromanzo Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio, editodalle edizioni e/o nel marzo 2006.7 Ambientato nella romana PiazzaVittorio, fino a qualche anno fa sede di uno storico mercato popolare etuttora centro del principale quartiere multietnico della capitale, ilromanzo, che ricorda sia il giallo che la commedia di costume, parte daun misterioso omicidio avvenuto in un condominio: LorenzoManfredini, detto il “Gladiatore”, è stato ucciso nell’ascensore, causa ditutti gli scontri fra condomini; lo stesso giorno è inoltre scomparso unsuo vicino, il misterioso Amedeo, apparentemente amato e stimato daicondomini, eppure introvabile dal giorno dell’omicidio.
Il primo elemento che colpisce nella costruzione della narrazioneromanzesca è la formula a monologo, con l’utilizzo reiterato della primapersona singolare, nella quale ciascuno degli undici personaggi, inun’ipotetica interrogazione da parte della polizia, fornisce la propriaversione dei fatti. Al termine di ciascun monologo, come un vero eproprio rovesciamento, vengono inserite alcune pagine del diario intimodi Amedeo, accusato dell’omicidio del Gladiatore. L’utilizzo degliundici monologhi e quindi degli undici (anzi dei dodici se viaggiungiamo anche il diario di Amedeo) punti di vista dei personaggi hauna funzione ben precisa: il fine dell’autore risiede infatti nella volontàdi mostrare la realtà migratoria, talvolta ignorata ed il più delle volte malconosciuta dagli autoctoni italiani; l’inserimento dei diversi punti divista serve a far capire come tale realtà sia più complessa di quanto sipensi e come gli stereotipi sugli immigrati siano molto spesso l’unico
5A. LAKHOUS, Le cimici e il pirata, traduzione di Francesco Leggio, Roma: Arlem,1999; poi con il titolo Un pirata piccolo piccolo, Roma: e/o, 2011.
6ID., Kaifa tardaa min al dhiba duna an-taodak, Alger: Al Ikhtilaf, 2003; Bāirut: Dar al arabiya li al ulum, 2006.
7ID., Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio, Roma: Edizioni e/o, 2006.
Daniele Comberiati
236
vero metro di giudizio. La pluralità dei punti di vista è inoltre unastrategia formale molto utilizzata negli autori migranti, soprattutto inquelli della terza fase: il romanzo Rhoda della somala Igiaba Scego, leraccolte di racconti della brasiliana Christiana de Caldas Brito, il testoNonno Dio e gli spiriti danzanti del senegalese Pap Khouma, fannoraccontare la vicenda a personaggi (o a gruppi di personaggi) diversi,mostrando così la molteplicità del reale e l’inutilità del cliché.8 Lapluralità dei punti di vista è spesso accompagnata da una polifonia cheal suo interno presenta registri linguistici differenti, e che costituisce lacifra stilistica principale del romanzo di Amara Lakhous.
Attraverso gli undici monologhi ed il diario, si dipana la doppiainchiesta del commissario Mauro Bettarini, che da una parte cerca dicomprendere chi sia stato ad uccidere il “Gladiatore”, mentre dall’altratenta di capire che fine abbia fatto Amedeo. La seconda indagine è peròsolo apparentemente parallela, perché si scoprirà in seguito come nonsia la ricerca di Amedeo il tassello mancante per scoprire l’omicida.L’autore in tal modo instrada il lettore su una falsa pista, poichéAmedeo, al di là del suo ruolo effettivo nell’omicidio del “Gladiatore”,diventa il centro catalizzatore della narrazione ed attira su di sé leattenzioni del lettore per distoglierle dal vero assassino. La costruzionedell’identità del protagonista sembra talvolta ripercorrere l’identicopercorso di ricomposizione degli eventi da parte del commissario e isuoi tentativi di fugare i punti oscuri della vicenda: nel lettorerimangono una serie di interrogativi irrisolti ed è in questo modo che ilpersonaggio di Amedeo si rivela come la chiave per comprendere ilsenso del romanzo. Come ciascun personaggio fornisce nel suomonologo una versione differente e dunque parziale dei fatti, così, inbase al proprio rapporto con Amedeo, ogni persona che lo ha conosciutone traccia un ritratto affatto diverso e talvolta persino contraddittorio.Non è un caso che il passato e molti aspetti enigmatici della suapersonalità vengano svelati solo poco prima della fine: è il monologo delsuo amico algerino Abdallah Ben Kadour a darci le ambite informazionied il mistero sul suo passato viene così definitivamente risolto. Ilmonologo successivo del commissario Bettarini dovrebbe in teoria solotirare le somme da una situazione in cui le carte sono tutte in tavola. Inrealtà, con un coup de théâtre finale, il commissario rivela ancora unavolta un’altra realtà, poiché è in possesso di un elemento (di un jolly sesi vuole continuare la metafora con il gioco delle carte) che il lettore nonconosce. Alla fine il commissario Bettarini estrapolerà dai dati in suo
8Cfr. I. SCEGO, Rhoda, Roma: Sinnos, 2004; C. DE CALDAS BRITO, Amanda OlindaAzzurra e le altre, Isernia: Cosmo Iannone, 2004; P. KHOUMA, Nonno Dio e glispiriti danzanti, Milano: Baldini&Castoldi Dalai, 2005.
Lo scontro di civiltà visto dagli altri: lo sguardo di Lakhous sull’Italia
237
possesso due conclusioni, entrambe attendibili e verosimili per quantoassolutamente in contrasto tra loro, e sarà proprio nell’impossibilità difar coesistere le due risoluzioni della vicenda che la struttura delromanzo giungerà al suo svelamento: un falso giallo, ovvero unacommedia di costume mascherata, “celata” sotto la forma del giallo, nelquale un’ipotetica doppia inchiesta, invece di portare alla risoluzionedell’enigma, si rivela un’indagine sul modo di vivere e di pensare di undeterminato ambiente.
Diventa a questo punto interessante cercare di capire quali siano imodelli comici presenti nel testo. Ve ne è un primo che saltaimmediatamente agli occhi e si rivela una sorta di guida, linguistica efilosofica, per leggere l’opera. Si tratta di Carlo Emilio Gadda e del suoromanzo Quer pasticciaccio brutto de via Merulana,9 i cui punti incomune con Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio sonomolteplici. Innanzitutto identica è l’ambientazione: via Merulanatermina in Piazza Vittorio ed il civico in questione nel romanzogaddiano, il duecentodiciannove, si trova proprio a pochi passi dallapiazza. L’idea di riprendere l’ambientazione di un testo classico e di unmodello alto della letteratura italiana, oltre che tipico espedienteletterario degli autori migranti e postcoloniali, fornisce la possibilità dimostrare i cambiamenti socio-antropologici che sono avvenuti nellegrandi città italiane con l’arrivo degli immigrati dalla seconda metàdegli anni Ottanta in poi. È un aspetto da analizzare con la dovutaconsiderazione perché l’idea stessa del romanzo è nata nella mentedell’autore dopo diversi anni di lavoro come mediatore culturale in uncentro per immigrati situato proprio a Piazza Vittorio e perché Lakhous,attento indagatore delle realtà socio-antropologiche dell’immigrazione,si è laureato in Antropologia culturale all’Università di Roma laSapienza e ha ultimato nella stessa università la tesi di dottorato Viverel’Islam in condizione di minorità: il caso della prima generazione diimmigrati arabi musulmani in Italia. L’importanza di Gadda, però, nonsi esaurisce nell’ambientazione: il plurilinguismo gaddiano viene presocome esempio e modello per delineare i tratti del linguaggio e delcarattere dei personaggi. Ci troviamo così di fronte alla portieranapoletana Benedetta Esposito, con il suo linguaggio colorito e pieno diformule scaramantiche e superstiziose; al romanesco del barista romanoSandro Dandini, angosciato da un presunto complotto dell’Italiasettentrionale contro la capitale; all’italiano intriso di termini edespressioni mutuati dal dialetto milanese del professore universitarioAntonio Marini, estremamente critico, fino a sfiorare il razzismo, sulla
9C.E. GADDA, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, Milano: Garzanti, 1957.
Daniele Comberiati
238
pigrizia e la lentezza dei romani. Accanto a loro si vedono gli immigrati:la donna delle pulizie peruviana Maria Cristina Gonzales, l’iranianoParviz Mansoor Samadi, il commerciante bengalese Iqbal Amir Allah etanti altri. La specificità linguistica adottata per ognuno di questipersonaggi (in particolare per i primi tre) ed il conseguenteplurilinguismo, hanno anche un ruolo nel senso ultimo del romanzo:come nel caso di Gadda, infatti, il plurilinguismo indica la complessità ela molteplicità del reale, e la rinuncia a trovare una soluzione univocaall’enigma ne è un esempio manifesto.
Vi è inoltre un altro riferimento comico preponderante: l’importanzadata al singolo personaggio, la possibilità che questi ha di esprimere lapropria personalità in un’interrogazione-monologo di stampo teatrale,non possono non ricordare alcuni aspetti della Commedia all’italiana.10
Come la Commedia all’italiana, il romanzo di Lakhous parte da unosfondo realista ed è completamente immerso nella contemporaneità, anzisi può senz’altro affermare che ne coglie gli aspetti di cambiamento edevoluzione. Nel monologo, a livello linguistico, viene valorizzata unacultura orale che emerge sotto forma di barzellette, proverbi, battute,doppi sensi, giochi di parole, stereotipi e luoghi comuni che costituivanola base dei monologhi dei personaggi dei film di Luciano Emmer o diMattoli. Dal punto di vista strutturale, inoltre, si può notare laprogressiva scomposizione della linearità della narrazione e laricomposizione del racconto in segmenti indipendenti e polifunzionali. Ildittico monologo-diario di Amedeo diventa nel romanzo un’unitàindipendente, come nei film comici ad episodi, e non è un caso che, daalcuni di questi dittici, decontestualizzati dal resto del romanzo, sianostate tratte opere teatrali assolutamente logiche e coerenti. La Commediaall’italiana viene inoltre citata esplicitamente in diverse occasioni: granparte del monologo dell’aspirante regista Johan Van Marten è basato sulcontrasto fra i suoi gusti cinematografici e quelli di Amedeo: se il primoè un fervente sostenitore del neorealismo e cerca di ritrovare lo spirito ele immagini di quel periodo nel quartiere dove fu girata una nota scenadi Ladri di biciclette di Vittorio De Sica, il secondo è un amante dellaCommedia all’italiana, della sua capacità di fondere tragico e grottescoriuscendo sempre ad essere attuale e a portare lo spettatore verso unariflessione sulla realtà contemporanea. Altre citazioni esplicite dellaCommedia all’italiana sono inserite nel monologo del professoremilanese Antonio Marini, come si vedrà ampiamente in seguito, e non sipuò ovviamente dimenticare l’importanza di Totò per la napoletana
10Per un approccio iniziale alle tematiche e allo stile della Commedia all’italiana, cfr.G. BRUNETTA, Cent’anni di cinema italiano, vol. II, Dal 1945 ai giorni nostri,Roma-Bari: Laterza, 1995, in particolare il capitolo XIV.
Lo scontro di civiltà visto dagli altri: lo sguardo di Lakhous sull’Italia
239
Benedetta Esposito, più volte menzionato e preso come punto diriferimento. Grazie ad un’analisi ulteriore, infine, si può comprenderequale sia il film che, al pari del Pasticciaccio di Gadda, funga dariferimento all’intera narrazione: Divorzio all’italiana di Pietro Germi.In entrambe le opere, infatti, il punto di partenza è una riflessione su unelemento sociale (l’approvazione della legge sul divorzio nel film diGermi, l’integrazione degli immigrati nel romanzo di Lakhous), cheperò viene celata dalla struttura della commedia noir, che attraversa ilgiallo e la commedia di costume. In sintonia con il film di Germi,inoltre, vi è il coup de théâtre finale, in cui le conclusioni logiche dellettore/spettatore vengono rimesse completamente in discussione.
È fondamentale analizzare in maniera più approfondita la produzionedel comico nel romanzo di Amara Lakhous, evidenziando le strategieformali con le quali è messo in atto, attraverso esempi tratti dalromanzo. Per la classificazione delle diverse modalità con cui il comicoviene presentato, si farà riferimento al saggio di Giulio Ferroni, Ilcomico nelle teorie contemporanee, e al precedente saggio di HenriBergson, Le rire. Essai sur la signification du comique, citato e preso adesempio, tra l’altro, proprio nel lavoro di Ferroni.11
Alcune delle categorie utilizzate da Bergson per svelare laproduzione del comico sono in Scontro di civiltà per un ascensore aPiazza Vittorio perfettamente riconoscibili. In primo luogo ci troviamodi fronte al camuffamento continuo dei nomi e degli attributi deipersonaggi: uno dei temi portanti del romanzo è infatti l’abitudine diciascun personaggio a guardare solo le proprie esigenze e a nonconsiderare minimamente le personalità e le abitudini altrui. La diversitàdi Amedeo, d’altra parte, si manifesta proprio nell’attenzione e nellapropensione all’ascolto verso gli altri condomini, che, unite allareticenza a parlare di se stesso, contribuiscono a rendere enigmatico ilsuo passato. Nel guardare solo se stessi vi è il rischio di noncomprendere gli altri, come accade a molti protagonisti, in particolarmodo alla portiera napoletana, Benedetta Esposito. La sua fobiadell’altro e del diverso la porta a confondere continuamente nomi,nazionalità e caratteristiche degli abitanti del condominio e delquartiere: l’iraniano Parviz diventa così un pericoloso albanese ed il suosolito ringraziamento, “merci” (che in iraniano significa “grazie”)acquista le parvenze di un’ingiuria della peggior specie; la peruvianaMaria Cristina Gonzales diventa filippina, in base ad un luogo comunesecondo il quale siano soprattutto le filippine ad assistere gli anziani
11G. FERRONI, Il comico nelle teorie contemporanee, Roma: Bulzoni, 1989;H. BERGSON, Le rire. Essai sur la signification du comique, Paris: Editions Alcan,1924; trad. it. Il riso. Saggio sul significato del comico, Milano: Mondadori, 1992.
Daniele Comberiati
240
nelle case private; il bengalese Iqbal Amir Allah viene scambiato peruno spacciatore pakistano, per lui orribile insulto, poiché il Pakistan è ilpaese con cui il Bengala ha combattuto la guerra d’indipendenza nel1971. Allo stesso modo i poliziotti confondono il suo nome e il suocognome, non riuscendo a distinguere quale sia il nome proprio e qualequello di famiglia, causandogli notevoli problemi di coscienza e diidentità, che lo portano a temere di essere scambiato per un terrorista e ascegliere di chiamare il prossimo figlio con un nome italiano, ondeevitare ulteriori fraintendimenti. Il misconoscimento e il travisamentodei nomi e delle personalità altrui creano così evidenti conclusionicomiche: il fatto di considerare insulti parole come “merci” e“pakistano” genera una serie di effetti a catena che contraddistinguonola narrazione. Misconoscimento e travisamento sono inoltre due degliaspetti che costituiscono la formazione dello stereotipo razzista, secondola definizione che ne dà Bruno Maria Mazzara nei saggi Stereotipi epregiudizi e Appartenenza e pregiudizio.12 Secondo lo studioso italiano,uno dei procedimenti con i quali lo stereotipo prende forma è quellodella “profezia che si auto-adempie”. In tal caso pregiudizi e valutazionipreventive sono talmente radicate in un soggetto da condizionareimmagine e percezione dell’altro, cambiandone le caratteristiche perseguire la propria aspettativa. È ciò che accade spesso nei confronti diminoranze etniche, sociali o religiose, e che è alla base di un razzismodiffuso, come le stesse esperienze emigratorie italiane possonotestimoniare.13 Nel capitolo dedicato alla signora Esposito, inoltre, moltodivertenti si rivelano le sue ripetizioni linguistiche e concettuali: irichiami continui alla Madonna e a San Gennaro, l’esibizione insistentedi un pensiero religioso basato sulla superstizione, l’utilizzo reiterato diparole di chiara origine napoletana come “scuorno”, creano un ulterioreaspetto umoristico nel testo, come si può notare da questo breve estratto:
Sono di Napoli, lo dico forte e senza mettermi scuorno. Poi perché dovreivergognarmi? Per caso Totò non è nato a Napoli? È il più grande attore delmondo, ha vinto cinque volte l’Oscar. Io sono un’ammiratrice di Totò, nonme ne perdo neanche uno dei suoi film e me li ricordo tutti a memoria. […]Mi chiamo Benedetta, però a molti piace chiamarmi la Napoletana. Questosoprannome non mi dà fastidio. So che molti inquilini del palazzo non misopportano e mi odiano senza motivo anche se io sono brava nel mio lavoro.Chiedete un po’ qual è il palazzo più pulito di tutta piazza Vittorio e virisponderanno senza esitare: “Il palazzo di Benedetta Esposito” [p. 41].
12B.M. MAZZARA, Stereotipi e pregiudizi, Bologna: Il Mulino, 1997; Appartenenza epregiudizio: psicologia sociale delle relazioni interetniche, Roma: Carocci, 2005.
13Cfr. a questo proposito il saggio di E. FRANZINA, G.A. STELLA, “Brutta gente. Ilrazzismo anti-italiano”, in AA. VV., Storia dell’emigrazione italiana, a c. di P.BEVILACQUA, A. DE CLEMENTI e E. FRANZINA, Roma: Donzelli, 2001, pp. 290-309.
Lo scontro di civiltà visto dagli altri: lo sguardo di Lakhous sull’Italia
241
Nell’ambito della ricerca dei modi di produzione del comico nelromanzo, non si può certo dimenticare il ruolo che gioca nellacostruzione della narrazione il diario di Amedeo, posto ogni volta altermine di ciascun monologo. Il diario, che l’autore chiama anche“ululato” poiché rappresenta un vero e proprio sfogo (non è un caso cheil diario non venga scritto, ma abbia bisogno del supporto audio delregistratore), rappresenta un costante rovesciamento delle verità espressenei monologhi. È grazie al diario di Amedeo, infatti, che veniamo aconoscenza dei fraintendimenti della signora Esposito: ci rendiamoconto della rabbia del bengalese Iqbal per essere stato chiamato“pakistano”, dell’insofferenza di Parviz, che considera la signora unagrande maleducata perché non risponde ai suoi ringraziamenti edell’imbarazzo di Maria Cristina per essere considerata filippina. Si puòanche affermare che il diario rappresenti ogni volta un’inversione dellesituazioni ed un colpo di scena per il lettore: la dicotomia monologo-diario porta ad un rovesciamento completo della realtà. Se ammettiamoche neanche quella fornita da Amedeo sia la reale versione dei fatti, marappresenti esclusivamente il suo punto di vista, possiamo così notarecome, fin dal suo segmento primario, il romanzo presenti al lettorequello che sarà poi il suo senso ultimo: la difficoltà (l’impossibilità?) ditrovare una sola realtà e una sola verità che contengano le visioniunivoche di ciascun personaggio.
Ugualmente utilizzato è il processo di degradazione, secondo ilquale vengono espressi in toni bassi e talvolta volutamente trivialiargomenti per cui sarebbe maggiormente adatto un registro più elevato.Sono molto interessanti a tale proposito le disamine di BenedettaEsposito sulla situazione politica italiana e in particolare sull’esito delprocesso all’ex Presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Le suevalutazioni sulla Prima Repubblica italiana vengono infarcite diconsiderazioni banali e luoghi comuni, mentre a supporto delle sue tesila donna inserisce elementi del tutto arbitrari, come l’innocenza diAndreotti e un auspicato ritorno alla politica di un tempo, in cui laDemocrazia Cristiana costituiva un punto di riferimento per unadeterminata tipologia di elettorato centro-meridionale:
Guardate che cosa è successo al povero Giulio Andreotti: dopo aver servitolo stato per decenni, è stato accusato di essere uno della mafia! Maro’,aiutace tu! Anzi, l’hanno accusato di aver baciato in bocca Riina! Chescuorno! Che scandalo! Chi può credere a questa menzogna? Quel poverocristo di Andreotti è un vero cattolico. Non si perde mai una messa, è unvero signore, e come dice Totò: “Signori si nasce”. Io sono pronta atestimoniare al tribunale di Palermo a voce alta: “Andreotti ha baciato unasola mano, quella del Santo Padre!” [p. 42].
Daniele Comberiati
242
Cercando inoltre di capire chi possa essere stato a rapire il cagnolinodell’inquilina Elisabetta Fagiani, Benedetta Esposito afferma consicurezza che i colpevoli non possono essere altri che i cinesi, visto chenella zona hanno molti ristoranti e che, “notoriamente”, utilizzano lacarne di cane nelle loro ricette. Allo stesso modo il professore di storiaall’Università la Sapienza, Antonio Marini, di origine milanese, siabbandona a convenzionalità imbarazzanti per la sua professionenell’intento di spiegare la famigerata pigrizia dei romani e, più ingenerale, le cause della “doppia economia” italiana. Nei film dell’attoreromano Alberto Sordi trova le spiegazioni per la presunta arroganza deicapitolini e considera il Sud la parte sottosviluppata dell’Italia:l’ascensore diventa per lui un simbolo quasi illuminista di progresso, ela portiera napoletana che ne controlla, e più spesso ne impedisce, l’uso,rappresenta il classico esempio di mentalità meridionale retrograda epiena di pregiudizi verso la modernità.
Così la gente del nord lavora, produce, paga le tasse, e la gente del sudsfrutta questa ricchezza per costituire bande criminali come mafia, camorra,‘ndrangheta e le bande di rapitori in Sardegna. Il dramma è che il nord è ungigante economico e un nano politico […] La situazione non è cambiatarispetto al passato, la mentalità è rimasta la stessa. Non ci aiuta la fuga inavanti, è giunto il momento di ammettere che l’unità d’Italia è stato unerrore storico irrimediabile [p. 106].
Altra procedura classica con cui il comico viene messo in atto èquello dell’interferenza, ovvero dell’accostamento, all’interno di unastessa frase o situazione, di due elementi differenti ed il più delle voltecontrapposti, come uno alto e uno basso, oppure come la combinazionedi elementi esotici accanto ad altri conosciuti e tipicamente italiani. Allafine del monologo della peruviana Maria Cristina Gonzales, peresempio, la donna, dopo aver presentato la sua triste condizione fisica,sentimentale e legale (notevolmente ingrassata, più volte incinta ecostretta ad abortire, senza permesso di soggiorno, dedita all’alcool persolitudine e disperazione), si lascia trasportare dai suoi sogni e dalle suesperanze più grandi: sogna di dimagrire, di diventare un’attrice bella efamosa per poter finalmente riuscire ad utilizzare l’ascensore, poichéBenedetta Esposito la costringe regolarmente ad usare le scale. Il lettoreche si aspetta in questo caso una voglia di riscatto per una vita miglioreresta colpito: assolutamente assorta dai suoi problemi, la povera MariaCristina non riesce neanche a vedere un roseo futuro per lei; ogni ipotesiè legata alla specifica realtà che sta vivendo e così un futuro migliore èesemplificato soprattutto dalla possibilità di prendere finalmentel’ascensore.
Anche il titolo del romanzo, Scontro di civiltà per un ascensore apiazza Vittorio, mette insieme nella stessa frase un elemento alto (il
Lo scontro di civiltà visto dagli altri: lo sguardo di Lakhous sull’Italia
243
famigerato “scontro di civiltà” fra la cultura occidentale e quellaislamica, espressione tratta dal saggio di Samuel Huntington The Clashof Civilizations e di cui molto si parla attualmente14) ed un elementoconcreto che riduce notevolmente la portata dello scontro: un sempliceascensore in un condominio di una piazza romana, per il quale peròemergono tutti i problemi di percezione dell’altro e di interazione fra iprotagonisti. Va tra l’altro notato che in Algeria vi era una grandetradizione di racconti popolari comici in cui venivano sapientementemescolate cultura alta e cultura bassa: come accadeva in Rabelais,15 cosìnei racconti popolari arabi, in particolare in quelli che avevano perprotagonista Giuha, sorta di trickster presente in tutte le culture delMediterraneo, i personaggi mostravano appieno la propria ambivalenza,proprio come i condomini di Lakhous.16 Probabilmente l’autore ha presospunto anche dalla propria cultura di origine nel creare situazioni in cuielementi contrastanti fossero costantemente a contatto. Il legame conRabelais invece è rafforzato dall’uso costante della maschera popolare edalla messa in scena di un mondo con propri riferimenti culturali, allevolte molto lontani dalle regole comunemente accettate.
Un ulteriore effetto di straniamento è generato nel lettore dalleinvenzioni culinarie dell’iraniano Parviz Mansoor Samadi, esperto dicucina del suo paese e acerrimo nemico di pizza e pasta. Parviz unisce,per cena, il “ghorme sabiz”, piatto tipico iraniano, con un nostranoChianti, per festeggiare insieme ad Amedeo e ritrovare, in cucina, gliodori e i sapori della sua terra. L’ossessione di Parviz contro la cucinaitaliana porta ad un ultimo procedimento di messa in atto del comico:l’esagerazione. Una questione che potrebbe essere semplicementeriferita al gusto personale e alle abitudini culinarie, si trasforma per luiin una vera e propria ossessione, simbolo del malessere della sua vita inItalia. Ma è soprattutto l’ascensore che esemplifica l’esagerazione, acausa dell’importanza incredibile che gli viene attribuita dai personaggi.Esso diventa di volta in volta uno spazio per pensare e riflettere (nelcaso di Parviz), un luogo dove sfogare le pulsioni più recondite e leproprie frustrazioni (come è accaduto al defunto Gladiatore), il simbolo
14S.P. HUNTINGTON, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order,New York: Simon & Schuster, 1996; trad. it. Lo scontro di civiltà e il nuovo ordinemondiale, Milano: Garzanti, 1997.
15Cfr. a tale proposito M. BACHTIN, Tvorcestvo Fransua Rable i narodnaja kul’turasrednevekov’ja i Renessansa, Moskva, Chudozestvennaja literatura, 1965; trad. it.L’opera di Rabelais e la cultura popolare: riso, carnevale e festa nella tradizionemedievale e rinascimentale, Torino: Einaudi, 1979.
16E. CONSOLE, C. GÜTERMANN e S. VILLATA (a c. di), Racconti arabi, introduzione diF. PEIRONE, Milano: Mondadori, 1989.
Daniele Comberiati
244
del proprio lavoro e quindi della propria condizione sociale (come per laportiera napoletana Benedetta Esposito), l’immagine del progresso edella modernità (per il professore milanese Antonio Marini) e infine larappresentazione di un futuro migliore, nelle speranze di Maria CristinaGonzales.
Inoltre l’ascensore si appropria di altre simbologie nell’ambito dellanarrazione: poiché molti protagonisti del romanzo sono immigrati, e lostesso autore è giunto in Italia abbandonando il proprio paese,l’ascensore, come ha ottimamente visto il giornalista ed espertodell’islam Khaled Fouad Allam,17 diventa anche metafora del viaggio, erappresenta il mezzo del passaggio da un paese all’altro e da una vitaall’altra. Da tale metafora se ne genera subito un’altra, piuttostocomprensibile se si tiene presente il processo di riscrittura dall’arabo cheè alla base della versione italiana del romanzo: il passaggio da un pianoall’altro, quindi da un paese all’altro, diventa anche il passaggio da unalingua all’altra e il risultato è un linguaggio ibrido, meticcio, dove siconfondono termini arabi e idiomi dialettali, detti, proverbi popolari emetafore calcistiche, e dove le citazioni colte si accompagnano avocaboli ed espressioni appartenenti ad un linguaggio prosaico e pocoelevato. La grande capacità dell’autore risiede proprio nel tentativo diricostruire, da un punto di vista esterno, le varie caratteristichelinguistiche italiane, come è possibile notare in particolar modo neicapitoli dedicati alla signora napoletana Benedetta Esposito, al baristaromano Sandro Dandini e al professore milanese Antonio Marini. Talerilevanza degli idiomi dialettali italiani rende evidente il processo diriscrittura, che non è assolutamente riducibile ad una mera auto-traduzione: nella versione in arabo che in un certo senso può essereconsiderata quella originale, infatti, le diversità dei registri linguisticierano espresse in maniera affatto diversa, poiché difficilmente i lettorisarebbero riusciti a comprendere un’ironia basata su modi di dire e suspecifiche situazioni culturali italiane. L’autore aveva in quel casooptato per personaggi che mostravano la propria identità linguistica eculturale grazie al diverso rapporto con la religione: Benedetta Esposito,per fare un esempio più volte citato, enfatizzava la propria religiosità edevozione rispetto alla versione italiana, religiosità che si rifletteva sulsuo linguaggio producendo un’ironia certamente più comprensibile peril pubblico algerino.
Si è potuto inoltre notare quanta importanza rivestano il concetto dimaschera e l’inversione dei punti di vista. Entrambi portano alla stessa
17K. F. ALLAM, “Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio – AmaraLakhous racconta la quotidianità degli immigrati”, La Repubblica, 11 maggio 2006,p. 58.
Lo scontro di civiltà visto dagli altri: lo sguardo di Lakhous sull’Italia
245
conclusione, al leit-motiv del romanzo: la verità non esiste, esistono solosomme di verità. Il concetto è espresso, esplicitamente, con unacitazione tratta da Il giorno della civetta di Sciascia18 posta come incipitdel testo e ripetuta nel diario di Amedeo successivo al monologo diBenedetta Esposito: “La verità è nel fondo di un pozzo: lei guarda in unpozzo e vede il sole o la luna; ma se si butta giù non c’è più sole né luna,c’è la verità”. L’impossibilità di ritrovare una verità univoca, checomprenda le molteplici sfaccettature della vita reale, si collega all’altropunto focale del romanzo: l’analisi delle problematiche dell’identità edell’alterità. I concetti di alterità e identità costituiscono infatti i cardinidel pensiero filosofico che soggiace al romanzo, avvalorando la tesi chela verità sia composta da innumerevoli verità parziali. L’alterità emergein modi diversi: dal punto di vista linguistico, per esempio, conl’immissione di termini stranieri non tradotti come i piatti di Parviz, iluoghi descritti da Abdallah, alcune citazioni di Amedeo; tali vocaboli,pur non immediatamente riconoscibili, rivestono una funzione evocativae non costituiscono affatto un problema alla comprensione del testo,anzi introducono il lettore, anche linguisticamente, verso una realtàaltra. La parola nel romanzo è sempre dialogica e l’opera si installa inun percorso intertestuale nel quale il linguaggio fa sempre trasparire ilsuo doppio. Si può certamente affermare che in Lakhous il comico abbiala carica eversiva di rompere il monologismo istituzionale e di portareall’intertesto, al rapporto con l’altro inteso come altra lingua, altracultura, altra persona che ci sta attorno e con la quale siamo costretti,volenti o nolenti, a rapportarci. L’esperienza migratoria ed il successivoprocesso di riscrittura hanno quindi portato ad un’alterità ben visibileattraverso un linguaggio che lascia trasparire continuamente l’arabooriginario, che a sua volta si proponeva come lingua ibrida, poiché iltesto è nato ed è stato concepito a Roma, e l’italiano ha necessariamenteimmesso nella lingua araba nomi di luoghi, persone, specificità culturalie sensazioni.
Importante appare inoltre la formazione dell’identità dei personaggi:ciascuno di loro proietta negli altri un’immagine ed un’idea diversa daciò che in realtà ritiene di essere (dal nome proprio alla nazionalità, dalfraintendimento degli atteggiamenti agli equivoci sulle parolepronunciate). L’identità, come la verità, esiste solo in quanto somma diidentità diverse, ed ogni personaggio si completa con diverse immaginie diverse proiezioni di sé. Alla stessa maniera dello scrittore surrealistafrancese René Daumal, Lakhous vede nell’elemento comico la capacitàdi mettere a nudo la frantumazione dell’universo e il carattere
18L. SCIASCIA, Il giorno della civetta, Torino: Einaudi, 1961.
Daniele Comberiati
246
imponderabile dell’esistenza individuale: il riso è anche il segnale di unadimensione sociale ben precisa, perché ridere significa cercare diavvicinarsi all’altro, dare spazio ad un tentativo di contatto fra soggettoe oggetto.19 Per tali ragioni nel romanzo nessun personaggio ride maiinsieme ad un altro: la complicità possibile viene sempre negata in nomedi uno “scontro di civiltà” che appare piuttosto un pretesto percontinuare a non volersi conoscere realmente.
Ci si potrebbe chiedere a questo punto quale sia il ruolo del comiconella ricerca del senso del romanzo: se si prendono in esame leconsiderazioni di Sigmund Freud sull’importanza del motto di spirito(Witz)20 e su ciò che esso sottintende, si può arrivare a comprenderecome il comico nasconda sempre significati psichici inconsci e comespesso li celi attraverso un processo di spostamento; è per tale motivoche l’ascensore diventa il fulcro catalizzatore dei problemi fra ipersonaggi, nascondendo di fatto la realtà dei contrasti più profondi, ma,così facendo, anche la possibilità di risolverli. Dietro agli aspetti piùgrotteschi e ridicoli che provocano il riso, si nascondono i problemi realidell’esistenza dei personaggi. Ogni monologo che fa nascere una risatatrova immediatamente, nell’ululato di Amedeo, il suo rovesciamento e ilsuo corrispettivo critico; se si ritorna per un momento al saggio diPirandello L’umorismo21 e si analizzano le due definizioni di comico eumorismo, secondo le quali il comico è “sentimento del contrario”,mentre l’umorismo è “avvertimento del contrario”, si può pensare che ildiario-ululato di Amedeo, rispetto al monologo che segue, abbia propriotale funzione: come nel noto esempio di Pirandello, nel quale la cadutadi un’anziana signora truccata e ben vestita genera immediatamente ilriso e solo in seguito provoca una riflessione sugli aspetti più tristi dellavicenda, così nel romanzo di Lakhous il divertimento che proviene dalmonologo di ciascun personaggio viene immediatamente bilanciatodalle riflessioni serie e talvolta amare di Amedeo. Solo grazie al suodiario, infatti, ci rendiamo conto della solitudine della vita di Parviz, deigravissimi problemi che affliggono Maria Cristina, delle fobie dellavedova Fagiani e delle illusioni di Johan Van Marten. In tal senso si puòdavvero affermare che le sue confessioni abbiano la funzione di“avvertimento del contrario”.
Il grottesco inoltre può essere utilizzato come grimaldello per scalfirel’apparente normalità borghese del condominio di piazza Vittorio per
19Cfr. R. DAUMAL, L’évidence absurde, Paris: Gallimard, 1972.
20S. FREUD, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, Leipzig und Wien: FranzDeuticke, 1905, trad. it., Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio, Torino:Bollati Boringhieri, 1975.
21L. PIRANDELLO, L’umorismo, Lanciano: R. Carabba, 1908.
Lo scontro di civiltà visto dagli altri: lo sguardo di Lakhous sull’Italia
247
andare oltre e tentare di analizzare i reali problemi che affliggono i varipersonaggi. Spesso l’elemento comico o grottesco è stato visto comeesplorazione dell’ulteriore, di ciò che va al di là della normalepercezione.22 In tal senso il diario di Amedeo, che mette a nudo alcunilati grotteschi delle dinamiche fra i condomini, si pone come una cartinaal tornasole (talvolta anche dura e accusatoria) delle reali interazioni frai personaggi del romanzo, qui messi in luce in tutta la loro meschinità.
In conclusione si può aggiungere che l’aspetto comico è funzionaleal senso e alla struttura del romanzo, da una parte perché permetteall’autore di utilizzare una sorta di “filtro” per riuscire a raccontarevicende che lo riguardano da vicino senza cadere nell’autobiografia onella retorica, dall’altra perché è proprio nelle modalità di utilizzo delcomico che si rivela la molteplicità del reale e quindi l’impossibilità diridurre l’esperienza vissuta ad una sola verità e la personalità umana adun’unica identità.
Bibliografia
A. LAKHOUS, Le cimici e il pirata, traduzione di Francesco LEGGIO, Roma:Arlem, 1999; ristampato con il titolo Un pirata piccolo piccolo, Roma, e/o,2011.
Kaifa tardaa min al dhiba duna an-taodak, Alger: Al Ikhtilaf, 2003; poiBāirut: Dar al arabiya li al ulum, 2006.
Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio, Roma: Edizioni e/o,2006.
C.U. ALI FARAH, Madre piccola, Milano: Frassinelli, 2007.
K.F. ALLAM, “Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio – AmaraLakhous racconta la quotidianità degli immigrati”, su La Repubblica, 11maggio 2006, p. 58.
M. BACHTIN, Tvorcestvo Fransua Rable i narodnaja kul’tura srednevekov’ja iRenessansa, Moskva, Chudozestvennaja literatura, 1965; trad. it. L’opera diRabelais e la cultura popolare: riso, carnevale e festa nella tradizionemedievale e rinascimentale, Torino: Einaudi, 1979.
H. BERGSON, Le rire. Essai sur la signification du comique, Paris: EditionsAlcan, 1924; trad. it. Il riso. Saggio sul significato del comico, Milano:Mondadori, 1992.
G. BRUNETTA, Cent’anni di cinema italiano, vol. II, Dal 1945 ai giorni nostri,Roma-Bari: Laterza, 1995.
C. DE CALDAS BRITO, Amanda Olinda Azzurra e le altre, Isernia: CosmoIannone, 2004.
22Cfr. G. GORI, Il grottesco nell’arte e nella letteratura, Roma: Stock, 1926, che in uncerto senso si collega all’esperienza futurista.
Daniele Comberiati
248
N. CHOHRA, Volevo diventare bianca, a c. di A. ATTI DI SARNO, Roma: Edizionie / o, 1993.
E. CONSOLE, C. GÜTERMANN e S. VILLATA (a c. di), Racconti arabi,introduzione di F. PEIRONE, Milano: Mondadori, 1989.
R. DAUMAL, L’évidence absurde, Paris: Gallimard, 1972.
G. FERRONI, Il comico nelle teorie contemporanee, Roma: Bulzoni, 1989.
E. FRANZINA, G. A. STELLA, Brutta gente. Il razzismo anti-italiano, in AA. VV.,Storia dell’emigrazione italiana, a c. di P. BEVILACQUA, A. DE CLEMENTI e E.FRANZINA, Roma: Donzelli, 2001, pp. 290-309.
S. FREUD, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, Leipzig und Wien:Franz Deuticke, 1905, trad. it., Il motto di spirito e la sua relazione conl’inconscio, Torino: Bollati Boringhieri, 1975.
C.E. GADDA, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, Milano: Garzanti,1957.
M. GADJI, Lo spirito delle sabbie gialle, Milano: Edizioni dell’Arco, 1999.
A. GNISCI, La letteratura italiana della migrazione, Roma, Lilith, 1997.
G. GORI, Il grottesco nell’arte e nella letteratura, Roma: Stock, 1926.
S.P. HUNTINGTON, The Clash of Civilizations and the Remaking of WorldOrder, New York: Simon & Schuster, 1996; trad. it. Lo scontro di civiltà e ilnuovo ordine mondiale, Milano: Garzanti, 1997.
P. KHOUMA, Io, venditore di elefanti, a c. di O. PIVETTA, Milano: Garzanti,1989.
Nonno Dio e gli spiriti danzanti, Milano: Baldini&Castoldi Dalai, 2005.
B.M. MAZZARA, Stereotipi e pregiudizi, Bologna: Il Mulino, 1997.
Appartenenza e pregiudizio: psicologia sociale delle relazioni interetniche,Roma: Carocci, 2005.
S. METHNANI, Immigrato, a c. di M. FORTUNATO, Roma, Theoria, 1990.
S. MOUSSA BA, La promessa di Hamadi, a c. di A. MICHELETTI, Novara: DeAgostini, 1991.
L. PIRANDELLO, L’umorismo, Lanciano: R. Carabba, 1908.
I. SCEGO, Rhoda, Roma: Sinnos, 2004.
L. SCIASCIA, Il giorno della civetta, Torino: Einaudi, 1961.