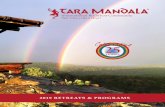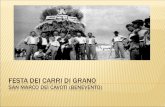tesi federica mandala
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of tesi federica mandala
Indice
Introduzione pag 3
Capitolo I: Il turismo e l’occupazione a
livello mondiale pag 5
1.1 Il rapporto globale sul turismo 2010
pag 5
1.2 Analisi dell’occupazione nel settore
turistico in Europa pag 9
1.2.1 Caratterizzazione per sesso pag 11
1.2.2 La stagionalità del lavoro pag 13
Capitolo II: Il fenomeno turistico in Italia
pag 15
1
2.1L’offerta di lavoro e l’occupazione
femminile pag 16
2.2 L’Italia di fronte alla crisi: l’impatto sulle lavoratrici pag 17
2.3 L’occupazione nel settore turistico
italiano pag 20
2.3.1 La consistenza del
comparto pag
21
2.3.2 Le categorie di lavoratori
pag 21
2.3.3 Caratterizzazione per
sesso pag 22
2.3.4 La
stagionalità
pag 24
2.4 Analisi dell’occupazione nel settore turistico svolta da
2
Federalberghi pag 26
2.4.1 Federalberghi
pag 26
2.4.2 L’indagine
pag 26
2.4.3 Le tipologie contrattuali
nei comparti del turismo pag 33
2.4.4 Il sesso dei lavoratori nei comparti del turismo pag 35
2.5 Indagine sull’occupazione nelsettore alberghierosvolta dall’Istatpag 40
2.5.1 Istituto nazionale distatistica pag 40
2.5.2 Rilevazione sulle forze di
lavoro pag 43
Capitolo III: Il caso Sicilia pag 50
3
3.1 Scenario generale pag 50
3.2L’occupazione femminile in Sicilia:confronto con le altre regioni italiane (2004-2010)pag 51
3.3 Occupati in Sicilia per sesso pag 54
3.4 Sicilia, Sardegna e Calabria a confronto pag 55
Conclusioni pag 56
Bibliografia pag 58
Siti web pag 59
INTRODUZIONE II turismo come fenomeno economico
Con 800 milioni di spostamenti internazionali in un anno ilturismo è "l'industria" che più di ogni altra mette inrelazione fra loro gli abitanti della Terra.
4
Il turismo è infatti considerato come un'attività pressochéindispensabile per le popolazioni occidentali ed è semprepiù diffusa nelle abitudini anche di quella parte di mondoche fino a un po’ di tempo fa era esclusa dall'opportunitàdi viaggiare. Se nell'opinione comune il concetto diturismo è sostanzialmente legato a quello di attivitàindividuale o di gruppo tesa a soddisfare bisogni personalio collettivi, dall'evasione dalla vita quotidiana allascoperta di altre realtà, dalla ricerca di emozioni albisogno di relax, il turismo si rivela in realtà unfenomeno che ha un forte impatto sul tessuto economico-sociale delle aree di destinazione. Il turismo ha subitocontinui mutamenti, legati alle variazioni di disponibilitàdi reddito, di tempo libero e di motivazioni, sviluppandoricchezza e benessere, ma portando con sé anche diversiproblemi, da quelle ambientali a quelle etiche del viaggio.Capace di generare uno straordinario volume di reddito, ilturismo si presenta come uno strumento privilegiato per lepolitiche di sviluppo di qualsiasi Paese, ma non sempre lacrescita del turismo nelle destinazioni apporta beneficieconomici e sociali diffusi alle popolazioni locali.Spesso, infatti, i policy maker individuano nel turismo lasemplice soluzione di problemi ben più complessi disottosviluppo sociale ed economico e un modo semplicisticodi portare soldi nelle casse dello Stato. Soprattutto neiPaesi più poveri, il turismo, grazie ai possibiliinvestimenti e ai grandi quantitativi di valuta stranierache potrebbe portare con sé, diventa la panacea – in largamisura utopistica – per combattere tutti i mali e ladestinazione turistica assume i connotati di una vera epropria merce da concedere al migliore offerente.Il turismo svolge un ruolo essenziale nella risoluzione diproblemi relativi all’occupazione in Italia. Le attivitàlegate al turismo concorrono in grande misuraall’occupazione, abbracciano una vasta gamma di professionie offrono indubbie possibilità di creazione di posti di
5
lavoro. Il turismo dovrebbe essere considerato un partnerideale per il processo di creazione di nuovi posti dilavoro, ma il suo contributo all'occupazione femminile èstato raramente esaminato a fondo e in tutti i suoiaspetti. Questo è tanto più deplorevole in quanto ilturismo incide su numerose attività economiche e richiedeinvestimenti considerevoli di risorse umane. Le moltepliciattività che concorrono a soddisfare il consumo turisticosono parte integrante del tessuto economico, laflessibilità dell'ambiente di lavoro nel settore deiservizi turistici facilita l'accesso dei giovani e inparticolare delle donne al mercato del lavoro e offremaggiori possibilità di formazione continua.Il presente elaborato si occupa di analizzare l’occupazionefemminile nel settore turistico, con maggiore riferimentoall’area degli alberghi e dei ristoranti, e quindi sioccupa di capire l’incidenza e l’importanza del fenomenostesso in tale settore.Nel capitolo 1 viene approfondito il tema dell’occupazionefemminile nel settore turistico in aree geografiche qualil’Asia, i Caraibi, l’ America Latina, l’Africa e l’Oceania,mostrando il ruolo fondamentale che il turismo gioca nellosviluppo di tali aree e, in particolare, il ruolo svoltodelle donne in tale settore, il quale offre loro lapossibilità di affermarsi nelle proprie società. Nellaseconda parte del capitolo invece viene analizzatal’occupazione femminile nel settore turistico in Europa.Nel capitolo 2 viene esaminata e misurata l’occupazionefemminile nel settore turistico in Italia, rilevando ledifferenze con l’altro sesso e analizzando l’andamentodell’occupazione femminile negli ultimi anni e negli ultimidecenni, sulla scorta delle indagini effettuate daFederalberghi e Istat.Infine, nel capitolo 3, viene analizzato il medesimofenomeno in Sicilia, confrontandolo nell’impatto che ilfenomeno dell’occupazione femminile nel settore turistico
6
ha nelle regioni concorrenti, Calabria e Sardegna, erapportandolo a tutte le regioni italiane.
CAPITOLO 1
Il turismo e l’occupazione a livello mondiale
1.1 Il rapporto globale sul turismo 2010
Le donne occupano una posizione di rilievo nel mondodell'industria del turismo. La capacità del turismo perl'empowerment delle donne socialmente, politicamente edeconomicamente è particolarmente rilevante per lo sviluppo
7
di regioni in cui le donne possono affrontare i più grandidisagi e le disuguaglianze. Il Rapporto globale sul turismomette in evidenza l'importante ruolo che il turismo rivestenel mettere in discussione gli stereotipi culturali,l'empowerment delle donne politicamente ed economicamente,e fornire opportunità di guadagno per le donne.Il Turismo è una delle industrie più grandi e in più rapidacrescita al mondo. In molti paesi si comporta come unmotore di sviluppo attraverso entrate in valuta estera e lacreazione di occupazione diretta e indiretta. Il turismocontribuisce al 5% del PIL mondiale e il 7% dei posti dilavoro in tutto il mondo. Essa rappresenta il 6% delleesportazioni mondiali e il 30% delle esportazioni mondialinel settore dei servizi. Nei paesi in via di sviluppo, ilturismo genera il 45% del totale delle esportazioni inservices. La ricerca mostra i diversi modi in cui il turismopuò contribuire alla crescita economica, alla riduzionedella povertà e allo sviluppo della comunità. Tuttavia,meno attenzione è stata rivolta al modo ineguale nel qualesono distribuiti i benefici del turismo tra uomini e donne,in particolare nei paesi in via di sviluppo. Il Turismo presenta sia opportunità che sfide perl'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne.Il Rapporto mondiale sulle Donne nel Turismo 2010 è unprimo tentativo di sviluppare un quadro quantitativo per ilmonitoraggio dello stato delle donne che lavorano nelsettore del turismo in tutto il mondo. Il suo focus è sulturismo nelle regioni di sviluppo. Gli obiettivi dellarelazione sono:1) stabilire una serie di indicatori e di un quadroindicatore che potrebbero essere utilizzati per monitorarele prestazioni del turismo come strumento perl'emancipazione femminile,e 2) di utilizzare gli indicatori per valutare la misura incui il turismo sta portando avanti i bisogni delle donnedei paesi in via di sviluppo.
8
La visione d’insieme del Rapporto Globale sulle Donne nelTurismo 2010 è di promuovere l'emancipazione delle donne eproteggere i diritti delle donne attraverso il migliorelavoro nel turismo. La relazione si articola attorno acinque aree tematiche: occupazione, l'imprenditorialità,l'educazione, la leadership, e la comunità. In taleelaborato si esaminerà solo il primo aspetto. Il risultatodi tale indagine deriva principalmente da un'analisi degliILO Laborsta database e ordinati per regioni in via disviluppo: i Caraibi, America Latina, Africa Asia eOceania.Il turismo presenta una vasta gamma di opportunità per ledonne nel mondo del lavoro sia formali che informali. Lecaratteristiche principali del lavoro delle donne in talipaesi sono: basso status, lavori mal pagati e precari nelsettore del turismo. Stereotipi di genere e ladiscriminazione indicano che le donne tendonoprincipalmente a svolgere lavori, come la cucina, lapulizia e l'ospitalità. L’occupazione nel settore turisticoè molto stagionale e varia a seconda della natura volatiledel settore. In alcune destinazioni sono stati trovati linktra il turismo e l'industria del sesso che potrebbe renderele donne più vulnerabili a exploitation sessuale.Le donne sono ben rappresentate nel mondo del lavoroturistico formale. Tuttavia, le donne sono più propensedegli uomini a lavorare nei ruoli quali impiegate ma sonomeno propense degli uomini a raggiungere un alto livelloprofessionale di occupazione nel settore turistico, e diconseguenza, la loro retribuzione media è inferiore aquello degli uomini.
Donne impiegate negli hotel e nei ristoranti per regione(%)
Region General averageLatin America 58,5Caribbean 55,4
9
Africa 47Oceania 46,8Asia 35,4Average 48,62Fonte: ILO Laborsta Database
La tabella mostra che le donne costituiscono una grandepercentuale di occupazione nel settore turistico eristorativo con una media del 49%. America Latina e iCaraibi hanno il più alto tasso di gestione stabilendoprogrammi di leadership a livello nazionale nelle grandi epiccole dimensioni delle imprese del turismo.
Anche se molte informazioni sono ancora mancanti, irisultati di questa indagine iniziale suggeriscono che valela pena di investire nel turismo che ha il potenziale peressere un veicolo per l'empowerment delle donne nelleregioni in via di sviluppo. Il turismo offre miglioriopportunità per la partecipazione delle donne nel mondo dellavoro, l'imprenditoria femminile e la leadership delle donnerispetto ad altri settori dell'economia. Le donne nelturismo sono sempre sottopagate, sottoutilizzate, sotto-istruite, e sottorappresentate; ma il turismo offrepercorsi per il successo. I caratteri principali delledonne impiegate nel settore turistico sono:1. Le donne costituiscono una grande percentuale dellaforza lavoro turismo formale.2. Le donne sono ben rappresentate a livello di impiegated’ufficio ma scarsamente rappresentate a livelliprofessionali.3. Le donne nel turismo in genere guadagnano dal 10% al 15%in meno rispetto ai loro colleghi maschi.4. Il settore turistico ha quasi il doppio di impiegatidonne rispetto agli altri settori.5. Uno su cinque ministri del turismo di tutto il mondosono donne.
10
6. Le donne costituiscono una percentuale molto più elevatadi lavoratori indipendenti nel settore del turismo che inaltri settori.7. Una grande quantità di lavoro non retribuito è svoltodalle donne nelle imprese turismo familiare.
Dipendenti donne nel settore degli alberghi e ristoranti perregione(%)
Region In generalIn hotel and restaurant
sectorLatin America 23,2 51,3Caribbean 26,4 32,8Africa 20,8 30,5Oceania 17,4 29,7Asia n/a n/aAverage 21,95 36,08Fonte: ILO Laborsta DatabaseIn termini di livello professionale, la media è simile pertutte le regioni per le quali sono disponibili dati. Questofenomeno è particolarmente rilevante in America Latina,dove la partecipazione delle donne nei processi di livelloprofessionale è quasi la metà di quella al servizio e illivello clericale. Tuttavia, in generale, anche se lapartecipazione delle donne in questo settore non è elevata,sembra essere un certo potenziale per le donne perraggiungere posizioni manageriali nel settore.In Nicaragua e Panama, oltre il 70% dei datori di lavorosono donne rispetto a poco più del 20% in altri settori.Questo modello è seguito in misura minore in tutte leregioni oggetto dello studio. Anche in questo caso, i datiper l'Asia variano notevolmente. Mentre in Indonesia,Malesia, Filippine, e più della metà delle impreseturistiche in Thailandia sono gestite da donne. Questodimostra che il turismo ha un forte potenziale per lapromozione delle donne un'attività in proprio.
11
Dipendenti donne per status occupazionale, per regione(%)
RegionProfessional Clerks Service workers
Latin America 38,9 49,4 35,6Caribbean 36,6 62,7 65,5Africa 34,9 56,6 34,8Oceania n/a 67,3 42,9Asia n/a n/a n/aAverage 36,8 59 44,7
Fonte: ILO Laborsta Database
1.2 Analisi dell’occupazione nel settore turistico in Europa
Prima di addentrarci nell’analisi del panorama italiano, sipropone un quadro europeo confrontando i 27 paesiappartenenti all’Unione Europea. L’analisi fa riferimentoalle statistiche Eurostat ed in particolare alla sezione I(Accommodation and food services) e alla sottocategoria I.55
12
(Accommodation) della classificazione delle attivitàeconomiche NACE Rev.22.Secondo le statistiche Eurostat, nel 2008 più di 9 milionidi persone residenti nell’Unione Europea sono stateoccupate nel sistema ricettivo e nel settore dellaristorazione, l’equivalente del 4,2% dell’intero mercatodel lavoro.Detengono il maggior numero di addetti la Germania (1,47milioni) e la Spagna (1,45 milioni), con incidenze chesuperano il 15% (su tutti i paesi appartenenti all’UnioneEuropea); al terzo posto troviamo il Regno Unito (1,27milioni di occupati) ed al quarto l’Italia (1,18 milioni),con incidenze rispettive del 13,6% e 12,6%.La comparazione tra i diversi paesi europei non è di facilerealizzazione, date le diverse modalità di rilevazionistatistiche e talvolta la mancata diffusione dei risultati,per cui lo stesso Eurostat ha dovuto avanzare alcune stimeper creare un panorama il più completo possibile. Nel 2008,comunque, molte difficoltà che hanno tormentato il passatosono state superate, per cui, in riferimento all’UnioneEuropea, mancano “soltanto” i valori relativi aLussemburgo. Tale retaggio storico ha reso comunqueimpossibile un quadro di lungo periodo.Rimanendo quindi nel breve periodo, rispetto al 2007 glioccupati nel settore ricettivo e della ristorazione hannosubito un incremento del +1,6%. Sei sono i Paesi che hannoregistrato una flessione: il Belgio (-5,3%), la RepubblicaCeca (-2,2%), l’Ungheria (-0,6%), i Paesi Bassi (-5,3%),l’Austria (-3,1%) e il Regno Unito (-1,2%).Diverso il panorama del solo comparto ricettivo cherappresenta il 24,6% della voce NACE I “Servizi ricettivi eristorazione” e l’1% dell’intero mercato occupazionale.Nonostante non sia possibile elaborare valutazioni per ognipaese data la mancanza di alcuni dati relativi al 2007, lestime Eurostat per arrivare al mercato occupazionale
13
dell’UE 27 vedono una riduzione degli occupati neglialberghi e altri alloggi del -0,8%.La Germania si attesta la prima posizione per numero dipersone occupate nel comparto ricettivo (383mila), con unaincidenza del 16,7%, seguita dalla Spagna (329mila e14,4%), Regno Unito (307mila e 13,4%), Italia (246mila e10,7%) e Francia (235mila e 10,3%).La Germania, oltretutto, registra una evoluzione positiva(+2,1%) rispetto al 2007, così come l’Italia (+3,4%),mentre in flessione sono gli occupati nei sistemi ricettivispagnoli (-2,4%) e francesi (-8,2%).
Distribuzione % degli occupati nel comparto ricettivo (NACEI.55) nei Paesi dell’Unione Europea. Anno 2008
14
GermaniaRegno Unito
FranciaPoloniaGrecia
Repubblica CecaRomania
BulgariaSlovacchiaDanimarcaSlovenia
MaltaLituania
Lussemburgo
16.714.4
13.410.7
10.34.14
3.43.32.7
2.12.11.91.71.71.6
1.210.80.700000000000
001
0.600000000000001
0.50.40.30.30.20.1
Fonte: Eurostat1.2.1 Caratterizzazione per sesso
L’analisi per sesso rivela una più alta percentuale dioccupati di sesso femminile nel settore ricettivo rispettoalla percentuale degli occupati del medesimo sesso neltotale delle attività economiche. Infatti, nel sistemaricettivo, quasi il 60% dei lavoratori sono donne, a fronte
15
del 45% se si considera l’intero mercato del lavoro. Seconsideriamo invece il sistema ricettivo e ristorazione il55% sono lavoratori di sesso femminile contro il 44,5%degli occupati maschi.
Composizione % del mercato del lavoro totale e turisticonell’UE27 per sesso.Anno 2008
40,50%
59,50%
Sistema ricettivo
MaschiFemmine
Fonti: Eurostat
55,20%
44,80%
Totale attività economiche
MaschiFemmine
Fonti: Eurostat
16
44,50%
55,50%
Sistema ricettivo e ristorazione
MaschiFemmine
Fonti: Eurostat
La Spagna, la Francia, l’Italia e il Regno Unito detengonouna percentuale di lavoratori donne inferiore alla mediadell’Unione Europea anche se continuano a rappresentare lamaggioranza del mercato del lavoro ricettivo. Al contrario,invece, la Germania registra una quota del 69,7%, diecipunti percentuali superiori rispetto alla media dell’UE27.
Composizione % del mercato del lavoro nel sistema ricettivo(NACE I.55) inalcuni Paesi dell’UE27 per sesso. Anno 2008
17
germania spagna regno unito italia francia
30.343.8 43.3 48 48.9
69.756.2 56.7 52.4 51.1
maschi femmine
Fonti: Eurostat
1.2.2La stagionalità del lavoro
Indubbia la maggiore stagionalità del lavoro del mercatoturistico rispetto all’intero sistema economico. Ilavoratori stagionali incidono nel 2008 per il 25,5% sultotale occupati nel ricettivo, mentre rappresentano il 14%dell’intero mercato del lavoro.
Stagionale 25,50%
Permanente 74,50%
Sistema ricettivo
18
Stagionale 14,00%
Permanente 86,00%
Totale attività economiche
Stagionale 22,60%
Permanente 77,40%
Sistema ricettivo e ristorazione
Fonte: Eurostat
L’Italia è uno dei Paesi dell’UE che presenta una fortestagionalità lavorativa nel turismo. Il 38,5% deilavoratori nel ricettivo ha un contratto stagionale, mentread esempio nel Regno Unito tale quota si riduce al 10,6%.Assieme all’Italia troviamo anche Spagna (32,8%), PaesiBassi (35,3%), Polonia (41,0%), Grecia e Svezia (40,0%ciascuna).
19
Composizione % del mercato del lavoro totale e turisticonell’UE27 perstagionalità del lavoro. Anno 2008
Germania Spagna Francia Regno Unito Italia
24.9 32.8 26.510.6
38.5
74.6 67.269.1
89.4
61.5
stagionale permanente
Fonti: Eurostat
CAPITOLO 2
Il fenomeno turistico in Italia
L’Italia si conferma una delle maggiori destinazionituristiche mondiali, al contrario di altre destinazioni divacanza, non conta solo sulla sua posizione geografica, sulclima e sulle bellezze naturali, ma anche sul fatto chealmeno il 40% della ricchezza monumentale, storica edartistica mondiale è distribuita sul suo territorio. Il 50%circa del movimento turistico italiano riguarda le vacanzebalneari, ma il Vaticano e Roma, città come Venezia,Firenze e Napoli, le Alpi e numerosi magnifici laghi
20
costituiscono alcuni di tanti altri motivi della grandeattrattività dell’Italia.Per quanto riguarda i dati statistici, con oltre 345milioni di presenze turistiche nel 2005, l’Italia è laquarta destinazione turistica mondiale.I turisti in Italia hanno speso circa 85.000 milioni dieuro per viaggi, alloggio, ristorazione, intrattenimento,divertimento e shopping, ma il giro d’affari complessivoprodotto dall’industria dell’ospitalità arriva a 152.000milioni di euro. Il turismo, pertanto, detiene la quotadell’11,7% del Prodotto Interno Lordo.In Italia gli occupati diretti in attività turistiche sonostimati in 1.600.000 unità, all’interno delle quali laforte presenza di lavoro autonomo rispetto alla mediadell’economia italiana si traduce in una quota pari a circail 38%, strutturalmente di ben 10 punti superiore a quellamedia nazionale.Dall’analisi settoriale risulta che 793.000 di tutti glioccupati diretti, pari al 49,5%, lavorano nel comparto“Alberghi e Ristoranti”, il più importante in termini dioccupazione, seguito a grande distanza dal “Commercio”(310.000 unità, pari al 19,4%) e dalle “Attivitàricreative” (205.000 unità, pari al 12,8%). Se siconsiderano anche le attività indirette (777.000 addetti),l’occupazione sale a 2.377.000 addetti, con unmoltiplicatore pari a 1,49.Complessivamente, l’incidenza dell’occupazione turisticadiretta e indiretta sul totale nazionale è pari al 9,8%.Si tratta, dunque, di una enorme area di occupazione,stagionale e permanente, all’interno della quale letendenze internazionali, la crescita dei redditi, l'aumentodel tempo libero disponibile, lo sviluppo dei viaggid'affari, e non ultime le mode, stanno producendoun’espansione dei consumi, dei bisogni e della qualità deiservizi. Sempre nel 2005 si contano più di un milione emezzo di persone impegnate in attività turistiche, di cui
21
il 34% è costituito da lavoratori indipendenti nel compartodegli alberghi e dei ristoranti, comparto che rappresentail 48% di tutti gli occupati con 785.000 lavoratori.Seguono il comparto del commercio con 304.000 unità, parial 19,3% degli occupati e quello delle attività ricreativecon 201.000 unità, pari al 12,7% del totale dei lavoratorituristici. Inoltre, si sottolinea che nel 2005 l’interosettore turistico, compresi gli occupati in attivitàindirette, ha dato vita a 2.354.000 unità di lavoro, parial 9,7% del totale nazionale dell’occupazione. Ma il BelPaese non si ferma qui. Si pensa, infatti, di progettareuna serie di misure tali da rendere l’Italia la prima metaturistica mondiale entro il 2016, anno in cui il turismorappresenterà il 12% del PIL, con un’occupazione pari al13% dei lavoratori.
2.1Offerta di lavoro e occupazione femminile
Sino a qualche tempo fa il problema principale per le donnein Italia era il loro scarsissimo accesso al mercato dellavoro: negli anni ‘70, infatti, dopo un declino iniziatonel dopoguerra, la presenza femminile nel mondo del lavororaggiunge il suo livello minimo. Fattori positivi enegativi congiurano nello spiegare questa fase di“esclusione” delle donne italiane dal lavoro: i buoni esicuri livelli di reddito raggiunti da un crescente numerodi capifamiglia, la debole diffusione dei servizi privati epubblici e delle nuove tecnologie domestiche, lo scarsolivello di istruzione delle donne.Poi l’occupazione femminile riprende a crescere el’attenzione degli studiosi e della pubblica opinione sisposta progressivamente sulla qualità delle occupazioni perle donne, cioè non più sulla discriminazione dal mercato dellavoro, ma su quella nel mercato del lavoro.Ad oggi, tuttavia, se si guarda più accuratamente allediverse realtà territoriali e alle differenze nei livelli
22
di istruzione, si vede che la questione della scarsapartecipazione al lavoro non è affatto superata né nelMezzogiorno né per le donne poco istruite, e quindi amaggior ragione per le donne meridionali poco istruite, cherimangono ancora escluse dal mercato del lavoro. Inoltre,dai confronti internazionali risulta che per le donne“quantità” e “qualità” dell’occupazione possono non andareinsieme, ma anzi essere in contrasto. Infine, è evidenteche in un sistema economico ove l’occupazione si concentrasempre più nei servizi la questione del lavoro “per ilmercato” delle donne solleva quella dell’assetto dellafamiglia e più in generale di quali valori o interessisiano più meritevoli da sostenere con le politichepubbliche.
2.2 L’Italia di fronte alla crisi: l’impatto sulle lavoratrici
Negli ultimi mesi della VII Consiliatura il CNEL haattribuito notevole priorità al problema del basso tasso dioccupazione delle donne e, conseguentemente, dell’impattodella crisi economica globale sul loro lavoro.Interrompendo la precedente tendenza favorevole, il tassodi occupazione delle donne (15-64 anni) è sceso nel 2009 al46,4 per cento, un valore molto lontano da quellodell’Unione europea (58,6 per cento). La crisi si èinnestata su una situazione già difficile dell’occupazionefemminile, contribuendo ad accentuarne le criticitàstoriche. La crisi economica, innescata nel 2007 dalledifficoltà del settore finanziario negli Stati Uniti, si èrapidamente trasformata nel più grave episodio recessivodella storia recente. La diffusione globale dell’impattodella crisi statunitense sull’economia reale è passataanche attraverso la caduta eccezionalmente ampia delcommercio mondiale.Secondo le stime del Fondo monetario internazionale, nel2009 il Pil mondiale in parità di potere d’acquisto è
23
diminuito dello 0,6 per cento, la produzione industrialedell’8,2 e il commercio internazionale del 10,6 per cento.Nel 2009 la caduta del Pil è stata del 4,2 per centonell’Unione europea (-4,1per cento nell’area dell’euro),del 5,0 per cento in Italia e Germania, del 4,9 per centonel Regno Unito, del 3,6 per cento in Spagna, del 2,2 percento in Francia. Tra la primavera del 2008 e quella del2009 la produzione industriale è scesa di circa un quartoin Italia, Germania e Spagna, di un quinto in Francia e diquasi il 15 per cento nel Regno Unito. Il valore delleesportazioni è diminuito di quasi il 25 per cento inItalia, del 20 per cento in Germania e di circa il 15 percento in Spagna, Francia e Regno Unito. Considerando ilbiennio 2008-2009, la caduta del livello del reddito haraggiunto in Italia il 6,3 per cento, il risultato peggioretra quelli delle grandi economie avanzate.In questo quadro, famiglie e imprese hanno rivisto alribasso le scelte di consumo, investimento e produzione. Lacontrazione dell’attività economica si è tradotta in unaprogressiva riduzione della quantità di lavoro impiegatanei processi produttivi. Nel 2009 l’occupazione è infattidiminuita di quasi quattro milioni di unità (meno 1,7 percento), nell’insieme dell’Unione europea, passando dal 65,9per cento del 2008 al 64,6 per cento del 2009.In calo già dal terzo trimestre del 2008 nel Mezzogiorno,la domanda di lavoro italiana si è contratta su tutto ilterritorio nazionale e soprattutto nel Nord, passando dal58,7 al 57,5 per cento. Si tratta di 380 mila unità, ingran parte lavoratori impegnati nella trasformazioneindustriale (-206 mila persone). Gli uomini (-274mila, parial 2 per cento) sono stati investiti dalla crisi più delledonne (-105 mila, pari all’1,1 per cento), così come igiovani tra i 15 e i 29 anni - categoria più colpita (-311mila, pari all’8,2 per cento) - rispetto agli adulti, gliautonomi (esclusi i collaboratori -141 mila, pari al 2,6per cento) rispetto ai dipendenti (-170 mila, pari all’1
24
per cento) e chi aveva un lavoro temporaneo (-240 mila,pari all’8,6 per cento) rispetto a chi aveva un contrattodi dipendente a tempo indeterminato (-33 mila, pari allo0,2 per cento).Interrompendo la precedente tendenza favorevole, il tassodi occupazione delle donne (15-64 anni) è dunque sceso nel2009 al 46,4 per cento, un valore molto lontano da quellodell’Unione europea (58,6 per cento). La crisi ha investitouna situazione già difficile dell’occupazione femminile,contribuendo ad accentuarne le criticità storiche. Leconseguenze sono state particolarmente evidenti nelMezzogiorno, che ha assorbito quasi la metà del calocomplessivo delle occupate (-105 mila donne), e che giàpresentava bassi tassi di occupazione femminile. Inquest’area territoriale, il tasso di occupazione è del 30,6per cento, contro il 57,3 per cento del Nord-est. Si èulteriormente abbassato il tasso di occupazione delle donnecon titolo di studio inferiore al diploma di scuolasecondaria superiore: nel Mezzogiorno raggiunge un livelloche supera di poco il 20 per cento. Solo le laureateriescono a raggiungere i livelli europei, se si escludonole giovani, che incontrano difficoltà all’ingresso nelmercato del lavoro. Si accentuano anche le difficoltà perle donne in coppia con figli, elemento già critico dellasituazione italiana: considerando la classe di età 25-54anni, e assumendo come base le donne senza figli, i tassidi occupazione sono inferiori di quattro punti percentualiper quelle con un figlio, di 10 per quelle con due figli edi 22 punti per quelle con tre o più figli. Tale andamentonon si riscontra per i principali paesi europei.A tutelare una parte delle famiglie con figli dal rischiodi perdita del lavoro di uno dei genitori è stato ilricorso alla Cig. Al tempo stesso, la famiglia ha svolto ilconsueto ruolo di ammortizzatore sociale, sopportando ilpeso della mancanza di occupazione dei figli. L’azione
25
congiunta di questi due aspetti ha quindi mitigato glieffetti della crisi, almeno per il momento.
Tassi di partecipazione alla forza lavorocome percentuale della popolazione dal 1960 al 2008 in Italia
anni Uomini donne1960 64 26,91970 57,8 22,21980 55,5 26,31990 56,1 30,92000 52,6 30,82005 51,6 32,82009 51,5 33,4
Fonti: Istat
Tassi di partecipazione femminile alle forze lavoro 1977-2008
26
Fonte: Elaborazione su dati OECD, Labor Force Statistics, 2010
2.3 L’occupazione nel settore turistico italiano
Le attività turistiche sono caratterizzate da un’elevataintensità di lavoro: l’occupazione del settore rappresenta,perciò,una misura sia della sua dimensione, sia delleopportunità occupazionali che esso offre. Lo si legge nellarecente indagine Istat “Noi Italia”.In Italia, nel 2008, un occupato su 20 lavora nel turismo,valore superiore a quello medio europeo e in costantecrescita. Secondo la definizione utilizzata nella ricercasono coinvolti i lavoratori di: alberghi e strutturesimili, alloggi per vacanze e altre strutture per brevisoggiorni (villaggi turistici, ostelli della gioventù,rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamereper brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed& breakfast, residence e alloggi connessi alle aziende
27
agricole), aree di campeggio e aree attrezzate per camper eroulotte ed altri alloggi.L’indicatore utilizzato è dato dal rapporto percentuale tranumero di occupati nel settore del turismo e totale deglioccupati.L’Italia, nell’ambito dei paesi Ue27, è l’ottavo paese perquota di occupati nel settore turistico (5 per cento).Prima dell’Italia si collocano Malta (8,4 per cento),Spagna (7,2 per cento), Grecia (6,9 per cento), Cipro (6,7per cento), Portogallo, Austria e Irlanda (tutte con il 6,1per cento). In coda alla graduatoria Polonia e Romania,rispettivamente con quote del 1,9 e del 1,6 per cento.Nel 2008, gli occupati nel settore del turismo sono pocomeno di 1 milione e 200 mila unità, pari al 5,0 per centodegli occupati totali. Tra le ripartizioni non si rilevanoelevate differenze della quota di occupati nel turismo: nelNord-ovest si registra quella più bassa (4,4 per cento),nel Centro quella più alta (5,7 per cento) A livelloregionale la situazione è più variabile.Le regioni con una maggiore quota di occupati nel settoreturistico sono la Valle d’Aosta e la provincia autonoma diBolzano (rispettivamente 8,7 e 10,8 per cento), seguite daLiguria e Toscana (entrambi con 6,8 per cento) e dallaSardegna (6,4 per cento). La più bassa quota di occupatinel settore si osserva in Basilicata e in Lombardia(entrambe al 3,9 per cento). Tra il 2004 e il 2008 la quotadi occupati del settore è aumentata di 0,4 puntipercentuali. Questa tendenza non è però condivisa da tuttele aree.L’incremento è stato più accentuato nel Centro (+1,0punti), grazie soprattutto all’apporto della Toscana(+1,9); mentre nel Nord-est si registra un lieve calo (-0,1), frutto di variazioni inferiori a quella media ditutte le sue aree a eccezione della provincia autonoma diBolzano. In particolare, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna registrano un calo della quota di occupati del
28
turismo. Tra le regioni in cui il peso occupazionale delturismo è aumentato di più vi sono, oltre alla Toscana,l’Abruzzo (+1,8) e la Calabria (+1,3).
2.3.1La consistenza del comparto
Le analisi a livello nazionale tengono in considerazione idati al 2008 contenuti negli archivi sul lavoro dipendentedell’Inps. È stato possibile, a livello nazionale,procedere ad un esame più approfondito del compartoturistico, considerando quindi assieme ai servizi ricettivianche i pubblici esercizi (bar, ristoranti, mense,discoteche e stabilimenti balneari), il compartodell’intermediazione (agenzie di viaggi, T.O. e guideturistiche) e gli stabilimenti termali, elementi che dannouna caratterizzazione maggiore del settore turismo anchese, come è noto, molti di essi possono servire siaresidenti che non.Nel 2008 il settore turistico ha registrato, in mediad’anno, 926mila lavoratori dipendenti (il 7,7% dell’interomercato del lavoro dipendente), il 5,7% in più rispetto al2007 e quasi il 20% in più rispetto al 2006 addetti perazienda. Rispetto al 2006, anche il numero di aziende ècresciuto sensibilmente (+15,2%), ma non tanto quanto èavvenuto per i lavoratori, portando ad un lieve incrementoil numero di dipendenti medi per azienda. Entrando neldettaglio, i servizi ricettivi hanno registrato nel 2008,in media d’anno, 241.299 lavoratori dipendenti, il 2,2% inpiù rispetto al 2007, i pubblici esercizi 639.293 (+7,2%),l’intermediazione 36.441 (+4,9%) e gli stabilimenti termali8.849 (-3,9%).In termini dimensionali, il comparto più consistente èquello degli stabilimenti termali che raccolgono 28,2dipendenti per azienda staccandosi nettamente dai restanticomparti. A seguire troviamo gli esercizi ricettivi con
29
10,4 dipendenti per azienda, i servizi di intermediazionecon 5,3 e i pubblici esercizi con 5,0.
2.3.2 Le categorie di lavoratori
Le funzioni direttive (dirigenti e quadri) sono statesvolte, in media d’anno, da 5.640 persone, lo 0,6% deilavoratori dipendenti; i dirigenti sono stati 918, mentre iquadri hanno toccato quota 4.722. Superiori alla media, ivalori riportati nel comparto della intermediazione e deglistabilimenti termali, dove le figure direttive intercettanorispettivamente il 3,1% e l’1,9% dei dipendenti, ma anche,seppur in misura inferiore, nei servizi ricettivi (1,0%).Gli impiegati sono stati in media d’anno 116.843,riportando una incidenza del 12,7%, gli operai 738.653(80,0%) e gli apprendisti 62.317 (6,7%). Sono stati esclusidal computo i contratti di inserimento.Rispetto al 2006, si registra per l’intero comparto unacrescita del numero di dipendenti afferenti tutte letipologie professionali, mentre, entrando nel dettaglio, idipendenti con contratto di apprendistato hanno visto unariduzione del 16,4% nei servizi ricettivi; gli stabilimentitermali hanno tagliato impiegati, operai e apprendisti, maaumentato il numero di dirigenti e quadri.
2.3.3 Caratterizzazione per sesso
Il settore turistico continua ad essere caratterizzato daun lavoro in prevalenza femminile (58,4% dei lavoratoridipendenti del 2008). Il peso del lavoro femminile è fortenel comparto della intermediazione, dove le donne incidonoper il 77,0% sul totale dipendenti, ma anche negli altriaggregati considerati, dove non scendono mai sotto la quotadel 55%.
30
Servizi r...
Pubblici ...
Intermed...
Stabilimen...
totale
44.5 41.523
38.1 41.6
55.5 58.577
61.9 58.4
Caratterizzazione per sesso Maschi Femmine
Fonte: EBNT, Osservatorio sul mercato del lavoro nel turismo, elaborazione Federalberghi e Fipe su dati INPS
In termini assoluti, su 925.882 lavoratori dipendenti nel2008, 540.715 sono state donne, il 21,7% in più rispetto al2006. I dipendenti maschi, invece, hanno registrato unacrescita leggermente più bassa (+19,2%). Nei serviziricettivi, le donne hanno registrato un incremento del 9,6%rispetto al 2006, nei pubblici esercizi del 28,0%,nell’intermediazione del 9,4%, mentre negli stabilimentitermali si riducono del 2,7%, in misura comunque piùcontenuta rispetto alla flessione dei lavoratori maschi(-4,5%).
Lavoratori dipendenti per comparto e sesso
Comparti Maschi Femmine
31
Servizi ricettivi 107.378 133.921
Pubblici esercizi 265.307 373.986
Intermediazione 8.381 28.060
Stabilimenti balneari 3.371 5.478
Totale 385.167 540.715
Fonte: EBNT, Osservatorio sul mercato del lavoro nel turismo, elaborazione Federalberghi e Fipe su dati INPS
2.3.4La stagionalità
Il turismo è notoriamente caratterizzato da una forteandamento stagionale della domanda che influenzaconseguentemente l’offerta e la dinamica occupazionale: ilrallentamento dell’attività in alcuni mesi dell’anno e lasospensione del ciclo produttivo in altri determinano unaforte oscillazione dei livelli occupazionali. Basti
32
considerare che nei mesi che vanno da giugno a settembre,ovvero i mesi di maggiore afflusso turistico, il numeromedio di dipendenti è superiore del 13,1% rispetto alvalore medio annuale.Il grafico confronta l’andamento occupazionale nei diversicomparti. Il comparto meno affetto dalla ciclicità delleassunzioni è quello della intermediazione, dove i livellioccupazionali sono piuttosto stabili. Anche nei pubbliciesercizi l’effetto stagionalità rimane piuttosto marginale,mentre negli stabilimenti termali (attività stagionale perdefinizione) e negli esercizi ricettivi i vari periodidell’anno influiscono fortemente sulla forza lavoroutilizzata.
Stagionalità dei lavoratori nei diversi comparti
Fonte: EBNT, Osservatorio sul mercato del lavoro nel turismo, elaborazione Federalberghi e Fipe su dati INPS
33
2.4 Analisi dell’occupazione nel settore turistico svolta daFederalberghi
2.4.1 Federalberghi
Federalberghi è un'associazione di categoria cherappresenta gli interessi delle imprese alberghiere inItalia. Il numero degli alberghi presenti sul territorionazionale, suddivisi in 5 categorie da 1 a 5 stelle, è dioltre 33.000, per un totale di circa 1 milione di camere e2 milioni di posti letto.Da oltre cento anni Federalberghi è l'organizzazionenazionale maggiormente rappresentativa degli albergatoriitaliani. Federalberghi rappresenta le esigenze e leproposte delle imprese alberghiere nei confronti delleistituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche esindacali.Federalberghi si propone di valorizzare gli interessieconomici e sociali degli imprenditori turistici e difavorire il riconoscimento del loro ruolo sociale,l'affermazione dell'economia turistica, la promozionedell'offerta turistico ricettiva nazionale.Federalberghi stipula contratti nazionali di lavoro, svolgee patrocina attività scientifica per l'analisi del settore,promuove la formazione imprenditoriale degli associati,assiste e coordina il sistema organizzativo a livelloterritoriale ed a quello regionale nelle attività di tuteladelle imprese.La Federalberghi aderisce a livello nazionale allaConfcommercio (Confederazione Generale Italiana delCommercio, del Turismo e dei Servizi) organizzazione delleimprese del settore terziario e ne rappresenta insieme a
34
FAITA, Fiavet, FIPE e Rescasa il settore turismo(Confturismo).
2.4.2 L’indagine
L’indagine è realizzata da Federalberghi e dall’EnteBilaterale Nazionale del settore Turismo con il supportotecnico scientifico del Centro Studi sul Turismo di Assisi.L’analisi del mercato del lavoro nel turismo, svolta nel2011 ma basata sui dati Inps e relativa al 2008, raffiguraun settore in cui circa 926 mila lavoratori dipendenti sonostati impiegati mediamente nell’anno, da quasi 158 milaaziende.La forte stagionalità che caratterizza il settore fa sì chequesti dati medi siano le risultanti di valori moltovariabili nell’arco dell’anno, con un ampio divario tralivelli minimi e massimi. Il rapporto tra lavoratori eaziende evidenzia una struttura produttiva caratterizzatada imprese di piccole dimensioni, con un numero didipendenti che, in media, è pari a 5,6 unità. Il maggiornumero di aziende (80,7%) e lavoratori dipendenti (69%) delsettore è concentrato nel comparto dei pubblici esercizi(bar, ristoranti, mense, discoteche e stabilimentibalneari). Segue poi il comparto dei servizi ricettivi(alberghi e altre strutture ricettive), che comprende il14,7% delle aziende e il 26,1% dei lavoratori dipendenti,e, assai distaccato, quello dell’intermediazione (agenziedi viaggio, tour operator, guide e accompagnatorituristici) e gli stabilimenti termali. Per converso, gliesercizi alberghieri presentano dimensioni mediamente piùelevate rispetto ad altri comparti: 10,4 dipendenti perazienda contro i 5 di pubblici esercizi e dei servizi diintermediazione. La quota più consistente di dipendenti nelturismo è rappresentata da operai e impiegati, che pesanoper oltre il 90% sul totale. Mentre nelle agenzie diviaggio prevalgono nettamente gli impiegati, nei servizi
35
ricettivi e nei pubblici esercizi a dominare è la categoriadegli operai; più equilibrato, con riferimento alladistribuzione dei lavoratori dipendenti tra le diversecategorie, si mostra, invece, il comparto termale. Aglioccupati in posizione dipendente si aggiungono circacinquecentomila lavoratori autonomi nel settore deglialberghi e dei pubblici esercizi; si tratta in prevalenzadei titolari e dei collaboratori familiari, che all’internodelle piccole e medie imprese svolgono funzioni direttivesvolgendo il ruolo che in altri contesti è svolto dadirigenti e quadri. Il tempo pieno rappresenta la modalitàcontrattuale più diffusa in tutti i comparti del turismo: èsuperiore all’80% negli stabilimenti termali, nei serviziricettivi e nell’intermediazione, si attesta intorno al 60%nei pubblici esercizi. L’incidenza dei lavoratori stranieriextracomunitari sul totale dell’occupazione dipendente nelsettore turismo è, mediamente, dell’8,4%: essirappresentano il 9% dei dipendenti dei pubblici esercizi el’8% di quelli delle imprese della ricettività, mentre sonoassolutamente marginali nelle imprese dell’intermediazioneturistica e negli stabilimenti termali. Il settoreturistico si caratterizza per un’alta partecipazionefemminile al lavoro, assai più elevata che in altri settoridell’economia nazionale. Il comparto in cui maggiore è laquota di lavoratrici è quello dell’intermediazione, dove ledonne rappresentano il 77% dei dipendenti; quello in cui èminore è il ricettivo, dove trova impiego una quotarelativamente più bassa di donne (il 55,5%), ma pur sempremaggioritaria. Il settore, inoltre, come è noto, sicaratterizza per uno spiccato andamento stagionale chedetermina evidenti effetti sulla dinamica dell’occupazione.Il rallentamento dell’attività in alcuni mesi dell’anno ela sua sospensione in altri generano forti oscillazioni deilivelli occupazionali: nei mesi estivi (da giugno asettembre) il numero medio dei dipendenti è del 13,1%superiore al valore medio calcolato sull’intero anno. Il
36
fenomeno della stagionalità incide maggiormente sulledinamiche occupazionali dei servizi ricettivi, mentrecondiziona in maniera molto più marginale il compartodell’intermediazione. All’interno del comparto ricettivo,gli alberghi rappresentano la tipologia prevalenteincidendo per l’82,2% in termini di lavoratori dipendenti eper il 75,9% in termini di aziende. A seguito del fenomenodella stagionalità, particolarmente incisivo per gliesercizi alberghieri, il maggior numero di dipendenti siriscontra nei mesi di luglio e agosto (+36% rispetto allamedia annua) mentre a novembre le chiusure degli eserciziportano ad una decrescita rispetto alla media annua del22%.
Comparti lavoratori dipendenti
Min. MaxMedia annuale
Servizi ricettivi 169.450 327.659 241.299Pubblici esercizi 578.693 714.548 693.293Intermediazione 34.953 38.197 36.441Stabilimenti termali 7.353 10.350 8.849Totale Turismo 803.307 1.090.126 925.882
lavoratori indipendenti
Min. MaxMedia annuale
Servizi ricettivi 18.567 28.515 23.194Pubblici esercizi 117.654 138.371 127.467Intermediazione 6.699 7.050 6.907
37
Stabilimenti termali 259 343 314Totale Turismo 144.006 174.026 157.882
Fonte: EBNT, “Osservatorio sul mercato del lavoro nel turismo”, dati relativi al 2008
Lavoratori dipendenti e aziende per comparto (composizione%)
15%0,2%
81%
4%
Aziende
Servizi ricettivi Stabilimenti termaliPubblici esercizi Intermediazione
Fonte: EBNT, “Osservatorio sul mercato del lavoro nel turismo”, dati relativi al 2008
Come si evince dal grafico i lavoratori dipendenti sono occupati in grande misura nei pubblici esercizi, seguono poi gli occupati nel settore dei servizi ricettivi, nell’area dell’intermediazione e infine una piccola quota di persone(1%) è impiegata negli stabilimenti termali.
38
26%
1%
69%
4%
lavori dipendenti
Servizi ricettivi Stabilimenti termaliPubblici esercizi Intermediazione
Fonte: EBNT, “Osservatorio sul mercato del lavoro nel turismo”, dati relativi al 2008
categorie di lavoratori nei comparti del turismo(composizione %)
39
Servizi ricettivi
Stabilimenti termali
Pubblici esercizi
Intermediazione
Totale turismo
1
1.9
0.4
3.1
0.600000000000001
18.6
38.9
6
82.9
12.7
77.2
58.6
85.6
4.6
80
3.2
0.600000000000001
8
9.4
6.7
Dirigenti e quadri ImpiegatiOperai Apprendisti
Fonte: EBNT, “Osservatorio sul mercato del lavoro nel turismo”, dati relativi al 2008
Analizzando le categorie di lavoratori nel comparto turistico,si evidenzia dal grafico che la maggior parte dei lavoratorinelle aree servizi ricettivi, stabilimenti termali, e pubbliciesercizi è costituita dagli operai, mentre nell’areaintermediazione essi rappresentano una piccola percentuale. Inquest’ultima prevalgono i lavoratori che fanno parte dellacategoria degli impiegati. In tutte e 4 le aree gli apprendistie i dirigenti costituiscono una piccola parte della composizionepercentuale delle categorie di lavoratori di ciascuna area.
40
CompartiDirigenti Quadri
Impiegati Operai
Apprendisti Totale
Valori assolutiServizi ricettivi 366 1.964 44.837
185.619 7.786
240.572
Pubblici esercizi 320 1.707 38.497
546.194 51.079
637.797
Intermediazione 180 939 30.074 1.670 3.395 36.258Stabilimenti termali 52 112 3.435 5.170 57 8.826
Totale Turismo 918 4.722 116.843738.65
3 62.317923.45
3
Quota % sul totale del compartoturistico
Servizi ricettivi 39,9 41,6 38,4 25,1 12,5 26Pubblici esercizi 34,9 36,1 32,9 73,9 82 69,1Intermediazione 19,6 19,9 25,7 0,2 5,4 3,9Stabilimenti termali 5,7 2,4 2,9 0,7 0,1 1Totale Turismo 100 100 100 100 100 100
Fonte: EBNT, “Osservatorio sul mercato del lavoro nel turismo”, dati relativi al 2008
41
Comparti Maschi Femmine Totale
Valori assoluti
Servizi ricettivi 107.378 133.921241.29
9
Pubblici esercizi 265.307 373.986639.29
3Intermediazione 8.381 28.060 36.441Stabilimenti termali 3.371 5.478 8.849
Totale turismo 384.437 541.455925.88
2
42
Quota % sul totale del comparto turistico
Servizi ricettivi 27,9 24,7 26,1Pubblici esercizi 69 69,1 69Intermediazione 2,2 5,2 3,9Stabilimenti termali 0,9 1 1Totale turismo 100 100 100
Fonte: EBNT, “Osservatorio sul mercato del lavoro nel turismo”, dati relativi al 2008
2.4.3. Le tipologie contrattuali nei comparti del turismo (composizione %)
Le tipologie contrattuali che prevalgono all’interno dei comparti del turismo sono quelle full time, dove si raggiunge quasi una parità con la tipologia part time solo nei pubblici esercizi.
43
Servizi ricettivi
Stabilimenti termali
Pubblici esercizi
Intermediazione
Totale turismo
82.1
85.3
51.8
80.2
61.1
17.9
14.7
48.2
19.8
38.9
Full time Part timeFonte: EBNT, “Osservatorio sul mercato del lavoro nel turismo”, dati relativi al 2008
Part time TotaleComparti Full time
44
Operai Impiegati TotaleValori assoluti
Servizi ricettivi 197.409 36.643 6.520 43.163240.57
2
Pubblici esercizi 330.111 293.106 14.580307.68
6637.79
7Intermediazione 29.085 691 6.482 7.173 36.258Stabilimenti termali 7.526 799 501 1.300 8.826
Totale 564.131 331.239 28.083359.32
2923.45
3
Quota % sul totale del comparto turistico
Servizi ricettivi 35 11,1 23,2 12 26,1Pubblici esercizi 58,5 88,5 51,9 85,6 69,1Intermediazione 5,2 0,2 23,1 2 3,9Stabilimenti termali 1,3 0,2 1,8 0,4 1Totale 100 100 100 100 100
Fonte: EBNT, “Osservatorio sul mercato del lavoro nel turismo”, dati relativi al 2008
45
2.4.4 Il sesso dei lavoratori nei comparti del turismo
Nei diversi comparti del turismo la percentuale di donne occupate nei medesimi è superiore ma in maniera lieve rispetto alla percentuale maschile. Si nota maggiore differenza fra i due sessi nell’area dell’intermediazione, dove la percentuale di donne è pari al 77% contro il 23% degli uomini impiegati in tale settore.
Servizi ricettivi
Stabilimenti termali
Pubblici esercizi
Intermediazione
Totale turismo
44.5
38.1
41.5
23
41.5
55.5
61.9
58.5
77
58.5
Maschi Femmine
Fonte: EBNT, “Osservatorio sul mercato del lavoro nel turismo”, dati relativi al 2008
46
Lavoratori dipendenti per comparto e sesso
Comparti Maschi Femmine Totale
Valori assoluti
Servizi ricettivi 107.378 133.921241.29
9
Pubblici esercizi 265.307 373.986639.29
3Intermediazione 8.381 28.060 36.441Stabilimenti termali 3.371 5.478 8.849
Totale turismo 384.437 541.455925.88
2
Quota % sul totale del comparto turistico
Servizi ricettivi 27,9 24,7 26,1
47
Pubblici esercizi 69 69,1 69Intermediazione 2,2 5,2 3,9Stabilimenti termali 0,9 1 1Totale turismo 100 100 100
Fonte: EBNT, “Osservatorio sul mercato del lavoro nel turismo”, dati relativi al 2008
Lavoratori dipendenti nelturismo per regione
48
RegioniLavoratori dipendenti
Valori assoluti
Quota % su tot.Italia
Piemonte 60.877 6,6Valle d'Aosta 4.036 0,5Lombardia 167.589 18,1Trentino A.A. 40.442 4,4Veneto 93.428 10,1Friuli V.G. 17.543 1,9Liguria 30.646 3,3Emilia-Romagna 97.350 10,5Toscana 72.388 7,8Umbria 13.365 1,4Marche 24.968 2,7Lazio 90.134 9,7Abruzzo 19.685 2,1Molise 2.636 0,3Campania 52.977 5,7Puglia 41.321 4,5Basilicata 5.115 0,6Calabria 16.357 1,8Sicilia 48.365 5,2Sardegna 26.392 2,9ITALIA 952.882 100
Fonte: EBNT, “Osservatorio sul mercato del lavoro nel turismo”, dati relativi al 2008
Lavoratori dipendenti nei comparti del turismo per regione
servizi ricettivi
pubblici servizi
intermediazione
stabilimenti termali
Piemonte 15,7 77,6 6,1 0,6Valle d'Aosta 53,7 41,2 4,6 0,4
49
Lombardia 16,6 78,4 4,7 0,3Trentino A.A. 59,4 38,8 1,3 0,5Veneto 28,7 67,1 3,2 1Friuli V.G. 21,6 76,1 2,1 0,1Liguria 28,5 67,2 4,3 0Emilia-Romagna 23 72,8 3 1,2Toscana 29,6 66,4 2,8 1,2Umbria 25,3 72,1 2,3 0,3Marche 17,8 78,5 3,3 0,4Lazio 25,8 66,6 7,2 0,4Abruzzo 23,3 70,3 2,4 4Molise 23,5 74,6 1,9 0Campania 31,5 62,1 4,5 1,9Puglia 23 74 2,6 0,4Basilicata 28,5 69,6 1,7 0,2Calabria 34,8 61,9 2,2 1,1Sicilia 32,1 62,3 3,7 1,9Sardegna 34,9 57,5 2,8 4,8ITALIA 26,1 69 3,9 1
50
Piemonte
Lombardia
Veneto
Liguria
Toscana
Marche
Abruzzo
Campania
Basilicata
Sicilia
ITALIA
0 20 40 60 80 100
Servizi ricettivi Pubblici serviziIntermediazione Stabilimenti termali
Fonte: EBNT, “Osservatorio sul mercato del lavoro nel turismo”, dati relativi al 2008
51
Lavoratori dipendenti nelle varie tipologie ricettive
Tipologie ricettive Lavoratori dipendenti
Valori assoluti
Quota % su tot. ricettivo
Alberghi e motel, con ristorante 168.123 69,9Alberghi e motel, senza ristorante 30.185 12,5Totale alberghi 198.308 82,20
Ostelli della gioventù 772 0,3Rifugi di montagna 844 0,3Villaggi turistici 8.219 3,4Colonie,case per ferie,case di riposo 16.486 6,8Affittacamere,case pervacanza 647 0,3Agriturismo 169 0,1Altri es. complementari 10.617 4,4
Totale altri esercizi ricettivi 42.991 17,8
Totale esercizi ricettivi 241.299 100,00
Fonte: EBNT, “Osservatorio sul mercato del lavoro nel turismo”, dati relativi al 2008
52
2.5Indagine sull’occupazione nel settore alberghiero svoltadall’Istat
2.5.1Istituto nazionale di statistica
L'Istituto nazionale di statistica è un ente di ricercapubblico. Presente nel Paese dal 1926, è il principaleproduttore di statistica ufficiale a supporto dei cittadinie dei decisori pubblici. Opera in piena autonomia e incontinua interazione con il mondo accademico e scientifico.Dal 1989 l'Istat svolge un ruolo di indirizzo,coordinamento, assistenza tecnica e formazione all'internodel Sistema statistico nazionale (Sistan). Il Sistema èstato istituito con il d. lgs. 322/1989 come modificato daldpr 166/2010 per razionalizzare la produzione e diffusionedelle informazioni e ottimizzare le risorse destinate allastatistica ufficiale. Del Sistan fanno parte l'Istat, gliuffici di statistica centrali e periferici delleamministrazioni dello Stato, degli enti locali eterritoriali, delle Camere di Commercio, di altri enti eamministrazioni pubbliche, e altri enti e organismi
53
pubblici di informazione statistica. La missionedell'Istituto nazionale di statistica è quella di servirela collettività attraverso la produzione e la comunicazionedi informazioni statistiche, analisi e previsioni dielevata qualità. Queste devono essere realizzate in pienaautonomia e sulla base di rigorosi principi etico-professionali e di più avanzati standard scientifici. Loscopo è quello di sviluppare un'approfondita conoscenzadella realtà ambientale, economica e sociale dell'Italia aidiversi livelli territoriali e favorire i processidecisionali di tutti i soggetti della società (cittadini,amministratori, ecc.).L'Istat intende essere un'amministrazione innovativa, chesi impegna al servizio della collettività, valorizzando laprofessionalità e l'integrità del proprio personale,creando appropriate condizioni di lavoro e minimizzando ilproprio impatto sull'ambiente. L'Istat rispetta la privacydei rispondenti, protegge la confidenzialità dei datiricevuti e svolge le proprie attività in modo trasparente eindipendente.L'Istat è orientato alla ricerca della massima efficacia edefficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili,promuove lo sviluppo del Sistan e la collaborazione con glialtri enti del Sistema Statistico Nazionale e dellapubblica amministrazione, con il mondo della ricerca e conla società civile, anche allo scopo di accrescere lacultura statistica.
Obiettivi strategici di lungo periodo
1. Valutare le esigenze informative attraverso un dialogocontinuo con gli utenti.
2. Produrre informazione statistica rilevante per gliutenti nazionali e internazionali secondo i piùelevati standard qualitativi e rigorosi principietico-professionali.
54
3. Condurre ricerche metodologiche e applicate allo scopodi migliorare i processi di produzionedell'informazione statistica e contribuire allaconoscenza della realtà ambientale, economica esociale dell'Italia.
4. Sviluppare il Sistema Statistico Nazionale peraccrescere l'offerta e la qualità dell'informazionestatistica fornita alla collettività, massimizzando ilcoordinamento e l'efficienza del sistema.
5. Favorire lo sviluppo coordinato dei sistemiinformativi della pubblica amministrazione e la loroutilizzazione per fini statistici, così da accrescerel'informazione disponibile, massimizzandol'integrazione delle fonti e minimizzando il caricostatistico sui rispondenti.
6. Contribuire allo sviluppo del Sistema StatisticoEuropeo e favorire la cooperazione internazionale incampo statistico.
7. Diffondere e comunicare in modo efficacel'informazione statistica e le analisi realizzate perfavorire la conoscenza della realtà economica, socialeed ambientale dell'Italia e migliorare i processidecisionali dei soggetti privati e delle istituzionipubbliche.
8. Promuovere la formazione in campo statistico e lacultura statistica per migliorare la comprensione, alivello istituzionale e dei singoli cittadini,dell'informazione prodotta sulla realtà ambientale,economica e sociale dell'Italia e per favorire un suocorretto utilizzo.
9. Sostenere la produzione statistica attraverso processiamministrativi e gestionali di elevata qualità.
10. Sviluppare il capitale umano e migliorare lecondizioni di lavoro del personale.
55
I dati delle indagini statistiche sui risultati economicidelle imprese industriali e dei servizi, realizzatedall’Istat, consentono di tracciare un quadro articolatodella struttura e della performance delle imprese deidiversi settori in cui si articola il sistema economico.Tra questi settori, è compreso anche quello delle “attivitàdei servizi di alloggio e ristorazione” che riveste unruolo di primaria importanza all’interno del sistematuristico e che è dunque interessante analizzare, sia nelsuo complesso che nella sua articolazione in “servizi dialloggio” (alberghi e altre strutture ricettive) e “servizidi ristorazione” (ristoranti e bar, gelaterie epasticcerie, mense, servizi di catering).Nel 2008 il settore dei servizi di alloggio e ristorazione,costituito da 291.197 imprese attive (pari al 6,6% deltotale), ha occupato circa 1,3 milioni di addetti (di cuicirca 800 mila dipendenti) e ha realizzato un fatturato di66.827 milioni di euro e un valore aggiunto di 25.634milioni di euro. Per quanto riguarda i principaliindicatori economici, il valore aggiunto per addetto èstato pari a 20,3 migliaia euro, il costo del lavoro perdipendente a 19,9 migliaia euro e gliinvestimenti per addetto a 4,3 migliaia di euro: sono tuttivalori inferiori ai corrispondenti dati medi del sistemadelle imprese italiane. All’interno del settore, i servizidi alloggio detengono un peso marginale in termini diimprese (15%) e addetti (23,1%), ma la loro incidenza siincrementa se si considerano gli aggregati economici:valore aggiunto prodotto e, soprattutto, investimentirealizzati. Di conseguenza, i principali indicatori diperformance economica, produttività del lavoro (misurata davalore aggiunto per addetto) e investimento per addetto,risultano più elevati nel comparto ricettivo che in quelloristorativo.La struttura produttiva del settore, nel complesso e neidue comparti che lo compongono, è caratterizzata da una
56
larga presenza di microimprese (con meno di dieci addetti),le quali rappresentano il 93,5% delle imprese attive, il61,2 % degli addetti e il 47,7% del valore aggiuntodell’intero settore. Queste stesse microimprese presentanoi valori più bassi degli indicatori economici, più elevatinelle classi dimensionali intermedie. Focalizzandol’attenzione sulleimprese alberghiere registrate (circa 26 mila nel 2008 perun totale di oltre 235 mila addetti), esse rappresentano il59,2% delle imprese ricettive ma pesano per l’81% circa intermini di addetti e fatturato prodotto. Anche tra glialberghi prevalgono le imprese di piccole dimensioni: il42,5% si colloca nella classe dimensionale 5-20 che occupail 43,7% degli addetti ed esprime il 38,6% del fatturato.Informazioni interessanti sulle imprese alberghiereprovengono anche dall’analisi di fonte Cerved basata suidati del registro delle imprese. Con riferimento alladinamica demografica, dal 2005 al 2008 il tasso di natalitàdelle imprese alberghiere (cioè il rapporto tra il numerodi nuove nate e quello delle imprese già esistenti) haavuto un andamento decrescente, passando dal 4,4% del 2005al 3% circa del 2008. Opposto è stato il trend del tasso dimortalità che è, invece, passato dal 4,5% del 2005 al 5,5%del 2008. La dinamica demografica complessiva, misurata intermini di turnover (dato dalla differenza tra il tasso dinatalità e quello di mortalità), presenta dunque unbilancio che, da una sostanziale parità nel 2005, haassunto valori progressivamente più negativi fino adarrivare al -2,6%. Nel 2008 era comunque ancora attivol’80,5% per cento delle imprese nate nel 2003 e l’87,2% diquelle nate nel 2005: si tratta di valori più alti rispettosia a quelli complessivi del settore “alberghi eristoranti” che a quelli del totale dei settori,evidenziando una maggiore stabilità delle impresealberghiere.
57
2.5.2 Rilevazione sulle forze di lavoro
Il bollettino mensile di statistica è una pubblicazioneperiodica che propone dati e indicatori in serie storica,aggiornati mensilmente o, in qualche caso, con cadenza piùampia.Il Bollettino mensile di statistica, pubblicato dall'Istatfin dal 1926, ora è anche disponibile nella versioneonline. Con lo sviluppo delle banche dati di diffusione ela progressiva riduzione delle pubblicazioni cartacee,poichè la maggior parte dei contenuti pubblicati nelperiodico sono forniti nell'ambito del patrimonioinformativo statistico diffuso dall'Istat attraverso lebanche dati, le informazioni rese con il Bollettino mensiledi statistica on line si ottengono seguendo opportunipercorsi di navigazione. Il Bollettino perde quindi quellacaratteristica di pubblicazione a cadenza temporalemensile, pur favorendo ove possibile la periodicità mensiledei dati forniti, per guadagnare in termini di una maggiorquantità di dati resi disponibili e di un livello didisaggregazione più puntuale.A partire dal 2004, la rilevazione campionaria sulle forzedi lavoro viene effettuata con riferimento a tutte lesettimane dell’anno, tenuto conto di un’opportunadistribuzione del campione complessivo nelle 13 settimanedi ciascun trimestre.La rilevazione è progettata per garantire stime trimestralia livello regionale e stime provinciali in media d’anno. Lestime trimestrali rappresentano lo stato del mercato dellavoro nell’intero trimestre. In tale elaborato teniamoconto solo del mese di dicembre di ciascun anno.Il campione utilizzato è a due stadi, rispettivamentecomuni e famiglie, con stratificazione delle unità di primo
58
stadio. Per ciascun trimestre vengono intervistate circa 77mila famiglie, cui corrispondono 175 mila individui,residenti in 1.246 comuni di tutte le province delterritorio nazionale. Tutti i comuni capoluoghi diprovincia o con popolazione superiore a una soglia perciascuna provincia, detti autorappresentativi, sonopresenti nel campione in modo permanente. I comuni la cuipopolazione è al di sotto delle soglie, detti nonautorappresentativi, sono raggruppati in strati. Essientrano nel campione attraverso un meccanismo di selezionecasuale che prevede l’estrazione di un comune non auto-rappresentativo da ciascuno strato. Per ciascun comuneviene estratto dalla lista anagrafica un campione casualesemplice di famiglie.La popolazione di riferimento è costituita da tutti icomponenti delle famiglie residenti in Italia, anche setemporaneamente all’estero. Sono escluse le famiglie chevivono abitualmente all’estero e i membri permanenti delleconvivenze (istituti religiosi, caserme eccetera). Lapopolazione residente comprende le persone, di cittadinanzaitaliana e straniera, che risultano iscritte alle anagraficomunali. L’unità di rilevazione è la famiglia di fatto,definita come insieme di persone coabitanti, legate davincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione,tutela o da vincoli affettivi. L’intervista alla famigliaviene effettuata utilizzando una rete di rilevazionecontrollata direttamente dall’Istat mediante tecniche Capi(Computer assisted personal interview) e Cati (Computer assistedtelephone interview). In generale le informazioni vengonoraccolte con riferimento alla settimana che precedel’intervista.Ogni famiglia viene intervistata per due trimestriconsecutivi; segue un’interruzione per i due successivitrimestri, dopodiché essa viene nuovamente intervistata peraltri due trimestri. Complessivamente, rimane nel campioneper un periodo di 15 mesi. Taluni quesiti della
59
rilevazione, a motivo della difficoltà nella risposta dafornire o della sensibilità dell’argomento trattato,prevedono la facoltà di non rispondere.A partire dal 2004 le definizioni adottate per i principaliaggregati sono state modificate al fine di assicurare unacompleta corrispondenza con quelle raccomandatedall’International Labour Organization (Ilo) e adottate insede Eurostat. Le nuove definizioni sono riportate diseguito.Forze di lavoro: comprendono le persone occupate e quelledisoccupate.Occupati: comprendono le persone di 15 anni e oltre chenella settimana di riferimento:- hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasiattività che preveda un corrispettivo monetario o innatura;- hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nelladitta di un familiare nella quale collaborano abitualmente;- sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie omalattia). I dipendenti assenti dal lavoro sono consideratioccupati se l’assenza non supera tre mesi, oppure sedurantel’assenza continuano a percepire almeno il 50 per centodella retribuzione. Gli indipendenti assenti dal lavoro, adeccezione dei coadiuvanti familiari, sono consideratioccupati se, durante il periodo di assenza, mantengonol’attività. I coadiuvanti familiari sono consideratioccupati se l’assenza non supera tre mesi.Persone in cerca di occupazione: comprendono le persone nonoccupate tra 15 e 74 anni che:- hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca dilavoro nei 30 giorni che precedono l’intervista e sonodisponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma)entrole due settimane successive all’intervista;
60
- oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla datadell’intervista e sono disponibili a lavorare (o ad avviareun’attività autonoma) entro le due settimane successiveall’intervista, qualora fosse possibile anticipare l’iniziodel lavoro.Tasso di attività: rapporto tra le persone appartenenti alleforze di lavoro e la corrispondente popolazione diriferimento.Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e lacorrispondente popolazione di riferimento.Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca dioccupazione e le corrispondenti forze di lavoro.Tasso di disoccupazione di lunga durata: rapporto tra le persone incerca di occupazione da 12 mesi e oltre e le forze dilavoro.Oltre alle modifiche nelle definizioni, a partire dal 2004è stato rivisto l’intero processo produttivo dellarilevazione. La profonda riorganizzazione che caratterizzala nuova indagine consiste nell’utilizzo di una rete dirilevazione controllata direttamente dall’Istat, nelricorso a tecniche di rilevazione Capi e Cati, nellacostruzione di un sistema informativo per la gestione delleindagini sulle famiglie e per il monitoraggio della qualitàdel lavoro sul campo.Sulla base dei dati riportati nei Bollettini mensili distatistica, per la creazione delle seguenti tabelle, si ètenuto conto solo dei dati sull’occupazione femminile emaschile nel settore alberghiero e ristorativo analizzandosolo il mese di dicembre di ciascun anno.
61
occupati maschi nel settore alberghiero e ristorativo (in migliaia)
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004Dipendenti 393 363 378 383 358 315 267dirigenti 4 6 3 4 4 3 3quadri 3 3 4 3 8 7 6impiegati 63 55 67 62 57 46 53operai 313 291 292 302 276 250 199apprendisti 10 8 12 12 13 9 6Indipendenti 222 234 226 229 234 239 232imprenditori 13 11 11 18 15 20 32liberi professionisti 2 1 1 2 3 3 7coadiuvanti familiari 25 25 25 21 22 26 50collaboratori 8 7 5 8 5 4 0lavoratori in proprio 174 189 184 177 189 184 136soci di cooperativa 0 1 0 3 0 2 7Fonti: Istat, Bollettini mensili di statistica (2004-2010)
L’andamento occupazionale maschile nel settore turisticomostra un aumento del numero dei lavoratori nel medesimopassando da 267000, nel 2004, a 393000, nel 2010, perquanto concerne i dipendenti. Per i lavoratori indipendentivi è stato, nel corso degli anni prima un aumento e poi unadiminuzione del numero degli stessi, nel 2004 gli uomini
62
erano 232000, nel 2010 sono 222000. I lavoratori in proprioe gli operai sono le categorie professionali in cui sihanno più lavoratori.
Dipend
enti
dirige
ntiqua
dri
impieg
atiope
rai
appren
disti
Indipe
ndenti
impren
ditori
liberi
profe
ssioni
sti
coadiu
vanti
famili
ari
collab
orator
i
lavora
tori i
n prop
rio
soci d
i coop
erativ
a
0150300450
occupati maschi nel settore alberghiero
2010200920082007200620052004
posizione nella professione
migliaia
Fonti: Istat, Bollettini mensili di statistica (2004-2010)
63
Donne occupate nel settore alberghiero e ristorativo(in migliaia)
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004Dipendenti 454 427 451 383 410 385 273dirigenti 3 2 2 4 3 0 1quadri 3 2 6 3 3 4 2impiegati 69 65 66 62 57 53 45operai 366 341 367 302 333 319 219apprendisti 13 17 10 12 14 9 6Indipendenti 157 160 180 229 160 161 179imprenditori 5 4 10 18 5 7 17liberi professionisti 1 2 1 2 0 0 3lavoratori in proprio 97 103 124 177 94 46 78coadiuvanti familiari 40 45 38 21 50 5 77collaboratori 13 6 6 8 11 102 0soci di cooperativa 1 0 1 3 0 1 4Fonti: Istat, bollettini mensili di statistica(2004-2010)
L’andamento occupazionale delle donne nel settore ricettivomostra un notevole aumento dal 2004 al 2010 passando da273000 a 454000 lavoratrici dipendenti nel settore. Perquanto riguarda il numero delle lavoratrici indipendenti
64
esso è aumentato dal 2004 al 2008, per poi diminuire nel2009 e nel 2010. Le donne sono occupate maggiormente nelleposizioni professionali quali operai e lavoratori inproprio.
65
Dipendentidirig
entiquadri
impiegatiopera
i
apprendist
i
Indipenden
ti
imprendito
ri
liberi pro
fessionist
i
lavoratori
in propri
o
coadiuvant
i familiar
icollaborat
ori
soci di co
operativa
0200400
occupati femmine nel settore alberghiero e ristorativo
2010200920082007200620052004
posizione nella professione
miglia
ia
Fonti: Istat, bollettini mensili di statistica
66
CAPITOLO3
Il caso Sicilia
3.1. Scenario generale
I dati sulla condizione delle donne e delle lavoratrici inSicilia non sono confortanti: il tasso di attivitàfemminile, ossia la percentuale di siciliane che dichiaranodi lavorare o di cercare occupazione, è fermo al 35 percento: due siciliane su tre sono fuori dal mercato dellavoro, ed esercitano lavori casalinghi di cura. La Siciliaè una delle regioni europee con il più basso tassod’attività femminile: stando alle rilevazioni Eurostat del2008, l’Isola è penultima tra le regioni dei 27 paesidell’Ue, battuta solo dalla Campania. Quelle poche donneche lavorano fuori casa, spesso lo fanno in nero, senzaalcuna garanzia o protezione in caso di incidenti,maternità e senza contributi pensionistici. Non nuovo è losquilibrio delle retribuzioni: in media le donne del Sudguadagnano il 7,1 per cento in meno rispetto agli uomini.Lo scarto retributivo è del 5,3 per cento tra i dirigenti,del 9,5 tra i quadri, dell’11,3 tra gli impiegati e del 3,6tra gli operai. Nel caso in cui si confrontino gli stipendidi laureati e laureate il divario aumenta: le laureateguadagnano in media 26.500 euro all’anno contro i 41.900euro dei loro parigrado uomini, anche se a questo di certonon è estranea la tradizionale diversa scelta dei percorsidi studi. Nei primi nove mesi del 2009, il tasso didisoccupazione femminile nell’Isola era del 16,7 per centocontro il 12,1 per cento di quello maschile: sintomo,questo, di maggiori difficoltà per le donne nel trovare unlavoro. Da interviste fatte a datori di lavoro emerge che
67
solo in quattro casi su dieci il genere non costituisce unelemento discriminante nelle scelte di assunzione, e duevolte su tre si preferisce assumere un uomo. Spesso perchégli uomini, oltre a non richiedere congedi di maternità,sono ritenuti più liberi di occuparsi del lavoro, nonpressati da incombenze casalinghe, tuttora consideratecompito quasi esclusivo delle loro compagne. Le donneitaliane sono quelle che in Europa lavorano di più tra orepassate in ufficio e lavori di casa.Al sud il 25% delle donne esce dal mondo del lavoro a causadella nascita del primo figlio, e capita addirittura cheuna donna sposata venga scartata all’atto del colloqui dilavoro perché potenzialmente madre. Sarebbe opportuno, sesi volesse sostenere in maniera fattiva l’occupazione delledonne, mettere in atto politiche di sostegno allelavoratrici madri, orari più flessibili degli asili,congedi parentali part-time a padri e madri.
3.2L’occupazione femminile in Sicilia: confronto con le altre regioniitaliane (2004-2010)
L’analisi effettuata in Sicilia prende in considerazione lelavoratrici con un’età che va dai 15 anni in su, effettuatasu tutta la popolazione , senza distinzione di titolo distudio né di posizione professionale. Analizzandol’occupazione nel settore turistico, con particolareattenzione al settore commercio, alberghi e ristoranti, dal2004 al 2010, si tengono in considerazione tutte le regioniitali anele quali, hanno subito un leggero incremento delnumero delle lavoratrici in tale settore ed alcune hannoavuto, nel corso degli anni, una diminuzione del numerocome ad esempio la Lombardia, il Veneto il Lazio e laCampania, ma si tratta di variazioni minime che incidonolievemente sul numero totale delle donne occupate nellemedesime regioni. Per quanto riguarda la Sicilia essa hasubito negli anni un leggero incremento del numero delle
68
lavoratrici, e si posiziona all’ 8° posto per numero didonne occupate nel settore turistico, dopo la Lombardia, ilVeneto, l’Emilia Romagna, il Lazio, il Piemonte, la Toscanae la Campania.
Regioni 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Piemonte 156 153 157 167 173 170 166
Valle d'Aosta 6 5 5 6 6 5 6
Liguria 71 65 66 76 69 63 67
Lombardia 348 346 357 358 347 343 344
Trentino Alto Adige 49 48 49 51 51 51 51
Provincia Autonoma Bolzano 30 28 31 31 30 30 31
Provincia Autonoma Trento 20 20 19 20 21 21 20
Veneto 187 184 193 179 193 193 180
69
Friuli Venezia Giulia 50 49 43 48 47 49 51
Emilia Romagna 177 185 194 191 194 192 188
Toscana 148 146 165 167 172 161 160
Umbria 31 33 34 36 34 32 36
Marche 57 57 58 66 61 58 57
Lazio 172 170 171 184 178 177 166
Abruzzo 41 45 46 49 52 47 49
Molise 8 8 8 9 10 10 9
Campania 118 101 118 127 124 112 108
Puglia 86 79 86 101 96 93 96
Basilicata 12 13 12 13 13 14 14
Calabria 41 37 39 41 43 42 41
Sicilia 94 94 93 94 101 105 106
Sardegna 62 61 59 54 55 54 62Fonti: Istat
70
piemonteligu
ria
trentino
alto ad
ige
provinci
a autono
ma trent
o
friuli v
enezia g
iuliatosca
namarc
heabru
zzocamp
ania
basilica
tasicilia
0
100
200
300
400
2004200520062007200820092010
Regioni
occupa
ti in
miglia
ia
Fonti: Istat
3.3 Occupati in Sicilia per sesso
71
L’analisi dell’occupazione femminile nel settore turisticosiciliano, mette in evidenza l’incremento del numero delledonne lavoratrici. Nel 2004 le lavoratrici eranocirca94000, arrivando a 106000 nel 2010. Nonostante taleaumento il numero delle donne presenti in tale settore ècirca la metà rispetto a quello degli uomini che mantienelivelli maggiori, nel 2004 pari a 215000 e si arriva nel2010 a 220000, con lievi aumenti e diminuzioni subiti neglianni.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
50
100
150
200
250
occu
pati
in
migl
iaia
Fonti: Istat
72
3.4 Sicilia, Sardegna e Calabria a confronto
Esaminando i dati relativi all’occupazione femminile nelsettore commercio, alberghi e ristoranti, nelle regioniconcorrenti quali la Sardegna e la Calabria, si evidenziache il numero delle lavoratrici in Sicilia è superiorerispetto al numero delle due regioni messe a confronto. LaCalabria ha circa la metà delle lavoratrici presenti inSicilia, mentre la Sardegna si pone a metà tra le due,avendo comunque un numero di lavoratrici abbastanzainferiore rispetto a quello siciliano.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
20
40
60
80
100
120
siciliacalabriasardegna
73
CONCLUSIONIIl turismo è un fenomeno in continua espansione e produceun effetto moltiplicativo sia sulla spesa turistica sia sullivello dell’occupazione nel medesimo. Un ruolo decisivo ègiocato dalle risorse umane, che costituiscono un fattoreessenziale nell’economia dei servizi, fatta dalle personeper le persone.Gli occupati nel settore sono in crescita e aumenta sempredi più il numero delle donne impiegate nel medesimo intutte le regioni italiane, aumentando così di anno in annoil contributo che il turismo offre alla produzione delreddito nazionale.Il turismo costituisce un fenomeno che coinvolge moltiaspetti sociali, culturali, politici ed economici. Èproprio quest’ultimo aspetto che si è voluto analizzare nelpresente elaborato, con particolare riguardo all’incidenzadello stesso nell’occupazione femminile in Italia,esaminando in particolare la regione Sicilia. L’analisi delfenomeno a livello globale il turismo mostra un gran numerodi posti di lavoro alle donne, che in alcune aree sonopresenti in misura addirittura maggiore rispetto agliuomini, offrendo loro possibilità di miglioramenti dellapropria condizione sociale ed economica ed offrendo ingenerale possibilità di sviluppo all’area stessa.In Italia il turismo dà lavoro ad oltre due milioni dipersone, di cui quasi la metà sono donne.L’analisi dell’occupazione femminile in Italia mostra unaumento significativo delle donne nel settore turistico dal
74
2004 al 2010, confermando che il turismo è un fattorecruciale dell’economia italiana e che non può esseretrascurato.Il turismo si presenta infatti come collante di diversisettori, i quali non riguardano soltanto gli alberghi e laristorazione in senso stretto, ma anche i trasporti, ilcommercio, i settori collegati trasversalmente come quellorelativo alle infrastrutture e dell’industria dei generialimentari. Per tali ragioni il fenomeno turistico generaun effetto moltiplicativo sul Pil nazionale.Per quanto riguarda la Sicilia anche qui il turismorappresenta un elemento fondamentale per la crescitadell’economia regionale, offrendo numerose possibilità diaffermazione del ruolo della donna nella società sicilianae in particolare sul fronte delle possibilità di carrieranel settore.In altre parole, il turismo lavora per l’Italia, per laSicilia; il turismo dà lavoro all’Italia e alla Sicilia. E,se si saprà assecondarne lo sviluppo, potrà darne sempre dipiù.
75
Bibliografia
Candela G.Figini P., “Economia del Turismo”, McGraw
Hill, Milano,2003
Federalberghi, Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, Centro Studi sul Turismo di Assisi, “Trend e statistiche sull’economia del turismo”, EDIZIONI ISTA, Roma,2011
Federalberghi, Mercury Strategie per il turismo, “Sesto rapporto sul sistema alberghiero in Italia”, EDIZIONI ISTA, Roma, 2010
76
Sistema statistico nazionale, Istituto Nazionale di Statistica , “Annuario Statistico Italiano”, Centro stampa e riproduzione s.r.l., Roma, 2010
Sistema statistico nazionale, Istituto Nazionale di Statistica , “Annuario Statistico Italiano”, Centro stampa e riproduzione s.r.l., Roma, 2009
Sistema statistico nazionale, Istituto Nazionale di Statistica , “Annuario Statistico Italiano”, Centro stampa e riproduzione s.r.l., Roma, 2008
Sistema statistico nazionale, Istituto Nazionale di Statistica , “Annuario Statistico Italiano”, Centro stampa e riproduzione s.r.l., Roma, 2007
Sistema statistico nazionale, Istituto Nazionale di Statistica , “Annuario Statistico Italiano”, Centro stampa e riproduzione s.r.l., Roma, 2006
Sistema statistico nazionale, Istituto Nazionale di Statistica , “Annuario Statistico Italiano”, Centro stampa e riproduzione s.r.l., Roma, 2005
Sistema statistico nazionale, Istituto Nazionale di Statistica , “Annuario Statistico Italiano”, Centro stampa e riproduzione s.r.l., Roma, 2004
Sistema statistico nazionale, Istituto Nazionale di Statistica , “Bollettino mensile di statistica”,
77
Rubbettino Industrie Grafiche ed Editoriali Soveria Mannelli (CZ), Roma, 2004
Sistema statistico nazionale, Istituto Nazionale di Statistica , “Bollettino mensile di statistica”, Rubbettino Industrie Grafiche ed Editoriali Soveria Mannelli (CZ), Roma, 2005
Sistema statistico nazionale, Istituto Nazionale di Statistica , “Bollettino mensile di statistica”, Rubbettino Industrie Grafiche ed Editoriali Soveria Mannelli (CZ), Roma, 2006
Sistema statistico nazionale, Istituto Nazionale di Statistica , “Bollettino mensile di statistica”, Rubbettino Industrie Grafiche ed Editoriali Soveria Mannelli (CZ), Roma, 2007
Sistema statistico nazionale, Istituto Nazionale di Statistica , “Bollettino mensile di statistica”, Rubbettino Industrie Grafiche ed Editoriali Soveria Mannelli (CZ), Roma, 2008
Sistema statistico nazionale, Istituto Nazionale di Statistica , “Bollettino mensile di statistica”, Rubbettino Industrie Grafiche ed Editoriali Soveria Mannelli (CZ), Roma, 2009
Sistema statistico nazionale, Istituto Nazionale di Statistica , “Bollettino mensile di statistica”,
78
Rubbettino Industrie Grafiche ed Editoriali Soveria Mannelli (CZ), Roma, 2010
World Tourism Organization (UNWTO), “Global Report onWomen in Tourism”, New York, 2011
Siti webISTAT:www.Istat.itINPS:http://www.inps.itCNEL:www.cnel.it ENIT:
http://www.enit.it
Mercury s.r.l.:
79
http://www.turistica.it
Osservatorio del turismo:
http://www.ontit.it/ont/
EBNT:
www. ebnt .it FEDERALBERGHI:
www.federalberghi.it
80