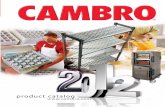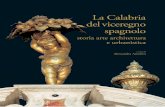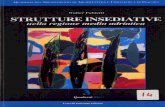Ordini mendicanti nella città e nella diocesi, in Storia della Chiesa riminese, II, Dalla lotta per...
Transcript of Ordini mendicanti nella città e nella diocesi, in Storia della Chiesa riminese, II, Dalla lotta per...
Ordini mendicanti nella città e nella diocesi*
Riccardo Parmeggiani
Un segno dell’incidenza dei nuovi ordini mendicanti sulla vita religiosa e cul-turale della Chiesa riminese nel medioevo emerge con evidenza dall’impianto
stesso di questo volume, dove i diversi studi dedicati all’agiografia, ai movimenti ereticali, alle testimonianze artistiche e architettoniche, alle attività caritative ed assistenziali, alla speculazione dei più illustri teologi diocesani, hanno come perno i conventi di queste religiones novae. Il loro insediamento in forma stabile nell’ambito urbano ebbe già a partire dalla metà del Duecento profonde e durature conseguen-ze anche sugli equilibri politici cittadini, accompagnando, e contemporaneamente guidando, il mutamento della società riminese, esercitando una funzione di raccor-do fra autorità pontificia e particolarismo locale, riuscendo ad intrecciare, special-mente per quanto riguarda l’ordine dei Minori, una relazione privilegiata con i ceti dirigenti comunali e ben presto con il potere signorile dei Malatesti.
L’analisi delle origini e degli sviluppi storici dei Mendicanti nella diocesi è in parte complicata dallo stato delle fonti conservate. Il panorama, pur con la relativa eccezione costituita dalla documentazione agostiniana, non risulta infatti estrema-mente ricco per l’epoca medievale a causa di distruzioni e dispersioni del materiale archivistico1. A questa carenza, cui in parte si sopperisce con il ricorso a testimo-nianze dal carattere più indiretto (testamenti, presenze testimoniali, ecc.) è da som-mare la scarsa affidabilità di alcune delle fonti superstiti, dai toni leggendari, se non addirittura dolosamente falsate o artatamente create in epoca successiva. A simili risultati ha portato la severa critica condotta da Jacques Dalarun, a sua volta, in par-te criticata, nei confronti di alcune fonti cronachistiche e agiografiche di notevole importanza per la storia religiosa riminese nel medioevo2.
Tenendo presenti queste acquisizioni vanno dunque opportunamente inquadrati i pionieristici esordi nel riminese dei due principali ordini mendicanti – francesca-no e domenicano – legati secondo la tradizione alla presenza di Francesco d’Assisi e a personaggi tra i più carismatici della prima generazione dei Minori e dei Pre-dicatori. Se il secondo dato risulta certamente fondato, sia pur proposto in alcuni casi con amplificazioni irreali, il primo non è storicamente dimostrabile, benché
* Versione originale ripristinata secondo la volontà dell’autore rispetto al testo edito a stampa.1. G. Plessi, Guida alla documentazione francescana in Emilia-Romagna, Padova 1989, passim; A. Tur-
chini, Il Tempio Malatestiano, Sigismondo Pandolfo Malatesta e Leon Battista Alberti, Cesena 2000, pp. 28-31; Id. 2009, p. 306 e nota 128.
2. J. Dalarun, La part du faux. Les bienheureux Andrea et Giovanni franciscains de Rimini au XIVe siècle, «Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen Âge», CII, 1 (1990), pp. 79-129; Id., «Lapsus linguae». La légende de Claire de Rimini, Spoleto 1994. Osservazioni critiche rispetto alle conclusioni dello storico francese si trovano in F. Costa, La B. Chiara da Rimini (ca. 1260-1326) e le pretese falsificazioni di France-scantonio Righini OFMConv (1722-1779), «Miscellanea francescana», CI (2001), pp. 792-826.
riccardo parmeggiani
venga ancora accreditato sulla scorta dell’annalistica del Wadding e di altre fonti locali dal carattere leggen-dario3. L’ipotetica presenza di un primitivo insedia-mento a Rimini fondato dal Poverello (fig. 1) tra il 1213 e il 1215 cozza del resto contro la testimonianza contenuta nella Vita del preposto Al-debrando, secondo la quale il religioso fu spinto verso un’energica predicazione antiereticale in città «per-ché allora non esistevano gli ordini mendicanti»4. Quest’ultimo episodio risa-lirebbe agli anni Venti, vale
a dire nello stesso decennio in cui altre fonti agiografiche fissano la venuta a Ri-mini del secondo santo francescano, Antonio da Padova, anch’esso impegnato in prediche miracolose in funzione antieterodossa5. Ben più tangibili, ma anche più tarde, sono le testimonianze circa la presenza in Romagna e nella stessa Rimini del domenicano Pietro da Verona (1249) – san Pietro Martire, il secondo santo dei
3. Come rigorosamente confermato da Giuseppe Plessi (Guida, cit., p. XVIII; ma cfr. anche p. 70): «la tradizione vuole che qualche […] paese o città, come Verucchio, Rimini, Longiano […] siano state visitate dal Santo, ma tali visite non vengono registrate dalle prime fonti francescane». La vulgata di un leggendario passaggio del Poverello di Assisi è tuttavia ancora viva, benché in forma ormai sostanzial-mente tralatizia: cfr., oltre a importanti, ma datati studi, quali C. Ricci, Il Tempio Malatestiano, Rimini 1974 (ristampa con appendice di P.G. Pasini dell’ed. del 1924), pp. 159-161, 167 e P.G. Giovanardi, L’ordine francescano a Rimini, «Studi francescani», XIV (1927), pp. 322-335 (nello specifico p. 322), la più recente ripresa in Turchini, Il Tempio Malatestiano, cit., p. 123. Anche nell’opera di Luigi Tonini (III, pp. 316-317) è dato credito alle ipotetiche fondazioni dirette da parte di Francesco.
4. J. Dalarun, Santa e ribelle. Vita di Chiara da Rimini, Roma-Bari 2000, p. 73.5. Intorno all’ipotetica data del 1227 non si registra un unanime consenso da parte della storiografia
specialistica: cfr. riepilogativamente per le diverse posizioni, A. Rigon, Antonio e il minoritismo padano, in I compagni di Francesco e la prima generazione minoritica. Atti del XIX Convegno internazionale (Assisi, 17-19 ottobre 1991), Spoleto 1992, pp. 167-199, ora in Id., Dal Libro alla folla. Antonio da Padova e il francescanesimo medioevale, Roma 2002, pp. 21-45 (nello specifico, p. 42 nota 61). Per i contenuti delle leggende e i parziali adattamenti all’ambito riminese del miracolo della mula, cfr. Dalarun, «Lapsus linguae», cit., pp. 285-286.
Fig. 1. Villa Verucchio, Chio-stro del convento francescano di S. Croce con il cipresso di san Francesco.
ordini mendicanti nella città e nella diocesi
Predicatori – e forse, se è corretta l’identificazione, di Giovanni da Vicenza, il leader del grande movimento devozionale dell’«Alleluia» (1233), frate che sarà protagonista dell’insediamento dell’ordine in città.
Pur se a cavaliere tra leggenda e realtà, è indubbio che precursori così illustri abbiano favorito l’affermazione dei rispettivi ordini, determinando verso i frati un immediato e crescente consenso da parte dei fedeli nella città e nella diocesi. La so-stanziale omogeneità cronologica dell’insediamento dei Mendicanti entro le mura attorno alla metà del Duecento – il fenomeno a Rimini è più tardo rispetto a quello di altre realtà urbane poste lungo l’asse della via Emilia – non è comunque casuale, né tantomeno riconducibile alla sola presenza di figure carismatiche.
1. Vescovi mendicanti
Con la morte di Federico II (1250) si era creato nel fronte ghibellino romagnolo un vuoto di cui il Papato seppe approfittare, sostenendo energicamente i partiti guelfi locali fino ad affermare anche temporalmente la propria autorità con l’annessio-ne della provincia di Romagna allo stato pontificio nel 12786. In questo processo la politica della Santa Sede fece leva essenzialmente sui Mendicanti, riuscendo a contrastare le fazioni filoimperiali e puntellando i risultati ottenuti dal guelfismo locale mediante la promozione di membri degli ordini alla cattedra episcopale. Le città di Rimini, Cesena, Cervia e Faenza, le stesse dove si era svolta la legazione del cardinale Ottaviano Ubaldini, porporato che reggerà la diocesi adriatica in qualità di amministratore apostolico tra il 1249 e il 1250, e in cui il domenicano Pietro da Verona aveva esplicato un’efficace azione pacificatrice nel 1249, registrarono una rei-terata presenza di vescovi reclutati tra le fila dell’ordine dei Predicatori e, in misura meno consistente, dei Minori7. Si tratta di nomine di frati in prevalenza provenienti da ambiti esterni a quello locale, secondo una prassi in quegli anni diffusa8 in base ad una logica che risponde a ragioni molteplici. Un candidato forestiero garantiva innanzitutto il necessario ruolo super partes in una fase particolarmente travagliata della vita comunale, in cui allo scontro tra la fazione guelfa e quella ghibellina si sommava il contrasto tra magnati e popolani. Il ricordo della ricomposizione dei
6. Su questo frangente storico il riferimento imprescindibile va ad A. Vasina, I Romagnoli fra autonomie cittadine e accentramento papale nell’età di Dante, Firenze 1965. Per l’affermazione papale su Rimini e sulla Romagna notevole fu il contributo di alcuni frati domenicani, come Giovanni da Viterbo, Lorenzo da Todi e, soprattutto, Latino Malabranca, cardinal legato e nipote del pontefice Niccolò III.
7. Sull’azione di san Pietro Martire in Romagna, cfr. A. Dondaine, Saint Pierre Martyr. Études, «Ar-chivum Fratrum Praedicatorum», XXIII (1953), p. 83, mentre sulla legazione del cardinale Ubaldini si veda Vasina, I Romagnoli, cit., pp. 3ss. Circa le designazioni pontificie di vescovi mendicanti nelle città citate, cfr. G.M. Varanini, Episcopato, società e ordini mendicanti in Italia settentrionale fra Duecento e Trecento, in Dal pulpito alla cattedra. I vescovi degli ordini mendicanti nel ‘200 e nel ‘300. Atti del XXVII Convegno Internazionale (Assisi, 14-16 ottobre 1999), Spoleto 2000, pp. 105-106.
8. Il rimando va agli atti dei convegni assisiati Il Papato duecentesco e gli ordini mendicanti. Atti del XXV Convegno Internazionale (Assisi, 13-14 febbraio 1998), Spoleto 1998 e Dal pulpito, cit. Cfr. più di recente in maniera riepilogativa L. Baietto, Il papa e le città. Papato e comuni in Italia centro-settentrionale durante la prima metà del secolo XIII, Spoleto 2007, pp. 417ss.
riccardo parmeggiani
conflitti intercittadini operata da Pietro da Verona era del resto vivissimo. Oltre a ciò, secondo un disegno accentratore del Papato, la scelta di un presule-frate as-sicurava ai pontefici ampi margini di manovra sulla Chiesa e la città locale. La politica filomendicante promossa anche sul fronte delle designazioni episcopali da Innocenzo IV (1243-1254) e, in forma ancor più accentuata, da Alessandro IV (1254-1261) è in buona parte dettata dal collegamento fiduciario tra questi ordini esenti e la sede pontificia, da cui dipendevano direttamente: tra i vescovi designati figurano inoltre frati assai vicini ai papi, a ulteriore riprova dell’importanza del ruolo rico-perto dai Mendicanti nel governo della Chiesa. I due pontefici appena ricordati impressero una svolta alle elezioni episcopali attraverso il sempre più frequente ricorso al diritto di riserva9, favorito nel caso riminese sia dall’emergere di contrasti in seno al Capitolo locale, sia – e soprattutto – in considerazione dell’immediata subordinazione ab immemorabili della diocesi alla Sede Apostolica e non all’autorità del metropolita ravennate.
Se sussistono molti e fondati dubbi sull’episcopato di un non meglio specifi-cato Ugolino (1245-1249), frate domenicano10, sono invece ben attestati quelli del bergamasco Algisio da Rosciate (1250-1251)11, penitenziere di Innocenzo IV, e di Ambrogio da Orvieto (1265-1277), entrambi appartenenti all’ordine dei Predicatori. Nell’elezione del secondo il pontefice Clemente IV era riuscito ad inserirsi cassando due contrapposte designazioni capitolari, probabile sintomo delle profonde divi-sioni che laceravano la città e opponevano le famiglie più in vista, tra i cui ranghi era normalmente reclutato il clero della cattedrale12. La scelta di un presule-frate allogeno si rivelava dunque strategica per l’affermazione di una soluzione che era sì pacificatrice, ma che mirava non secondariamente a ridurre i margini di manovra dei poteri cittadini. La supremazia pontificia su Rimini e sull’intera regione passa-va naturalmente anche attraverso il controllo della Chiesa locale. L’incorporazione della Romagna nello stato papale, avvenuta l’anno seguente alla morte di Ambrogio, segnò un’attenuazione dell’interventismo pontificio; nonostante ciò, la presenza di vescovi provenienti dalle fila dei Predicatori, questa volta di estrazione locale, pro-seguì nel primo Trecento, come testimoniano gli episcopati di Lorenzo Balacchi (1300-1303) e Girolamo Fisici (1323-1328), penitenziere apostolico e cappellano di Giovanni XXII13. Di lì alla fine del medioevo si registreranno soltanto altri due
9. L. Pellegrini, Vescovi e ordini mendicanti in Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo, Atti del VII convegno di storia della Chiesa in Italia (Brescia, 21-25 sett. 1987), Italia sacra. Studi e docu-menti di storia ecclesiastica, 43-44, I, Roma 1990, p. 212.
10. Tonini, III, pp. 289-293.11. Ibid., pp. 299-300; A. Caldara, Algisio da Rosciate, DBI, 2, pp. 363-365.12. Le bolle pontificie del 5 ottobre 1265 contenenti la comunicazione della nomina a vescovo da parte
di Clemente IV all’interessato e alle autorità civili riminesi sono edite in Th. Ripoll – A. Bremond, Bul-larium Ordinis Fratrum Praedicatorum, I, Romae 1729, pp. 458-459, nn. 24-27; la prima, con un’opportuna correzione, è edita anche in Tonini, III, pp. 568-569 n. CXIV. L’atto di imperio del papa per la cattedra riminese è ripreso da E. Pásztor, I pontefici romani e i vescovi mendicanti, in Dal pulpito, cit., p. 36, e Va-ranini, Episcopato, cit., p. 111.
13. Su cui si vedano, Tonini, IV, pp. 401-402, 406-408 e, unicamente circa il secondo, Dalarun, «Lapsus linguae», cit., pp. 126-131.
ordini mendicanti nella città e nella diocesi
vescovi mendicanti, entrambi agostiniani, il celebre Ugolino da Orvieto (1371-1373)14 e Girolamo Leonardi (1418-1435)15. Stupisce non rilevare la presenza di un francesca-no, nonostante un frate dell’ordine, Francesco da Rimini, fosse stato postulato alla cattedra nel 1450 da Sigismondo Pandolfo Malatesti16: l’incidenza dei Minori sulla vita politica e religiosa riminese troverà, come vedremo, altri canali di affermazione.
2. Una strategia insediativa organizzata? Le origini, gli sviluppi, l ’inquadramento isti-tuzionale.
Gli ordini mendicanti si radicano all’interno della città proprio nel periodo di in-tervallo tra i due vescovi domenicani duecenteschi, vale a dire durante l’episcopato del presule di origine bolognese Giacomo (1251-1262). Per meglio comprendere la dinamica storica che portò alla formazione dei diversi insediamenti è opportuno analizzarli singolarmente17.
2.1 Minori
Prescindendo dai dati leggendari, un primitivo nucleo francescano è attestato in città a partire dal 1228, quando in un testamento è presente un lascito pauperibus Christi fratribus Minorum, in civitate Arimini ultra Apusam permanentibus nunc et permansuris ibidem. Si tratta della prima attestazione certa, che denota il carattere provvisorio della sede, ma in via di stabilizzazione, come confermano successivi documenti dei primi anni Trenta in cui il luogo è definito heremus / locus fratrum Minorum / locus Ecclesie beati Francisci de Arimino18. I quattro lasciti testamentari nel breve volgere di pochi anni (1228-1235) suggeriscono, anche in considerazione della scarsa sopravvivenza documentaria, un immediato consenso nei confronti di quel primo gruppo di frati. La specificazione ultra Apusam sembra doversi riferire alla Fossa Patara e non all’Ausa, una zona disabitata e ricca di vegetazione (broilus) non lontana da quello che di lì a breve sarà il luogo di insediamento dei membri dell’ordine, la chiesa di S. Maria in Trivio19 (fig. 2). Si trattava di un piccolo, ma
14. Il frate agostiniano, già generale dell’ordine (1368-1371), era Patriarca di Costantinopoli e resse la diocesi in qualità di administrator. Fine teologo e autore di diverse opere (tra cui un importante commento alle Sentenze di Pietro Lombardo), Ugolino si avvalse nel governo della Chiesa riminese dell’aiuto di un vicario suo confratello, Paolo da Pisa (Tonini, IV/1, pp. 417-418).
15. Su cui cfr. infra, nota 75.16. La supplica, avanzata al Capitolo della cattedrale per interposta persona dal fratello di Sigismondo
Pandolfo, Malatesta Novello, signore di Cesena, è edita in Tonini, V/2, pp. 175-176, n. LVII. 17. Sugli insediamenti mendicanti le annotazioni di carattere generale sono da intendersi costantemen-
te riferite ai numerosi studi che Luigi Pellegrini ha dedicato a questo specifico tema, tra cui principal-mente: Gli insediamenti degli ordini mendicanti e la loro tipologia. Considerazioni metodologiche e piste di ri-cerca, in Les Ordres Mendiants et la Ville en Italie centrale (v.1220-v.1350), «Melanges de l’École française de Rome. Moyen Age», LXXXIX, (1977), pp. 563-573; Insediamenti francescani nell’Italia del Duecento, Roma 1984; Conventi mendicanti e spazio urbano nell’Italia dei secoli XIII-XIV, in C.D. Fonseca – C. Violante (a cura di), Chiesa e città, Galatina 1990, pp. 45-53.
18. Un sunto della documentazione si trova in Garampi, Memorie ecclesiastiche, pp. 412-413.19. Tonini, III, pp. 317-318.
riccardo parmeggiani
significativo avvicinamento da un luogo più periferico ad uno più centrale, secondo un topico paradigma che accomuna molti dei primi insediamenti dei frati Minori. Tale vicinanza è confermata dall’atto con cui il vescovo Giacomo il 9 giugno 1257 consegnò l’edificio sacro ai francescani, dal momento che questo si trovava troppo a ridosso (ecclesia … nimium contigua et vicina) al rudimentale locus dei Minori, tra-sferendo materialmente il possesso della chiesa al frate guardiano Domenico. Nel processo era intervenuto lo stesso pontefice Alessandro IV, il quale aveva ordinato all’abate di Pomposa, da cui l’allora monastero di S. Maria in Trivio dipendeva, la concessione a titolo gratuito della chiesa, nonché, previo indennizzo, di una casa
Fig. 2. J. Janssonius, Veduta della Città di Rimini, tratta dal Theatrum celebriorum, urbium Italiae…, Amsterdam, 1656, acquaforte, particolare. Evoluzione dell’area d’insediamento dei frati Minori in S. Maria in Trivio.
ordini mendicanti nella città e nella diocesi
e di un orto annessi all’edificio. Il papa dovette inoltre confermare ed approvare l’operato del vescovo riminese con un atto d’autorità (de plenitudine potestatis) in assenza del consenso del Capitolo della cattedrale20, segno evidente di frizioni e resistenze da parte del corpo ecclesiastico più influente della diocesi. L’intervento pontificio nei confronti dei monaci pomposiani denota inoltre una precisa strategia da parte del filomendicante Alessandro IV, con lo scopo evidente di dare un nuovo slancio alla pastorale attraverso la sostituzione di strutture più tradizionali con i più dinamici ed efficaci frati Minori. Come suggerisce il nome stesso di S. Maria in Trivio, la chiesa era situata alla confluenza di diverse strade21 all’interno del quar-tiere che proprio ai monaci di Pomposa doveva la sua denominazione. La posizione era dunque centrale, nella zona della città detta anche nelle fonti più tarde “la Pa-terina”, con riferimento ai gruppi ereticali, e nello specifico a quello cataro, radicati in quell’area. L’indicazione toponomastica è tuttavia attestata da testimonianze non anteriori al Quattrocento, fatto che contribuisce a sollevare alcuni dubbi anche sul nesso direttamente causale che avrebbe legato l’insediamento francescano locale alla repressione della dissidenza religiosa mediante l’attribuzione dell’ufficio inqui-sitoriale da parte del Papato a partire dal 125922. Certamente la concentrazione ete-rodossa in specifiche zone urbane non va intesa come isolamento, una sorta di più o meno volontaria ghettizzazione: al contrario, gli eretici privilegiano le aree ad alta densità di attività produttive, artigianali e commerciali, come appunto quelle lungo il corso della Fossa Patara23. I frati Minori riminesi dovettero dunque confrontarsi con un milieu sociale composito e particolarmente dinamico in quel secolo di forte espansione economica e demografica che fu il Duecento, fronteggiando gli avver-sari più sul piano indiretto della pastorale che su quello esclusivamente repressivo.
Il complesso di S. Maria in Trivio subì in seguito profonde trasformazioni, che richiesero lunghi lavori, in parte favoriti dalla concessione di indulgenze, come te-stimonia la bolla Vite perennis gloria del pontefice francescano Niccolò IV nel 129224. Non molto più tardi, tuttavia, un violentissimo terremoto, avvenuto il 25 gennaio 1308, causò il crollo parziale della chiesa e quello totale della sagrestia e della sala capitolare25 (fig. 3).
Il convento riminese era inquadrato nella provincia francescana di Bologna e nella subordinata circoscrizione della custodia di Forlì. Benché siano incerte le date
20. Cfr. il contenuto delle due bolle Iustis petentium desideriis (28 luglio 1257) e Solet annuere (20 settem-bre 1259), edite in I.-H. Sbaralea, Bullarium Franciscanum Romanorum pontificum constitutiones, epistolas ac diplomata continens tribus ordinibus Minorum, Clarissarum, et Poenitentium concessa, II, Romae 1761, pp. 231-33 (n. 350), 362 (n. 509).
21. Tonini, Rimini dopo il Mille, p. 85.22. Dalarun, «Lapsus linguae», cit., pp. 275-277, 287-288.23. A. Vasina, La società riminese nel tardo medioevo, in Id., Romagna medievale, Ravenna 1970, p. 259;
per una riflessione di carattere generale, L. Paolini, Domus e zona degli eretici. L’esempio di Bologna nel XIII secolo, RSCI, XXXV/2 (1981), pp. 371-387, in particolare pp. 385-387.
24. Sbaralea, Bullarium Franciscanum, cit., IV, Romae 1768, p. 314, n. 590.25. Cfr. la testimonianza diretta dell’anonimo inquisitore riminese dell’epoca riportata in C. Piana,
Chartularium Studii Bononiensis sancti Francisci (saec. XIII-XVI), Analecta Franciscana, x1, Ad Claras Aquas 1970, p. 368.
riccardo parmeggiani
di fondazione, nel corso del Duecento e, probabilmente, del primo Trecento si mol-tiplicarono gli insediamenti minoritici nella diocesi: sorsero infatti conventi a Monte Formosino (nei pressi di Mondaino, nella custodia di Fano, risalente almeno al 1256), Longiano (prima del 1277), Santarcangelo (prima del 1298) – città sede almeno dal 1289 di una “fraternita” di Penitenti, poi Terz’Ordine francescano –, Verucchio (pri-ma del 1311) e Montescudo (prima del 1450)26. L’importanza acquisita dal convento di S. Maria in Trivio è testimoniata dalla frequente celebrazione di capitoli provin-
26. Per Monte Formosino, cfr. Sbaralea, Bullarium Franciscanum, cit., II, p. 174, n. 254; IV, p. 316, n. 594; Tonini, III, p. 297. Per Longiano e Montescudo, Plessi, Guida, cit., rispettivamente pp. XIX, XXII. Per Santarcangelo, G. Fussenegger, De manipulo documentorum ad usum inquisitoris haereticae pravitatis in Romandiola saec. XIII, «Archivum Franciscanum Historicum», XLIV (1951), pp. 81-82. Per Verucchio, M. Medica, L’insediamento francescano di Villa Verucchio. Note sulla provenienza del “dossale Corvisieri” e su un modello giottesco per la Romagna, in D. Ferrara (a cura di), Giovanni Baronzio e la pittura a Rimini nel Trecento, Cinisello Balsamo 2008, pp. 59-67. Sulla “fraternita” santarcangiolese, cfr. Mariano d’Alatri, Penitenti francescani di Romagna nel secolo XIII, in Id. (a cura di ), Il movimento francescano della penitenza nella società medievale, Roma 1980, p. 323, ora in Id., Aetas poenitentialis. L’antico Ordine francescano della penitenza, Roma 1993, pp. 115-116.
Fig. 3. Rimini, Il chiostro dell’ex convento di S. Francesco, di fianco al Tempio Malatestiano. Al centro del cortile, il pozzo cinquecentesco proveniente dall’abbazia di S. Giuliano. Il complesso è stato completamente distrutto dai bombardamenti del 1943-‘44.
ordini mendicanti nella città e nella diocesi
ciali dell’ordine nel corso del Trecento (1319, 1331, 1347, 1357, 1363, 1374, 1381), nonché di quello generale nel 139627. L’accrescimento del ruolo esercitato dai francescani riminesi è del resto confermato dalla creazione di una custodia autonoma almeno a partire dalla fine del Quattrocento28; la tipologia circoscrizioniale in ambito pro-vinciale era stata stabilita già nella prima metà del Duecento, quando la marginalità originaria dell’insediamento giocò a sfavore di un maggior protagonismo.
Da ricondurre al movimento dell’Osservanza è il convento di S. Maria delle Grazie (fig. 4), fondato nel 1396 dai conventuali e passato agli Osservanti nel 142029.
2.2 Predicatori
La figura del vescovo Giacomo fu decisiva anche per l’introduzione in città dei frati domenicani, riguardo ai quali – a differenza di quanto avvenne per i france-
27. Piana, Chartularium, cit., pp. 205, 220, 234, 245, 249, 259, 266, 91*. Nel corso del medioevo capitoli provinciali si tennero anche a Longiano (nel 1395; ibid., p. 278) e a Santarcangelo (nel 1473; ibid., p. 323).
28. Ibid., p. 324 e, per un’attestazione più tarda, p. 136.29. Tonini, IV/1, pp. 435-436.
Fig. 4. Rimini, Il chiostro del convento francescano di S. Maria delle Grazie (XV secolo).
riccardo parmeggiani
scani – non si ha notizia di un precedente stanziamento. Ad appena un lustro di distanza dalla venuta a Rimini di Pietro da Verona, fu Giovanni da Vicenza, con ogni probabilità lo stesso illustre membro dell’ordine primattore del grande moto dell’«Alleluia»30, a richiedere e ad ottenere dal Comune la concessione di un ter-reno nella contrada di S. Cataldo ab Ecclesia et territorio Ecclesie … inferius versus Apsam e l’acquisto di una casa, perché i frati vi potessero risiedere fintanto che la chiesa non fosse stata costruita, giustificando la propria richiesta quale elemosina in remissione dei peccati e quale compensazione per i “mali commessi” (con topica formulazione, frequentissima nei testamenti, pro male ablatis). Il consenso unanime delle autorità civili alla richiesta fu seguito due anni dopo (1256) dalla concessione di un altro terreno posto a fianco della chiesa, appena oltre le mura cittadine, con la promessa di crearvi una piccola porta d’accesso e di farvi edificare alcune abitazioni a ridosso della cerchia, all’interno o all’esterno di essa, secondo le richieste dei fra-ti. Proprio l’apertura del passaggio creò a meno di un decennio di distanza (1265) motivi di attrito con il Comune, che forse saltuariamente riemersero, se è vero che la proprietà conventuale esterna alle mura fu racchiusa nel Quattrocento entro un bastione murato fatto erigere da Carlo Malatesti. Non per questo venne meno il contributo da parte delle autorità civili cittadine, che nel 1332 concessero ai frati un altro terreno limitrofo al convento31. Oltre al fattivo sostegno dei vertici politici riminesi, nel 1256 intervenne il vescovo Giacomo, in questo caso con il concorso del Capitolo. La chiesa di S. Cataldo era parrocchiale, per cui successivamente alla rinuncia del rettore, necessaria per l’avvicendamento con i domenicani (ottenuta attraverso un indennizzo), gli abitanti della circoscrizione ecclesiastica urbana chie-sero ed ottennero dai frati che fosse assicurata la cura animarum, direttamente o tra-mite un cappellano32. L’assenso dei canonici della cattedrale verso il mantenimento della parrocchialità, pur se affidata a chierici secolari, era certamente agevolato in considerazione del più tradizionale carattere canonicale dell’ordine dei Predicatori rispetto alla più dirompente novità rappresentata dall’originaria struttura dei Mi-nori33. Come avvenne per i francescani in S. Maria in Trivio, anche i domenicani provvidero alla costruzione di un nuovo edificio sacro in luogo del preesistente, evidentemente rivelatosi insufficiente: allo scopo il cardinal legato Latino Mala-branca, anch’egli frate Predicatore, oltre che nipote dell’allora pontefice Niccolò III, concesse nel 1279 l’indulgenza a chi avesse versato elemosine finalizzate all’erigenda chiesa.
30. Così anche Tonini, III, p. 329; Id., Rimini dopo il Mille, p. 103 e nota 144. L’ipotesi ha inoltre il con-forto della cronologia, dato che il frate morì posteriormente al 1259, quando si recò nelle Puglie – dunque muovendosi lungo la costa adriatica – a predicare la crociata (L. Canetti, Giovanni da Vicenza, DBI, 56, pp. 263-267).
31. Tonini, IV/2, pp. 125-127 (LXXVI).32. Tonini, III, pp. 328-330, 543-544 (C), 557-558 (CV), 560-561 (CVII); ASRn, Pergamene, nn. 571-575;
G.C. Mengozzi, I domenicani a Rimini, «Memorie domenicane», XLVI (1929), pp. 194-195, 332-334.33. L. Pellegrini, Cura parrocchiale e organizzazione territoriale degli ordini mendicanti tra il secolo XIII
e il secolo XVI, in Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV), Atti del VI convegno di storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 sett. 1981), Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica 35-36, I, Roma 1984, pp. 288-289.
ordini mendicanti nella città e nella diocesi
L’insediamento riviera-sco di S. Cataldo (fig. 5), po-sto nei pressi dell’omonima porta nel quartiere a Mare, quasi al confine con quello di Pomposo34, si inserisce nel più classico paradigma delle presenze urbane dei dome-nicani in Emilia-Romagna, i quali, a Rimini, così come a Cesena, Faenza e Piacenza scelsero di stanziarsi in zone vicine alle mura urbane, non lontane dai luoghi di accesso alla città. Nella diocesi non si registrano altri conventi dell’ordine, se si eccettuano alcune tarde fondazioni minori nel contado, comprese nel vicariato di S. Cataldo e giuridicamente dipendenti dalla casa madre. Si tratta delle piccole comunità di S. Pietro Martire (1401), di S. Maria del Soccorso di Valliano (1491) (fig. 6) e di S. Mauro di Savignano, oggi S. Mau-ro Pascoli, la cui fondazione, cronologicamente incerta, risale probabilmente allo scorcio del medioevo35. L’insediamento riminese si iscrive entro la provincia do-menicana della Lombardia inferior, articolazione territoriale introdotta nel 1303 per spezzare in due segmenti l’amplissima circoscrizione originaria che comprendeva l’intera Italia settentrionale. Se già prima di quella data il convento di S. Cataldo ebbe l’onore di ospitare (nel 1288) un capitolo provinciale36, a maggior ragione con
34. Tonini, Rimini dopo il Mille, pp. 103ss.35. V. Alce, I Domenicani nell’Emilia-Romagna dal 1218 ad oggi, «Il Carrobbio», VII (1981), pp. 6-12. La
fondazione di S. Pietro Martire, resa possibile da un dono di un nobile veneziano, conferma il fenomeno della significativa immigrazione dalla città lagunare verso Rimini nel Quattrocento, messa in luce da Augusto Vasina (La società, cit., pp. 256, 277-278). La presenza domenicana a Valliano fu resa possibile grazie alla cessione della chiesa ai frati di S. Cataldo di Rimini ad opera di canonici Lateranensi. Su queste fondazioni si veda anche S.L. Forte, Le province domenicane in Italia nel 1650. Conventi e religiosi. La «provincia utriusque Lombardiae», «Archivum Fratrum Praedicatorum», XLI (1971), pp. 429-431, 449.
36. Th. Käppeli, Acta capitulorum Provinciae Lombardiae (1254-1293) et Lombardie inferioris (1309-1312), «Archivum Fratrum Praedicatorum», XI (1941), p. 163.
Fig. 5. J. Janssonius, Veduta della Città di Rimini, tratta dal Theatrum celebriorum, urbium Italiae…, Amsterdam, 1656, acquaforte, particolare con il convento di S. Cataldo, fonda-zione dell’Ordine Domenicano, nelle adiacenze delle mura del quartiere a mare.
riccardo parmeggiani
l’introduzione della nuova e più ristretta provincia au-mentò il peso della fonda-zione riminese, come sem-bra suggerire la temporanea reggenza della stessa (con funzione vicaria) da parte del priore di S. Cataldo su designazione del capitolo generale di Parigi del 130637. Il prestigio del convento fu determinato da presenze particolarmente illustri nelle prime generazioni di frati ri-minesi, tra le cui fila si anno-verarono personaggi di pro-fonda cultura come Guido Vernani, Enrico da Rimini e,
ancor prima, il celebre giurista Martino da Fano, che il cronista francescano Salim-bene de Adam incontrò proprio nella fondazione riminese38.
2.3 Agostiniani
La vicinanza geografica della diocesi di Rimini a quelle di Fano e di Cesena costi-tuisce un’indubbia spiegazione al precoce e rapido diffondersi in essa di due delle principali famiglie eremitiche che confluirono nella Grande Unione del 1256, se-gnando la nascita dell’ordine degli Eremitani di S. Agostino. Il riferimento va ri-spettivamente a quelle dei Brettinesi e dei Giamboniti, le cui origini sono legate alle due circoscrizioni ecclesiastiche a cavallo della diocesi riminese. Già dal 1228 è atte-stata la presenza di una piccola comunità di eremiti, congetturalmente giambonita,
37. Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum ab anno 1304 usque ad annum 1378, ed. B. Reichert, Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica, 4, Romae 1899, p. 19, rr. 9-12.
38. Cfr. Salimbene de Adam, Cronica, ed. G. Scalia, nuova ed. riveduta, I, Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 125, Turnholti 1999, p. 60; F. Liotta, Del Cassero, Martino (Martino da Fano), DBI, 36, pp. 442-446.
Fig. 6. Pala d’altare con la raffi-gurazione della Madonna con il Bambino che dona il rosario a san Domenico a santa Caterina da Siena e ad alcuni devoti del rosa-rio, 1588 (Montescudo, chiesa di S. Maria di Valliano).
ordini mendicanti nella città e nella diocesi
a Donegaglia, l’attuale Bordon-chio (frazione del Comune di Bellaria – Igea Marina). I frati di Donegaglia furono in seguito autorizzati dal vescovo domeni-cano Algisio (1250-1251) a trasfe-rirsi in S. Maria de Limata, nella parrocchia di S. Giustina39.
La primitiva presenza di un insediamento, probabilmente giambonita, a Rimi-ni risalirebbe all’incirca al 1236, secondo l’indiretta testimonianza di metà Duecen-to che si ricava dalle dichiarazioni rese da un frate al processo di canonizzazione di Giovanni Bono da Mantova40. A poco più di dieci anni di distanza (1247) è invece attestata la presenza di un nucleo stabile di eremiti brettinesi, definiti Ariminen(ses), in risposta ad una loro supplica il pontefice Innocenzo IV concesse un’indulgenza a chi avesse contribuito alla costruzione da poco intrapresa opere somptuoso della chiesa e degli annessi locali conventuali41 (fig. 7). Rimane incerto il collegamento tra questo progetto in via di definizione e l’effettivo insediamento all’interno delle mura cittadine, che avvenne con certezza soltanto nel dicembre 1256 (a pochi mesi dalla Grande Unione), quando il vescovo Giacomo assegnò ai frati, dopo reiterate suppliche pro loco ipsorum [fratrum] construendo infra muros civitatis, la chiesa par-rocchiale di S. Giovanni Evangelista (fig. 8), nel quartiere di S. Colomba. Analo-gamente a quanto avvenuto nel marzo dello stesso anno per i domenicani, anche in questo caso vi fu il consenso da parte del Capitolo; venne inoltre versato un inden-nizzo al precedente rettore e fu richiesta l’assunzione diretta, o mediata attraverso un cappellano, della cura animarum. All’edificio sacro il presule aggiunse per l’ere-zione del convento una casa con torre, posta accanto al cimitero, cedendo ai frati il diritto che egli vantava su di essa42. Un ulteriore sostegno alla fondazione giunse
39. V. Bassetti, Regesto agostiniano riminese sino all’anno 1300, «Analecta Augustiniana», LXII (1999), pp. 252ss., 257ss.; M. Mattei, Il processo di canonizzazione di fra Giovanni Bono (1251-1253/54) fondatore dell’Ordine degli Eremiti, Fontes Historiae Ordinis Sancti Augustini, Series Altera, 4, Roma 2002, p. 645; A. Donati – G.L. Masetti Zannini, Santa Maria di Scolca abbazia olivetana di Rimini. Fonti e documen-ti, Rimini 2009, p. 35 (ma cfr. anche, pp. 78, 223-224).
40. Bassetti, Regesto, cit., p. 253 n. 25; Mattei, Il processo, cit., pp. 644-645.41. Tonini, III, p. 526 (LXXXVIII).42. L’importante documento è edito in L. Torelli, Secoli agostiniani, IV, Bologna 1675, pp. 586-587, n.
175. Per gli esordi e gli sviluppi dell’ordine a Rimini tra Due e Trecento, con riferimento anche alla produ-
Fig. 7. Copia autentica di privile-gio del 1246 aprile 26, indirizzato da papa Innocenzo IV ai frati eremitani, particolare contenente i segni di Rota, Bene valete e le sottoscrizioni del papa e del collegio cardinalizio (Rimini, ASRn, Diplomatico, Pergamena s.n.).
riccardo parmeggiani
dal pontefice Alessan-dro IV, che un mese dopo, acconsentendo ad un specifica ri-chiesta, concesse agli agostiniani riminesi di ricevere somme frutto di illeciti (de usuris, rapinis et ali-
is male acquisitis) non eccedenti le trecento lire ravennati, qualora le vittime non fossero state individuabili o rintracciabili43. La grandiosità della costruzione, il cui progresso avvenne, come vedremo, non senza contrasti con le parrocchie confi-nanti, determinò un’assoluta centralità della chiesa agostiniana sia all’interno della città, dove divenne il fulcro della splendida stagione artistica del Trecento rimine-se, sia in seno all’ordine, giungendo ad ospitare diversi capitoli generali (1278, 1318, 1394, 1515, 1555), oltre che provinciali44. Un duro colpo fu in seguito inferto in conco-mitanza dell’offensiva di Pio II contro Sigismondo Pandolfo Malatesti: nel 1463 il convento propter gueras et malam dispositionem civitatis venne distrutto, depredato di preziose suppellettili e privato di importanti fonti di reddito45. La gravità della situazione è comprovata dal protrarsi dei lavori di ripristino, che un quarto di se-colo più tardi, quando il vicario vescovile autorizzò gli agostiniani alla vendita di un terreno per poter disporre dei mezzi necessari al restauro del campanile (1487), non erano ancora stati completati46.
La diffusione dell’ordine nella diocesi fu considerevole47. Nel corso del medio-
zione artistica, si rimanda a C. Lugato, Gli Agostiniani a Rimini e gli affreschi in Sant’Agostino, in D. Be-nati (a cura di), Il Trecento riminese. Maestri e botteghe tra Romagna e Marche, Milano 1995, pp. 82-93; Id., La comunità agostiniana a Rimini tra XIII e XIV secolo, «Analecta Augustiniana», LIX (1996), pp. 313-330.
43. ASRn, Pergamene, n. 594; il documento è edito da Torelli, Secoli agostiniani, cit., p. 599, n. 24.44. Lugato, La comunità agostiniana, cit., pp. 320-322; V. Bassetti, Un ritrovato “libro di entrate / uscite”
della provincia agostiniana di Romagna (1437-1538), «Analecta Augustiniana», LXIII (2000), pp. 65-67, 90-93.45. Bassetti, Un ritrovato, cit., p. 75.46. Tonini, V/1, p. 632.47. L’adozione della regola di sant’Agostino da parte del moltiplicarsi di congregazioni ospedaliere che
sorsero tra XII e XIII secolo ha ingenerato anche per Rimini qualche equivoco sull’appartenenza di alcune
Fig. 8. J. Janssonius, Vedu-ta della Città di Rimini, tratta dal Theatrum ce-lebriorum, urbium Ita-liae..., Amsterdam, 1656, acquaforte, particolare con la chiesa di S. Giovanni Evangelista (S. Agostino) nel quartiere di S. Colomba.
ordini mendicanti nella città e nella diocesi
evo nacquero infatti numerosi conventi agostiniani anche nel contado: così, oltre a quello di Donegaglia-Limata, si svilupparono insediamenti a Pantano (nei pressi di Riccione) precedentemente al 128048, a Cerreto (con dedicazione a S. Giovanni Battista) prima del 138149, a Verucchio – nonostante la leggendaria fondazione due-centesca, legata al beato Gregorio Celli – prima del 144050. A questi conventi ad inizio Cinquecento si aggiunsero quelli di S. Clemente e Spinalbeto (nei pressi di Santarcangelo)51.
2.4 Serviti Pur se più tarda di oltre mezzo secolo rispetto agli altri insediamenti esaminati, la presenza dei Servi di Maria a Rimini – l’unico altro ordine mendicante che si aggiunse in epoca medievale; i Carmelitani, infatti, si stabiliranno in città solo nel tardo Cinquecento – è da collocare in anni relativamente prossimi alla definitiva approvazione dell’ordine (1304). Già nel 1312, infatti, il vicario del provinciale di Romagna procedette all’acquisto di una casa, nel quartiere di S. Colomba, con il decisivo contributo della cospicua somma di 500 lire ravennati piccole (pari a 5/6 del totale) messa a disposizione da Malatestino Malatesti, che agiva in qualità di esecutore testamentario del padre, Malatesta52. Gli sviluppi dell’ordine in città sono ulteriormente legati alla famiglia signorile: Ferrantino Malatesti, unitamente al Consiglio del Comune, accolse favorevolmente nel 1317 la supplica della comunità servita con cui veniva richiesta l’esenzione dall’estimo di alcune case di proprietà dell’ordine in vista del progetto di costruzione della chiesa53. Il primitivo nucleo di frati era in parte preponderante di “importazione” dalle diocesi più prossime, probabilmente da Cesena e Forlì54, ma anche dalla più lontana Firenze55 (fig. 9). La
comunità di fratres all’ordine agostiniano successivamente istituito: un caso in cui più incerti appaiono i contorni e gli sviluppi è costituito invece dal duecentesco locus de Montirone, ritenuto convento agostinia-no dal Bassetti (Regesto, pp. 255-256, nn. 33-34, 36; cfr. in particolare nota 9). Nel corso del medioevo la fondazione si trasformò in ospedale, benché, almeno a metà Quattrocento, la reggenza dello stesso fosse affidata ad un frate agostiniano (Tonini, V/1, p. 622).
48. Tonini, III, p. 328; Bassetti, Regesto, cit., p. 265, n. 65. Come per S. Giovanni Evangelista di Rimi-ni, anche il convento di Pantano attraversò un momento difficile nel 1463, quando a causa del conflitto in corso i frati abbandonarono temporaneamente il complesso (Bassetti, Un ritrovato, cit., p. 73).
49. ASFo, Corporazioni religiose soppresse, Agostiniani di Rimini, pergamena unica. Trattandosi del rin-novo di un’enfiteusi, la fondazione di S. Giovanni Battista di Cerreto risale probabilmente ad alcuni decenni prima. Per motivi che ci sfuggono, il convento non sopravvisse a lungo, dal momento che esso non figura nel registro tardomedievale della provincia agostiniana di Romagna studiato dal Bassetti (Un ritrovato, cit.).
50. Ibid., p. 68. Sugli incertissimi contorni storici della vita del beato Gregorio Celli da Verucchio, cfr. Tonini, IV/1, pp. 493-497; A. Donati, I beati di Verucchio. Giovanni Gueruli, Gregorio Celli, Bionda Foschi, Galeotto Roberto Malatesta. Storia e iconografia, Villa Verucchio 2004, pp. 35-43.
51. Bassetti, Un ritrovato, cit., p. 69.52. A. Turchini, Documenti sulla presenza dei serviti a Rimini (1312-1316), «Rivista Diocesana di Rimi-
ni», LXXIII / LXXIV (1972), pp. 91-98.53. Tonini, IV/1, pp. 431-432; IV/2, pp. 37-38 (XIII).54. Turchini, Documenti, cit., p. 94.55. Nell’Archivio di Stato di Firenze (Diplomatico, Santissima Annunziata, s. d.) è conservata una per-
riccardo parmeggiani
disponibilità patrimoniale dei Servi di Maria fu rapidamente incrementata grazie a numerose donazioni56 e a lasciti testamentari, tra cui particolarmente generosi furono quelli dei Malatesti57. L’ordine non espresse figure di rilievo pari a quelle degli altri Mendicanti; prescindendo dalle notizie leggendarie relative alla terziaria servita Bionda Foschi da Verucchio58 (fig. 10), il personaggio più importante fu Silvestro da Rimini, che nel 1362 venne eletto vescovo di Numana59.
Escludendo al momento dalle considerazioni di carattere generale, in quanto più tardo, l’insediamento dei serviti, va rilevata l’omogeneità dal punto di vista cro-nologico tanto dell’inurbamento di francescani e agostiniani, quanto dell’introdu-zione ex novo dei domenicani. In generale, come premesso, si tratta di insediamenti intramurari più tardi rispetto ad altre realtà della regione, ed in particolare rispetto alle fondazioni presenti in altre città disposte lungo la via Emilia. La concomitan-za verificatasi a Rimini avrebbe risposto secondo una suggestiva tesi ad un piano
gamena del 19 marzo 1317 contenente la professione di fede di Simone di Pagno da Figline nella neonata comunità servita riminese. L’atto è rogato nel convento di S. Maria dei Servi di Rimini.
56. Per una cui breve campionatura, cfr. Turchini, Documenti, cit., p. 98, nota 17.57. Tonini, IV/2, pp. 261, 314.58. Ibid., V/1, pp. 674-675; Donati, I beati, cit., pp. 47-51.59. Piana, Chartularium, cit., p. 23.
Fig. 9. La Pietà e i fondatori dell’ordine dei Servi. Tela originariamente in S. Maria dei Servi, distrutta dai bombardamenti del 1943-’44.
ordini mendicanti nella città e nella diocesi
sostanzialmente organizzato: gli Eremitani di S. Agostino si situarono non lontano dalla zona ebraica, i Predicatori nel quartiere a Mare, a ridosso del porto, i Minori nell’area ad alta densità ereticale nei pressi della Fossa Patara60. Una simi-le schematizzazione presenta indubbi elementi di verità, con il rischio, tuttavia, di schiaccia-re la prospettiva verso un fine esclusivo. I fattori che determi-narono la rapida affermazio-ne degli ordini in città furono sicuramente molteplici, dovuti ad esigenze e sollecitazioni diverse. Certamente i Mendi-canti seppero rispondere con efficacia alle necessità spiritua-li di una società dinamica ed in forte evoluzione, rivolgendosi non solo alle classi più umili e marginali, ma anche ai ceti urbani emergenti e a quelli dominanti61. Questa trasversalità è confermata sia dai numerosi lasciti testamentari62, utili per la salvezza individuale, soprattutto se destinati alla riparazione dei danni commessi in vita, sia, su un piano istituzionale, dal decisivo contributo delle autorità civili alla costruzione dei nuovi luoghi di culto, che divennero il fulcro del rinnovamento dell’edilizia sacra cittadina. Tale fattiva partecipazione avviene perché gli ordini mendicanti vengono ritenuti “fonte di bene” civico e di utilitas per la collettività nel suo complesso63. Con la costruzione delle nuove chiese, le strutture dei Mendicanti si impongono come un nuovo polo religioso di riferimento, anche in considera-zione delle crescenti dimensioni degli edifici, proporzionali al concorso dei fedeli,
60. Gobbi – Sica 1982, p. 46.61. Pellegrini, Cura parrocchiale, cit., p. 293; A. Rigon, Frati Minori e società locali, in Francesco d’Assisi
e il primo secolo di storia francescana, Torino 1997, p. 278. 62. Per un’esemplificativa campionatura, cfr. ASRn, Pergamene, nn. 1931, 2063a, 2172, 2529a, 2546a, 2547a
e 2760a, 2799 e, per documentazione più risalente, legata agli agostiniani, Bassetti, Regesto, cit., pp. 263-265, nn. 59, 60, 65 e Lugato, La comunità, cit., p. 318.
63. Secondo l’efficace formulazione di Rigon, Frati Minori, cit., p. 271.
Fig. 10. Anonimo, Beata Bionda Foschi da Verucchio, con i beati Gregorio Celli e Giovanni Gue-ruli (XVII secolo) (Rimini, BG, Gabinetto delle stampe).
riccardo parmeggiani
costituendosi come uno spazio alternativo a quello tradizionale della parrocchia e della cattedrale64. Un simile successo dei Mendicanti costituiva naturalmente una “turbativa” per il clero secolare, in quanto tendeva inevitabilmente a sottrarre i par-rocchiani al proprius sacerdos, minandone quell’esclusività pastorale e sacramentale richiamata con forza nel IV Concilio Lateranense (1215)65. La bolla Etsi animarum di Innocenzo IV (1254) è un’esatta fotografia del generalizzato squilibrio prodottosi a danno del clero secolare, la cui reazione diede luogo ad un diffuso clima di anti-mendicantismo, che conobbe le sue punte più accese, anche in ambito universitario, a partire dalla seconda metà del Duecento.
3. I rapporti con il clero secolare
Il richiamo di uno specialista, quale Luigi Pellegrini, a non inquadrare i rapporti tra Mendicanti e clero secolare unicamente in un contesto di attriti e frizioni, trova nel caso riminese un serio ostacolo, specialmente in riferimento ai francescani. Si è già avuto modo di rilevare il mancato consenso del Capitolo della cattedrale alla devoluzione di S. Maria in Trivio ai Minori. L’impossibilità di ridurre il fatto ad una semplice mancanza formale è confermata dalla violenta bolla Perlata nuper inviata da Alessandro IV al vescovo di Rimini, oltre che agli omologhi di Cesena e Forlì, il 24 aprile 125566 affinché provvedessero a far cessare le molestie e le resistenze nei confronti dei frati Minori e Predicatori, sollecitandone invece l’appoggio nelle ri-spettive diocesi. Pur se le accuse vengono mosse ai presuli, rimane difficile crederle riferibili – e in tale misura – al vescovo Giacomo, il cui contributo alle fondazioni dei Mendicanti fu assolutamente decisivo. Le cause di contrasto indicate dal papa riguardano non solo aspetti pastorali – in particolare la predicazione –, quanto mo-tivi economici, con specifico riferimento ai lasciti testamentari e al preteso diritto vescovile sulla quarta parte delle elemosine e dei pii legati espressamente destinati all’ornamento delle chiese dei Mendicanti. Proprio su quest’ultimo tema il pontefi-ce intervenne nuovamente in difesa dei Minori pochi mesi dopo (12 dicembre) con la lettera De pia et, con cui si esortavano i vertici religiosi delle diocesi di Lombardia e Romagna ad impedire che alcuni – nonnulli: ma il riferimento sembra andare al clero parrocchiale – richiedessero “dietro pretesto della portio canonica” la terza o la quarta parte dei beni testamentari destinati ai frati67. Le ragioni di una così marcata ostilità contro i francescani a Rimini si spiegano in buona parte perché il loro fu
64. Pellegrini, Cura parrocchiale, cit., p. 304. 65. Sulla conflittualità in ambito pastorale tra clero parrocchiale e ordini mendicanti nel Duecento, cfr.
L. Pellegrini, Mendicanti e parroci: coesistenza e conflitti di due strutture organizzative della «cura anima-rum», in Francescanesimo e vita religiosa dei laici nel ’200. Atti dell’VIII Convegno Internazionale (Assisi, 16-18 ottobre 1980), Assisi 1981, pp. 129-167.
66. Sbaralea, Bullarium Franciscanum, cit., II, pp. 38-39, n. 46 (ma cfr. anche ibid., n. 47). Un’analisi della bolla è fornita da L. Paolini, Insediamenti degli Ordini Mendicanti (secc. XIII-XV), in M. Mengozzi (a cura di), Storia della Chiesa di Cesena, I/1, Cesena 1998, pp. 178-179.
67. La bolla, non compresa nel repertorio del Potthast, è conservata in ASFo, Corporazioni religiose soppresse, Frati conventuali di Rimini, n. 2. Se ne veda la trascrizione e l’analisi in Turchini, Il Tempio, cit., pp. 126-127.
ordini mendicanti nella città e nella diocesi
l’unico ordine mendicante a non essere subentrato in una chiesa parrocchiale, e a non godere pertanto degli annessi diritti, che riguardavano comunque, come ovvio, i soli parrocchiani. Non che questa fosse una condizione sufficiente: laddove infatti si verificò una simile attribuzione, come nel caso degli agostiniani in S. Giovan-ni Evangelista, emersero comunque tensioni già negli anni Ottanta del Duecento con la confinante parrocchia dei SS. Giovanni e Paolo per l’«aggressiva» politica di acquisizione immobiliare nel territorio di propria competenza, con conseguente lesione delle prerogative giurisdizionali68.
Nonostante l’equilibrio fissato da Bonifacio VIII con la Super cathedram (1300) circa la regolamentazione dei diritti funerari – ma la decretale affrontò anche l’aspet-to pastorale (predicazione) e sacramentale (confessione), disciplinando il ruolo dei Mendicanti in funzione sussidiaria a quello vescovile e del clero diocesano – nuovi contrasti si verificarono ad inizio Quattrocento, quando si aprì un contenzioso plu-riennale tra il Capitolo della cattedrale e i Minori circa la portio canonica relativa al testamento del vescovo Leale Malatesti69. Di questa quota di “legittima” veniva rivendicata la fruizione non solo dalla parrocchia del defunto, ma anche dal vescovo. Proprio per questo motivo emersero forti tensioni tra il 1445 e il 1446 tra l’altro pre-sule proveniente dal casato signorile, Bartolomeo, e l’intero parco degli ordini men-dicanti riminesi (Minori, Predicatori, Eremitani di S. Agostino e Servi di Maria): la composizione del contrasto, aspro al punto da richiedere l’intervento di Eugenio IV, segnò la fine di due secoli di dispute, stabilendo la liceità della richiesta della sola “quarta” parrocchiale70. Ovviamente non si trattava di una semplice questione di principio, ma di un importante cespite, la cui proporzione si inferisce dalle scelte dei conventi mendicanti quale luogo di sepoltura privilegiato del ceto urbano rimi-nese, nonché della sua classe dirigente e dei cittadini più illustri (celebri gli esempi del cardinale Gozio Battagli71 e dell’umanista Roberto Valturio). Esemplificativo è il caso di S. Maria in Trivio, dove alle tombe di mercanti e artigiani si affiancarono quelle dei lignaggi più in vista: lo spazio del chiostro, in particolare, rappresentò il vero e proprio mausoleo di famiglia dei Malatesti, come plasticamente testimoniato dal prezioso sepoltuario che si è conservato fino ai nostri giorni72.
Il rapporto privilegiato dei Mendicanti, e dei francescani in particolare, con la famiglia dominante fu una chiave decisiva per l’affermazione degli ordini in ambito locale: l’influenza del potere signorile costituì una sorta di scudo verso il clero dio-cesano, anche se, come si è appena visto, i contrasti maggiori si registrarono proprio
68. Tonini, III, pp. 326-327.69. Turchini, Il Tempio, cit., pp. 125-126.70. Ibid., p. 127 e, per l’edizione del documento, pp. 591-592, n. 6.71. Il testamento del porporato, che aveva fatto erigere una cappella in S. Maria in Trivio, denota uno
speciale riguardo nei confronti degli ordini mendicanti cittadini: il documento è edito in Tonini, IV/2, pp. 165-172.
72. Su questa fonte, particolarmente studiata, si veda da ultimo D. Frioli, Un ‘cimitero su libro’: il re-pertorio di sepolture del convento francescano di Rimini, in D. Puncuh (a cura di), Studi in onore di Giorgio Costamagna, Genova 2003, pp. 425-454; l’edizione di riferimento è ancora quella di Giuseppe Gerola, con la revisione di A. Massèra, contenuta in Ricci, Il Tempio, cit., pp. 563-584. Sulle tombe malatestiane, cfr. Turchini, Il Tempio, cit., pp. 129-132.
riccardo parmeggiani
in concomitanza della presenza di due vescovi di casa Malatesti sulla cattedra rimi-nese, Leale (1374-1400) e Bartolomeo (1445-1448). In queste particolari circostanze i presuli dovettero farsi latori delle istanze dei secolari, tentando di arginare, in accordo con il Capitolo (e su sua presumibile sollecitazione), i privilegi derivanti dall’esenzione. A sostegno di Leale intervenne anche Pandolfo Malatesti, la cui supplica avanzata nel 1397 per una temporanea revoca di dodici anni dell’esonero fiscale dei regolari che ne avevano diritto, tra cui appunto i Mendicanti, venne positivamente accolta dal pontefice73. Le rivendicazioni dei secolari facevano leva sull’ambiguità derivante dalla conduzione di chiese parrocchiali da parte di ordi-ni direttamente dipendenti dall’autorità papale, con conseguente sottrazione alla mensa vescovile delle imposte sui non modica bona posseduti dalle chiese dei frati. Analogamente a quanto già avvenuto per agostiniani e domenicani, anche i fran-cescani di S. Maria in Trivio avevano infatti ottenuto per la loro chiesa lo status di chiesa parrocchiale, giungendo nel 1436, con il consenso di Eugenio IV, all’esercizio diretto e non più per mezzo di un sacerdote secolare della cura animarum 74.
Le frequenti tensioni con il vescovo e con il Capitolo conobbero comunque fasi di stasi e di maggior collaborazione e accordo: ad esempio furono proprio i canonici di S. Colomba a postulare a vescovo nel 1416 l’agostiniano Girolamo Le-onardi75. Gli equilibri ecclesiastici diocesani dipendevano del resto in larga misura dalla politica dei Malatesti, per cui l’appoggio fattivo e costante del potere signorile ai Mendicanti determinò, a Rimini come altrove, una sostanziale sostituzione del ruolo del vescovo con i frati, e in maniera preponderante dei Minori, quale tradizio-nale referente istituzionale ecclesiastico nei rapporti tra Chiesa e città76. L’avvicen-damento trovò, benché molto più tardi, una sua icastica evidenza con la traslazione della cattedra episcopale da S. Colomba a S. Maria in Trivio, già divenuta sotto Sigismondo Pandolfo Tempio Malatestiano.
4. Gli ordini mendicanti e la politica cittadina
Si è già avuto modo di rilevare come l’affermazione del guelfismo a Rimini fu so-stenuta dall’intervento papale e dall’azione pacificatrice di Pietro da Verona77. La successiva e travagliata fase della vita comunale che preluse all’affermazione defi-nitiva di Malatesta da Verucchio (1295), conobbe, soprattutto a partire dall’imposi-zione del dominio pontificio sulla città e sulla Romagna, un notevole protagonismo degli ordini mendicanti. Il forte legame con tutte le componenti sociali determinò
73. Tonini, IV/2, pp. 413-415.74. Turchini, Il Tempio, cit., pp. 127-128, con edizione della bolla pontificia a p. 587 (n. 1).75. Tonini, V/1, pp. 608-614; V/2, pp. 118-120, n. XXIX.76. Rigon, Frati Minori, cit., p. 260.77. San Pietro Martire si adoperò per la composizione dei conflitti tra i comuni romagnoli: nel palazzo
comunale di Rimini il 10 marzo 1249, dopo una solenne predica (perfecta ab ipso prius predicatione divina venusta locucione) ottenne all’unanimità dal Consiglio la delibera della compensazione delle violenze e dei danni prodotti contro i comuni di Faenza, Cervia e Cesena sia per il presente, sia per il recente passato (prima, cioè, della deposizione di Federico II). Cfr. Tonini, III, pp. 531-532, n. XCII.
ordini mendicanti nella città e nella diocesi
un comune riconoscimento, anche nei momenti di maggior divisione, nelle figure dei frati78. Significativamente, nell’atto di formale sottomissione della città al papa nella persona del domenicano Giovanni da Viterbo (27 luglio 1278) figurano tra i testimoni i capi del partito guelfo, Malatesta da Verucchio (insieme al figlio Gian-ciotto), di quello ghibellino, Montagna Parcitadi, e tre frati Predicatori79. I vertici dei Mendicanti riminesi sono del resto ripetutamente presenti in importanti atti pubblici sulla fine del Duecento80. Fin dai tempi dell’Alleluia il generale consenso verso francescani e domenicani impose i membri degli ordini come pacificatori sociali, non secondariamente – ma il caso riminese in questo fa, come vedremo, eccezione – in nome del comune impegno antiereticale, con un crescente coinvol-gimento degli stessi in missioni di carattere politico81.
Con l’affermazione di Malatesta da Verucchio la saldatura tra potere civile e or-dini mendicanti conobbe il suo apice duraturo. Già nel 1302 tra i trentanove ufficiali al servizio dell’Inquisizione francescana eletti in accordo con il vescovo e nominati dal podestà Malatestino, figlio di Malatesta stesso, compaiono non solo il Mastin Vecchio con i suoi familiari Pandolfo e Ferrantino, ma anche numerosi loro fautori, tra cui Oddo delle Caminate, fratello del presule di Rimini82. Il testamento redatto pochi anni più tardi da Malatesta stesso (1311)83 ci restituisce l’esatta dimensione dell’intensità del rapporto privilegiato con i Mendicanti, con speciale riguardo ai Minori84. Il valore storico del documento, la cui struttura portante fu in seguito sostanzialmente mutuata anche dai testamenti di Malatesta Antico (1364)85 e Ma-latesta Ungaro (1372)86, merita un approfondimento.
Il Mastin Vecchio di dantesca memoria dispose innanzitutto di essere sepolto
78. Sull’incidenza dei Mendicanti sulla società urbana nel medioevo, si veda A. Vauchez, Ordini men-dicanti e società italiana XIII-XV secolo, Milano 1990.
79. ASV, Instrumenta miscellanea, 166; il documento, in cui risulta presente anche un frate gaudente, è edito in Tonini, III, p. 601 (CXXXII). Un esponente della famiglia ghibellina dei Parcitadi, Gelasio di Cignatta, venne affidato dal rettore di Romagna Massimo da Piperno alla custodia dei francescani riminesi (per poi venire liberato nel 1297; cfr. Sbaralea, Bullarium Franciscanum, cit., IV, p. 444, n. 125; Tonini, III, p. 712).
80. Tonini, III, pp. 603, 605, 704.81. G.G. Merlo, Francescanesimo e signorie nell’Italia centrosettentrionale, in I francescani nel Trecento.
Atti del XIV Convegno internazionale (Assisi, 16-18 ottobre 1986), Assisi 1988, pp. 101-126, ora in Id., Tra eremo e città. Studi su Francesco d’Assisi e sul francescanesimo medievale, Assisi 1991, pp. 337-356; cfr. in particolare pp. 347-348.
82. Nell’elenco (pubblicato dal curatore C. Campeggi nella parte introduttiva alla sua edizione del ma-nuale inquisitoriale di Zanchino Ugolini, Tractatus de haereticis, Romae 1568, pp. VIII-IX) è compreso anche un altro membro della medesima famiglia, Ugolino; circa il sostegno fornito dai delle Caminate ai Malatesti, cfr. anche l’episodio citato da P. J. Jones, The Malatesta of Rimini and the Papal State, Cam-bridge 1974, pp. 38-40.
83. Se ne veda l’edizione in Tonini, IV/2, pp. 21-35; una riproduzione, con traduzione a fronte in ita-liano, si trova in appendice a S. Pari, La signoria di Malatesta da Verucchio, Premessa di A. Vasina, Centro Studi malatestiani, Storia delle Signorie dei Malatesti, I, Rimini 1998.
84. Sul rapporto privilegiato tra Minori e poteri signorili, si vedano le illuminanti pagine, cui si farà costante riferimento, di Merlo, Francescanesimo e signorie, cit.
85. Edito in Tonini, IV/2, pp. 261-269. Alla redazione del testamento partecipano in qualità di testimo-ni i vertici dei Minori riminesi, guardiano, lettore e inquisitore.
86. Anche per questo documento, mutilo, cfr. Tonini, IV/2, pp. 312-321.
riccardo parmeggiani
nella chiesa dei Minori, nella stessa tomba della sorella Emilia, vestito in abito da terziario francescano; volle che i beni illecitamente acquisiti fossero restituiti in base alle scritture del proprio confessore, il frate minore Ventura di Paganuccio, per il quale era previsto uno specifico legato; tra gli enti ecclesiastici beneficiati da lasciti in denaro, figurano ai primi posti i Mendicanti sia cittadini che del contado, senza trascurare i rami femminili dei rispettivi ordini; auspicò, come già da tempo sollecitato, che in remissione dei propri peccati si celebrasse a Rimini, a spese della famiglia Malatesti, un capitolo generale dei Minori, dei Predicatori e degli Eremi-tani di S. Agostino (gli unici per cui il desiderio si concretizzò, nel 1318), prevedendo allo scopo l’invio di ambasciatori presso il Papa e la Curia; in caso di decesso degli esecutori testamentari – la moglie Margherita e il figlio Malatestino – ne decretò la sostituzione con il guardiano dei Minori e il priore dei Predicatori di Rimini; pre-vide inoltre una clausola, per cui, qualora gli eredi fossero risultati inadempienti alle disposizioni previste, la forte penalità pecuniaria stabilita sarebbe stata affidata ai frati Minori, surrogando, in caso di mancata celerità nella riscossione, gli inquisitori francescani nella gestione di tale somma, da spendere in favore dei bisognosi o, in alternativa, del buon funzionamento dell’ufficio. A coronamento di questa intensa devozione verso i Mendicanti, la grossa cifra di cinquecento lire ravennati pro male ablatis incertis da impiegare immediatamente dopo la morte del testatore, avvenuta nel 1312, per la costruzione di un edificio ecclesiastico, venne messa a disposizione dal figlio Malatestino per la costruzione della nuova chiesa dei Servi di Maria, con-sentendo così l’ingresso in città dell’ordine di recente approvazione87.
Le estreme volontà di Malatesta Antico e Malatesta Ungaro non si discostano di molto da quelle del Mastin Vecchio (ad eccezione dell’assenza della clausola relativa alla celebrazione di capitoli generali dei Mendicanti a Rimini), incremen-tando ulteriormente la relazione con i Minori attraverso ingentissimi legati (mille ducati d’oro nel primo caso, duemila nel secondo) destinati alla costruzione di cap-pelle in S. Maria in Trivio. È da segnalare, tra le costanti presenti in questi testa-menti, la reiterata presenza di un francescano quale confessore personale88, figura che diviene un abituale interlocutore del signore non solo sul piano spirituale, ma anche, conseguentemente, su quello politico. Il topos dell’umiltà determinato dalla scelta dell’abito francescano, prassi assai diffusa tra i viri excellentes, contribuisce a trasmettere una parvenza umile del potere signorile (e, al contempo, ad esaltare l’ordine)89: che, pur tenendo conto dei frequenti usi strumentali, non la si debba invariabilmente intendere come una ripetitiva e sterile immagine di facciata, ben-ché in taluni casi di sincera e profonda adesione, lo conferma la figura del terziario Galeotto Roberto Malatesti, pio signore di Rimini dal 1427 al 143290, cui è legata una
87. Turchini, Documenti, cit., pp. 91-94.88. Incerta, anche se altamente probabile in considerazione dell’appellativo frater e della continuità
della tradizione famigliare, nel caso del lacunoso testamento di Malatesta Ungaro (Tonini, IV/2, p. 314).89. Merlo, Francescanesimo, cit., pp. 337-338.90. Su cui si veda, da ultimo, A.G. Luciani, La signoria di Galeotto Roberto Malatesti (1427-1432),
Premessa e appendice documentaria di A. Falcioni, Centro Studi malatestiani, Storia delle Signorie dei Malatesti, 4, Rimini 1999.
ordini mendicanti nella città e nella diocesi
consistente tradizione agiografica. In precedenza già lo zio Carlo Malatesti aveva donato alcuni terreni sul colle di Scolca, in particolare uno (1393) in favore di Ange-lo da Corsica, membro del Terz’Ordine, perché vi stabilisse un romitorio, e un altro (1424) per i Minori Osservanti da poco subentrati ai conventuali in S. Maria delle Grazie, chiesa eretta a partire dal 1389 col contributo della famiglia delle Camina-te, casato storicamente contiguo a quello dei Malatesti91. La particolare devozione della famiglia dominante verso i Minori è del resto una caratteristica comune anche al ramo cesenate e pesarese dei Malatesti. La sublimazione di un così intenso rap-porto, con un reciproco riflusso di prestigio tra l’ordine e il potere signorile, si ebbe con la sontuosa trasformazione voluta da Sigismondo Pandolfo con il contributo di Leon Battista Alberti della gotica S. Maria in Trivio, la cui struttura si era già arricchita di numerose cappelle istituite dalla famiglia, in Tempio Malatestiano92 (fig. 11), gli evidenti intenti propagandistici che non devono comunque far pensare ad una totale subordinazione dei Minori.
Le relazioni tra Malatesti e Mendicanti non si esaurirono sul piano dei legati testamentari e delle scelte funerarie, e rinsaldandosi ulteriormente con una nutrita e vicendevole serie di rapporti di natura patrimoniale, i cui esempi, sotto svariate forme (compravendite, donazioni ecc.) sono numerosi93. Un così stretto raccordo garantiva una reciproca convenienza, non solo agli enti beneficiati, ma alla signoria stessa: del resto è evidente come la volontà di controllo della società passasse an-che attraverso i canali religiosi, sfruttando sia lo stretto e diretto collegamento dei Mendicanti al Papato – indubbiamente un utile tramite, soprattutto nei momenti di riemergenti tensioni –, sia l’ascendente di questi ordini sulla spiritualità della società riminese. A questi, e ai Francescani in particolare, era riconosciuta una larga e condivisa publica fides, un cui segno tangibile è costituito dal deposito degli statuti, dei privilegi e dei documenti attestanti i diritti del Comune presso la sagrestia dei frati Minori94.
91. Tonini, IV/1, pp. 435-436; V/1, pp. 656, 661; A. Donati, Introduzione, in Santa Maria di Scolca, cit., p. 19.
92. Per un cui approfondimento, oltre che al saggio di Pier Giorgio Pasini contenuto nel presente volu-me, il rimando va a Turchini, Il Tempio, cit.
93. Come già intuito da Augusto Vasina (La società, cit., p. 286, n. 39). Un paio di esempi contribuisco-no a mostrare come i Mendicanti in questo tipo di rapporto non fossero solo soggetti passivi: nel 1302 un domenicano vendette a Pandolfo Malatesti i beni provenienti dall’eredità paterna, in modo da destinarne il ricavato ad opere pie, mentre nel 1369 sono gli agostiniani a cedere a Galeotto Malatesti una casa di proprietà dell’ordine (Turchini 2009, pp. 222, n. 59, 235, n. 122; cfr. anche ibid., pp. 235-236 n. 125).
94. Come evidenziato da Giuseppe Rabotti, in Vasina, Statuti comunali, I, p. 328; cfr. anche Id., Rimini, 1334-1475, in U. Zaccarini – G. Rabotti, Rubricari degli statuti comunali inediti di età signorile, Bologna 1998, p. 61, n. 35. Cfr. poi, oltre a Tonini, Rimini dopo il Mille, p. 94, Turchini 2009, p. 87. Proprio in considerazione del rapporto fiduciario che i ceti dirigenti normalmente instaurarono con i francescani, la prassi di affidare ai frati dell’ordine la custodia di registri pubblici, anche di natura contabile, risulta diffusa nel medioevo italiano (Rigon, Frati Minori, cit., p. 273).
riccardo parmeggiani
5. L’Inquisizione
Al ruolo attivo dei francescani nella vita politica cittadina e alla speciale predile-zione della famiglia signorile, già a partire da Malatesta da Verucchio, contribuì in maniera decisiva la conduzione del tribunale dell’Inquisizione. Nell’ambito della riorganizzazione del negotium fidei operata da Innocenzo IV all’indomani dell’as-sassinio di Pietro Martire (fig. 12) per mano di eretici (1252), il pontefice previde per l’Italia la formazione di otto province inquisitoriali, affidando ai frati Minori l’intera area centrale della penisola, compresa la provincia di Romagna95, per la
95. Le diocesi comprese nella provincia inquisitoriale romagnola sono elencate nella bolla Licet ex om-nibus nella redazione di Urbano IV (23 marzo 1262), per cui si rimanda a G. Fussenegger, De manipulo, cit., p. 76, n. 10 e a G. Rossini, Un piccolo codice «inquisitoriale» del convento di S. Francesco di Rimini nella Biblioteca Comunale di Faenza, «Studi Romagnoli», II (1951), p. 139, n. 5. Per questa ripartizione territoriale vigevano diverse possibilità di identificazione (Romandiola, Romaniola, Aemilia, Flaminia, administratio Bononiensis), per una cui esemplificazione si rimanda per brevità a Mariano d’Alatri, L’Inquisizione francescana nell’Italia centrale del Duecento, Roma 1996, p. 346.
Fig. 11. Anonimo, Il cantiere del Tempio Malatestiano da una illustrazione dell’Hesperis di Basinio da Parma, Rimini 1794.
ordini mendicanti nella città e nella diocesi
quale Alessandro IV nel 1259 stabilì la creazione di due sedi, una a Faenza, e l’altra a Rimini. In realtà fu proprio quest’ultima il vero centro della repressione della dis-sidenza religiosa nella pro-vincia, come testimoniano le fonti superstiti (tra le più nu-merose in ambito italiano)96, anche in considerazione del-la forte presenza catara a ri-dosso della Fossa Patara. La probabile distruzione a furor di popolo del vicus Pataranie – l’unica testimonianza super-stite è tuttavia quella seicen-tesca del De vetusta Arimini urbe et eius episcopis di Giaco-mo Villani97 – in anni imme-diatamente successivi al 1254 (avvenuta quindi in sostanziale coincidenza cronologica con l’attribuzione ai Mi-nori delle mansioni inquisitoriali in Romagna e nel riminese), indurrebbe a ritenere la repressione dell’eresia un importante fattore di coesione sociale nel nome del comune impegno dei cives a difesa della fede. In realtà la situazione appare molto più complessa. L’istituzione del tribunale inquisitoriale a Rimini si situava in anni delicatissimi per gli equilibri politici cittadini, a tal punto da far emergere diffusi dubbi circa la possibilità di prosecuzione dell’officium in città in presenza della forte conflittualità interna tra guelfi e ghibellini e del fenomeno del fuoriuscitismo. Si-
96. Sulle fonti e sulle vicende del tribunale dell’Inquisizione a Rimini, cfr. Piana, Chartularium, cit., pp. 363ss. passim; J. Dalarun, Hérésie, Commune et inquisition à Rimini (fin XIIe- debut XIVe siècle), StMed, ser. IIIª, XXIX (1988), pp. 641-683; R. Parmeggiani, Inquisizione e frati Minori in Romagna, Umbria e Marche nel Duecento, in Frati Minori e inquisizione. Atti del XXXIII Convegno internazionale (Assisi, 6-8 ottobre 2005), Spoleto 2006, pp. 113-150; da ultimo, con edizione di nuovi documenti, Turchini 2009, pp. 320-325.
97. «Quare coeuntibus catholicis, omnia patarenorum sunt direpta, et eversa aedes et domicilia… et vicus totus… brevi manu mutatur in campum locumque perpetuo in anathema jacet»: traggo la citazione da G. Mussoni, I Patarini in Rimini, «La Romagna», II (1905), pp. 400-411; il passo è ripreso in forma più estesa in Dalarun, «Lapsus linguae», cit., p. 276.
Fig. 12. A. Bolzoni, San Pietro martire, incisione, Ferrara 1738 (Rimini, BG, Gabinetto delle stampe).
riccardo parmeggiani
gnificative circa le difficoltà dell’esercizio repressivo sono le admonitiones del 1270-1271 degli inquisitori Bonaventura da Bologna, Manerio da Pisa, oltre che quella poco più tarda di Giovannino Lupicini da Reggio Emilia; da questi documenti98, poi inseriti negli statuti comunali riminesi, si desume quanto strettamente si mesco-lassero eresia e politica. Illuminante è in particolare il pronunciamento dell’ultimo giudice della fede, il quale, oltre a riaffermare il divieto di ostacolare in qualunque modo il regolare svolgimento del negotium fidei e soprattutto di impiegare in lotte di fazione gli ufficiali al servizio dell’inquisitore, sottraendoli conseguentemente ai propri doveri – per di più appunto un ufficiale era stato ucciso apparentemente per motivazioni squisitamente politiche –, si spinge ad equiparare in tempo di conflitti violenti gli avversari dell’autorità pontificia agli eretici. Così gli inquisitori, giudici delegati la cui autorità deriva direttamente dal pontefice, possono perseguire in tale veste, inizialmente soltanto mediante la scomunica, chiunque frapponga publice vel privatim ostacoli e impedimenti all’adempimento del loro mandato. Il fatto che tra i fautori degli eretici vi fossero esponenti del ghibellinismo riminese99, induce a credere – senza per questo svilire la portata del fenomeno eterodosso alla fuor-viante e riduttiva equazione ghibellino = eretico; assai risalente e ben radicata era infatti la presenza catara in città – che la persecuzione del dissenso religioso abbia contribuito non poco all’affermazione del guelfismo, soprattutto in considerazione del forte collegamento dell’officium locale con l’autorità papale: ne sono una chiara dimostrazione i ripetuti consulti richiesti tra gli anni Sessanta e Ottanta del Due-cento dagli inquisitori riminesi alla Curia romana, con particolare riferimento ai cardinali Giovanni Gaetano Orsini e Benedetto Caetani, i futuri papi Niccolò III e Bonifacio VIII100. Il fattivo sostegno dei Malatesti al tribunale antiereticale, con-fermato dalla nutrita presenza di membri della famiglia e di loro stretti sostenitori nel numero degli ufficiali del 1302 (una sorta di corpo di polizia laico al servizio dell’inquisitore) cui si è avuto modo di accennare, contribuisce ad individuare una volta di più il ruolo cardine dei Minori, anche nella veste di inquisitori, nel raccordo tra Papato e signoria locale. Mastin Vecchio, secondo il cronista Marco Battagli, fu inoltre beneficiato dai riminesi con la donazione di alcune case confiscate ad un’ere-tica faentina che erano situate nella zona del Gattolo, dove fu costruito un palaz-zo101. Lo stretto legame tra potere signorile e negotium fidei garantiva alla famiglia dominante non solo un indiretto controllo sul dissenso, da presumere religioso e politico, all’interno della città e dei confini diocesani, ma anche e non seconda-riamente una forte presenza nella rete sociale e nei robusti interessi finanziari che facevano capo all’inquisitore a motivo della gestione dei cospicui introiti derivanti dalla prassi delle multe e delle confische dei beni degli eterodossi. La familia del
98. Editi in Id., Hérésie, cit., pp. 676- 678, nn. 3-6.99. Si veda in proposito il saggio di Lorenzo Paolini contenuto nel presente volume.100. Per l’incerta datazione dei due consilia e per le edizioni di riferimento mi permetto di rimandare
al mio I consilia procedurali per l’Inquisizione medievale (1235-1330), Bologna 2011, pp. 73-83, 138-143. Cfr. comunque già Parmeggiani, Inquisizione, cit., pp. 124-128.
101. Nobilissimorum clarissime originis heroum de Malatestis regalis ystoria, in Marcha di Marco Battagli da Rimini [aa. 1212-1354], a cura di A.F. Massèra, RIS2, XVI/3, Città di Castello 1912-1913, p. 74.
ordini mendicanti nella città e nella diocesi
gestore dell’officium era vasta ed articolata, comprendendo, oltre ai già citati ufficia-li, vicarî, socii, notai, nuntii, giuristi consultori, sindici, procuratori economici, come ben esemplificato nel manuale inquisitoriale redatto a Rimini a cavaliere tra Due e Trecento durante il mandato del frate parmense Tommasino Malebranchi102. Il formulario contenuto nell’opera103, dal quale si evince l’intensa attività legata alla gestione dei numerosi beni dell’Inquisizione, che costringeva il titolare a frequenti spostamenti a Santarcangelo e Cesena, ci restituisce piuttosto l’immagine di un agente finanziario, che quella di un giudice della fede, secondo un paradigma valido anche per molte altre sedi italiane dell’officium. Il continuo e ingente flusso di dena-ro gestito dagli inquisitori indusse il Papato ad introdurre con il Trecento la norma della diretta partecipazione della Camera apostolica alla divisione dei proventi del tribunale, sottoponendo di conseguenza ad un regolare controllo la rendicontazione esibita dai titolari del negotium fidei, prassi del resto testimoniata anche dalle fonti superstiti relative all’attività inquisitoria nel riminese.
Con la cessazione della conflittualità cittadina e l’agonia del catarismo, l’azione repressiva dell’Inquisizione con l’inizio del XIV secolo si era notevolmente attenua-ta anche a Rimini, mutando come altrove obiettivi polemici ed affinando gli stru-menti procedurali. Proprio nella città dei Malatesti fu scritto il più celebre manuale inquisitoriale del medioevo (almeno prima della comparsa di quello di Eymerich nel 1376), vale a dire il Tractatus de hereticis dell’advocatus riminese Zanchino Ugoli-ni († 1340), redatto per l’inquisitore Donato da Sant’Agata attorno al 1330104. L’au-tore, anch’esso assai vicino ai Malatesti – partecipò infatti nel 1334 alla redazione dei nuovi statuti cittadini, che ribadirono la piena affermazione della dinastia signori-le, con cui condivise anche la sepoltura in S. Francesco105 – , è il primo giurista di professione a scrivere un manuale, genere fino ad allora riservato per realizzazione e fruizione ai soli giudici della fede. Il Tractatus presenta una notevole solidità e un rigoroso ordine strutturale – lo si potrebbe definire al passo con i tempi – che prevede anche le nuove tipologie di devianza perseguite dal tribunale. Lo dimostra il particolare accento posto sulla perseguibilità degli ebrei e sulla condanna della
102. Fussenegger, De manipulo, cit., e, per l’individuazione di un secondo testimone dell’opera, Par-meggiani, Inquisizione, cit., pp. 123ss.
103. Fussenegger, De manipulo, cit., pp. 81-86, cui sono da aggiungere due inediti documenti (Qualiter conficitur instrumentum ad emendum per inquisitorem confiscata; Qualiter fiat instrumentum donationis in-quisitori a premisso emptore) contenuti nel ms. Latin 3373 nella Bibliothèque Nationale de France di Parigi (c. 69r-v).
104. Zanchino Ugolini, Tractatus, cit. Per una breve descrizione del Tractatus de haereticis dell’Ugolini e per la sua fortuna a stampa nel Cinquecento rimandiamo invece a A. Dondaine, Le manuel de l’inqui-siteur (1230-1330), «Archivum Fratrum Praedicatorum», XVII (1947), pp. 121-124; A. Errera, Processus in causa fidei. L’evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore perugino, Bologna 2000, pp. 112-115 e passim; P. Diehl, An Inquisitor in Manuscript and in Print: The Tracta-tus super materia hereticorum of Zanchino Ugolini, in S. Echard – S. Partridge (a cura di), The Book Un-bound. Editing and Reading Medieval Manuscipts and Texts, Toronto-Buffalo-London 2004, pp. 58-77. Ai sei testimoni della tradizione manoscritta finora noti indicati nello studio dello storico francese e mutuati dal Diehl occorre aggiungerne altri nove, oltre a diversi frammenti: cfr. Parmeggiani, I consilia, cit., p. 219.
105. Per le scarse notizie biografiche su Zanchino Ugolini, cfr. Tonini, IV/1, pp. 375-376; Tonini, Coltu-ra, pp. 32-38; F. Viroli, Statuti riminesi del XIII e XIV secolo, «Studi Romagnoli», XIV (1963), pp. 368-369.
riccardo parmeggiani
pratica dell’usura – sostenerne la liceità fu riconosciuto come eresia a partire dal ca-none Ex gravi del concilio di Vienne (1311) – che trova una precisa corrispondenza negli atti processuali superstiti del Trecento106. Oltre a queste categorie incontriamo nell’opera di Zanchino nuove definizioni di non conformismo religioso. Queste ultime sono molto differenti dal punto di vista formale e vanno dal generico male sentire de fide – etichetta sotto la quale è raggruppata una variegata tipologia di per-sone, dai bestemmiatori ai magistri assertori di teorie in contrasto con i dogmi della fede – alla contestazione dell’autorità papale, una forma di “dissenso” che tornerà nuovamente a colorare l’eresia di un significato politico. Quest’ultima colpa, defi-nita “disprezzo delle chiavi”, colpì oltre ai fautori di Ludovico il Bavaro e i vertici del ghibellinismo italiano – tra cui Federico da Montefeltro, sottoposto ad inchiesta dall’inquisitore Lorenzo da Mondaino (1320-1321)107 – la dissidenza interna all’or-dine francescano emersa in tutta la sua virulenza a seguito della deposizione del generale Michele da Cesena (1328). Non sembra tuttavia che l’ala rigorista dell’or-dine minoritico, fautrice di un pauperismo radicale, abbia avuto largo seguito nel riminese, nonostante l’adesione ai Michelisti dello stesso inquisitore di Romagna, Audedero da Bertinoro108, attivo forse a Rimini.
Una concezione così fluida di eresia, definita, con felice intuizione “eresia d’opi-nione” (Dupré Theseider) presupponeva un inquisitore ben preparato e in possesso di un vasto bagaglio culturale. La riprova ci viene dalla provenienza di alcuni in-quisitori trecenteschi dalle cattedre dello Studium francescano di Rimini, secondo una prassi formalmente sancita dal capitolo provinciale dei Minori di Romagna del 1411, per cui si stabilì il lettorato come requisito indispensabile per la nomina ad inquisitore109. Emblematica del prestigio culturale e dell’importanza dell’incarico antieterodosso è la figura di frate Leoncino da Rimini: già bacceliere nello Studium francescano di Bologna (1347-1348) e successivamente della propria città natale (1349), ricoprì due mandati in veste di inquisitore in Romagna (1352; 1362-1363), per poi essere promosso a vescovo di Fano110.
6. L’apporto culturale
Quanto lo studio fosse per i Mendicanti strettamente legato all’esercizio della re-pressione dell’eresia, almeno nel periodo delle origini, è del tutto palese, in par-ticolare con riferimento ai Predicatori, ordine per cui il binomio studio / attività antiereticale si configura come un’endiadi fin dalla fase costitutiva dello stesso. Il crescente successo del catarismo indusse il Papato, constatata l’inadeguatezza e l’inefficacia della pastorale affidata al clero tradizionale, alla promozione dei nuovi
106. Piana, Chartularium, cit., pp. 368ss.; Dalarun, «Lapsus linguae», cit., p. 298 e nota 91.107. Tonini, IV/1, p. 537; cfr. più diffusamente Mariano d’Alatri, Gli idolatri recanatesi secondo un
rotolo vaticano del 1320, «Collectanea franciscana», XXXIII (1963), pp. 82-105, ora in Id., Eretici e inquisitori in Italia. Studi e documenti, II, Roma 1986, pp. 9-40.
108. Piana, Chartularium, cit., p. 370.109. Ibid., p. 363.110. Ibid., pp. 28, 383.
ordini mendicanti nella città e nella diocesi
ordini, destinati a far mutare profondamente il carattere della predicazione attra-verso l’elaborazione di nuovi strumenti, quali le concordantiae bibliche, che consen-tirono ai frati di proporre una forma più creativa di predica, detta sermo modernus, in opposizione a quello antiquus, consistente nella volgarizzazione di testi omiletici tramandati da secoli. A conferma dell’originaria finalità antiereticale, diretta o indi-retta, dello studio e della predicazione presso i Mendicanti (settori che acquisirono poi progressivamente una propria dimensione autonoma), molti giudici della fede furono autori di importanti raccolte di prediche, come accadde per l’anonimo in-quisitore francescano attivo a Rimini ad inizio Trecento, di cui in un codice della Biblioteca Apostolica Vaticana si conserva una silloge di sermones dominicales111.
La predicazione dei Mendicanti presentava dunque elementi innovativi e di maggior richiamo per i fedeli rispetto a quella dei secolari112, anche in considerazio-ne della capacità di plasmare il proprio messaggio in funzione dell’uditorio, adatta-mento verificabile nei sermones ad status indirizzati alla classe mercantile-borghese in via di affermazione, in cui si legittimava moralmente la ricchezza, se opportu-namente utilizzata, derivante dalle diverse attività professionali dei ceti produttivi. Quanto questa mediazione culturale avvenisse anche attraverso l’adozione di stru-menti linguistici adeguati, lo dimostra esemplificativamente la “volgarizzazione”, contenutistica e letterale, delle bolle di Giovanni XXII contro Ludovico il Bavaro e Castruccio Castracani compiuta nel 1325 nella cattedrale di S. Colomba dal celebre domenicano riminese Guido Vernani113.
L’assoluta centralità della Parola divina nella sua corretta interpretazione è del resto evidente nella denominazione stessa dell’istituto religioso dei domenicani, ordo Praedicatorum. I primi domenicani avevano previsto nelle costituzioni del pro-prio ordine una precisa organizzazione degli studi, successivamente mutuata an-che dai francescani, che si concretizzò sia nella fondazione di studia generalia, sorti presso i conventi delle principali città universitarie ed aperti agli studenti di tutte le province, che di studia di più ristretto ambito locale (provinciali e conventuali). In queste scuole la formazione dei futuri predicatori attraverso l’insegnamento della nuova teologia scolastica era uno dei compiti fondamentali. Lo Studium mendican-te aveva come perno le figure del lettore e del baccelliere, il cui compito era quello di studiare, commentare e disputare le Sentenze di Pietro Lombardo, il manuale teologico di riferimento nel medioevo, e successivamente la Bibbia114.
A Rimini le prime attestazioni certe degli studia mendicanti risalgono agli anni
111. Cod. Vat. Lat. 9375; cfr. Piana, Chartularium, cit., p. 368.112. Pellegrini, Mendicanti e parroci, cit., p. 163; più in generale, cfr. i saggi contenuti in La predicazione
dei frati dalla metà del ‘200 alla fine del ‘300. Atti del XXII Convegno internazionale (Assisi, 13-15 ottobre 1994), Spoleto 1995.
113. Tonini, IV/1, p. 532.114. In generale sugli studia mendicanti medievali, si rimanda ai seguenti atti congressuali: Le scuole degli
ordini mendicanti (secoli XIII-XIV). Atti del XVII convegno del Centro di studi sulla spiritualità medieva-le (Todi, 11-14 ottobre 1976), Todi 1978; Studio e studia: le scuole degli ordini mendicanti tra XIII e XIV secolo. Atti del XXIX Convegno internazionale (Assisi, 11-13 ottobre 2001), Spoleto 2002. Si veda utilmente an-che L. Pellegrini, L’incontro tra due “invenzioni medievali”: Università e Ordini Mendicanti, Napoli 2003.
riccardo parmeggiani
a cavaliere tra Due e Trecento, benché la fondazione di tali scuole debba proba-bilmente rimontare al periodo immediatamente successivo all’insediamento degli ordini in città. Per i frati Minori l’esistenza dello Studium è verificabile a partire dal 1298, quando l’inquisitore Tommasino Malebranchi nominò proprio vicario (nonché poi futuro inquisitore) frate Vincenzo da Bologna, lector fratrum Mino-rum de Arimino115. Nel 1336 il pontefice Benedetto XII riconobbe alla scuola fran-cescana di Rimini una particolare importanza, annoverandola tra le poche sedi, non comprese nel numero degli studia generalia, che fossero in grado di “abilitare” i propri lettori al successivo insegnamento e commento delle Sentenze di Pietro Lombardo a Parigi, Oxford e Cambridge116. A conferma del rilievo acquisito, nel corso del Trecento lo Studium di S. Maria in Trivio fu meta obbligata di studenti provenienti da altre province italiane (come quella milanese, umbra e toscana), per poi diventare indistintamente possibile approdo per i frati di ogni provenienza, grazie alla facoltà attribuita dal capitolo generale di Firenze del 1467 per cui «ad Studium philosophiae Ariminense mittere possunt omnes provinciae», ratificando forse una situazione di fatto già in essere, come dimostrerebbe un documento del 1461 in cui la comunità minoritica risulta riccamente composita, comprendendo frati provenienti non solo da diverse parti d’Italia, ma anche da oltralpe e dalla sponda opposta del mare Adriatico117. Nonostante il riconoscimento di simili pre-rogative, la scuola francescana attraversò proprio in quegli anni un momento criti-co, in coincidenza con l’inasprirsi del conflitto tra Sigismondo Pandolfo Malatesti e Pio II. Come si è già avuto modo di rilevare per la chiesa degli agostiniani, anche per il complesso francescano i danni materiali furono così ingenti da spingere in seguito il pontefice Sisto IV a destinare una cospicua parte della dotazione patri-moniale delle Clarisse riminesi non solo alla riparazione del convento, ma anche «in manutentionem Studii, quod ibi vigere solet»118. Se la politica sigismondea cagionò indirettamente danni di tale proporzione, per altri versi il mecenatismo e la sensibilità umanistica del Malatesti favorì il decisivo incremento della biblioteca conventuale con una ricchissima donazione di testi che spaziavano dall’ambito sacro a quello profano, dalla cultura classica alla tradizione cristiana, coprendo di-
115. Fussenegger, De manipulo, cit., V, p. 83; un ulteriore documento, inedito, relativo al mandato vicariale del lettore dello Studium francescano riminese è contenuto nel ms. Latin 3373 della Bibliothèque Nationale de France di Parigi (c. 69r). Celestino Piana (Chartularium, cit., p. 368, n. 4) avanzò l’ipotesi che si trattasse dello stesso Vincenzo inquisitore in Romagna impegnato nel 1311 in un celebre processo contro i Templari. La recente edizione di un inedito frammento del novembre 1310 relativo al medesimo procedimento sembra confermare l’intuizione dello studioso francescano (cfr. F. Tommasi, Interrogatorio di Templari a Cesena (1310), in F. Tommasi (a cura di), Acri 1291. La fine della presenza degli ordini militari in Terra Santa e i nuovi orientamenti nel XIV secolo, Ponte San Giovanni (Pg) 1996, pp. 275s., 278, 287).
116. M. Bihl, Ordinationes a Benedicto XII pro fratribus Minoribus promulgatae per bullam 28 novembris 1336, «Archivum Franciscanum Historicum», XXX (1937), pp. 327-328. L’ambigua interpretazione della congiunzione latina vel contenuta nel documento papale ha indotto alcuni studiosi a pronunciarsi per una promozione pontificia della scuola riminese al rango di Studium generale (cfr., ad esempio, Mariano d’Alatri, Italia, in Le scuole, cit., p. 67), ipotesi tuttavia da escludere.
117. Turchini, Il Tempio, cit., pp. 80-81 e, per l’edizione del documento, ibid., pp. 643-644, n. 87.118. Sulle vicende dello Studium francescano riminese nel medioevo, si veda la relativa scheda in Piana,
Chartularium, cit., pp. 24*-25*.
ordini mendicanti nella città e nella diocesi
versi settori dello scibile. A quel patrimonio librario si aggiunse di lì a breve (1475) l’eccezionale lascito dell’intera biblioteca del principale intellettuale al servizio della corte di Sigismondo, Roberto Valturio. Condividendo la scelta funeraria del protettore, indirizzata verso i Minori, l’umanista dispose inoltre per l’accoglimento dei propri volumi la costruzione di una libreria al piano superiore rispetto a quella già esistente, stabilendo il divieto di vendita dei volumi contenuti nella biblioteca, la cui fruizione non doveva essere riservata ai soli frati studenti, ma aperta all’intera cittadinanza. Si trattava dunque di una libreria del tutto simile a quella, anch’essa pubblica e di ispirazione umanistica, impiantata ed eretta nel convento dei fran-cescani di Cesena (l’attuale Biblioteca Malatestiana) alla metà del secolo con il determinante contributo del fratello di Sigismondo Pandolfo, Malatesta Novello (fig. 13). I Minori riminesi, nonostante alcune difficoltà finanziarie, che riuscirono tuttavia a superare, giunsero a completare la biblioteca nel 1490119, in breve arric-chita da ulteriori donazioni. Un’idea della ricca e variegata composizione della stessa, prima della rovinosa dispersione seicentesca, ci è restituita da un prezioso inventario del Cinquecento in cui sono elencati quasi trecento codici tra testi pa-tristici, teologici, filosofici, giuridici, retorici e letterari (comprendenti opere di Dante, Petrarca e Boccaccio)120. Nello Studium francescano riminese mossero con ogni probabilità i primi passi della propria formazione personaggi di una qualche importanza, quali Giovanni Bertoldi da Serravalle (1350/1360 ca. – 1445)121 e Fran-cesco da Rimini († 1460/1470 ca.)122.
Le prime notizie certe sull’esistenza di uno Studium presso i domenicani di S. Cataldo, nonostante la leggendaria ipotesi dell’insegnamento tenutovi da Tomma-so d’Aquino123 († 1274), ci giungono dagli atti del capitolo provinciale dell’ordine tenutosi a Vicenza nel 1307. In quell’assise venne destinato ad insegnare filosofia naturale presso la scuola dei Predicatori di Rimini Biagio da Trento124; contestual-mente, secondo una prassi diffusa che garantiva una vasta circolazione dei membri dell’ordine, al convento vennero assegnati alcuni frati provenienti da altri centri della Lombardia inferior, anche se per la massima parte (cinque riminesi su sette) si trattava di un ritorno al luogo di provenienza. Abbiamo dunque la certezza che S. Cataldo fosse uno Studium provinciale e non semplicemente conventuale. Il presti-gio della scuola fu notevolmente accresciuto nel corso del Trecento dalla presenza di teologi di grande spessore, che svolsero in parte preponderante altrove il proprio magistero, quali Guido Vernani (l’acerrimo rivale di Dante) ed Enrico da Rimini,
119. Turchini, Il Tempio, cit., pp. 82-83.120. Edito da G. Mazzatinti, La biblioteca di San Francesco (Tempio Malatestiano) in Rimini, in Scritti
vari di filologia, Roma 1901, pp. 345-352; cfr. anche per utili precisazioni A.F. Massèra, Roberto Valturio «omnium scientiarum doctor et monarcha» (1405-1475), «Annuario del R. Istituto Tecnico “R. Valturio” di Rimini», III (1925-1926), pp. 39-52; IV (1926-1927), pp. 73-91, riprodotto in A. Piromalli (a cura di), La cultura letteraria nelle corti dei Malatesti, Rimini 2002, pp. 213-248 (in particolare p. 225).
121. A. Vallone, Bertoldi, Giovanni (Giovanni da Serravalle), DBI, 9, pp. 574-576.122. Tonini, V/1, pp. 709-712, P. Vian, Francesco da Rimini, in DBI, 49, pp. 826-828.123. Come sostenuto dal Clementini, senza tuttavia addurre alcuna fonte: cfr. Tonini, III, p. 330.124. A. D’Amato, Atti del Capitolo Provinciale della Lombardia inferiore celebrato a Vicenza nel 1307,
«Archivum Fratrum Praedicatorum», XIII (1943), p. 148.
riccardo parmeggiani
maestri alla cui attività speculativa è dedicato un apposito saggio nel presente volume. Il dif-ficile frangente storico dello Scisma (1378-1417) produsse rovinosi effetti per lo Studium dome-nicano. Carlo Malatesti, fedele nell’obbedien-
za a Gregorio XII (opposto a Benedetto XIII), appoggiò il pontefice, ospitandolo in città. Papa Correr dovette stabilirsi proprio nel convento di S. Cataldo (dove il Clementini afferma che Vincenzo Ferrer avrebbe persuaso il papa ad abdicare)125, inducendo i frati ad alienare una loro
estesa proprietà per per contribuire alla politica pontificia. Il danno patrimoniale fu così in-
gente da far diminuire in maniera drastica le presenze di maestri e studenti presso lo
Studium e da convincere papa Eugenio IV nel 1442, a circa trent’anni di distanza da-gli eventi, a destinare al convento i beni del monastero femminile domenicano di
S. Caterina, destinato alla soppressione126.La celebre figura dell’agostiniano Gregorio da Rimini, che fu anche generale
dell’ordine (1357-1358), contribuì in maniera determinante a dare risalto allo Stu-dium riminese degli Eremitani di S. Agostino, attestato a partire dalla prima metà del XIV secolo. Nonostante facesse parte, insieme a conventi di diverse altre città, degli studia generalia Italie istituiti dai capitoli dell’ordine su sollecitazione delle autorità locali, quello riminese non va tecnicamente considerato un vero e proprio Studium generale127. Ciononostante nella scuola di S. Giovanni Evangelista, su cui possediamo una discreta documentazione per il Quattrocento128, furono attivi in qualità di docenti, oltre appunto all’insigne Gregorio da Rimini, teologi del cali-bro di Giacomo e Paolo da Rimini (rispettivamente nel 1384 e nel 1390)129, il fu-
125. Tonini, III, p. 330.126. Il documento relativo all’applicazione della patrimonialità del monastero di S. Caterina a S. Catal-
do è edito in Ripoll – Bremond, Bullarium, cit., III, pp. 160-161, n. 253.127. D. Gutiérrez, Los estudios en la Orden Agustiniana desde la edad media hasta la contemporánea,
«Analecta Augustiniana», XXXIII (1970), pp. 67-68.128. Cfr. C. Piana, Ricerche su le Università di Bologna e di Parma nel secolo XV, Spicilegium Bonaven-
turianum, I, Quaracchi 1963, pp. 80, 111, 120, 202, 259, 287, 432, 441-443, 462; Id., Nuove Ricerche su le Uni-versità di Bologna e di Parma, Spicilegium Bonaventurianum, II, Quaracchi 1966, pp. 161, 315; Bassetti, Un ritrovato, cit., in particolare p. 75.
129. Tonini, IV/1, p. 539.
Fig. 13. Ritratto di Malatesta Novello, signore di Cesena.
ordini mendicanti nella città e nella diocesi
turo vescovo Girolamo Leonardi (1414)130, Giuliano Falciglia (1433)131 e, con ogni probabilità, Gerardo da Rimini, che divenne poi generale dell’ordine dal 1431 al 1443132. Circa la biblioteca conventuale, non disponiamo, purtroppo, che di scarse notizie133. Allo Studium agostiniano riminese si aggiunse almeno dalla metà del XV secolo quello di Verucchio, scuola probabilmente di respiro provinciale134.
7. Le comunità femminili
A completare la presenza dei Mendicanti concorse l’insediamento in città del ramo femminile degli ordini. La documentazione, anche in virtù del diverso carattere del Secondo Ordine di questi istituti religiosi, risulta tuttavia ancor più sfuggente.
Particolarmente precoce fu lo stanziamento delle Clarisse. Decisiva fu la do-nazione fatta dal iudex riminese Benno nel 1253 con lo specifico intento di fondare un monastero damianita in loco qui dicitur Mirasole fuori Porta S. Andrea, cosa che avvenne con il consenso del vescovo Giacomo e del pontefice Innocenzo IV. La permanenza del primitivo nucleo femminile in S. Maria di Mirasole fu comunque di breve durata, perché in seguito alla cattiva gestione del monastero urbano di S. Marino de Abbatissis da parte delle relative religiose, probabilmente benedettine – prima dell’autorizzazione innocenziana del 1247 all’adozione di una propria regola le Damianite avevano seguito quella, già riconosciuta, di san Benedetto –, il presule Giacomo nel 1258 vi introdusse in aggiunta alle stesse le monache damianite (poi Clarisse) di Mirasole, decisione successivamente ratificata dal pontefice Alessandro IV. Si verificò dunque a livello istituzionale una situazione incerta quanto transito-ria, presto superata in nome della comune appartenenza di entrambi i distinti nuclei originari ora all’ordine di S. Chiara135. La cura monialium era affidata ai frati Minori di S. Maria in Trivio. A questo primo insediamento se ne affiancò un secondo a cavaliere tra Due e Trecento. In un arco temporale compreso tra il 1288 e il 1311 – ma gli estremi possono probabilmente restringersi agli anni 1295-1303 – giunse a Rimini un gruppo di Clarisse proveniente dal castello di Begno, nei pressi di San Leo, che avevano dovuto abbandonare a causa di scontri bellici136. Il terminus ante quem è co-stituito dal testamento di Malatesta da Verucchio, nel quale è previsto uno specifico lascito per le monache de Castro Begni ordinis sancte Clare de Arimino. Le Clarisse si stabilirono nel quartiere di S. Andrea, nel monastero dedicato a S. Chiara, che in ragione delle origini delle religiose fu detto “di Begno”. La situazione critica di metà Quattrocento, dovuta all’offensiva papale contro Sigismondo Pandolfo Mala-
130. Cfr. Tonini, V/1, pp. 608-609. 131. D. Gionta, Falciglia, Giuliano (Giuliano da Salem), DBI, 44, pp. 270-272.132. Tonini, V/1, p. 709.133. Lugato, La comunità, cit., p. 319.134. Bassetti, Un ritrovato, cit., p. 76.135. Tonini, III, pp. 333-334; Id., Rimini dopo il Mille, pp. 114-115.136. Dalarun, «Lapsus linguae», cit., p. 124 e nota 272; cfr. tuttavia anche A. Benvenuti, La fortuna del
movimento damianita in Italia (sec. XIII): propositi per un censimento da fare, in Chiara d’Assisi. Atti del XX Convegno Internazionale (Assisi, 15-17 ottobre 1992), Spoleto 1993, pp. 80-81.
riccardo parmeggiani
testi, non risparmiò neppure le due comunità del Secondo Ordine francescano. Nel 1464 alle Clarisse di Begno vennero unite per volere di papa Paolo II le consorelle di S. Marino, il cui monastero fu concesso ai canonici Lateranensi, mentre parte della patrimonialità acquisita venne devoluta da Sisto IV ai frati Minori per la riparazione del loro convento137. Sullo scorcio del medioevo, in esecuzione di una bolla di papa Alessandro VI (1496), fu poi creata una nuova comunità di Clarisse. Il pontefice, in risposta ad una supplica di Elisabetta Malatesti e delle monache “delle Murate” di S. Cristoforo, cassò l’unione precedentemente stabilita con il mo-nastero di S. Maria degli Angeli, estinguendo in S. Cristoforo la regola benedettina ed introducendovi quella di S. Chiara. Il rinnovato ente religioso contestualmente mutò la dedicazione ora al SS. Corpo di Cristo, e la cura monialium venne affidata ai Minori Osservanti di S. Maria delle Grazie138.
La tradizione agiografica ha a lungo ed erroneamente accostato all’ordine francescano la straordinaria figura di Chiara da Rimini (ca. 1260-1326) (fig. 14), il personaggio femminile più carismatico del medioevo religioso riminese, che i magistrali studi di Jacques Dalarun hanno decisivamente contribuito a collocare nella sua dimensione più genuina139. Nonostante gli stretti rapporti in vita con i Mendicanti, l’autonoma fondazione della beata fu trasformata in un monastero di Clarisse soltanto nel 1522, dopo essere stato precedentemente unito con altri enti religiosi femminili.
Più tardo e di breve durata rispetto a quello del Secondo Ordine francescano fu l’insediamento delle monache domenicane, la cui introduzione fu voluta dal vescovo e frate Predicatore Girolamo Fisici. Il 7 maggio 1326, alla presenza, tra gli altri, di Guido Vernani, il presule con il consenso del Capitolo della cattedrale compì i passi necessari perché si costruisse un monastero femminile del proprio ordine da dedica-re a S. Caterina nel luogo in cui sorgeva l’ospedale nel Borgo appena fuori Porta S. Andrea. La struttura caritativa, che rimase comunque in essere, fu sottoposta, come si evince da un documento del 1374, alla diretta amministrazione delle monache do-menicane. A causa dell’eccessiva vicinanza di S. Caterina all’area del Gattolo, dove Sigismondo Pandolfo stava attendendo alla costruzione del Castello che porterà il suo nome, nel 1442 l’ente religioso fu soppresso e i beni furono destinati ai frati Pre-dicatori di S. Cataldo. Le poche monache di S. Caterina passarono nel monastero delle Umiliate di S. Matteo140. Risulta invece assai difficile seguire con sicurezza, a Rimini, come altrove, le vicende del movimento femminile agostiniano, soprattutto in considerazione della frequente “nebulosità istituzionale” che caratterizzò molte fondazioni. Questa incertezza dipende in larga parte dalla frequente assegnazione della regola di sant’Agostino da parte vescovile nei confronti di gruppi autonomi di donne penitenti; del resto molti dei monasteri che espressamente seguirono quella
137. Tonini, Rimini dopo il Mille, pp. 114-115; Piana, Chartularium, cit., p. 24*.138. Tonini, V/1, p. 666; V/2, pp. 313-318 (CXXXIX).139. Il rinvio obbligato è a Dalarun, «Lapsus linguae», cit. e, con taglio più divulgativo, a Id., Santa e
ribelle, cit.140. Tonini, IV/1, pp. 442-443, 456; IV/2, pp. 101-102, n. LIV; V/1, pp. 649, 658; Id., Rimini dopo il Mille,
p. 188. Cfr. anche supra, nota 126.
ordini mendicanti nella città e nella diocesi
norma non fecero in realtà parte dell’ordine femminile agostiniano141. Non sussi-stono invece dubbi, se non lievi e di carattere pura-mente cronologico, circa la fondazione di un monaste-ro femminile agostiniano tra il 1420 e il 1424 ad opera di Michelina da Sannaza-ro, già artefice secondo la tradizione di un analogo insediamento a Pavia142. Fondamentale per l’avvio del monastero e per i suoi immediati sviluppi fu il ruolo giocato dalla famiglia Malatesti. Carlo, ottemperando alle disposizioni testamentarie della sorella Rengarda, concesse nel 1429 a Michelina una casa in contrada S. Andrea (precisamente in S. Onofrio, nell’attuale via Bonsi, nella zona della comunità ebraica)143, che rappresentò il punto di partenza del pro-getto di costruzione, ottenendo in seguito da Galeotto Roberto l’esenzione fiscale della stessa. Alla fondatrice del neonato ente religioso Isabetta Malatesti, vedova di Obizzo da Polenta, lasciò alla sua morte (1433) l’intero patrimonio, la cui portata fu tale da far dubitare le monache circa l’effettiva possibilità di acquisire un così ingente volume di beni. Fu quindi necessario l’intervento di Sigismondo Pandolfo che, anche a nome del fratello Malatesta Novello, confermò il vigore delle ultime volontà della defunta144: si trattò forse di un atto di tutela del convento a fronte delle pretese avanzate sull’eredità dal Capitolo della cattedrale di S. Colomba, con cui in effetti sorse un contenzioso da cui le monache dovettero uscire vittoriose. Nel 1494 le agostiniane traslarono poi il proprio monastero nel quartiere di Pomposo di fronte a S. Giorgio Antico, costruendo un nuovo edificio con dedicazione a S. Sebastiano.
Non va infine dimenticata la presenza in città del ramo femminile dei Servi di Maria. La comparsa delle servite, da ricondurre presumibilmente all’iniziativa
141. P. Piatti, Il movimento femminile agostiniano nel Medioevo: momenti di storia dell’Ordine eremitano, Roma 2007, pp. 34-36.
142. Tonini, V/1, pp. 663-666.143. Vasina, La società riminese, cit., p. 256.144. Turchini 2009, p. 260, n. 6 (documento del 17 gennaio 1434).
Fig. 14. Maestro della Beata Chiara da Rimini, La visione della Beata Chiara da Rimini, 1330 ca., particolare (Londra, National Gallery).