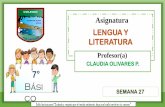L'adolescenza nella narrativa di Alberto Moravia
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of L'adolescenza nella narrativa di Alberto Moravia
1
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO
CHIETI – PESCARA
Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di laurea in Lettere moderne
L’ADOLESCENZA NELLA NARRATIVA DI ALBERTO
MORAVIA
Laureando Relatore
Dario Angelucci Prof. Giancarlo Quiriconi
Anno accademico 2011/2012
2
Indice
Introduzione 5
Capitolo 1
Sul “romanzo di formazione” 6
1. Parabola storica del romanzo di formazione 8
2. La formazione 11
3. L‟iniziazione 15
4. Tre cronotopi della formazione 16
5. L‟io e il mondo 16
6. Formazione all‟italiana 17
Capitolo 2
Gli indifferenti 18
1. Michele e Carla 20
Capitolo 3
Agostino 25
1. La banda 30
2. I soldi 32
3. Lo spazio 33
4. Il postribolo 34
5. Altre prove di iniziazione 35
3
Capitolo 4
La disubbidienza 36
1. Io VS mondo 38
2. La scuola 39
3. La famiglia 40
4. L‟incidente della camera da letto 41
5. Thanatos e Eros 43
6. L‟infermiera 45
7. Happy ending 48
8. Osservazioni finali: il tempo, lo spazio e il clima 50
9. Conclusioni 52
Bibliografia 53
4
Ai miei genitori,che non hanno mai posto vincoli alle mie potenzialità,ed han sempre
creduto in me.
5
Introduzione
“Ci sono bambini tonti, ottusi, insensibili. Ci sono quelli molto sensibili, ipersensibili.
Quelli ipersensibili possono diventare dei disadattati; ma possono anche diventare degli artisti”1.
Moravia, testimone principe del naufragio dei valori borghesi, è un autore di cui si è scritto
molto, ma che a sua volta si è molto raccontato. La grande autoconsapevolezza della sua
opera e la trasfigurazione letteraria della sua vicenda biografica fanno sì che nel critico o nel
lettore si crei l‟illusione che basti poco per ricomporre il profilo della sua personalità e della
sua storia.
Con questo lavoro si intende ripercorrere una sezione della ricca produzione artistica di
Alberto Moravia (1907-1990) per analizzare il rapporto tra uno degli scrittori più “scomodi”
del „900 italiano ed un altrettanto problematico genere letterario : il “romanzo di formazione”;
in virtù del fatto che lo scrittore romano è stato un acuto fenomenologo dell‟adolescenza e
interprete di quel genere narrativo che è per definizione indagatore dei rapporti umani e del
senso della vita.
Il romanzo di formazione è un genere tipicamente sette - ottocentesco, frutto di una complessa
struttura simbolica, ed è opinione diffusa (riconducibile al cardinale studio di Franco Moretti,
Il romanzo di formazione) che si sia eclissato dopo il 1915.
1 A. MORAVIA – A. ELKANN , Vita di Moravia , Milano, Bompiani, 2007, cit., p. 7
6
Questo lavoro non vuole convalidare la generale sentenza di morte del romanzo di
formazione, ma dimostrare come, nello scenario postbellico italiano, questo genere continui
ad esistere con caratteristiche radicalmente nuove; nella convinzione che Moravia abbia
operato una personale restaurazione di questo congegno narrativo.
Capitolo 1
Sul “romanzo di formazione”
Cosa intendiamo per romanzo di formazione? Si riscontra, in ambito critico, una certa
mancanza di approfondimento specifico sulla tematica della formazione; attualmente l‟unica
trattazione esauriente sembra essere Il romanzo di formazione (1999) di Franco Moretti, e
difatti sarà un costante punto di riferimento in questo percorso di analisi.
Il romanzo di formazione narra le vicende biografiche di un giovane eroe, il quale attraverso
diverse esperienze di vita, riesce a dare una forma organica e compiuta alla propria
individualità, riuscendo così a vivere serenamente nella società in cui è immerso.
Moretti sostiene che non si può “concedere il romanzo di formazione a tutti, come se fosse
l‟assistenza sanitaria”2, ed è vero, ma la selezione che opera considera per lo più criteri
cronologici e geografici, e non propriamente qualitativi.
Fissando i limiti geografici della sua indagine Moretti rileva come il fenomeno sia
significativamente presente in Francia, Germania e Inghilterra, mentre esclude il romanzo
russo per il permanere di una forte componente religiosa, quello americano per l‟importanza
attribuita alla natura (in contrasto con la dimensione essenzialmente urbana del romanzo di
formazione) e quello italiano.
2 F. MORETTI , Il romanzo di formazione , Torino, Einaudi, 1999, cit., p. 15
7
I limiti cronologici fissati da Moretti racchiudono la parabola di questo genere fra il tardo
„700 ed il primo dopoguerra.
Nella prospettiva darwiniana del critico i generi letterari si presentano come meccanismi
“problem solving”, cioè con la funzione di conciliare e attenuare tensioni e paradossi generati
dai mutamenti storico-sociali; e sono destinati a scomparire all‟insorgere di problemi che sono
incapaci di affrontare e risolvere.
Il principale tema affrontato dal romanzo di formazione è quello della socializzazione nella
moderna civiltà borghese. Il problema nasce dal momento in cui i processi di sviluppo e
autodeterminazione dell‟individuo devono fare i conti con le esigenze di socializzazione
imposte dalle istituzioni, le quali prevedono integrazione,omogeneità e consenso. Il dissidio si
acuisce e drammatizza soprattutto per quella cultura borghese proveniente dagli
stravolgimenti della rivoluzione francese e dall‟esperienza napoleonica, che dovrà fare i conti
con la lezione della generazione precedente.
Questo genere nascerà proprio dal tentativo di compromesso (simbolico) tra le esigenze di
socializzazione moderne e la sfera più personale e soggettiva dell‟individuo.
Il frutto migliore di questo compromesso simbolico è il “bildungsroman” (termine tedesco che
indica appunto il romanzo di formazione), che Moretti considera lo stadio iniziale (e più
perfetto ) del romanzo di formazione . Opera fondante della tradizione è Gli anni di
apprendistato di Wilhelm Meister (1796) di Johann Wolfgang Goethe, in cui il protagonista,
un giovane borghese, viene iniziato alla vita e all'arte attraverso un viaggio sia fisico che
spirituale attraverso l'Europa.
La socializzazione moderna è un processo che prevede, per l‟individuo, una fase dinamica,
“giovanile” e intensamente soggettiva; soltanto quando l‟individuo si stancherà di questa
condizione di spossante disillusione e del peso di una forte individualità gli sarà suggerito che
la gioventù non è altro che un‟effimera parentesi in un mondo di adulti. L‟individuo si
integrerà nel codificato mondo degli adulti solo a prezzo di una volontaria rinuncia .
8
Ma progressivamente la dottrina freudiana e la disgregazione della coscienza generata dai
conflitti mondiali furono apportatrici di problemi insolubili per “la convenzione artistica forse
più alta mai prodotta dall‟occidente moderno”3.
Benché concordi sulla data di nascita del romanzo di formazione canonico ci sentiamo di
discordare con Moretti sulla sua data di decesso, nonché sull‟ipotesi stessa di decesso.
È innegabile che vi siano profonde differenza tra il contesto culturale in cui questo genere
affonda le radici e quelli in cui si è progressivamente sviluppato; ma leggendo Moravia ed
altri autori resta la sensazione che il ventesimo secolo non abbia assistito alla fine del
romanzo di formazione ma abbia solo contribuito alla sua trasformazione.
Cerchiamo ora di definire meglio in cosa consiste il romanzo di formazione: esso è il racconto
di una vita (o di un segmento di essa); ma ciò non basta. La vicenda deve far capo ad un
“round character”, giovane e “mobile”, affinché questi, attraverso esperienze di varia natura,
subisca un mutamento che generi uno “scarto” tra la sua condizione iniziale e quella finale.
Fondando il suo modello teorico di bildungsroman esclusivamente su due romanzi (Gli anni
di apprendistato di Wilhelm Meister e Orgoglio e pregiudizio) Moretti poi si ritrova a
constatare che le opere che si conformano a tale modello sono davvero poche.
Anche se valido e coerente, bisogna dunque rendere più elastico il modello delineato da
Moretti, ad esempio abolendo le varie distinzioni terminologiche e modificando i limiti
storico-geografici del campo di indagine.
Parabola storica del romanzo di formazione
“Non gli rimaneva che rinchiudersi in sé , un destino che nei piccoli e nei grandi ha gravi
conseguenze.”4
3 Ibid., p. 255
4 J. W. GOETHE , La missione teatrale di Wilhelm Meister , Milano, BUR, 2008, p. 25
9
Il vertice della parabola del romanzo di formazione coincide con L’educazione sentimentale
di Flaubert (1869), nel quale si intravedono già chiari segni di mutamento nella struttura dei
personaggi. Moretti è convinto che con Flaubert inizi il processo di degenerazione (simbolica)
del romanzo di formazione, che darà vita a quello che definisce “tardo romanzo di
formazione”, di cui è un limpido esempio Tonio Kroger di T. Mann (1903). Si acuisce, in
questi racconti, il divario tra interiorità e esterno, e nascono dei personaggi strani, ambigui e
contraddittori.
L‟identità più verace si rinchiude nell‟interiorità più profonda : siamo agli antipodi dell‟eroe
del bildungsroman, dove l‟identità si manifestava e oggettivava pienamente.
La contraddittorietà della fase storica (quella della restaurazione post-napoleonica) incrina la
struttura del romanzo, che ora non riesce più ad esorcizzare la paura degli stravolgimenti
sociali e dei nuovi valori.
Questi nuovi personaggi sono duplici e rischiano quello stallo esistenziale che mina le
esigenze di unità psichica preliminari ad ogni progetto di vita. I sogni, gli ideali, i valori,
entrano tutti in crisi con il “principio di realtà”: quella tendenza psichica che ha lo scopo di
farci sentire accettati e in pace col mondo, e che nasce dal fisiologico bisogno di conciliare
forze contrastanti, dal bisogno di equilibrio, portando così a scendere a compromessi con la
realtà.
Progressivamente il tardo romanzo di formazione (sempre secondo Moretti) sfocerà in veri e
propri anti-bildungsroman, estremizzando il percorso di esplorazione e demistificazione della
realtà e della falsa coscienza borghese.
Tra ‟800 e „900 si afferma la società capitalistica, con tutto il suo carico di indifferenza etica,
che non sente più il bisogno di legittimazione morale. Il mondo inizia a configurarsi come un
labirinto dove non è possibile vedere una meta largitrice di senso : meglio accettare allora le
regole del gioco, tradendo i propri ideali, piuttosto che restare in una sorta di limbo.
10
Il racconto di gioventù cessa di essere la forma narrativa che permette di umanizzare la
struttura sociale (Wilhelm Meister) o di metterne in dubbio la legittimità (Il rosso e il nero);
ora invece sembra rappresentare il lato più disumano, incurante e distruttivo del nuovo ordine
del mondo.
Al crollo di ogni illusione seguirà un brusco risveglio e la gioventù piomberà in una vecchiaia
afasica. Alla sfera dell‟essere subentrerà quella dell‟avere ed i primi effetti collaterali saranno
l‟alienazione e la tragica separazione tra vita e professione; un problema già affrontato nel
Meister. Wilhelm cerca infatti un lavoro estetico, umanizzante, che produca non merci ma
cose armoniose che risaldino il rapporto fra uomo e natura.
Trascorso un secolo, una tale sintesi non sarà più possibile in un mondo travolto da un lavoro
strumentale e alienante.
A questo punto Moretti sentenzia che una tale convenzione artistica non è più possibile al
venir meno dei suoi presupposti ;
“e quando le scienze dell‟uomo presero a smantellare l‟immagine unitaria
dell‟individuo;[…] quando la gioventù si tradì da sé aspirando a non finire mai;
quando si diffusero ideologie in cui il singolo figurava immediatamente come
parte del tutto – allora il secolo del bildungsroman fu davvero finito”5.
L‟ideale goethiano di formazione viene travolto dal trauma del soggetto, determinato
dall‟affermarsi di tendenze nichiliste e dalle teorie psicanalitiche che scandagliano e
decostruiscono l‟Io. Viene meno l‟immagine unitaria della coscienza, determinando quel
senso di inconoscibilità dell‟io che pervade la cultura moderna.
Dopo la psicanalisi sarà la grande guerra a dare il colpo di grazia al concetto di formazione
tradizionale; ed il terreno sarà pronto per veri e propri romanzi afasici.
5 F. MORETTI , Il romanzo di formazione , cit., p. 255
11
Verissimo, ma anche l‟individuo moderno dovrà pervenire ad una qualche forma di crescita,
seppur con modalità nuove, dando vita a storie di fiducia in uno sviluppo positivo
dell‟individuo; e, paradossalmente, sarà la grande esclusa di Moretti (l‟Italia) a produrre simili
esempi.
Consideriamo ora il carattere di fluidità dei generi letterari, nella convinzione che tra di loro
esistano continui processi di osmosi, e che il romanzo di formazione non sia sorto
all‟improvviso, come un big bang letterario, ma che sia il frutto di lunghi compromessi
simbolici e traslazione di motivi. Pertanto riteniamo che, assumendo Wilhelm Meister come
matrice del romanzo di formazione, la critica abbia interrotto in modo artificioso questo flusso
della narrativa europea.
La formazione
Perché l‟eroe del romanzo di formazione è un giovane? E che cosa si intende con
“formazione”?
Il processo di rivalutazione di infanzia e adolescenza che si verifica tra „700 e „800 è parallelo
all‟ascesa sociale della borghesia, che diverrà destinataria e protagonista del romanzo di
formazione. La giovinezza per il suo carattere di mobilità assurge a simbolo della modernità e
della borghesia divenendo “l‟età che racchiude in sé il senso della vita”6.
Mentre nelle società stabili il giovane reca il segno di mancanza e incompletezza (in quanto
“non adulto”), con gli stravolgimenti sociali e la conseguente riorganizzazione degli status
viene meno l‟ereditarietà dei ruoli sociali, così che ogni giovane può tentare di realizzarsi
pienamente inseguendo i suoi sogni.
I giovani proletari non dispongono di quel periodo di latenza che consente un personale e
autonomo sviluppo della propria personalità; mentre i giovani aristocratici ereditando uno
status fisso non sviluppano quel senso di precarietà e irrequietezza che li spinge a muoversi
6 F. MORETTI , Il romanzo di formazione , cit., p. 4
12
nella realtà sociale. Ma (ci ricorda Moretti) dal momento in cui la borghesia si afferma
storicamente perde la sua identità propulsiva e dinamica, ed il romanzo di formazione inizia il
suo declino.
Julien Sorel, Lucien Chardon, Frèdèric Moreau hanno tutti un‟età che si aggira fra i vent‟anni;
bisogna però rilevare che in molte opere novecentesche l‟età tende dei protagonisti tende a
diminuire, fino alla pubertà.
In ogni caso la gioventù dovrà rapportarsi con la maturità del mondo degli adulti, e sarà
proprio questo confronto a determinare l‟impianto ideologico dell‟opera.
Servendosi delle teorizzazioni di J. M. Lotman Moretti riprende il “principio di
classificazione” e il “principio di trasformazione” per descrivere due diversi tipi di
formazione possibili.
Se prevale il primo principio la giovinezza sarà considerata come una fase destinata a finire,
determinando una crescita positiva dell‟individuo, mentre nel secondo caso la gioventù non
saprà o vorrà tradursi in maturità, cercando velleitariamente di prolungare la sua condizione il
più possibile. Il primo caso si riscontra nel bildungsroman classico e nel romanzo inglese, nei
quali vige una retorica teleologica che impone all‟eroe la rinuncia ad ogni intervento
interpretativo della realtà circostante. Questa tipologia di romanzi rappresenta il più felice
tentativo di compromesso ad un grande dilemma della società moderna : quello tra
autodeterminazione dell‟individuo e socializzazione. Con la rivoluzione francese e
l‟esperienza napoleonica l‟Europa piomba nella modernità, con tutto il suo carico di
stravolgimenti ideologici; con l‟esperienza di Wilhelm Meister la modernità viene appunto
ingabbiata ed esorcizzata. Ma se ciò è possibile, per Goethe, lo è solo grazie alla contingenza
storico-sociale in cui scrive.
Il primo principio è riconducibile direttamente al Wilhelm Meister e a tutti i romanzi che
presentano un “happy ending” o un finale matrimoniale (ad esempio Orgoglio e pregiudizio ,
Tom Jones , David Copperfield , ecc…) .
13
Se invece prevale il principio di trasformazione il giovane guarderà il mondo come un sistema
conflittuale e tra i due si instaurerà una forte alterità; a questa seconda categoria corrisponde
la maggior parte dei romanzi di formazione più recenti.
Ci ricorda Moretti che il romanzo di formazione è sempre stato ambiguo circa la definizione
di “maturità”; ma allora la formazione è solo un utopia? E il romanzo di formazione una pura
astrazione?
Sarebbe forse meno difficile rispondere se riformulassimo il modello teorico rendendolo più
elastico e tollerante. Bisogna poi abbandonare la forma ormai sclerotizzata e anacronistica del
bildungsroman classico, poiché anche questa presenta un alto tasso di problematicità. Si
consideri il finale de “Gli anni di noviziato di Wilhelm Meister”: nonostante il finale chiuso,
nel segno di una ricomposizione antitragica della vicenda, restano dei forti elementi
problematici; ci fa notare infatti Moretti che
“la benevolenza coercitiva della Società della Torre gli impone la sua felicità:
una funzione sociale, una residenza, una moglie”7.
Tutto ciò al piccolo prezzo della propria libertà e personalità.
Si può notare dunque come sia difficile reperire un modello assoluto di formazione, e come
non esista una formazione ideale.
I due principi lotmaniani però non determinano necessariamente il successo o il fallimento di
una formazione dato che possono essere compresenti ; ciò che davvero ci interessa è che le
varie esperienze di vita producano nel giovane uno scarto tra la sua condizione iniziale e
quella finale.
7 F. MORETTI , Il romanzo di formazione , cit., pp. 198-99
14
È altrettanto vero che di fallimento si può parlare laddove la gioventù aspira solo a
conservarsi in quanto tale poiché, se rimane imbrigliata in una cronica sindrome di Peter Pan,
è difficile che si realizzi uno scarto formativo.
Prendiamo ora il caso de Il rosso e il nero : “unhappy ending” e “open ending” non escludono
necessariamente una formazione; infatti l‟ipotesi del narratore su un futuro di crescita positiva
per Julien è sicuramente significativa per l‟economia del racconto :
“era ancor molto giovane; ma, secondo me, sarebbe stato una bella pianta. Invece
di procedere dalla sensibilità alla furberia, come la maggior parte degli uomini,
l‟età gli avrebbe dato una bontà facile alla commozione e lo avrebbe guarito da
una folle diffidenza…”8.
In queste parole è contenuto il successo della formazione, anche se questa è collocata in un
futuro solo vagheggiato.
Moretti ci offre un ulteriore spunto di riflessione quando ci avverte che la lunghezza del
romanzo di formazione si riduce progressivamente dando vita, nel „900, a numerose “short
stories”, al confine col racconto. Ne consegue (ed è questo il punto importante) che sono
sempre più rari i casi in cui una formazione si possa compiere entro i limiti del racconto.
Bisogna poi considerare non solo il rapporto tra adolescenza e maturità, ma soprattutto quello
fra soggettivismo e oggettività, interiorità e mondo esterno. Infatti se il soggetto rimane
isolato nel suo mondo ideale non potrà formarsi poiché è necessario esperire la realtà,
cercando un contatto con essa; sarà la realtà ad accogliere le speranze dell‟eroe o a decretarne
il crollo definitivo. Possibilità ben riassunte dai titoli di due diversi romanzi di formazione :
Grandi speranze (1860) di Dickens e Le illusioni perdute (1839) di Balzac.
Spetterà a Stendhal e Puskin riformulare un
8 STENDHAL , Il rosso e il nero, Roma, Newton, 2006, cit., p. 287
15
“paradigma essenziale per l‟esistenza moderna: la maturità non consiste più
nell‟acquisire delle qualità: consiste , sostanzialmente , nel perderle”9.
E a giovarne sarà il freudiano “principio di realtà”, che comporta un‟adesione più serena e
pragmatica al mondo che ci circonda e alle possibilità che offre.
Nel caso in cui il giovane eroe non riesca ad elaborare la disillusione allora è alquanto
improbabile che si realizzi una formazione.
L’iniziazione
Abbiamo detto che è l‟esperienza di vita a determinare il passaggio dall‟incoscienza
giovanile alla consapevolezza adulta, poiché essa è la chiave di volta del processo formativo.
Al concetto di formazione possiamo accostare quello di iniziazione : la dinamica iniziatica
infatti non presenta limiti storici e geografici poiché risponde (come il processo di
formazione) a esigenze profonde e istanze psichiche di carattere universale.
Inoltre, mentre non esiste un chiaro momento della vita in cui il ragazzo può affermare <<ora
sono un uomo>>, l‟iniziazione è forse l‟unica vera prova in grado di determinare un forte
scarto e segnare una svolta nel processo di crescita.
Il processo di crescita del giovane eroe prevede, nel romanzo di formazione, il confronto con
delle “prove”; ma oltre queste prove quotidiane che vengo man mano incorporate ve ne sono
altre straordinarie, enfatizzate dalla loro forte valenza simbolica. È possibile rinvenire casi del
genere proprio in molte opere moraviane, anche se forse l‟esempio più fulgido è offerto dal
romanzo Le avventure di Pinocchio (1883) di Carlo Collodi.
È lo stesso Moravia a sottolineare l‟importanza del carattere iniziatico di alcune sue opere:
9 F. MORETTI , Il romanzo di formazione , cit., p.100
16
“Il giovane coniuga il massimo di vitalità passionale con il massimo di ideali. Poi
c‟è stata una specie di rivoluzione a partire dall‟Ottocento, per cui il narratore ha
attribuito una particolare importanza a quella che chiamerei l‟iniziazione
dell‟adolescenza e l‟età dei protagonisti si è abbassata. In questo senso i miei
quattro romanzi dell‟adolescenza sono quattro romanzi di iniziazione.”10
.
Tre cronotopi della formazione
Facendo un breve riferimento agli studi di M. Bachtin passiamo in rassegna i “cronotopi”11
privilegiati dal romanzo di formazione : la soglia, la strada e il salotto.
Il primo è strettamente legato al (necessario) distacco del protagonista dalla dimensione
famigliare, infatti la “soglia di casa” è spesso assurta a linea di demarcazione tra le sicurezze
infantili e le incertezze giovanili, tra innocenza puerile e maturità sessuale o sociale.
La strada, luogo per eccellenza di incontri casuali e esperienze di socializzazione, è il secondo
dei cronotopi che è possibile riscontrare nei romanzi di formazione (si pensi, ad esempio, a
L’asino d’oro di Apuleio o al più prossimo Le avventure di pinocchio).
Il terzo è quello più storicamente connotato : il salotto; esso rappresenta la vetrina in cui
l‟eroe può esporsi per ricevere consenso o meno dalla realtà pubblica e sociale. Il salotto è il
luogo in cui sì riversa la vasta gamma delle gerarchie sociali, ed è anche il luogo della
demistificazione dei falsi costumi e delle ipocrisie di classe.
L’io e il mondo
Abbiamo visto come il confronto tra l‟individuo e la realtà sociale possa essere costruttivo o
distruttivo, all‟insegna del dissidio o della conciliazione.
10
A. MORAVIA – A. ELKANN , Vita di Moravia , cit., p. 277 11
Il cronotopo è secondo Bachtin una forma di interconnessione artistica attraverso la quale la letteratura si
impadronisce dei peculiari aspetti di un tempo e di uno spazio , storico o fantastico.
17
Ma non è detto che io e mondo debbano necessariamente convergere, può anche darsi una
formazione che non consista tanto nella riconciliazione con la realtà, quanto in un nuovo e
diverso rapporto con essa. La formazione è un concetto relativo, si può manifestare in diversi
modi e,come avremo modo di vedere, può delinearsi oltre i confini del testo.
Formazione all’italiana
Nonostante Moretti escluda l‟Italia dal suo studio sul romanzo di formazione, noi riteniamo
che questo sia una presenza costante all‟interno del panorama italiano, anche se si presenta
con forme inedite e variegate rispetto alle teorizzazioni canoniche.
Da Vita Nuova di Dante è possibile incontrare opere che analizzano la strutturazione
dell‟individuo nell‟arco di tutta la tradizione letteraria italiana. Alcuni esempi: Le ultime
lettere di Jacopo Ortis, nonostante prevalga la spinta lirico–oratoria può ascriversi al genere
del romanzo di formazione (o “di disillusione”). Anche I promessi sposi può essere
considerato un romanzo di doppia formazione poiché le vicende di Renzo e Lucia si
configurano come un‟esplorazione della realtà storico-sociale, e innescheranno due diversi
processi di crescita : Renzo abbandonerà ogni velleità d‟azione mentre Lucia perderà la sua
visione idilliaca della vita. Entrambi perderanno la loro ingenua fiducia provvidenziale e
acquisteranno una nuova maturità. Basterà poi ricordare le avventure di Pinocchio (romanzo
di formazione allegorico-esemplare) e, per il „900, L‟isola di Arturo di Elsa Morante.
Il romanzo di formazione è nato perché l‟uomo ha bisogno di una forma simbolica che colmi
le distanze tra i suoi valori ed il funzionamento effettivo della realtà, e perché per il singolo
individuo partecipazione e integrazione sono delle esigenze vitali.
Di norma nella società borghese etica morale e prassi non coincidono; il bildungsroman tenta
appunto di ridurre questa discrepanza e legittimare l‟ideologia borghese, divenendo la forma
simbolica più complessa (e problematica) mai elaborata, affinché il borghese sia educato e
18
“convinto dell‟assurdità dei suoi valori culturali. E a lui che va dimostrato quanto
sia vantaggiosa la conciliazione sociale. È a lui che viene offerto il senso –
l‟appartenenza felice a una totalità armonica - in cambio della libertà”12
.
Come si può notare il romanzo di formazione è sempre stato permeabile ai grandi mutamenti
storici, e ognuno di questi ne ha modificato la struttura.
Nel „900 si accentua il lato più coercitivo e oggettivo della socializzazione, dimenticando il
versante soggettivo dell‟individuo, anzi irretendolo con organismi e forze sovrapersonali. In
una società irreggimentata le ingerenze delle istituzioni in ogni sfera dell‟essere possono
portare l‟individuo ad una reazione di rigetto e avversione, cosi che non si sentirà mai a casa
nel mondo.
Ma la gioventù resta ancora uno dei più validi concentrati simbolici di incertezze, istanze e
tensioni del sistema culturale; e ci sembra possibile che anche all‟interno delle recenti
tendenze del romanzo di formazione ci sia spazio per una maturità,
seppur dolorosamente conquistata.
Capitolo 2
Gli indifferenti
“Non vi fu mai molta speranza. Solo quella di uno sciocco”13
.
Chiunque intraprenda uno studio della narrativa moraviana deve inevitabilmente confrontarsi
con la sua opera prima.
12
F. MORETTI , Il romanzo di formazione , cit., p.73 13
J. R. R. TOLKIEN , Il signore degli anelli , Milano, Bompiani, 2000, cit., p. 978
19
Sappiamo che Moretti fissa l‟inizio del processo di decadenza del romanzo di formazione con
l‟opera di Stendhal, Flaubert e Balzac, e la conclusione con il colpo di grazia della grande
guerra, evento collettivo e totalizzante che priva l‟individuo di ogni speranza di crescita
attraverso l‟esperienza: il risultato di questo evento epocale sarà una gioventù inetta,
traumatizzata e immobile. Non è un caso allora se i due protagonisti de Gli indifferenti,
Michele e Carla, racchiudono delle vicende esemplari di afasia e deriva esistenziale.
Gli indifferenti è infatti un romanzo esistenzialista14
, oltre che psicologico. Moravia vi svolge
la sua riflessione sulla solitudine dell‟io di fronte al mondo, e sul presentimento di inutilità,
precarietà, finitudine e assurdità dell‟uomo. Questo nuovo e problematico confronto con se
stessi si riversa drasticamente sul rapporto tra uomo e realtà. Ci troviamo dunque di fronte ad
un “tardo romanzo di formazione”; ma il titolo saggistico, che indica subito il problema
trattato, ci introduce alla tematica dell‟indifferenza, non dell‟adolescenza .
La sostituzione del rapporto dell‟uomo con se stesso a quello tra io e mondo determina un
cambiamento nelle dinamiche formative del romanzo, ma non implica la rottura con la
tradizione narrativa precedente, a cui invece Moravia si dimostra particolarmente legato.
Infatti leggendo quel vasto calderone biografico che è Vita di Moravia ci si imbatte
continuamente nei nomi di quei russi, inglesi e francesi che hanno significativamente
contribuito allo sviluppo del romanzo di formazione.15
Un nuovo tipo di formazione nascerà dalle ceneri di questa prima opera: le crisi e gli stalli, nel
primo romanzo irrisolti, diverranno in seguito crisi propulsive e quindi di crescita.
L‟opera, inizialmente concepita come una tragedia in forma narrativa, presenta pochi
personaggi: Mariagrazia, la madre vedova, cerca disperatamente di mantenere legata a se il
più giovane amante Leo. Leo invece aspira semplicemente ad impadronirsi della casa di
14
“Ero uno dei precursori dell‟esistenzialismo europeo. Ora, il romanzo esistenzialistico viene da Dostoevskij,
che era stato infatti il mio maestro.” (A. MORAVIA – A. ELKANN , Vita di Moravia , Milano, Bompiani, 2007
cit., p. 126) 15
“Il curioso era che, sebbene conoscessi e amassi gli americani, ero soprattutto influenzato dai russi e dai
francesi.” (Ibid., p. 126)
20
famiglia grazie ad un‟ipoteca, e nel frattempo tenta di insidiare la giovane figlia Carla.
Michele, il vero protagonista, è descritto come un personaggio amletico, insicuro, incapace di
agire, suoi sono i lunghi monologhi su ciò che dovrebbe fare, ma che inevitabilmente non si
realizza, per noia e mancanza di carattere. Alla male assortita compagnia si aggiunge Lisa,
amica della madre, la quale cerca invano di sedurre il giovane Michele.
Fra questi personaggi si consuma una squallida vicenda: tre giorni spesi nell'inerzia di piovose
giornate, di cene e pranzi, tra dialoghi vacui e subdole macchinazioni. In questa versione
decadente della vita, la giovinezza rappresenta forse il peso maggiore: questi giovani
posseggono l‟energia , l'età , la vita , ma non sanno cosa farsene e si lasciano trasportare dagli
eventi , incapaci di reagire.
La situazione più esasperata è quella di Michele, poiché egli partecipa all‟insensibilità
generale ma conserva un grado di consapevolezza che gli permette di contemplare la sua
miseria. Possiamo leggere i suoi soliloqui come strumenti di diagnosi della marcescente
società borghese negli anni venti, mentre la loro stessa frequenza indica la situazione di
solitudine di Michele, il quale si perde tutto nella prospettiva della fantasticheria, del
sezionamento della realtà, senza riuscire a stabilire un contatto con essa.
L‟indifferenza che pervade i cinque personaggi è dunque una sorta di alienazione esistenziale,
di immobile fissità; condizione da cui non può scaturire una formazione.
Michele e Carla
L‟età dei due è superiore ai circa vent‟anni dell‟eroe in formazione dell‟800. Entrambi non
sono soggetti innocenti in quanto la loro età anagrafica li ha già portati a contatto con diverse
realtà (l‟inizio in medias res ci permette di considerare un precedente sviluppo biografico dei
personaggi), ed entrambi appaiono già consapevoli della corruzione che li circonda e permea.
Il senso di tragico fatalismo che si respira in tutta l‟opera puntualmente si realizzerà. Con il
mondo borghese (e allusivamente fascista) Michele vive un rapporto conflittuale perché anche
21
se indifferente a tutto non è indifferente alla propria indifferenza, inoltre egli soffre perché
non riesce ad agire. Il motivo dell‟azione si configura come dominante ne Gli indifferenti: un
motivo essenziale del romanzo di formazione è, come abbiamo visto, il dinamismo, il
movimento che si concretizza in azione e esperienza; mentre l‟intellettualismo estremo di
Michele corrode la volontà e mina ogni principio di azione. All‟eroe contemplativo è negata
dunque ogni esperienza.
Michele appare scisso, diviso tra ciò che è e ciò che sente di dover essere, e per lui l‟azione si
configura essenzialmente come rivolta contro Leo. Leo: sicuro dei propri mezzi,disposto a
comprare ogni sentimento; arrivista e insincero; esperto alla vita e subdolo affabulatore; un
perfetto filisteo. Ma qual è la sua funzione? Leo è chiaramente la nemesi di
Michele,sublimazione di quell‟ipocrisia che Moravia vuole denunciare. Ma egli rappresenta
per Michele anche quell‟integrazione tanto agognata alla vita; egli anzi ne approfitta, vuole
spremerla, senza tormentarsi e illudersi. Leo è il grande burattinaio, emblema del parvenù.
Idolo odiato di Michele poiché rappresenta la perfetta sintesi tra aspirazioni e risultati.
L‟antagonista è un ruolo cardine nel sistema dei personaggi del romanzo di formazione
tradizionale, come Werner in Wilhelm Meister, o il classico “villain” nei romanzi inglesi
dell‟800.
Michele al contrario è debole, accidioso, disadattato, per effetto collaterale della sua
sensibilità; non è fatto per questo mondo perché è tormentato da una tragica solitudine, da
un‟incomunicabilità insormontabile.
Un‟ altra caratteristica dei giovani eroi moraviani è la loro natura sognante; essi covano
nell‟animo la nostalgia e la speranza di un paradiso sconosciuto, un‟isola felice. Se Michele
vagheggia un mondo sentimenti puri e sinceri, Agostino (nell‟omonimo romanzo) si mostra
altrettanto ingenuo nel desiderio di abbandonare quel suo mondo ormai incrinato e macchiato.
Attraverso questi sogni essi esprimono la loro incapacità di adattamento alla vita reale.
22
Le intenzioni di Michele falliscono sistematicamente; le prove (di sincerità e di contatto con
la vita) a cui si sottopone falliscono e producono niente meno che una regressione.
Per Moravia l‟esperienza sessuale, oltre a determinare il passaggio dalla pubertà alla virilità,
rappresenta il principale mezzo di conoscenza del mondo e di partecipazione alla vita. A
colpire Moravia è il fatto che sia un atto non relativizzabile, ma assoluto: il sesso rappresenta
un approdo sicuro, e allo stesso tempo un punto di (ri)partenza; è l unico vero appiglio alla
realtà .
Ma Michele è stato già iniziato all‟eros e l‟esperienza con l‟appassita e inautentica Lisa si
offrirà a lui come una semplice e disperata occasione per risvegliare una pulsione ormai
quiescente. Lisa è vista come una delle tante prove di assenso alla vita che, se superata,
permetterebbe all‟eroe una crescita positiva; ma egli fallirà anche in questa prova e l‟amore
non potrà rappresentare per lui un‟ancora di salvezza : “Lisa, era falsa, mascherava con dei
sentimentalismi intollerabili delle voglie troppo semplici ed era impossibile amarla”16
.
“Credi tu forse che si debba andare con una donna soltanto quando la si
ama?[…]…se a tutto questo aggiungi che Lisa non ti costerà un soldo, dico un
soldo…ecco io non so cosa si possa desiderare di più…”17
.
Con queste ed altre parole Leo inizia il ragazzo ad una visione prosaica e pragmatica
dell‟amore, e Moravia ci introduce ai temi di sesso e denaro, il duplice perno della sua
poetica.
Sebbene ai fini della formazione non è necessario che le prove siano superate, è necessario
che vengano affrontate; per Michele queste restano invece solo su un piano ideale, incapaci di
generare una qualche crescita.
16
A. MORAVIA , Gli indifferenti , Milano , Bompiani , 2007, p. 17
A. MORAVIA , Gli indifferenti , Milano , Bompiani , 2007, pp. 95-96
23
“Come doveva essere bello il mondo […] quando non si pensava tanto, e il primo
impulso era sempre quello buono; quando la vita non era come ora ridicola, ma
tragica, e si moriva veramente, e si uccideva, e si odiava, e si amava sul serio, e si
versavano vere lacrime per vere sciagure, e tutti gli uomini erano fatti di carne ed
ossa e attaccati alla realtà come alberi alla terra. ”18
.
L‟immagine isotopica dell‟albero attaccato alla terra (che ritroveremo ne La disubbidienza)
esprime il suo bisogno di partecipazione e contatto con il mondo, ma allo stesso tempo è un
addio ad un intero universo, ideale e sincero.
Ma a congedare questo mondo è il solo Michele, non Moravia. All‟inerte Michele
succederanno dei giovani in grado di agire, e per i quali la realtà non sarà un‟utopia ma
un‟entità concreta con cui confrontarsi per riuscire a crescere (seppure dolorosamente).
Persino Agostino e Luca, che possono esser considerati idealmente come dei “fratelli minori”
di Michele, agiranno nella realtà e soffriranno per essa. Provano, forse falliscono, ma il valore
di positività è dato proprio da questo tentativo; questi ultimi due personaggi rappresentano il
lato nobile di questa grigia medaglia borghese.
Carattere negativo avrà invece l‟iniziazione di Carla, poiché decreterà il segno di una
definitiva morte interiore, e non una nuova e rigenerata forma di esistenza.
L‟atto amoroso rende manifesto in lei un‟impurità, una fase di corruzione già in atto, di cui
ella stessa si stupisce. Però è l‟unica dei due protagonisti che sembra intraprendere un
percorso di formazione, il quale le permetterà l‟accesso al mondo degli adulti.
In realtà, più che un processo di crescita, la storia di Carla sembra una vera e propria
catabasi, una discesa agli inferi senza alcuna speranza.
Moravia elegge a quinta della sua vicenda l‟interno borghese: la villa Ardengo è il luogo del
tempo immutabile e improduttivo, degli atti vuoti e reiterati all‟infinito. I personaggi si
18
Ibid., p.191
24
allontanano raramente da questo centro e non subiranno una trasformazione a causa dei
rapporti spaziali, come invece accade nelle dinamiche del romanzo di formazione
tradizionale. Il vero esterno, oltre la soglia del mondo indifferente, è lo spazio utopico di
Michele; l‟unico modo per approdarvi è l‟interiorità.
Se la storia di Carla presenta un difficile e doloroso adattamento, quella di Michele è la storia
di un adattamento mancato; e se consideriamo l‟assenza del benché minimo scarto di
condizione nel personaggio allora non si può proprio parlare di formazione. La
consapevolezza del proprio fallimento non sembra poter generare una formazione.
Abbiamo detto che mentre Michele è incapace di agire Carla decide volontariamente di
accettare la vita rinunciando a giudicarla .
A ben guardare però Carla non sceglie nulla, è travolta dalla vita, ed è costretta ad accettare
come fantomatica salvezza il matrimonio riparatore con Leo. Dunque le prove a cui si
sottoporrà si riveleranno semplici prove di conferma anziché di verifica; il suo destino si
compirà non nel segno della conciliazione ma nel segno di un ingrato sacrificio. E la rovina
finale giungerà, paradossalmente, dal matrimonio, con cui potrà continuare a perpetuare i falsi
e ridicoli schemi materni.
Si potrebbe obiettare che le loro siano semplici crisi giovanili che bisogna pur attraversare,
poiché passeggere, innocue e salutari.
Ma nel testo non sono poste le basi per un futuro sviluppo dei personaggi oltre la fine del
discorso; Moravia non lascia alcun indizio su una possibile crescita di Michele.
Dal romanzo dei vinti e dal romanzo di formazione mancato si passerà poi (con Agostino e La
disubbidienza) ai romanzi della riconciliazione; una riconciliazione che è prima di tutto dello
scrittore con la realtà, grazie anche alla funzione catartica di quest‟opera prima.
Certo, Gli indifferenti sembra convalidare la sentenza di morte del romanzo di formazione,
ma Moravia saprà offrirci anche alcuni esempi di speranza nell‟adolescenza e nel suo
25
sviluppo, rinvigorendo la convinzione che il romanzo di formazione non si sia estinto del tutto
ma che continui ad aggirarsi nel panorama italiano sotto mentite spoglie.
Capitolo 3
Agostino
“andai a Viareggio in vacanza. Avevo nove anni . A Viareggio successero molte cose : venni a sapere
cos‟era il sesso e anche che cos‟era la classe. Insomma più o meno l‟esperienza di fondo che ho
raccontato in Agostino”19
.
Agostino subisce un lungo e tortuoso processo di sviluppo, in uno spazio limitato ma
altamente simbolico.
Del romanzo di formazione Agostino reca un chiaro segno distintivo: il titolo onomastico.
La brevità del testo condiziona però il dispiegarsi e il concludersi di un chiaro processo
formativo, il che porta a ritenere che Moravia si sia voluto soffermare solo su una singola
fase. Bisogna poi considerare che tendenzialmente i romanzi brevi possiedono più dei
romanzi lunghi un finale trasformazionale e che dunque la formazione può passare dalla
“storia” al “discorso” imponendo uno sforzo interpretativo supplementare.
Un ragazzino di buona famiglia e la madre (vedova ma ancora giovane e bella) si recano in
villeggiatura in Versilia nel mese di agosto.
“È la storia di una vacanza infantile, ma è anche la storia dell‟incontro di
Agostino con la cultura moderna, che presuppone l‟opera di due grandi
19
A. MORAVIA – A. ELKANN , Vita di Moravia , cit., p. 12
26
smascheratori, Marx e Freud. Si intende che io avevo voluto solo raccontare una
favola, ma si deve anche intendere che ogni favola, spinta fino all‟ultima
conseguenza, non può non rivelare un proprio segreto rapporto con la cultura
dell‟epoca.”20
L‟inaspettato avvenimento generatore d‟intreccio sarà l‟intrusione dell‟amante della
madre all‟interno dell‟armonia figliare. A complicare successivamente la condizione
psicologica di Agostino sarà l‟incontro con un gruppo di coetanei che lo inizieranno alle realtà
del sesso e del denaro. Il tema della rivelazione sessuale non è un fatto inedito nella narrativa
moraviana, anzi la tematica occupa una posizione centrale nel panorama del romanzo europeo
del „900.
Sappiamo inoltre che tramite il sesso lo scrittore romano allude sempre ad una dimensione più
ampia, esistenziale; infatti per Agostino tale rivelazione sarà strettamente legata alla
rivelazione del male, della lotta per la vita, e infine della sua condizione di borghese.
Moravia ci introduce così ai suoi due grandi poli culturali, freudismo e marxismo, che sono
anche i principali fulcri ermeneutici della sua opera.
Più che di un‟iniziazione sessuale (mancata) si tratta dunque di un‟iniziazione alla vita.
Inoltre il rapporto con la realtà famigliare, appena abbozzato nel primo romanzo , qui
verrà rappresentato con gran lucidità, e affronterà il rapporto biunivoco madre-figlio.
Moravia ci presenta ancora una volta un personaggio orfano di padre, ma se per
Michele de Gli indifferenti la condizione di orfano può alludere ad una gioventù
mutilata e senza riferimenti, per Agostino l‟assenza del padre sembra un semplice
espediente narrativo per analizzare le tensioni edipiche del ragazzo.
Celebre è l‟incipit del racconto, con cui è presentata la condizione di serenità, di
armonia e di fusione panica di entrambi con la natura.
20
Ibid., p. 153
27
Il “mare calmo e diafano”21
, in cui nuotano i due, da semplice elemento paesaggistico
si fa correlativo oggettivo della loro idilliaca condizione iniziale.
Inoltre il fatto che Moravia stesso giudichi la sua opera una “favola” ci permette di
porre in rilievo gli elementi simbolico-fiabeschi del romanzo. Si prenda in
considerazione il mare in cui madre e figlio nuotano: l‟acqua possiede un‟intrinseca
forza simbolica che evoca l‟immagine dell‟utero, della culla materna; in quel luogo
primordiale che è il mare è come se Agostino non si fosse ancora staccato dal grembo
materno. Non a caso il corpo della madre è per il fanciullo addirittura oggetto di culto
da rispettare con timore reverenziale.
La dimensione di felice vanità figliare è incrinata da un evento inaspettato: “tutto ad un
tratto l‟ombra di una persona ritta parò il sole davanti a lui”22
.
La situazione di tranquilla routine del ragazzo viene profanata e l‟arrivo dello
sconosciuto si arricchisce della valenza nefasta attribuita spesso all‟oscurarsi del sole.
Privato del suo trono immaginario Agostino resta tramortito e si ritrova a “ruzzolare
giù da un‟illusione come da una montagna, restando tutto ammaccato e dolente”23
.
Inizia da questo momento il processo di demistificazione genitoriale attraverso gli
occhi del figlio, tramite cui Moravia rielabora la tradizionale dinamica formativa di
illusione-disillusione. La presenza dell‟amante genera in Agostino una sorta di gelosia
edipica oltre che la progressiva cognizione della femminilità della madre.
L‟iniziale idillio simbiotico, già incrinato, si infrangerà definitivamente con lo schiaffo
che la donna darà al figlio. Agostino, fuggito via dopo il colpo ricevuto, si nasconde ad
analizzare questa nuova scoperta del male, in una sorta di masochismo cognitivo:
21
A. MORAVIA , Agostino , Milano , Bompiani , 2011 , cit., p. 5 22
Ibid., p. 8 23
Ibid., p. 11
28
“come chi abbia trovato un tesoro e corra a nascondersi per guardarlo a suo agio ,
con lo stesso senso pungente di scoperta egli correva a rintanarsi con il suo
schiaffo , cosa tanto nuova per lui da parergli incredibile”24
.
La vera svolta narrativa del racconto si ha dunque quando Agostino perviene alla percezione
erotica della madre, cioè alla coscienza della madre come donna. Questo brusco processo di
demitizzazione materna scaturisce dal fatale incontro con la sfrenata banda di ragazzi del
luogo, che non esiteranno a porgli domande sconcertanti; le rivelazioni saranno insostenibili
per il protagonista che, in quanto adolescente, non ha ancora i mezzi psicologici per
metabolizzare la realtà e impadronirsene. Allo sconcerto però si aggiunge un‟esasperata
curiosità, che non ha nulla di perverso ma è sintomo della grande urgenza conoscitiva del
ragazzo.
“Egli avvertiva che l‟affetto di un tempo, stava cambiandosi in un sentimento
tutto diverso, insieme obiettivo e crudele; e gli pareva che quelle ironie pesanti,
per il solo fatto di affrettare questo cambiamento , andassero ricercate e coltivate.
Perché poi desiderasse tanto non amare più sua madre […] non avrebbe saputo
dirlo. Forse per il risentimento di essere stato tratto in inganno e di averla creduta
così diversa da quella che era nella realtà; […] D‟istinto cercava di liberarsi una
volta per sempre dall‟impaccio e dalla vergogna del vecchio affetto ignaro e
tradito”25
.
Alla fine deciderà di frapporre tra sé ed il fantasma materno l‟immagine di una prostituta, ma
il tentativo di ingresso in una casa di tolleranza si risolverà in un fallimento.
24
Ibid., pp.19-20 25
Ibid., p. 58
29
Come si può vedere una formazione in questo groviglio di sentimenti e sensazioni? E a “che
serviva vederci chiaro se questa chiarezza non portava che nuove e più fitte tenebre?”26
.
È importante proprio la consapevolezza del drammatico stallo a cui è giunto, poiché può
rappresentare l‟inizio di una nuova fase di crescita: “tu mi tratti sempre come un bambino”27
protesta Agostino contro la madre nel finale del romanzo. Egli non si sente più un bambino e
pretende il riconoscimento di un mutamento avvenuto, o per lo meno innescato.
Agostino inoltre interiorizza l‟incontro con l‟altro, non resta inerme, non fugge dalle prove
che gli si presentano; è egli stesso a cercare il contatto col mondo. Egli è all‟inizio del tutto
ignaro del bene e del male, rinchiuso com‟è nel suo microcosmo materno. La sua mente è
come una tabula rasa su cui si incideranno le esperienze della vita, ma queste causeranno in
lui una profonda ripugnanza; infatti rimpiangerà quel momento di innocenza primigenia,
benché proprio nella perdita della condizione originaria consiste la sua formazione: Agostino
resterà in una sorta di limbo fino alla fine del racconto, in una fase ben descritta da Goethe:
“l‟adolescenza , credo , è meno amabile dell‟infanzia perché rappresenta uno
stadio intermedio , incompleto. L‟infanzia è ancora attaccata ai ragazzi e i ragazzi
all‟infanzia , tuttavia questi hanno perso , unitamente all‟ingenuità di un tempo ,
l‟affettuosa naturalezza; la loro mente li precede , vedono innanzi a sé il
giovanotto , l‟uomo , e poiché quella è la loro strada , l‟immaginazione corre
avanti , i desideri si spingono oltre , e i ragazzi imitano , rappresentano ciò che
non possono ne debbono essere”28
.
In Agostino tutti i dissidi interiori restano aperti ma già potenzialmente predisposti alla
conciliazione. Il rapporto con la madre lo pone in uno stato di dipendenza (o meglio, di
26
Ibid., p. 88 27
Ibid., p. 126 28
J. W. GOETHE , La missione teatrale di Wilhelm Meister , Milano , BUR , 2008 , cit., pp. 40-41
30
sudditanza) che deve essere superato per permettergli di ampliare i propri orizzonti
relazionali e sviluppare una propria identità.
La banda
La frequentazione della banda offre ad Agostino una serie di occasioni conoscitive da
cogliere avidamente.
Agostino fuggito dalla madre, dopo lo schiaffo, incontra casualmente Berto, figlio di un
bagnino o di un marinaio, che lo introduce nella banda del Bagno Vespucci: un gruppo di
popolani che si radunano in una baracca al cospetto di un misterioso adulto. La banda si
configura come una comunità alternativa, cloaca di tutti i reietti di quel mondo balneare; qui
vigono la violenza irrazionale, i bassi istinti, la legge del più forte.
Questi ragazzi appaiono a Agostino degli esseri repellenti e bestiali; rappresentano,
sostanzialmente, l‟irrequieta e virile pubertà, in contrapposizione alla pacata e silente
infanzia di Agostino. Nonostante ciò Agostino è alla ricerca di modelli e la banda diverrà il
punto di riferimento a cui conformarsi, perché lo scontro con la realtà non genera in lui solo
repulsione ma anche un opposto bisogno di integrazione. L‟integrazione però non giunge a
compimento ed Agostino si sente escluso dall‟amore materno, estromesso dal sapere adulto
(esclusione a cui reagisce con una sorta di voyeurismo conoscitivo) e diverso dalla banda di
“diversi”; diverso soprattutto per la sua profonda sensibilità, ma anche per la differenza
sociale. Agostino però non penetra fino in fondo il senso di ciò che gli accade, ne ricava solo
delle vaghe intuizioni:
31
“In realtà non aveva tanto compreso quanto assorbito la nozione come si assorbe
un farmaco o un veleno e l‟effetto lì per lì non si fa sentire ma si sa che il dolore o
il benessere non potrà fare a meno di verificarsi più tardi”29
.
Il termine “banda”, che ricorre più volte nel libro, come quello di “branco” rimanda alle
forme di aggregazione degli animali suggerendo l‟idea di violenza e primitività, ed è un
motivo codificato e ricorrente nella narrativa degli ultimi secoli (ce ne offre un perfetto
esempio Il signore delle mosche di William Golding).
In realtà il contatto con questo gruppo rivelerà ad Agostino la sua condizione di
borghese. È all‟interno di questo microcosmo che assisterà all‟agnizione delle classi
sociali e della dialettica di classe (tipica del romanzo di formazione); ma se il romanzo
di formazione ottocentesco prevedeva un percorso ascensionale fra borghesia e
aristocrazia Agostino intraprenderà una discesa sociale verso il proletariato. C‟è un
episodio altamente significativo nel quarto capitolo: Agostino si presenta sotto mentite
spoglie di popolano ad un padre e un figlio borghesi che volevano fare una gita in
barca. Nella veste di garzone avrà la possibilità di scrutare la miseria morale ed il vuoto
buonsenso della propria classe.
Il contatto con quella banda lo aveva reso insofferente alle vecchie amicizie:
“Ma come gli apparvero scoloriti i ragazzi bene educati che qui lo aspettavano,
come noiosi i loro svaghi regolati dagli ammonimenti dei genitori e dalla
sorveglianza delle governanti, come insipidi i loro discorsi sulla scuola, le
collezioni di francobolli […] e altre simili cose.”30
.
29
A. MORAVIA , Agostino , Milano , Bompiani , 2011 , cit., p. 40 30
Ibid., p. 93
32
Questo passo muove una chiara critica alla repressiva e artificiosa educazione borghese.
D‟altra parte, l‟integrazione con i giovani proletari non si compie poiché “troppa delicatezza
restava in lui”31
, ma il contatto con quella realtà non può che svolgere una funzione
pedagogica purchessia.
Non bisogna poi dimenticare che Moravia con questo romanzo breve analizza soltanto una
fase del processo di formazione. Agostino tornerà forse alla sua vecchia vita borghese (non ci
è dato saperlo) ma sicuramente conserverà la conoscenza di una realtà diversa, sicuramente
meno alienata di quella borghese; egli sente di non appartenere più a quel mondo,“e
comunque di essersi così incanaglito ormai da non poterci più vivere senza ipocrisia e
fastidio”32
.
I soldi
Il denaro è sempre stato funzionale alla rappresentazione dell‟uomo nella società borghese
moderna, soprattutto per il romanzo di formazione. Questo tema è presente anche nei
romanzi di Moravia, in cui il rapporto dell‟uomo col denaro si carica di problematiche
esistenziali (come vedremo bene ne La disubbidienza).
Il rapporto col denaro si fa critico per Agostino nel momento in cui si collega alla dimensione
dell‟essere e della sessualità; nel momento in cui avverte l‟oscuro nesso che fa si che la vita,
una volta mercificata, perda il suo valore di fine:
“Così , al primo invidioso disprezzo motivato dalla sua ricchezza, se ne era
aggiunto un altro fondato sulla sua supposta corruzione. E l‟uno pareva […]
giustificare l‟altro. L‟uno nascere dall‟altro.”33
.
31
Ibid., p. 98 32
Ibid., p. 97 33
Ibid., p. 91
33
Agostino inizia a pensare che non esista abbastanza denaro “per pagare una esperienza come
quella che a lui doveva concludere un periodo della vita e dischiuderne un altro.”34
.
Un episodio significativo è quello della rottura del salvadanaio a forma di porcellino, chiaro
simbolo dell‟infanzia e della concezione infantile dei soldi: scagliandolo a terra egli manda in
frantumi la sua infanzia, la sua ingenuità economica, e l‟avidità vorace e nervosa con cui si
appresta a contare i soldi non è altro che il segno di una nuova e disincantata coscienza del
denaro. A sue spese scoprirà poi che il denaro è legato ad un mondo di crudeltà e menzogne:
sarà infatti costretto a mentire alla madre per ottenere ulteriore denaro e sarà beffato a sua
volta da un compagno più grande. Sembra di trovarci davanti al classico caso della truffa ai
danni del giovane inesperto, un topos ben presente nella tradizione italiana, da Boccaccio a
Collodi, e proprio l‟analogia con quest‟ultimo esempio rafforzerebbe il carattere fiabesco di
Agostino. Non si dimentichi poi che è lo stesso Moravia ad avvertirci che ci troviamo di
fronte a una favola.
Lo spazio
La struttura spaziale della storia si presenta molto articolata. Il principale rapporto
spaziale che si instaura è quello tra Bagno Speranza e Bagno Vespucci, cioè fra la
spiaggia incontaminata degli agiati borghesi e quella rozza delle classi inferiori.
Il primo toponimo allude forse al mondo delle illusioni infantili ed è il luogo delle
sicurezze mentre il secondo evoca il mondo delle insicurezze, ma anche
dell‟esplorazione e delle scoperte.
Il viaggio tra questi due spazi mette il protagonista in contatto con realtà sconosciute,
configurandosi come un vero viaggio di formazione. Giunto nella sede della banda ciò
che più colpisce Agostino è “la sua piccolezza come una casa di fiaba”35
, ma essa reca
la contraddizione tra piacevolezza della casa e la minacciosità degli abitatori tipica del
34
Ibid., p. 106 35
Ibid., p. 35
34
mondo fiabesco (si pensi alle storie dei fratelli Grimm). È poi uno spostamento
tipicamente fiabesco quello dalla propria casa alla casetta nel bosco o nel reame
lontano. Ma questo viaggio gli causerà solo dolori e sarà costretto a rivolgere la mente
altrove, verso un mondo utopico
“dove sarebbe stato accolto come voleva il cuore, e dove gli sarebbe stato
possibile dimenticare tutto quanto aveva appreso, per poi riapprenderlo senza
vergogna ne offesa, nella maniera dolce e naturale che pur doveva esserci”36
.
Agostino sogna la sua “isola che non c‟è”, dove crescere non comporti tutta quella sofferenza
straziante. Questo vagheggiamento è strettamente legato, come abbiamo già detto, alla sua
condizione di alienazione ed esclusione.
Il postribolo
L‟espediente della casa di tolleranza potrebbe dipendere, oltre che dall‟incidenza biografica,
dall‟adesione ad un motivo letterario ben codificato.
Agostino viene condotto dal compagno Tortima davanti ad un villino; l‟alone di mistero che
avvolge la casa, apparentemente disabitata, allude alla sacralità dell‟iniziazione che in essa
dovrebbe compiersi, ma l‟episodio collasserà in tutta la sua drammaticità.
Agostino si era recato infatti lì nel tentativo di sovrapporre l‟immagine di un‟altra donna a
quello della madre, ma a causa della sua età gli sarà proibito entrare.
La soglia della casa di tolleranza, limite tra innocenza puerile e maturità sessuale, se varcata
forse tramuterebbe il ragazzino in giovane, eppure rimane bruscamente insuperata. La casa di
tolleranza era divenuta per Agostino un secondo spazio utopico, ma la porta sbattutagli in
faccia segnerà una nuova esclusione.
36
Ibid., pp. 78-79
35
Per Agostino questa concreta formazione è preclusa (soltanto) dalla sua minorità anagrafica,
ed impedisce che la maturità venga raggiunta entro i limiti del discorso.
L‟explicit ci avverte che la maturazione è molto lontana, ma ancora possibile, e possiamo
congetturare che si realizzerà nel suo alter ego, Luca, de La disubbidienza.
Ma la storia di Agostino è molto di più di un‟iniziazione sessuale, è un‟iniziazione alla
realtà. La sua vicenda si configura come un susseguirsi di riti e di prove; e ciò grazie
alla banda di popolani, che presenta tutti i tratti tipici di una comunità tribale, con le
sue gerarchie e il suo linguaggio esoterico.
L‟iniziazione sessuale nel romanzo moraviano prende, sul piano simbolico, il posto
dell‟istituzione del matrimonio la quale serviva a sancire l‟avvenuta maturazione
dell‟eroe e la sua integrazione nel tessuto sociale.
Certo, per Agostino quest‟iniziazione non si tradurrà in atto ma egli si approprierà
comunque della cognizione della sessualità. Non sappiamo se l‟esperienza sessuale
avrebbe sciolto il legame edipico con la madre e le altre tensioni psicologiche, ma quel
che è certo è che l‟episodio della casa di tolleranza, anche se fallimentare, contribuirà
alla formazione di un sapere adulto.
Altre prove di iniziazione
Il primo evento che sancisce l‟ingresso di Agostino all‟interno della comunità è il
soprannome subito affibbiatogli, “Pisa”, il quale rivela che il novizio è pronto ad una
nuova dimensione. Ma il percorso formativo si rivelerà subito pieno di insidie e soprusi
e Agostino sarà chiamato a diverse prove (di sopportazione) del dolore: dalla sigaretta
spentagli sulla mano alle reiterate percosse, passando per altre prove spietate.
Attraverso queste prove svilupperà la cognizione del dolore, della violenza e
dell‟universalità di essi.
36
Possiamo dunque pensare che parte della formazione si sia conclusa poiché Agostino è
stato compiutamente iniziato a molti aspetti della realtà. Alla fine delle vacanze nel
personaggio si sarà verificato un profondo scarto ontologico.
Ma, come ci avverte il narratore, il romanzo si chiude senza una vera formazione,
poiché Agostino non trova una felice sintesi alle sue contraddizioni interiori, e “non
riusciva ad immaginare quando ne sarebbe uscito”37
.
Occorre ribadire però un aspetto peculiare dei romanzi di formazione contemporanei: la
rarità di un processo concluso entro i limiti della vicenda, per cui bisogna affidarsi agli
indizi seminati dal narratore.
Ciò che Moravia analizza è solo un breve segmento biografico, un segmento di piena
transizione, e si può immaginare che in futuro Agostino troverà i mezzi per rielaborare
le nuove e vecchie conoscenze e raggiungere una vera maturazione.
Infatti, spostando la formazione dal piano della storia al piano del discorso, potremmo
concludere che la maturità è stata solo rinviata, non preclusa. Lo scoraggiamento
anagrafico con cui si chiude il romanzo sarà presto o tardi superato.
Agostino potrebbe diventare un Michele Ardengo, sconfitto e indifferente, ma potrebbe
anche tornare alla vita come Luca Mansi.
Capitolo 4
La disubbidienza
37
Ibid., p. 82
37
Con La disubbidienza, iniziato poco dopo Agostino (nel ‟42 o nel „43), Moravia torna ad
occuparsi dell‟adolescenza. Questo racconto viene infatti a formare con Agostino un vero e
proprio “dittico”, reso possibile dalla contiguità tematica e dalla natura dei due protagonisti. I
due romanzi sembrano rappresentare due periodi di una stessa vita, poiché si possono
incastonare in una lineare successione cronologica.
In quest‟ultimo romanzo breve però l‟impronta esistenzialista è più marcata, così come il lato
psicologico ed intellettuale del protagonista.
Luca non è semplicemente un Agostino un po‟ cresciuto; con lui Moravia porterà all‟acme
l‟insofferenza del borghese nei confronti della propria classe. Quella di Luca è insomma la
storia di una crisi di rigetto individuale non molto diversa da quella collettiva del „68. Quindi
dalla crisi di contatto (con la realtà) di Agostino si passerà alla crisi di rigetto di Luca.
Dal titolo biografico di Agostino si passerà ad un titolo saggistico che estende l‟orizzonte
morale dell‟opera.
Di ritorno dalle vacanze estive Luca avverte uno strano turbamento nell‟animo. Questo
malessere indefinito sfocia progressivamente in un totale disinteresse per tutto ciò che lo
circonda, e si compiacerà a tal punto di questa nuova condizione da renderla programmatica,
fino all‟autodistruzione della propria persona. Le privazioni a cui si sottoporrà in nome della
sua disubbidienza peggioreranno sempre di più le sue condizioni, e solo grazie alle cure di
un‟infermiera riuscirà a riprendersi e a “guarire”.
Nelle prime pagine del romanzo ci viene fornita la descrizione del ragazzo, che reca in viso i
segni di una personalità riflessiva e problematica che lo accomunano al fascino sinistro di
Julien Sorel , o di Michele Ardengo. Ricorrendo a tratti morfologici come pallore e magrezza
lo scrittore romano si avvale di un topos iconografico ben riconoscibile. È possibile inoltre
ravvisarvi l‟eco di una matrice biografica poiché, come ricorda Moravia, gracilità ed
38
espressività degli occhi lo hanno sempre caratterizzato, sin dai tempi del sanatorio; tanto da
impedire ad una donna di dimenticare i suoi “poveri occhi tristi”38
.
Il primo capitolo ci mostra Luca, sul treno in viaggio verso casa; lo specchio del bagno ci
mostra il suo volto, trasformato da un silente urlo di disperazione:
“Luca stava a bocca aperta con il senso di urlare più forte del fragore del treno e il
suo furore gli pareva il treno stesso che ad un certo momento dovesse uscire dalle
rotaie e volare attraverso la scarpata per sfracellarsi contro il fianco di una
collina”39
.
Dopo il bozzetto impressionista di Agostino ora è l‟espressionismo a dominare la
rappresentazione, e contribuisce ad aumentare il senso di angoscia e claustrofobia.
Mentre Agostino non può essere considerato davvero un borghese Luca e Michele Ardengo lo
sono eccome, e per la loro spiccata natura intellettuale soffrono la condizione di algida
alienazione, verso se stessi e verso la realtà che li circonda.
Chiariamo che, per Moravia, l‟intellettuale non è altro che un indagatore della verità, che mira
ad andare alla natura delle cose, senza alcuna mistificazione. L‟intellettuale moraviano,
essendo consapevole portavoce del conflitto tra esistenza ed essere, tra vita autentica ed in
autentica, è in qualche modo la risposta all‟inetto di Svevo e Pirandello; la coscienza della
crisi porterà Luca ad agire e a squarciare il velo fittizio della realtà.
Io VS mondo
Il rapporto tra l‟io del personaggio e la prosa del mondo svolge un ruolo chiave nel romanzo
(soprattutto di formazione). Spesso questo confronto genera una frattura tra le aspettative
dell‟eroe e la realtà dei fatti; frattura che può restare aperta o condurre ad una rassegnazione.
38
A. MORAVIA - A. ELKANN , Vita di Moravia, cit., p. 43 39
A. MORAVIA , La disubbidienza , Milano, Bompiani, 2003, cit., p. 12
39
Ma questa dicotomia ormai ci appare troppo rigida, poiché abbiamo visto che anche da una
forte disillusione può innescarsi un processo di formazione.
Il vero nemico di Luca è la realtà stessa: essa gli si oppone in modo subdolo, attraverso
“incidenti” minimi. “Incidenti” e “occasioni”, parole significative e ricorrenti (ne La
disubbidienza e in Agostino), non sono altro che spie di una concezione antiprovvidenziale
della formazione.
Moravia torna dopo Agostino ad analizzare quella fase in cui l‟individuo avverte di non poter
essere più un ragazzino senza però riuscire a divenire un uomo.
Giunto alla piena consapevolezza della propria condizione Luca agirà secondo un preciso
programma di rinuncia e rivolta.
“Luca non si intendeva di termini di lotta sociale; altrimenti non avrebbe tardato a riconoscere
nella nuova forma che assumeva la sua rivolta le caratteristiche dello sciopero”40
I “fili” dai
quali si sente imbrigliato sono ovviamente quelli dei falsi valori borghesi e delle istituzioni,
come la scuola, la famiglia, la proprietà e il denaro.
Vivere, essere al mondo comporta obbedire a delle leggi, a delle abitudini, sia nella sfera
naturale (come il dover mangiare) sia nella sfera sociale (come il dover andare a scuola)
mentre la disubbidienza di Luca consiste proprio nel non scendere a compromessi con i
vincoli imposti dall‟esterno, di qualsiasi natura essi siano. La sua rivolta è finalizzata ad una
generica conquista della libertà, anzi si configura essenzialmente come “libertà da…”, non
come “libertà di…”.
La scuola
La scuola è il primo dei “fili” che Luca recide, poiché gli sfuggiva il senso di tutto ciò che gli
veniva imposto di studiare; e se si dedicava a delle letture “scolastiche” era solo per trovarvi
40
Ibid., p. 14
40
la noia ed un sonno senza sogni (il sonno non è altro che l‟adempimento del suo bisogno di
regressione simil-morte ).
Insomma, il suo progetto di svalutazione e boicottaggio degli studi sembra davvero anticipare
le contestazioni giovanili degli anni ‟60, le quali erano rivolte verso le istituzioni scolastiche e
la loro cultura accademica e stagnante, in cui non era più possibile identificarsi.
Luca ha una visione della scuola come organo del sistema borghese, portavoce non di valori
ma di obblighi e lezioni ridondanti che
“pur risuonando nella sua mente sillaba dopo sillaba, restavano incomprensibili,
slegate da ogni significato […] più morte di quelle di qualsiasi linguaggio
morto”41
.
La famiglia
La famiglia, prima di Marx e Freud, era un luogo innocente e intoccabile, un caposaldo
dell‟ideologia borghese.
La famiglia e la società sono la diarchia che regge i fili dello sviluppo dell‟individuo mediante
un complesso sistema di indottrinamento, ricompense e punizioni.
La disubbidienza ci presenta il nucleo famigliare al completo: microcosmo di menzogne e
ipocrisie borghesi. I due coniugi sono mediocri e prevedibili; tra di loro corre un legame
puramente formale ed entrambi si dimostrano insensibili trattando Luca come una sorta di
oggetto senza bisogni, sogni, volontà. L‟aggettivazione (come ne Gli indifferenti e ne La
disubbidienza ) insiste sulla mancanza di tutte quelle qualità che tradizionalmente attribuiamo
alla madre, un faro rassicurante in quel mare che è il mondo.
41
A. MORAVIA , La disubbidienza , Milano, Bompiani, 2003, cit., p. 16
41
Anche in questo caso, come in Agostino, i genitori appariranno sotto due luci diverse, segnate
da un avvenimento spartiacque. Questo mutamento nella coscienza dei figli è generato dalle
scoperta dei genitori in atteggiamenti prosaici, laidi, prima del tutto sconosciuti.
Come per Agostino, c‟era stato per lui un periodo in cui aveva provato per i genitori un senso
di reverenza religiosa; ma poi
“riaprì gli occhi e guardò i genitori. […] Per la prima volta sentì la durezza e virtù
materne, il buonsenso e la benevolenza paterne come cose non soltanto esterne
ma anche ostili. Con le quali egli non poteva accordarsi in alcun modo.”42
L’incidente della camera da letto
Quando il padre rincasava era solito consegnare dei giornali a Luca, per poi riprenderseli al
momento di coricarsi. “Era una delle abitudini familiari che costituivano la superficie liscia e
senza fratture della vita quotidiana.” 43
Una sera però il padre non torna a riprendersi i giornali
e Luca decide di portarglieli personalmente in camera dove assiste ad una scena molto
significativa. Egli scorge in un angolo della camera i genitori: mentre il padre reggeva in
mano biglietti di banca e titoli industriali la madre era intenta a rimuovere un quadro dalla
parete, il quale celava un forziere d‟acciaio. Non si tratta di un quadro qualsiasi, ma della
copia di una Madonna di Raffaello, sotto la quale i genitori avevano posto l‟inginocchiatoio
dove Luca adempieva ai suoi doveri religiosi. La rassicurante immagine della Madonna col
bambino diviene allora simbolo della maschera di bontà dei genitori, dietro la quale si
nascondono meschini interessi, e avidità.
L‟educazione era stata sino ad allora, per Luca, educazione alla proprietà, all‟impiego
fruttuoso del denaro e aveva prodotto in lui un sentimento di forte gelosia verso gli oggetti
42
Ibid., p. 11 43
Ibid., p.23
42
che possedeva: il collezionismo praticato dal ragazzino infatti non è altro che esplicita
metafora dell‟accumulazione capitalistica. La sua iniziazione al denaro era culminata con un
piccolo stipendio mensile che riscuoteva in cambio di un bacio sulla guancia del padre.
Così, un altro atto di protesta verso il mondo sarà il suo “francescano” voto di povertà,
attraverso cui vorrebbe liberarsi dall‟autorità del denaro, dei genitori e della loro ideologia.
Il primo passo di questo processo di spoliazione consiste nel regalare la sua collezione di
francobolli al suo compagno di classe, seguiranno poi la vendita dei libri e delle attrezzature
sportive: Luca non può semplicemente disfarsene poiché i genitori non tollererebbero la
mancanza di un profitto o di un nuovo investimento. Allora è costretto a ricorrere a delle
bugie (la relazione tra menzogna e denaro è già presente in Agostino ) : la menzogna del
portafogli gli permetterà di portare a compimento il suo piano, attraverso uno dei gesti più
simbolici e drammatici di tutta l‟opera moraviana.
Recatosi nei giardini pubblici, Luca scava una buca in cui getta le banconote, accuratamente
lacerate, ed un sacchetto di monete d‟argento, per poi ricoprire tutto con terra e morte foglie;
“scoprì di provare per quel denaro un odio profondo; come si odia qualcuno che ci
ha dominato e contro cui ci si è ribellati. […] Lacerando quei biglietti, sentiva di
vendicare le sue preghiere, di compiere una riparazione. […] Idolo odiato, come
sentiva, non ci voleva meno di quella lacerazione profanatoria, per sconsacrarlo
definitivamente.”44
Ora, Luca si è liberato da oggetti e denaro, ma gli resta ancora una cosa: la propria coscienza,
il proprio io, che egli avverte come suprema forma di possesso. Ed il mezzo con cui tenta di
sbarazzarsi di se stesso è il digiuno, la più radicale delle disubbidienze.
44
Ibid., p. 41
43
Thanatos e Eros
Il romanzo di formazione nasce come romanzo della vita e del dinamismo giovanile, per cui
non può che risultare paradossale il caso in cui a muovere l‟eroe sia l‟alternanza dei freudiani
“thanatos” e “eros”, istinto di morte e pulsione vitale.
Ma è proprio l‟iniziale istinto di morte a fare di Luca un eroe in formazione.
Il progetto di disubbidienza è messo in crisi dall‟inaspettato incontro con una governante: una
signorina di buona famiglia, sui trentacinque anni, non bella ma dal carattere vivace e
gioviale; ella svolge una chiara funzione propulsiva nella vicenda e nella condizione di Luca.
Con fugaci giochi e “incidenti” ella dischiude al ragazzo la prima esperienza di sereno
abbandono alla vita. A Luca si manifesterà per la prima volta la vitalità dell‟eros con tutto il
suo mistero, grazie all‟esperienza decisiva del primo bacio: primo stadio di quell‟iniziazione
che invece sarà preclusa ad Agostino.
La donna rivela al ragazzo tratti animaleschi, decisamente consoni al suo ruolo di
sacerdotessa della natura. In quanto nuovo oggetto di voluttà e possesso, però, la governante
minaccia il programma di Luca. Egli intuisce infatti che la governante, seducendolo, vorrebbe
(come i genitori, i professori ecc…) che egli vivesse, adempiendo così ad un compito
prestabilito. Ma alla fine la reticenza di Luca sarà vinta.
Fin da Agostino Moravia ci lascia intendere che, in fondo, la perdita dell‟innocenza non è
altro che una forma di progresso necessario.
La disubbidienza di Luca però può continuare grazie al crudele corso degli aventi, dato che la
governante di lì a poco morirà per una grave malattia. Questa figura lo porterà dunque a
confrontarsi con due realtà invincibili e autentiche: vita e morte, eros e thanatos.
Luca a questo punto si trova nella stessa frustrata condizione in cui abbiamo lasciato
Agostino, in un limbo causato dalla mancata iniziazione, e ripiomba nella sua malattia. Questa
si aggrava sempre di più dacché troviamo Luca non soltanto alienato ma addirittura
dissociato, perso in sogni deliranti. Ma Moravia attribuisce un alto potenziale formativo alla
44
malattia; lui in questa “atmosfera insieme disperata e piena di speranza” ci si era trovato solo
in due occasioni in tutta la sua vita (durante il secondo conflitto mondiale,in attesa degli
alleati e “durante gli anni del sanatorio”), e l‟unica cosa che poteva fare era desiderare e
aspettare un semplice “ritorno alla normalità”45
.
Il capitolo XII si apre con una precisazione del narratore: “la malattia di Luca durò quasi tre
mesi”46
. Ora, questo intervento implica l‟intersezione di due punti di vista: se infatti per Luca
la malattia è espressione del suo progetto di morte, il narratore la considera semplicemente per
ciò che è, nient‟altro che una fase passeggera, preannunciandoci la scontata guarigione. Anche
i progetti della madre sul futuro del ragazzo sottolineano il carattere di parentesi della
malattia, che si spera porterà ad un futuro migliore, senza dissidi. Sia il narratore sia i genitori
hanno il presentimento di come andrà a finire.
La vicenda di Luca sembra sempre più avviata sui binari di una futura guarigione e alla fine
del romanzo la sua sorte non sembra poi così diversa da quella di Wilhelm Meister,
all‟insegna di una rassegnata ma felice conciliazione col reale.
Siamo in sintonia allora con la considerazione di Fernandez: “La malattia di Luca è insieme
simbolo della morte a una realtà cattiva e della resurrezione a una realtà felice”47
. Lo stesso
Luca sembra averne coscienza quando considera il suo programma
“un‟operazione magica che gli avrebbe permesso di creare un mondo meno
assurdo, più amabile e più intimo, in cui ogni cosa fosse giustificata dall‟amore.
Egli comprese che doveva, non tanto a se stesso quanto alla realtà fuori di sé, di
morire per darle un ordine e renderla viva”48
.
45
A. MORAVIA - A. ELKANN , Vita di Moravia, cit., p. 143 46
A. MORAVIA , La disubbidienza , Milano, Bompiani, 2003, cit., p. 82 47
D. FERNANDEZ , Il romanzo italiano e la crisi della coscienza moderna , trad. it. di Franca Lerici, Milano,
1960, p.27 48
A. MORAVIA , La disubbidienza , Milano, Bompiani, 2003, cit., p. 86
45
Insomma il percorso di Luca non si presenta più come un‟iniziazione alla morte ma alla vita,
in quanto disillusione, dolore e morte non sono altro che prove, occasioni di rinascita. Questa
“resurrezione” non è un punto di arrivo, ma rappresenta la prima tappa di un possibile
percorso di crescita
L’infermiera
Nel parossismo della malattia,
“pur soggiacendo agli incubi del delirio, aveva la sensazione di farsi strada tra le
allucinazioni, come un viandante tra i tronchi e le tenebre di una foresta, verso
un‟apertura che non poteva mancare, finché un giorno, seduta accanto a lui, in
atto di sostenergli la fronte con una mano e con l‟altra di imboccarlo, vide una
donna”49
.
L‟infermiera appare come una “donna salvifica”, e la sua si configura come un‟apparizione
angelica, “quasi gli venne l‟impulso di tendere la mano e accarezzare quelle guance e quegli
occhi”50
. Basta la sua presenza a profondere in lui un nuovo e piacevole sentimento, tanto da
rendergli amabili per la prima volta la realtà e gli oggetti che lo circondano:
“con sorpresa si rese conto che non tanto guardava alle cose quanto si lanciava
ghiottamente con lo sguardo su di esse, come si lancia una bestia affamata sul
cibo dopo un lungo digiuno”51
.
49
Ibid., p. 90 50
Ibid., p. 91 51
Ibid., p. 91
46
La fame, prima condannata come forma di possesso, ora viene accettata da Luca grazie ad una
nuova pulsione di vita.
Dopo le cure affettuose della donna, e l‟emergere di nuove sensazioni “fece un sogno
singolare, in cui gli pareva di essere un albero.”52
. Nel sonno Luca esperisce l‟onirica
metamorfosi in albero; sente di crescere e proliferare finché “ad un tratto non era più un
albero, bensì uomo, ritto in piedi, le braccia levate verso il sole.”53
. L‟episodio indica
chiaramente la conquista di una nuova dimensione esistenziale, l‟approdo ad un saldo
radicamento alla realtà. Quel contatto autentico e vitale col mondo non è invece consentito a
Michele Ardengo, che si limita a vagheggiare un tempo in cui “gli uomini erano fatti di carne
ed ossa e attaccati alla realtà come alberi alla terra”54
.
Dopo la prima fase di reviviscenza dei sensi sarà proprio l‟infermiera a condurlo con
contegno e devozione nelle fasi successive della guarigione. Il primo passo è il “bagno
purificatore”: l‟importanza simbolica del bagno è evidenziata dalla solennità della
genuflessione con cui la donna si appresta a lavare Luca. Il bagno rimuove dal ragazzo
l‟impurità della malattia e del conflitto col mondo. Al termine del bagno
“i suoi piedi riprendevano confidenza col suolo e comunicavano alle gambe e a
tutto il corpo un senso nuovo e piacevole di solidità e di sicurezza […] e gli parve
un segno di più della sua nuova confidenza con se stesso e il mondo”55
Luca appare ora pronto per l‟ultimo “rito” che lo attende: guarda la donna
52
Ibid., p. 105 53
Ibid., p. 106 54
A. MORAVIA, Gli indifferenti , Milano, Bompiani, 2007, cit., p. 191 55
A. MORAVIA, La disubbidienza , Milano, Bompiani, 2003, cit., pp. 96-99
47
“senza turbamento né imbarazzo, con una curiosità che sentiva innocente, come
se ella non avesse apprestato il luogo per l‟amore ma avesse compiuto i gesti
prestabiliti di un rito sconosciuto.”56
.
Ne Gli indifferenti l‟iniziazione sessuale è presentata come un fatto compiuto, in Agostino
resterà un sogno frustrato; ne La disubbidienza l‟iniziazione si compie realmente e determina
la soluzione fulminea e definitiva dei conflitti del protagonista:
“Seconda e più vera madre, l‟infermiera l‟aveva fatto nascere una seconda volta,
dopo che era morto nel suo desiderio di morte.”57
.
Ciò che la critica ha rilevato è il carattere eccessivamente meccanico e artificioso
dell‟iniziazione sessuale, che sblocca magicamente l‟intreccio.
In realtà questa iniziazione va considerata come una più ampia introduzione alla realtà, alla
vita stessa; grazie a quell‟antico rito Luca può tornare a vivere con sorpresa e partecipazione.
Moravia vuole liberare il sesso dal suo carattere laido presentandolo come qualcosa di
vitalmente necessario. È vero che vi è nell‟autore una sorta di pansessualismo di fondo, ma
questo non sfocia mai in una rappresentazione volgare.
La donna e il rito che ella presiede sono dunque i canali di un più profondo contatto con la
vita:
“Luca pensò che la venuta della donna gli avrebbe fatto piacere come gli
facevano piacere, da quando si era destato dal delirio, tutti gli avvenimenti, tutte
le presenze, tutti i rapporti”58
.
56
Ibid., p. 107 57
Ibid., p. 109 58
Ibid., p. 105
48
Happy ending
Di Moravia si è sempre apprezzata la capacità di scavo psicologico e di analisi dei rapporti
interpersonali, mentre gli espedienti narrativi con cui chiude le sue opere hanno spesso destato
diatribe critiche.
Nell‟ultimo capitolo vediamo Luca e la madre in viaggio verso il sanatorio, in un‟imprecisata
località di montagna (un eco biografico); tutta la scena è dominata da una forte retorica della
speranza.
Pur riconoscendo il carattere artificioso e improbabile del finale si può però concludere che
esso risponde ad una precisa poetica, piuttosto che ad una presunta superficialità dell‟autore.
Se si osserva la prima pagina del racconto notiamo l‟incapacità di Luca di avere un sereno
controllo del proprio corpo, che anzi si configura come un corpo estraneo; l‟iniziazione di
Luca allora acquista un‟ulteriore valenza di crescita in funzione della conquista di una piena
fisicità.
Secondo il critico francese D. Fernandez Moravia avrebbe scelto di distribuire l‟iniziazione
sessuale (e la formazione) in due opere: Agostino e La disubbidienza. Per Agostino, infatti,
non si può parlare di happy ending, poiché la soluzione dei dissidi giovanili viene
procrastinata in un vago futuro, ritardando così un finale classificatorio. Ma la sua vicenda
può benissimo congiungersi a quella di Luca. Se ad Agostino vengono aperti gli occhi per
forza senza che la nuova maturità venga sancita da un‟iniziazione finale, a Luca sarà concesso
di ottenere una visione più serena della vita. Alla fine, quindi, con questa diade di racconti
l‟antinomia fra io e mondo verrà risolta.
Ma le cose non sono così semplici. Con il normale e sereno futuro che la madre prospetta a
Luca (un futuro da avvocato e l‟iper classificatorio matrimonio con una donna di buona
famiglia) Moravia sembra smentire le premesse esistenzialiste e quelle intuizioni più
contemporanee per arrestarsi al modello Wilhelm Meister. Come si può notare, il finale è
49
altamente problematico a causa della compresenza di due poetiche: una goethiana ed un‟altra
più moderna.
Mentre Luca si trova sul treno, immerso nel paesaggio montano
“tutto ad un tratto pensò che sarebbe stato bello continuare così tutta la vita. Al
treno, all‟infermiera, ai genitori, sarebbero succedute forze più vaste se non più
misteriose; e lui si sarebbe affidato ad esse con uguale fiducia ed uguale
delizia.”59
.
Ciò che traluce da questo passo è il raggiungimento di una nuova fiducia, dell‟accettazione
della vita e del futuro.
“Gli occhi spalancati, prese a guardare il monte; e più lo guardava e più sentiva
crescere nel proprio animo quella esultanza fiduciosa e inebriata. Capiva che non
c‟era alcuna ragione obbiettiva di rallegrarsi a quel modo perché scorgeva la cima
nevosa di una montagna; e tuttavia non poteva fare a meno di rendersi conto che
proprio quella vista metteva in movimento il meccanismo per tanto tempo
inceppato della sua più profonda speranza.”60
.
Lo scarto rispetto all‟iniziale condizione di alienazione e tanatosi è evidente. Certo,
nonostante la retorica della speranza che impregna la scena finale non si può parlare di
armonioso happy ending, ma i dissidi interiori di Luca, se non risolti, sembrano prossimi a
trovare una soluzione.
59
Ibid., p. 111 60
Ibid., p. 113
50
“e capì che da ora in poi non soltanto il fragore di un treno in una galleria o la
bianchezza delle nevi sulla cima di una montagna, ma tutte le cose avrebbero
avuto per lui un senso e gli avrebbero parlato nel loro muto linguaggio. Poi, con
un altro fischio, il treno riuscì nella luce del giorno”61
.
Si può concludere che quello che attende Luca non sarà un frustrante futuro da inetto; dentro
di sé troverà la forza di andare avanti, crescere e proliferare, “come si accresce e fruttifica una
pianta”62
.
Osservazioni finali: il tempo, lo spazio e il clima
Le indicazioni temporali di Agostino e de La disubbidienza fanno si che le due vicende si
richiamino reciprocamente e si fondino in modo complementare. La storia di Agostino si
svolge in estate, ad agosto (mese che ispirò il titolo del libro) mentre quella di Luca si apre
proprio con il ritorno del ragazzo dalle vacanze estive e si conclude con la primavera
successiva.
Allo sfondo della vicenda mancano precisi riferimenti cronologici: come per Agostino, tale
mancanza conferisce un carattere di atemporalità e esemplarità alla vicenda. Inoltre Moravia
si dimostra attento all‟uso simbolico delle stagioni, le quali accompagnano chiaramente
l‟evoluzione psico-fisica del personaggio.
La disubbidienza è ambientato a Roma, come si deduce dai pochi indizi toponomastici, ma la
città, come per Gli indifferenti, non è altro che uno sfondo, sbiadito, grigio e immobile, agli
antipodi della frenetica e pulsante città balzachiana. In questi romanzi la città perde quel
valore pedagogico solitamente attribuitogli dal romanzo di formazione tradizionale: non è più
un polo di attrazione, ma una realtà ostile da cui allontanarsi. Per questo motivo Luca prova
61
Ibid., p. 114 62
Ibid., p. 29
51
tanta ostilità verso il treno che lo sta riportando a casa, ai suoi obblighi scolastici, alle rigide
convenzioni sociali. Al contrario, il viaggio in treno con cui si conclude la storia sembra
contenere decise premesse formative.
Le notazioni climatiche sono un altro espediente con cui Moravia carica simbolicamente le
scene. “Ciò che colpisce è l‟assenza dei climi temperati dove l‟uomo sia a tu per tu con le
cose, in accordo con l‟universo”63
. Spesso nelle opere di Moravia ci si imbatte in un clima
inquieto e fastidioso, in un cielo tonante o in un sole abbagliante, e ciò vale soprattutto per i
tre testi qui affrontati, in virtù della loro profonda forza evocativa. Ne Gli indifferenti, ad
esempio, una pioggia pesante si abbatte sulla città come un‟onnipresente sottofondo musicale,
dandoci la sensazione di soffocamento e alterità, e l‟impressione di un mondo chiuso, oscuro
e immutabile. Il caso estremo di questo rapporto tra personaggi e clima si trova nel lungo
racconto La disubbidienza dove il cielo nero e gravido di pioggia è uguale all‟animo turbato
di Luca, quasi ne fosse il correlativo oggettivo.
Con Agostino Moravia sostituisce alla pioggia il sole estivo, ma anche questo è un sole
accecante, spossante, e contribuisce a rendere più sofferta la percezione del mondo di
Agostino; inoltre si instaura una profonda dissonanza tra l‟interiorità del protagonista e la
solarità del paesaggio.
Ma la primavera (e la guarigione) deve pur arrivare. Il cielo non tarderà a schiarirsi:
“In cielo le nuvole si erano aperte e il sole illuminava quella neve lontana
facendola scintillare. Allora, non sapeva neppur lui perché, alla vista di quella
bianchezza inattesa, maestosa e romita, lo assalì una esaltazione improvvisa”64
.
Questo cielo sereno, insperato e scrutato dal treno in viaggio, assurge a definitivo simbolo di
una vitale rinascita e di una nuova vita per Luca.
63
D. FERNANDEZ , p. 50 64
A. MORAVIA , La disubbidienza , Milano, Bompiani, 2003, cit., p.113
52
Conclusioni
Abbiamo analizzato questa coppia di romanzi in quanto romanzi di formazione; abbiamo cioè
cercato di analizzare il tema della formazione nella narrativa moraviana poiché ci offre un
ulteriore punto di vista e di riflessione: considerando questo genere letterario è possibile far
luce sul modo dell‟autore di guardare la realtà e il suo modo di rappresentarla. Infatti
l‟adolescente, ci ha sempre offerto uno speciale punto di vista; Moravia si è impossessato di
questa figura per farne un particolare filtro ottico attraverso cui riesce a penetrare negli antri
oscuri della società, e nei moti reconditi dell‟animo umano.
Abbiamo visto che egli ha saputo dar luce ad almeno due storie di formazione e di fiducia, pur
con le proprie peculiarità. Abbiamo visto che ogni romanzo di formazione, pur affrontando la
stessa tematica di fondo e pur ricorrendo a un definito repertorio di motivi e espedienti, sia
dotato di una propria originalità; ed essendo un genere proteiforme ci permette di dimostrare
come Moravia se ne sia impadronito, reinventandolo.
Si va infatti da Gli indifferenti, romanzo di formazione impossibile, ad Agostino, dove la
formazione dell‟eroe resta sospesa, fino al romanzo di formazione integrale con La
disubbidienza; all‟insegna di un progressivo ritorno alla forma tradizionale del bildungs.
Ma questa regressione formale non intacca in alcun modo l‟importanza fondamentale dei
contenuti e l‟apporto che egli ha fornito alla tradizione letteraria italiana ed europea del
Novecento.
53
Bibliografia
MORAVIA, Agostino, Milano, Bompiani, 2011
MORAVIA, Gli indifferenti, Milano, Bompiani, 2007
MORAVIA, La disubbidienza, Milano, Bompiani, 2003
MORAVIA – A. ELKANN, Vita di Moravia, Milano, Bompiani, 2007
D. FERNANDEZ, Il romanzo italiano e la crisi della coscienza moderna, trad. it. di
Franca Lerici, Milano, 1960
M. M. GALATERIA, come leggere Gli indifferenti di Alberto Moravia, Milano,
Mursia Editore, 1996
J. W. GOETHE, La missione teatrale di Wilhelm Meister, Milano, BUR, 2008
R. MANICA, Moravia, Torino, Einaudi, 2004
V. MASCARETTI, La speranza violenta, Bologna, Gedit Edizioni, 2006
F. MORETTI, Il romanzo di formazione, Torino, Einaudi, 1999
F. PANDOLFI, “LA SCUOLA È UNA SPECIE DI MORFINA ”, Roma, Biblink
editori, 2009
R. PARIS, MORAVIA. UNA VITA CONTROVOGLIA, Milano, Mondadori, 2007
H. D. THOREAU, VITA SENZA PRINCIPI, Milano, La Vita Felice, 2007
J. R. R. TOLKIEN, Il signore degli anelli , Milano, Bompiani, 2000
STENDHAL, Il rosso e il nero, Roma, Newton, 2006
J. WIENSTEIN, L’opera di Alberto Moravia nel giudizio dei critici, Department of
Italian Language and Literature, McGill University, Montreal, 1969