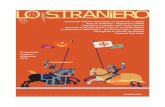Nolli e Piranesi all’Aventino, in M. Bevilacqua, D. Gallavotti Cavallero (a cura di), L’Aventino...
Transcript of Nolli e Piranesi all’Aventino, in M. Bevilacqua, D. Gallavotti Cavallero (a cura di), L’Aventino...
120 Mario Bevilacqua
Fig. 1 - JOHAN BAPTIST BAADER. Ritratto di Felice Nerini col progetto di facciata di S. Alessio (olio su tela,1753 circa; Collezione privata).
Nolli e Piranesi all’AventinoMario Bevilacqua
no del conterraneo Giambattista Nolli, ed è sovrintendente scien-tifico della grande impresa cartografica della Nuova Pianta diRoma, iniziata sotto i suoi auspici nel 173610. Revillas promuove lecompetenze tecniche di Nolli: nella ricomposizione dei frammen-ti della Forma Urbis lungo le scale del palazzo Nuovo in Campido-glio, sotto la sovrintendenza di Ferdinando Fuga; nelle consulen-ze sulle lesioni della cupola di S. Pietro; in studi di progetto per labonifica delle paludi Pontine. È inevitabile dedurre che dal suoarrivo a Roma nel 1740 anche Piranesi sia stato, in alcune di que-
121
Piranesi conosce bene l’Aventino fin dai suoi primi anniromani: lo esplora, disegna reperti nelle sue vigne, a S. Prisca, a S.Saba, e molti elementi antichi, cornici e capitelli, verranno poiriprodotti nelle tavole della Magnificenza ed Architettura de’ Roma-ni. In un rapido appunto nel giovanile taccuino di Modena (fig.2), uno scarno elenco di luoghi visitati, Piranesi annota anche lachiesa di S. Alessio dei Girolamini lombardi, negli anni in cuiveniva sottoposta a una profonda riconfigurazione architettonicasu progetto di Giovanni Battista Nolli, uno dei primi protettoriromani di Piranesi1.
La riedificazione del complesso di S. Alessio, conclusa nei pri-mi anni ’50, e la di poco successiva riqualificazione piranesianadell’adiacente S. Maria del Priorato, propongono un inevitabileconfronto, sul crinale dell’Aventino, tra due protagonisti del Set-tecento europeo.
Giovanni Battista Nolli architetto.Tra i tardi anni ’30 e la metà degli anni ’60 del ’700 il mona-
stero dei Girolamini di Lombardia dei SS. Bonifacio e Alessioall’Aventino è un centro riconosciuto di cultura scientifica e diricerca antiquaria, animato dal matematico, cartografo e antiqua-rio Diego Revillas, che promuove il rinnovamento della bibliote-ca monastica soprattutto in chiave scientifica (i lacerti, con diver-si volumi di argomento scientifico, astronomico, matematico,con atlanti e raccolte di carte geografiche, nonché alcuni mano-scritti dello stesso Revillas, si conservano ora nella biblioteca del-la Pontificia Università Lateranense)2, e quindi dal suo allievo, mapoi antagonista, Felice Nerini, che porta a conclusione i lavoridi ricostruzione, restauro e decorazione e, su sollecitazione delcardinal Querini, cura la pubblicazione di una compiuta ma atratti celebrativa, monografia storica sulla chiesa3. Nei loggiatiinferiori e superiori del chiostro vengono quindi esposti iscri-zioni e reperti antichi, oltre che una collezione “di carte geo-grafiche, e serie cronologiche, di piante di edifici e di altriistruttivi arredi”4; la volta del salone della biblioteca è affresca-ta nel 1754 con la macchinosa allegoria del Progresso delle scienzee delle arti che scaccia, con la luce di verità e civiltà, le tenebre dell’igno-ranza e i fantasmi della menzogna e dell’errore, probabile opera deltedesco J.B. Baader5, autore anche di un grande ritratto di Nerini,enfatico e celebrativo6 (fig. 1).
Diego Revillas è coinvolto in realizzazioni e cantieri importan-ti della Roma del tempo: è nominato responsabile delle iscrizionida apporre alla Fontana di Trevi7; promuove gli scavi del circo diAdriano ai prati di Castello8; esegue le prime carte scientifiche,basate su operazioni geodetiche, dei territori delle diocesi Tibur-tina e dei Marsi9. Lombardo, Revillas è il primo protettore roma-
Nolli e Piranesi all’Aventino
Fig. 2 - GIOVAN BATTISTA PIRANESI. Elenco di chiese di Roma (disegno dal Tac-cuino ‘A’ di Modena, 1743-1749 circa; Modena, Biblioteca Estense Universitaria).
122
ste imprese – dalla Nuova Pianta di Roma allo studio e ricostruzio-ne dei frammenti della Forma Urbis in Campidoglio – in direttocontatto con Revillas e Nolli, giovane collaboratore di opere diret-tamente legate allo studio dell’antichità romana che inciderannoprofondamente nella sua maturazione11.
La ristrutturazione del complesso di S. Alessio inizia, curatadai monaci, nel 1741; dal 1743 è promossa, limitatamente all’an-tica basilica, dal cardinale Angelo Maria Querini12. In entrambi icasi, i lavori sono affidati a Revillas, il quale coinvolge Nolli cometecnico e progettista. Alla morte di Revillas nel 1746 i lavori, pres-soché conclusi per quanto riguarda il monastero (figg. 13-19),meno avanzati per la basilica, vengono interrotti, anche a seguitodi preoccupanti cedimenti statici delle strutture: Nolli, allontana-to dal cantiere subito dopo la morte di Revillas e quietanzato con50 scudi nel 1747, non subisce ripercussioni, mentre gravi ina-dempienze vengono contestate al capomastro Bartolomeo Rinal-di, a cui i padri intentano causa nel 1748-175013. Tommaso DeMarchis viene quindi nominato responsabile di un progetto alter-nativo per la basilica (fig. 3), e della conclusione dei lavori al
monastero, avvenuta dopo il giubileo del 1750 (l’architetto è sal-dato nel 1757; lo scultore Andrea Bergondi, per la statua di Bene-detto XIII nel portico della chiesa, dopo un contenzioso con ipadri, 1761, viene saldato nel 1763)14.
È ipotizzabile, dalla scarsa documentazione rimasta15, che ildisegno di Revillas e Nolli, poi obliterato da de Marchis, preve-desse la sostituzione, o rafforzamento, dell’originaria teoria diarchi su colonne che scompartiva la basilica medievale in tre nava-te, attraverso il tamponamento alternato delle arcate, così da crea-re un uniforme partito a serliane, inserito entro un ordine mag-giore di paraste corinzie. La crociera e tutta l’area absidale (doverimane l’iscrizione apposta nel 1744 per ricordare l’inizio dei lavo-ri e celebrativa del mecenatismo del cardinal Querini) potrebberoinvece essere ancora quelle progettate da Nolli e Revillas, pur consuccessive modifiche: non resta traccia ad esempio delle grandicolonne libere ricordate dai documenti, e visibili ai lati delle duecappelle laterali del transetto nella pianta della chiesa inserita nel-la Nuova Pianta di Roma pubblicata nel 1748, ma sicuramente inci-sa già nel 1743, benché con rimaneggiamenti successivi, entro il1747, particolarmente visibili proprio nell’area del monastero diS. Alessio a includere i lavori di ampliamento eseguiti sotto ladirezione di Nolli16 (figg. 4-6).
Nolli e Revillas salvano dunque solo l’invaso spaziale dell’an-tica basilica, ridefinendone interamente la struttura internasecondo un disegno che, è possibile ipotizzare, doveva comunquerifiutare ogni esuberanza decorativa. L’unica altra opera architet-tonica di Nolli confrontabile con l’impegno per i Girolamini è lachiesa di S. Dorotea in Trastevere (fig. 10), dove la struttura pree-sistente, di piccole dimensioni e di scarsa rilevanza monumenta-le, ne ha consentito la integrale sostituzione con un’architetturainnovativa, apprezzata dallo stesso difficile Giovanni GaetanoBottari, uno dei principali animatori culturali della Roma di metàsecolo17. Alcune altre opere architettoniche di Nolli sono rimastefino ad oggi meno note: oltre ad interventi e progetti a Roma enel circondario (tra tutti l’impiego per il cardinale AlessandroAlbani nelle fasi iniziali di impianto della sua villa sulla Salaria),emergono come significative alcune realizzazioni in piccoli centridel Lazio meridionale.
Nolli è documentato dai primi anni ’30 nella diocesi di Feren-tino, dove già risiedono alcuni suoi familiari attivi in campo edili-zio. Durante l’episcopato di monsignor Fabrizio Borgia, esponen-te di una delle principali famiglie nobili di Velletri (città con cuiNolli manterrà stretti rapporti per tutta la vita)18, è possibile cheinsieme ai congiunti egli abbia potuto trovare cospicue occasionidi impiego nella capillare campagna di interventi promossi dalvescovo nella Cattedrale, nel palazzo Vescovile e nel Seminario diFerentino, e poi nelle principali chiese e monasteri della città edelle terre della diocesi19. Il legame di Nolli con monsignor Borgiaè del resto, anche se indirettamente, testimoniato dalle belle inci-sioni con la raffigurazione di Sant’Ambrogio martire protettoredella città e della sua macchina processionale commissionate nel1749 a Carlo Nolli, figlio e stretto collaboratore di Giovanni Bat-tista20 (figg. 7, 8).
Il diretto intervento di Nolli nella diocesi di Ferentino è docu-mentato nella progettazione della parrocchiale di S. Giovanni
Mario Bevilacqua
Fig. 3 - Roma, SS. Bonifacio e Alessio. Interno.
123
Battista a Ceccano, chiesa medievale già ampliata alla fine del’500, ricostruita su suo disegno dal 1740-1742 e in parte finanzia-ta dal vescovo Borgia21: la navata centrale (di cui tra ’800 e ’900 siè ribaltato l’orientamento, con la costruzione di una nuova absi-de e di una nuova facciata, raccordata con una campata più bre-ve), coperta da una volta a botte unghiata (fig. 9), è scandita daarcate su pilastri incassate entro setti murari profilati da unamodanatura liscia rilevata; un ordine maggiore di paraste compo-site sorregge la trabeazione aggettante, su cui si impostano le fasceche scandiscono la volta in tre campate; le navate laterali, sulle cuipareti di addossano le cappelle-altari, sono coperte da una serie divolte cupoliformi, simili a quelle delle navate laterali di S. Alessio.
Nella sede episcopale di Ferentino Nolli poté essere coinvoltodal vescovo Borgia nella ristrutturazione del monastero delle Cla-risse, e nella progettazione della nuova chiesa annessa di S. Chia-ra22 (figg. 11, 12): una piccola struttura a pianta ellittica coperta acupola, con due cappelle-altari laterali e abside rettangolare, defi-nita da un ordine unico di paraste composite. La facciata, inseri-ta nel più ampio fronte del monastero, è a semplice edicola, tralisce paraste laterali che incorniciano il portale in travertino: unoschema che, con diversa articolazione e monumentalità, sarà poielaborato nella facciata romana di S. Dorotea. La ricerca dovreb-be poi essere approfondita per accertare un eventuale coinvolgi-mento di Nolli negli altri principali interventi promossi dal vesco-vo Borgia: la chiesa di S. Lucia a Ferentino, “restaurata ed abbel-lita” nel 1740, la matrice di S. Giovanni di Patrica, iniziata nel1746 “con nobile disegno”23.
Il linguaggio di Nolli sembra connotarsi, pur nella parsimoniadei mezzi a disposizione in una realtà di provincia, per la sobriaraffinatezza dell’articolazione spaziale, coniugata a una semplicitàlineare degli alzati, con uso di ordini di paraste giganti, arcate supilastri, e una esuberanza trattenuta nelle decorazioni. La più auli-
Fig. 4 - GIOVAN BATTISTA NOLLI. Nuova Pianta di Roma(1748). Particolare con l’area dei SS. Bonifacio e Alessio.
Figg. 5-6 - Roma, SS. Bonifacio e Alessio. Rilievo del com-plesso prima e dopo i lavori di ristrutturazione (rilievo di G.B.Nolli, incisioni di Carlo Nolli, da Nerini 1753).
ca e impegnativa ristrutturazione di S. Alessio, lontana da ognistravolgimento della planivolumetria originaria, ne avrebbe evi-denziato solo singoli elementi (le antiche colonne inserite nelsistema di serliane): una soluzione in piena sintonia coi tantiinterventi di riconfigurazione di antiche strutture, ma che pro-prio negli anni del pontificato di Benedetto XIV si inizia a per-cepire come irrispettoso del valore storico-documentario ditestimonianze monumentali della chiesa delle origini24. Le dra-stiche censure che lo stesso pontefice ebbe ad esprimere pub-blicamente nei confronti dei lavori di ristrutturazione di S.Maria Maggiore e di S. Croce in Gerusalemme25, assieme alleaccese polemiche sui restauri dell’interno del Pantheon26, indi-cano l’insoddisfazione per una tale prassi di intervento di“restauro”, e la rapida maturazione, alla metà del secolo, di unadiversa sensibilità conservativa.
A S. Alessio Nolli e Revillas, e poi Felice Nerini che porta acompimento i lavori della chiesa affidandone la riprogettazione ecompletamento a Tommaso De Marchis, prevedono la sottilemodifica di elementi antichi, come il pavimento marmoreo co-smatesco, integrato coi gigli araldici queriniani, e la rimozione ditutte le antiche lastre tombali, iscrizioni e altri reperti lapidei, rior-ganizzati in massima parte in un lapidario allestito lungo le paretidel chiostro27 (fig. 17). Se da un lato la chiesa viene quindi privatadei documenti “parlanti” delle sue origini e della sua vita plurise-colare, un approccio rigorosamente storicistico, sistematico e clas-sificatorio, porta a una precisa forma di musealizzazione – secon-do una prassi operativa messa a punto da tempo, se pure conmodalità e intenzioni diverse (si pensi alla sistemazione bianchi-niana del lapidario nel portico di S. Maria in Trastevere) - cioè auna organizzazione scientificamente ordinata del materiale rimos-so e di ogni altro “monumento” dell’antico cenobio: iscrizioni eframmenti lapidei antichi esposti in sequenza, senza alcun cedi-
Nolli e Piranesi all’Aventino
124
Fig. 7 - CARLO NOLLI. Sant’Ambrogio martire pro-tettore di Ferentino (incisione; Velletri, BibliotecaComunale, fondo Borgia).
mento a una disposizione di natura estetico-decorativa; riordina-mento dell’insieme della documentazione archivistica28; indaginestorico-documentaria sulla nascita e vicende dell’insediamentocon riordinamento, regestazione e pubblicazione dei principaliatti ufficiali29.
Per quanto riguarda il complesso monastico, che i documen-ti del tempo attestano come opera autonoma di Nolli, pur se incollaborazione con Revillas, il geometra-architetto opera su unastruttura compiuta, intervenendo con una generale razionaliz-zazione degli spazi, e unificando i prospetti secondo un lin-guaggio funzionale che appare privo di decise caratterizzazioni(fig. 19). Ritratto dal filo stradale, da cui lo divide un ampiopiazzale, schermato da un semplice muro di cinta privo di aper-ture (l’ingresso al monastero avveniva unicamente attraverso lacorte antistante la chiesa) ricostruito – rettificato – nel 174930,il corpo principale del monastero si eleva su due ordini con unfronte privo di particolare qualificazione architettonica: Nollisembra intervenire unicamente riquadrando le finestre del pri-mo livello con una semplice incorniciatura, e conclude la fac-ciata con un semplice cornicione a guscio, secondo un proce-dere di neutro decoro sperimentato anche nell’alto fronte del-la casa dei padri Paolotti a ponte Sisto31. Gli spazi interni sonoampi, luminosi, resi sobriamente monumentali dalle incorni-ciature timpanate dei portali (fig. 14); la scala principale, sfrut-tando l’esiguo spazio disponibile nella resa di massima spazia-lità, è su due rampe aperte nell’unico vano voltato, con riccabalaustra in ferro battuto32 (fig. 15). Il chiostro (fig. 16), con le
Fig. 8 - CARLO NOLLI. Macchina di Sant’Ambrogiomartire protettore di Ferentino (incisione, 1749;Velletri, Biblioteca Comunale, fondo Borgia).
arcate sorrette dalle preziose ma tozze colonne di spoglio, rica-vate dal taglio di fusti di grande dimensione, aveva assunto lasua configurazione durante i lavori di ristrutturazone condottinel secondo ’500, e conclusi intorno al 1577 (una iscrizionerelativa alla realizzazione del pozzo centrale presentava la data1570, mentre conti e ricevute dei muratori Bartolomeo eDomenico per lavori alla chiesa e al monastero erano archivia-ti al 1577)33. Qui Nolli sembra intervenire unicamente nellaregolarizzazione dei prospetti e delle bucature. La parte piùconsistente della ristrutturazione è la costruzione della nuovaala del monastero verso il Tevere, connotata da un ampio pro-spetto aperto a piano terra con una loggia a tre fornici apertasul giardino (fig. 18) e sullo straordinario panorama della cittàdominato dalla cupola di S. Pietro, inquadrata non certocasualmente nell’infilata di aperture dal giardino meridionaleal chiostro alla loggia sul giardino pensile settentrionale sul fiu-me. Anche in questo caso il linguaggio di Nolli è essenziale,meramente funzionale: ulteriormente semplificato ancherispetto al probabile disegno di progetto, identificabile con unfoglio della Kunstbibliothek di Berlino34, dove si mostrano det-tagli (paraste e cantonali a bugnato, timpano su porta-finestra ebalcone al piano nobile) poi mai eseguiti. Un linguaggio cheappare in sintonia con le poche altre architetture civili che èpossibile attribuire a Nolli: la casa d’affitto dei Paolotti a ponteSisto e quella del gentiluomo velletrano Benigno Giorgi a piaz-za del Pantheon35; e di natura simile agli interventi, ancora daapprofondire, che gli possono essere riferiti in vari cantieri a
Fig. 9 - Ceccano (Frosinone), parrocchiale di S. GiovanniBattista. Interno e volte della navata maggiore.
Mario Bevilacqua
125
Roma e nel Lazio meridionale: l’ampliamento del perduto casi-no Santacroce, già De Carolis, fuori porta S. Giovanni36; i lavo-ri al castello Colonna di Ceccano37 e ai conventi dei frati Mino-ri conventuali della Provincia romana a Sezze e a Ferentino38
(fig. 20). Un linguaggio funzionale che, rifacendosi a evidentidettami bottariani, Francesco Devoto, autore di alcuni testi dicarattere storico-architettonico, sodale della corsiniana Accade-mia dei Quirini e strettamente legato a Nerini, definisce – rife-rendosi al monastero ma attribuendone il disegno a Nerini –come schiettamente “lombardo”, aggiungendo che ai lombardiappare ridicola quella magnificenza che non guarda all’utile,ma aggiunge vanamente decorazione a decorazione39: un’inter-pretazione originale, e precoce, che lega al riconoscimento del-la secolare tradizione costruttiva settentrionale le teorizzazionidi un funzionalismo razionalista che a metà del ’700 mature-ranno in modo specifico, e vedranno, a Roma, la netta e auto-noma presa di posizione di Piranesi.
Fig. 10 - Roma, S. Dorotea.
Nolli e Piranesi all’Aventino
Figg. 11-12 - Ferentino (Frosinone), S. Chiara. Facciata e interno.
126
la modesta struttura originaria; i documenti “parlanti” dell’anticastruttura – iscrizioni, lapidi e monumenti funerari – all’oppostodi quanto avvenuto a S. Alessio, non vengono decontestualizzatie musealizzati, ma integrati nel nuovo disegno secondo il model-lo borrominiano di S. Giovanni in Laterano, su cui negli stessianni Piranesi riflette nei progetti per il nuovo coro della cattedra-le di Roma41. La nuova facciata della chiesa, completata con l’atti-co “araldico”, poi distrutto nell’800, si erge monumentale sulciglio del colle, in dialogo evidente – a sottolineare il ruolo e larilevanza della chiesa del Gran Priorato di Roma della Sacra reli-gione Gerosolimitana – con le chiese di S. Pietro in Montoriodegli Spagnoli, Trinità dei Monti dei Francesi, che dall’alto delGianicolo e del Pincio dominano la città pontificia: punti di sta-zione elevati di una ideale triangolazione dell’Urbe.
Piranesi aggancia quindi l’edificio chiesastico, e le più mode-ste costruzioni adiacenti, alla viabilità dell’Aventino, che nell’oc-casione viene modificata significativamente in funzione del rin-novamento del complesso. L’accesso diretto a S. Maria del Priora-to avveniva dal Tevere attraverso un ripido vicolo alberato confi-nante con la proprietà di S. Alessio, bisognoso di continua manu-tenzione, e già oggetto di lavori e controversie tra i due confinan-ti in occasione dei lavori di sistemazione di S. Alessio nel 174642.Anche Piranesi dovette provvedere a nuovi lavori di ripristino,comprensivi di “sbancamenti e spianamenti”, e rifacimento deimuri di contenimento della “strada dell’Alborata”43. L’accessoprincipale, e l’unico transitabile con le carrozze, era però quellodell’antico percorso di crinale che, salendo dal Circo Massimo epassando rettilineo per S. Sabina e S. Alessio, in corrispondenzadel Priorato fletteva a 90° per scendere ripido verso Testaccio,seguendo l’antico tracciato romano oggi regolarizzato in via diPorta Lavernale. L’ingresso al giardino del Priorato avveniva,secondo una preziosa descrizione coeva dei lavori, da un’“aja, equesta angusta e sozzissima […] dentro l’imboccatura d’un vicolotanto più sconvenevole e stretto, il quale divideva il giardino dauna vigna de PP. di S. Savina, enfiteutica dello stesso gran Priora-to”. Giovan Battista Rezzonico “ricomperò da que’ Padri tantosito di detta vigna, quanto è bastato a spianare innanzi alla portaquella nuova piazza, la quale, mentre rende comodo e decorosol’ingresso del Priorato, ricrea chiunque passa per quel luogo adiporto”44. In diretta relazione coi lavori piranesiani, nel 1765 ilTribunale delle Strade deliberava la sistemazione della strada diMarmorata dal Tevere a Porta S. Paolo45.
L’evidente sforzo di riqualificazione urbana, sottolineatoanche dalla lapide celebrativa fatta apporre nel 1765 da G.B. Rez-zonico sul lato breve della piazza, esposta dunque “agl’occhi deviandanti al primo giungere in quelle parti” (fig. 21), cioè prove-nienti dall’accesso principale al colle attraverso la salita dal CircoMassimo, lungo la direttrice S. Sabina-S. Alessio, ottemperava an-che all’esigenza di razionalizzare l’ingresso facilitando il transito ele operazioni di manovra delle carrozze46, secondo una concretanecessità funzionale che aveva spesso modellato la viabilità urba-na, e di cui l’esempio più celebre, nel secolo precedente, era costi-tuito dallo slargo progettato da Pietro da Cortona davanti S. Maria della Pace. L’intervento piranesiano incideva pertantosull’intera viabilità del colle, che da secoli era percepito come
Fig. 13 - Roma, convento dei SS. Bonifacio e Alessio. Particolare di un corridoioal primo piano.
Piranesi a S. Maria del Priorato.Pochi anni dopo la conclusione dei lavori a S. Alessio, nel
1764 Piranesi, che arrivando ventenne a Roma nel 1740 era statoallievo-collaboratore di Nolli, è incaricato di riconfigurare l’adia-cente proprietà – la chiesa e lo slargo monumentale d’ingresso –di S. Maria del Priorato40. Unica sua opera architettonica realizza-ta e capolavoro della maturità, il complesso piranesiano si radicanelle sue ragioni stilistico-iconologiche nell’evocazione della sto-ria dell’antico Aventino; ma inevitabilmente, ritengo, non puòeludere un confronto diretto, e consapevole, con l’opera di rin-novamento del confinante complesso dei Girolamini.
La piccola chiesa dei Cavalieri di Malta è investita da un pro-cesso di rinnovamento che ne deve mantenere inalterata la strut-tura: l’interno è interamente ripensato secondo un disegno cheoblitera, attraverso un uniforme, candido rivestimento in stucco,
Mario Bevilacqua
127
Figg. 14-15 - Roma, convento dei SS. Bonifacio e Alessio. Scala principale, acces-so e particolare della ringhiera.
periferico e raggiungibile solo attraverso un percorsi disagevoli. La nuova piazza del Cavalieri di Malta, definita attraverso l’e-
sproprio di una porzione di vigna, e quindi la monumentalizza-zione del lato nord dove si apre l’ingresso ai giardini del Prioratoin asse col viale che traguarda la cupola di S. Pietro, e dei due nuo-vi muri di cinta a est e a sud, contrasta in modo stridente con lasemplicità del muro del confinante monastero di S. Alessio rico-struito, rettificato, nel 1749. Ma la straordinaria originalità archi-tettonica della piazza è stata indagata soprattutto nelle sue piùcomplesse ragioni iconologiche; restano forse da approfondire lemodalità, le ragioni e i modelli di riferimento – non solo archi-tettonici, ma anche urbanistici e funzionali – che hanno portanoalla sua ideazione e realizzazione.
La disposizione di elementi funerari nella decorazione deimuri di delimitazione, allusivi dell’affastellamento di monumen-ti lungo il tracciato extraurbano dell’antica via Appia47, evocandoi temi funerari legati alla storia antica del colle, ne sottolineaimplicitamente anche la lontananza dall’abitato. Impegnato intutta la sua opera in una profonda riflessione sulla topografia del-la città antica, Piranesi calibra il suo intervento ridisegnando lamaglia viaria circostante e progettando, per frammenti incastona-ti nello sfondo neutro di semplici muri che definiscono lo spazio,forse l’ultima piazza barocca della città48. L’asimmetria dell’invasospaziale appare evidente e, considerando la vicenda della sua for-mazione (creato ex-novo con l’esproprio di una parte di vigna giàgoduta in enfiteusi dal Priorato, e quindi a costo molto ridotto),evidenzia una volontà progettuale consapevole, priva di condizio-namenti dettati da preesistenze vincolanti49.
I giudizi dei contemporanei sulla realizzazione di Piranesiappaiono drastici: tanto da contribuire forse a spiegare la manca-ta traduzione in incisione della sua unica opera architettonica rea-lizzata (e l’ironia vuole che la sola raffigurazione del prospetto dellachiesa pubblicata Piranesi vivente sia quella incisa da Giuseppe Vasinella grande tavola con la Veduta dell’Aventino con la basilica di SanPaolo, del 1771; un artista attento come Thomas Jones, che fece intempo a conoscere Piranesi nel suo soggiorno romano nel 1778,disegna il crinale dell’Aventino ma non ritiene utile soffermarsi suidettagli del Priorato)50. È noto il giudizio espresso da Luigi Vanvi-telli appena saputo dell’incarico affidato a Piranesi nel febbraio1764: “È un fenomeno particolare che il pazzo Piranesi ardisca farl’architetto: solo dirò che non è mestiere da pazzi”51. A lavori anco-ra non ultimati, seppure in privato a Roma si commentava già chePiranesi “si è reso favola di tutta Roma, onde il Sig.r Ambasciatoredi Malta, che sta in Roma, e che è Signore d’un ottimo gusto in piùgeneri di cose, ebbe a dire, che se non esistessero altre fabbriche diquesto Secolo da qui a mille anni, fuori, che quella del Gran Prio-rato, si direbbe senza meno dai posteri, che nel secolo XVIII iRomani erano tornati a imbarbarirsi”52: posizione peraltro mitigatadalla redazione di una articolata e ufficiale “Descrizione delle Rin-novazioni fatte nella Chiesa di S. Basilio Magno su l’Aventino, spet-tante al Gran Priorato di Roma della Sacra Religione di Malta”53
che tende a giustificare l’esuberanza decorativa specificandone indettaglio le ragioni iconologiche.
Nel 1769 James Barry scriveva a Edmund Burke censurando ilgusto dell’architettura di Piranesi, “flowing out of the same cloa-
Nolli e Piranesi all’Aventino
128 Mario Bevilacqua
Fig. 16 - Roma, convento dei SS. Bonifacio e Alessio. Chiostro.
Fig. 18 - Roma, convento dei SS. Bonifacio e Alessio. Loggia verso il giardinopensile.
Fig. 17 - Roma, convento dei SS. Bonifacio e Alessio. Chiostro, particolare conla sistemazione del lapidario.
129
cus with Borromini’s”54. Nel 1771 Antonio Visentini, nelle sueOsservazioni al trattato di Teofilo Gallaccini sopra gli errori degli archi-tetti, a testimonianza della immediata diffusione di informazionie disegni della chiesa piranesiana, censura la ristrutturazione di S.Maria del Priorato subito dopo dopo aver censurato l’esuberanzadecorativa di porte e finestre del Trattato di Bernardo Vittone,accostando Piranesi ad Andrea Pozzo:
Lo stesso possiamo dire del Piranese, che vanta il nome d’Architetto spi-ritoso per aver ristaurato in Roma la Chiesa del Priorato dentro e fuori,sì per l’Architettura, che per gli ornati. Questo pure volendosi distin-guere più degli altri, immaginò un’Architettura secondo il suo capric-cio, e gli ornati parimente proporzionati al suo scarso giudizio, poten-dosi in ciò accompagnare col Posi, il quale s’impegnò nel ristaurare ilPantheon in tutto l’Attico, come dicemmo, il quale diè a conoscere ilcorto suo pensare. Di questi due Architetti può dirsi, che uniforme-mente al Padre Pozzi tutto rovinarono e sconvolsero nell’Architettura.Cosa veramente deplorabile ai nostri tempi per Roma, ove i suoi Arte-fici vanno guastando i pochi aurei avanzi dell’Antichità, sotto il reo pre-testo di vie più nobilitarla. È cosa pur da maravigliarsi, che dopo il PadrePozzi tutti gli Architetti sienosi appigliati a pensamenti lontanissimi dalvero, ed a veri seminarj d’errori55.
Ancora, in un testo rimasto manoscritto Visentini definivaPiranesi “povero spensierato”, che “pretende di esaltar Romasopra la Grecia al sommo, e la abasò per così dire al limo […] Lefolie del Piranese, son pure fantasie di un dicitor che studia di esal-tare le cose viste […]”; arrivando a concludere che Piranesi “sempreintende le cose fuori del suo luoco senza posata considerazione”56.Richard Norris, architetto e costruttore inglese, a Roma in viaggiodi studio nel 1771-1772, dove entra in stretto rapporto con Pirane-si, visita più volte il Priorato; il 15 aprile 1772 “went to the Chur-ch built by Piranesi and called the Priorato belonging to Card.lResonico”. Rispetto alla ridondanza di Visentini, Norris annotacon laconicità nel suo diario che “the Church is in my Opinionvery bad, a strange composition of Ornaments that mean nothing– some of which, that is to say some small parts of the Ornaments,are good, but on the whole is a part of confusion”57.
I giudizi sul complesso del Priorato non sembrano inserirsi inquel disagio montante, dalla metà del secolo, di fronte al rinno-
vamento “alla moderna” delle antiche basiliche romane (Piranesistesso sembra voler prendere le distanze dall’idea di “restauro”,secondo l’uso lessicale settecentesco, dichiarando di aver voluto“rinovare, anziché ristorare”)58; riflettono piuttosto l’incompren-sione per una confusione decorativa che offusca la logica sintatti-ca dell’architettura, e la stessa funzionalità dell’intervento urbano,che non a caso, omesso dallo stesso Piranesi nella sua Pianta diRoma del 1773 (fig. 22), verrà registrato dalla cartografia romanasolo a un secolo di distanza59.
L’Aventino di Piranesi: ordine, caos, magia, sogno. Le origini e le ragioni della “confusione decorativa” che lascia
perplessi i contemporanei di Piranesi sono complesse, e traggonoorigine anche da una autonoma riflessione sull’architettura, oltreche antica, tardoantica e altomedievale, come assemblaggio diframmenti, strutturali e decorativi, di tipo ed epoche diverse, rise-mantizzati in insiemi nuovi. Nel primo dei suoi taccuini modene-si, utilizzato nella seconda metà degli anni ’40, Piranesi cita ripe-tutamente esempi evidenti della fortuna moderna di questa con-cezione architettonica e decorativa, che sconfina con quegli aspet-ti “parlanti” – dalle “parlanti ruine” giovanili alla maturazione diuna personalissima iconologia che si fa vera e propria “architettu-ra parlante” anche sulla scorta della lezione borrominiana persovrapposizione di segni e simboli60: i prospetti interni del cortiledi palazzo Mattei di Giove; i fronti di villa Borghese e villaPamphili; la facciata di S. Nicola in Carcere. Più tardi, Piranesiciterà nel Ragionamento Apologetico la casina di Pio IV di Ligorio,dalle cui piante di Roma antica pure trae l’idea di caos della topo-grafia dell’Urbe, negando alla nuova piazza del Priorato una piùevidente chiarezza di sviluppo regolare e simmetrico61.
Un edificio che colpisce in modo forte l’immaginazione diPiranesi fin dagli anni ’40, venendo a costituire una matrice diriferimento sostanziale nell’evoluzione della sua poetica architet-tonica, è poi anche la cosiddetta Casa dei Crescenzi alle radici del-l’Aventino62, legato, per diretta associazione, ai processi inventividi Borromini, con l’ovvio rimando soprattutto alla ristrutturazio-ne di S. Giovanni in Laterano. Piranesi teorizza la libertà dell’as-
Nolli e Piranesi all’Aventino
Fig. 20 - Ferentino (Frosinone), convento di S. Francesco.Fig. 19 - Roma, convento dei SS. Bonifacio e Alessio. Facciata sulla corte.
131Nolli e Piranesi all’Aventino
semblaggio decorativo dell’architettura nel Parere, opponendosi alfunzionalismo razionalista di stampo lodoliano, che ridurrebbe laprogettazione a “vile mestiere”: un richiamo alla montante cor-rente neoellenica, ma anche, riprendendo una polemica tuttabottariana (nei Dialoghi), una opposizione all’“architettura deicapomastri”, funzionale, seriale, priva di invenzione colta63.Un’“architettura lombarda” di cui Nolli, geometra e capomastroformato nell’ambito di quella funzionalità esaltata dal bottarianoFabio Devoto nella ristrutturazione di S. Alessio, era invece unesponente di punta: come attestano le opere realizzate nel Laziomeridionale, tra Velletri, Sezze, Ferentino, Ceccano, con inter-venti funzionali e perizie elaborati nell’ambito di quella prassiconsolidata tra maestranze comasche insediate a Roma e nelLazio sulla scia di una secolare migrazione.
Piranesi procede per sovrapposizioni di elementi derivati eclet-ticamente da una conoscenza profonda dell’antichità e dei suoicodici architettonici e decorativi, e sembra riproporre nell’asim-metria della nuova piazza del Priorato il caos magmatico e monu-mentale idealizzato nella topografia del Campo marzio antico, chepure è basato, come le sue piante di Roma del 1756 e del 1773,sull’esatto rilievo scientifico della città moderna offerto dalla Nuo-va Pianta di Roma di Nolli del 1747.
Come per magia, come in un sogno, l’esuberanza e l’ecletti-smo dei processi compositivi di Piranesi, stridenti con la sensibi-lità classicista e col pragmatismo utilitario, ma funzionali alla con-cretizzazione di un’idea esasperata di magnificenza, trovano pre-coci sintonie con la modernità romantica: come sintetizza inmodo evocativo un critico inglese nel 1811, in Piranesi “all thegrand architectural forms of Egypt, Greece, and Italy, appear to beassembled as if by magic”64.
Magia e sogno diventano allora le cifre attraverso cui leggerel’Aventino di Piranesi. Horace Walpole dedica a Piranesi un lun-go paragrafo nell’introduzione al quarto volume dei suoi Anecdo-tes of Painting in England (1771), in cui indica come modello perl’architettura dei suoi tempi “the sublime dreams of Piranesi”.Thomas Jenkins, scrivendo al collezionista inglese Charles Town-ley da Roma nel 1774, allude all’ambiguo statuto del “sogno” inarchitettura: “his works are as you know mere dreams”. In unaneddoto che ripropone topoi classici, ma che si tinge ora, al tra-monto del secolo dei Lumi, di venature massoniche e libertarie,Piranesi pare affermasse: “J’ai besoin de produire de grandesidées, et je crois que si l’on m’ordonnait le plan d’un nouvel uni-vers j’aurais la folie de l’entreprendre”65. “Piranesi fameuxrêveur”, riassume con giudizio ambiguo Pierre-Adrien Pâris66,
Fig. 22 - GIOVAN BATTISTA PIRANESI. Pianta di Roma e del Campo Marzio (acquaforte, 1773), particolare con l’Aventino.
132
ripreso pochi anni dopo da Boullée, che ammira e censura inmodo ambivalente “l’art fantastique” di Piranesi, fatta di “idéejetées ça et là, sans suite, sans liaisons, sans but, des désordres d’e-sprit, en un mot des rêves”67.
Un disegno di Piranesi, genericamente schedato come Vedutacon barche a vela di fronte a una città ai piedi di una catena montuosa68
(fig. 24), sembra riflettere con efficacia questo irrefrenabile biso-gno di creare realtà magiche, oniriche e grandiose, pur semprepartendo da dati concreti analizzati con acribia e attraverso l’ap-profondimento dell’iconografia storica. Come nel processo dicrescita irrefrenabile del Campo marzio, Piranesi costruisce unavisione monumentale dell’Aventino trasfigurando l’oggettività
della veduta classica del colle da Ripa grande, codificata dasecoli di vedutismo, da Duperac (fig. 23) a Lorrain, a Poussin69:di fronte a un porto fluviale animato di vascelli si ammassanole grandiose costruzioni di un quartiere monumentale che, dalfiume, si inerpicano rigogliose sul fianco scosceso del colle:immagine visionaria, onirica della magnificenza dell’anticoAventino imperiale.
Sogno e magia si sovrappongono al caos topografico e all’assem-blaggio eclettico e ridondante di spolia: nell’arco di pochi decenni, trala ristrutturazione di S. Alessio e il completamento della chiesa e del-la piazza di S. Maria del Priorato, sul crinale dell’Aventino si consu-mano esperienze e si avviano forme espressive antitetiche.
Mario Bevilacqua
Fig. 24 - G.B. PIRANESI. Veduta con barche su un fiume (l’Aventino dalTevere) (disegno; Vienna, Albertina da Birke, Kertesz 1997).
Fig. 23 - ETIENNE DU PÉRAC. Veduta dell’Aventino dal Tevere (acquaforte, 1569-1575 circa).
133
NOTE
* Abbreviazioni: ASCC=Archivio Storico del Comune di Ceccano (Fr);ASPS=Archivio Storico dei Padri Somaschi, Morena (Rm); ASR=Archivio diStato di Roma; BAV=Biblioteca Apostolica Vaticana; BCV=Biblioteca Comu-nale di Velletri (Rm); BEUM=Biblioteca Estense Universitaria, Modena;BLL=British Library, Londra.
1 M. BEVILACQUA 2008.2 Su Revillas vedi M. PEDLEY 1991; M. BEVILACQUA 1998a. Le sue carte,
disperse nell’800 insieme a tutto l’archivio di S. Alessio, sono oggi in buona par-te conservate alla British School at Rome; alcuni manoscritti sono a Berlino,Staatsbibliothek, Lat. fol. 61. Parte del carteggio è stato venduto all’inizio del’900 (F. Tonetti 1901), mentre singole lettere sono disperse in biblioteche italia-ne e straniere: segnalo qui una lettera inviata al confratello Carlo Herbert “pub-blico lettore nello studio di S. Barbaziano a Bologna”, da Roma, 29 agosto 1739,indicativa dell’impegno dello studioso e dell’interesse che che rivestirebbe l’inte-ro carteggio: “Ringrazio ben distintamente la P.V.M.R. del gradimento con cuiha ricevuta la mia Topografia Tiburtina, la quale non è che una piccolissima par-te delle fatiche nelle quali mi trovo impegnato per pubblicare, come spero, quan-to prima un’Opera in materia antiquaria, e geografica. Molti eruditi inglesi, chene han veduto qualche saggio, mi vanno stimolando a sollecitare la stampaanche con uimpegno di soccombere in parte alla spesa, la quale a cagione demolti rami, sarà considerabile. Ella intanto mi fa molto onore col voler inviareall’accademia di Lione la suddetta carta. Le operazioni fatte al Nord dagli Acca-demici di Parigi trovano molti contraddittori. In questi giorni i PP. Gesuiti condue Pubbliche Tesi Matematiche hanno proccurato di buttarle a terra. Io nonso, se loro riuscirà. Io le trovo assai esatte. Ma per determinarmi, aspetto quelledell’Equatore. Prima, che uscisse il libro di Maupertuis io aveva letta la Criticadi M. Celsius sopra quelle di M. Cassini il vecchio, e le risposte di M. Cassini ilGiovine. Certamente vi sono da un canto, e dall’altro ragioni assai forti: e per-ciò son persuaso doversi aspettare il risultato delle predette osservazioni sotto l’e-quatore. Gli Elementi Newtoniani di M. de Voltaire non hanno qui avutogrand’applauso. Maggiore crederei dovesse averlo il commento, che si fa su laFilosofia di Newton da due PP. Minimi della Trinità de Monti, che sono i PP.Jaquier, e le Seur. Il p.o tomo di quest’Opera s’attende a momenti da Genevra,ove si stampa. Questi Religiosi vi hanno molto faticato; e la loro capacità nel cal-colo fa sperare un buon esito alle loro fatiche […]” (BEUM, autografi Campori).
3 F. NERINI 1752; sull’opera, per più versi criticata dai contemporanei, cfr.M. Bevilacqua 1998b e 2002.
4 B. MANCINI 1787, p. 38.5 M. BEVILACQUA 1998b e 2002: l’attribuzione a Baader viene accolta da D.
RADEGLIA, L’affresco della biblioteca del convento, in O. MURATORE, M. RICHIELLO
2004, pp. 144-146, che riporta anche l’iscrizione, in puro “stile encomiasticoneriniano”, posta in un cartiglio retto dalla figura allegorica della Musica: “Vivasempre Fellice Nerinni Abbas Generalle 1754 pinxit”.
6 Il grande olio su tela, firmato, è ora in collezione privata; non è impossibi-le che Baader sia autore anche dei quattro ovali a olio coi ritratti di Diego Revil-las (forse copia da un originale di Georg Caspar von Prenner inciso da CarloNolli), Felice Nerini (inciso da S. Mannelli da un originale di Baader del 1753),Benedetto XIV e Clemente e XIV, inseriti nei lati della volta dell’anticamera del-la biblioteca.
7 BAV, Vat. lat. 9024; M. Bevilacqua 1998a, p. 31. 8 Casale Monferrato, Biblioteca Civica, Archivio Canina, mazzo 11, fasc. 183,
“Relazione della scoperta del Circo Adriano fatta ne’ Prati di Castello S. Angeloper ordine di N. S. Papa Benedetto XIV con alcune riflessioni e memorie spet-tanti al medesimo circo” [Memoriale indirizzato al pontefice da “Diego de Revil-las ab. gen., dall’Ospizio di S. Alessio, 14 ottobre 1743”]. Ringrazio SusannaPasquali per la gentile segnalazione.
9 M. PEDLEY 1991.10 M. BEVILACQUA 1998. 11 M. BEVILACQUA 2007.12 M. BEVILACQUA 1998b e 2002; sulle vicende architettoniche più antiche
del complesso di S. Alessio vedi L. ZAMBARELLI 1924; O. MURATORE, M.RICHIELLO 2004.
13 Per gli atti e le perizie presentate nel corso della causa contro Rinaldi cfr.M. BEVILACQUA 1998b.
14 Vedi sotto, nota seguente.15 Dell’archivio dei Girolamini di S. Alessio, andato disperso già alla fine del
’700, si conservano acuni fascicoli in ASR, Congregazioni religiose maschili,Girolamini in S. Alessio, b. 2097; poche carte sparse, per lo più sette-ottocente-sche, sono presso l’ASPS, oggi a Roma, località Morena (ringrazio il padre archi-vista don Maurizio Brioli per la gentile disponibilità; cfr. anche M. BEVILACQUA
1998b), dove sono anche i preziosi registri delle scritture (cronologico e per sog-getto) redatti nella seconda metà del ’700, da cui è possibile ricostruire la for-mazione delle proprietà di S. Alessio, sull’Aventino oltre che a Roma e nel Lazio,a partire dal XV secolo.
Riporto l’indice della “cartella A”, in cui era conservata la documentazionepiù specificamente attinente la fabbrica della chiesa e del monastero, da cui ècomunque possibile ricavare una serie di dati cronologici (cfr. M. BEVILACQUA
1998b):“Indice generale delle Scritture che si trovano nell’Archivio di S. Alessio
divise in Cartelle come segueCartella AChiesa, e Monistero di S. AlessioAnno 1577. Lavori di Bartolomeo, e Mastro Domenico Muratori fatti intor-
no la Chiesa, e’l Monastero di S. Alessio, e loro quietanze […] Numero I1589. Spese fatte nell’edificare l’Altar maggiore […] II[…]1674. Istrumento pel trasporto della Madonna dalla Navata di mezzo alla
cappella, ove è tuttora […] IV1740. Convenzione fatta dal Monastero con Girolamo Mariani per la spesa
e fattura di più aparati […] VI1741. Conti de Muratori, Stagnaro, e Chiavaro nella nuova fabbrica del
Monastero di S. Alessio, e loro saldo […] VII1743. Memorie per la fabbrica della Chiesa, e del Monastero […] VIII1743. Danaro speso nella fabbrica della Chiesa di S. Alessio, oblazione fatta
per la Scala del Monastero. Conto, e saldo d’ogn’opra del Sig.r Blasio, e del-l’Imbiancatore […] IX
1746, e 47. Scritture pro, e contro le pretese di Gio. Batta Noli per l’assi-stenza prestata alle fabbriche della Chiesa, e del Monastero, di lui quietanza, ericevuta di scudi 50 in graziosa ricognizione […] X
1748. Scritture per la lite contro il Capo mastro Bartolomeo Rinaldi per lafabbrica della chiesa […] XI
49 e 50. Scritture per l’Emo Querini contro il d.o Rinaldi […] XII- 50. Scritture contro il Rinaldi per la fabbrica del Monastero […] XIII52. Conto della Porta di noce che chiude l’appartamento del P.A.; ordini
del falegname pel pagamento, e conto Almerici […] XIV-53. Scandaglio dell’importo de lavori d’ogni arte fatti nella fabbrica della
chiesa a spese del C. Querini […] XV57. Conto del Chiavaro per lavori fatti per la chiesa, altro conto, e suo saldo
[…] XVI57. Ragioni dell’Architetto De Marchi per la fabbrica della Chiesa e del
Monastero, e sua ricevuta […] XVII1761, e 63. Scritture per il Monastero di S. Alessio contro il Borgondi per la
statua di Benedetto XIII e sua ricevuta […] XVIII- Oblazioni fatte da Monaci per la Fabbrica del Monastero di S. Alessio […]
XIX- Notizie spettanti alla Cappella Bagni […] XX- Inventario delle Robe lasciate dal S. C. Bagni ad uso della Cappella, che
poi devono spettare al Monastero […] XXI1763. Memorie spettanti al Monastero, ed alla Chiesa […] XXIIQuattro cartelle di Luoghi di Monte date al Monastero da Mons.r Bagni per
l’obbligo delle MesseAltra cartella del Monte Fede per le Messe del Lunedì e del Sabbato. Vedi
tirat. I […] XXIII1768. Copia d’Istrumento fatto con Mons. Gian Franc.o Bagni per la ces-
sione di due Luoghi di Monte per soddisfazione del Legato C. Bagni, e di quat-tro altri pel Legato Mons.r Ricciardo […] XXIV
Scritture per gli argenti stati impegnati al Monte in occasione della fabbricadel Monastero […] XXV
Nota de rami nuovi stati fatti per la cucina, ed altre spese spettanti alla stal-la […] XXVI
Nolli e Piranesi all’Aventino
134
[…]Cartella HContiene varie cose spettanti al Monastero di S. Alessio[…]1753. Convenzione collo Stuccatore per la Porteria del Monastero […] VI[…]- Convenzione col Ferraro […] X- Capitoli per le cave di tavolozze, ed altri materiali […] XI- Diverse altre convenzioni […] XII”.16 Nella “pianta piccola” di Nolli, incisa nel 1743 e non aggiornata, come
invece la “pianta grande”, il monastero e la chiesa non presentano alcuna trac-cia dei lavori intrapresi da Nolli e Revillas.
17 J. ZÄNKER …; M. BEVILACQUA 1998a, pp. 164-167.18 M. BEVILACQUA, M. NOCCA 2006.19 Un elenco dettagliato degli interventi promossi da mons. Borgia a Feren-
tino e in tutta la diocesi è riportato in diversi appunti da lui stesso compilati:BCV, ms. VI.29, Fabrizio Borgia, Memorie di Ferentino (ringrazio Filippo Aliver-nini, Responsabile della Biblioteca, per la gentile disponibilità).
20 Ibidem.21 L’intervento di Nolli nella ricostruzione della chiesa di Ceccano, sfuggito-
mi nello studio del 1998 (M. BEVILACQUA 1998a) era stato segnalato da SINDICI
1893, sulla base di un registro di verbali della Comunità che, oggi non più pre-sente nell’ASCC, ho potuto rintracciare nell’Archivio della collegiata di S. Gio-vanni (Registro di verbali della comunità di Ceccano [c. 149v, 4 aprile 1741]: “Sipropone alle Sig.re VV come fin dal mese di maggio pross.to il sig. arcipreteordinò al sig. Gio. Batta Nolli architetto, che facesse la pianta della chiesa nuovada fabricarsi nell’istesso sito, dove è la presente e questa in parte disfarla, edhavendo ora d. Sig. Nolli mandata la pianta sud.a in tre maniere, il tutto si faintendere alle SS. Loro se sì o no stimano necessario far detta chiesa nuova, equale delle tre piante mettere in opera, però risolvino il loro parere […] [c. 150]Alla prima proposta ha arringato il sig. Francesco Donaggi uno de sig.ri Consi-glieri ed ha detto essere necessarissimo fare la nuova chiesa per maggior com-modo del Popolo, atteso [c. 150v] che la chiesa presente è assai angusta, e noncapace di ricevere la metà della gente del paese per essere questo in gran quan-tità cresciuto, e stimasse bene si mettesse in opera la pianta a tre navate per esse-re più grande, e di comparenza, e rispetto alla spesa supplicare Monsignor vesco-vo di Ferentino [Fabrizio Borgia] acciò voglia far contribuire li luoghi Pii, ed inquanto alla Communità si dia la facoltà alli Sig.ri sindico ed officiali di poter ele-gere li deputati, e commandare per turnum li contadini per la sud.a fabrica, efarvi altre cose necessarie, onde chi approva detto arringo ponghi nel bussolo lapalla bianca, e chi lo disapprova la negra [l’esito è di 21 palle bianche, 3 nere]”.Il 20 agosto si deliberava che […] “Sarebbe necessario di far li deputati per darprincipio alle calcare per la fabrica della nova chiesa […] far tagliare li legnami perla legna per le calcare alla selva della comuinità Faito, e di commandare il Popo-lo” [c. 53v, 20 agosto 1741]. L’anno successivo il consiglio riporta “Che mons Ill.Vescovo insiste che si fabrichi in questo luogo la nuova chiesa o che si ampli lapresente già che si vede non esser più capace per tutto il Popolo, oltre la struttu-ra indecente che ha, esibendo far contribuire per la loro rata li luoghi pii per laspesa che occorrerà che la comunità nostra dasse almeno cinquanta scudi annuioltre l’opere degli abitanti […]. Quando la comunità sarà in stato di erogar lisopravanzi nella fabrica della chiesa venuta che sarà la licenza dalla sagra con-gregazione del Buon Governo si diano l’anno scudi cinquanta durante la fabri-ca et il tutto è stato approvato” [c. 165r-v, 15 maggio 1742]. Dopo una lacuna tra1742 e 1749, il 25 aprile 1751 si riporta che “Essendo stato mons. Ill.mo BorgiaVescovo di Ferentino in questa terra in visita ha fatto tutte le premure per ridur-re a fine la fabrica della nuova chiesa di S. Gio Battista anche in seguela d’altrepremure fatte da S. Ecc.za con lettera all’Ill.mo sig.re Uditore, e doppo fatti mol-ti discorsi per terminare detta fabrica, non si è trovato il modo di avere li denarinecessari per la qual causa resta incagliata la prosecuzione della sud.a fabrica,onde si è pensato che la Comunità debba soccombere a qualche contribuzioneper detta fabrica, e però dicano il loro parere […]. Risoluzioni: Alla prima pro-posta arringa il sig Pietr’Angelo Gizzi, e dice che se bene la Comunità abbia con-tribuito alla fabrica della chiesa li denari dell’organo, e della predica, oltre l’an-gariamento del popolo comandato per assistere a muratori, e per condurre imateriali, tutta volta per dar vedere che con tutto il zelo si desidera l’ultimazionedella fabbrica della chiesa, non ostante che la comunità si angustiata, lui sareb-
be di parere che si dassero alla med. Fabbrica scudi cento moneta dentro il ter-mine di due anni da principiare doppo che se ne sarà ottenuta la licenza, edapprovazione dalla Sagra congregazione del Buon Governo, avanti la quale,restando accettato il presente arringo, dovranno li ss.ri sindaci, et officiali insi-stere […]” [l’arringo è approvato con 13 voti a 11; cc. 218-219]).
Dal “Libro d’Amministrazione della V. Chiesa di S. Gio. Battista di Cecca-no”, relativo agli anni 1721-1774, si evince come anche durante la ricostruzionela chiesa dovette continuare ad essere officiata; nel libro sono riportati i paga-menti all’architetto nel dicembre 1743: “fatti pagare in Roma al sig. Nolli scudidieciotto per final pagamento della Pianta della nova chiesa, come per ricevutadel medesimo” [c. 167 ], e nel 1750 al pittore Giacomo per gli affreschi della vol-ta della navata centrale: “Pagati al sig. Giacomo pittore per aver fatto le quattropitture al soffitto della nuova chiesa sc. 21” [c. 205]. Ringrazio la Responsabiledell’Archivio Storico Comunale, e don Franco Quattrociocchi, parroco di Cec-cano, per la gentile disponibilità.
Monsignor Fabrizio Borgia vescovo di Ferentino registra nei suoi appunti,alla data 1742: “principiata la fabrica della nuova chiesa matrice della terra diCeccano, quale ora sta a buon termine” (BCV, ms. VI.29).
Nel marzo 1755, quando la Comunità di Ceccano “umilmente espone,come essendo stata di pianta rifatta la Chiesa matrice in d.a Terra, per orna-mento della medesima, e per comodo del Giudice, e Magistrato è necessario fareivi un nuovo Banco Priorale per esser il vecchio tutto tarlato, ed inutile” (ASR,Buon Governo, II serie, b. 936), i lavori dovevano essere pressoché terminati.
22 Il nuovo monastero voluto e iniziato dal vescovo mons. Fabrizio Borgia(1729-1754), è portato a compimento dal suo successore Pietro Paolo Tosi di Bel-vedere (1754-1798). La consacrazione della chiesa è ricordata da un’iscrizioneall’ingresso con la data 1760; cfr. B. CATRACCHIA 1980. L’attribuzione a Nolli èavanzata da M.T. TODARO 1993, p. 125, che però non cita esplicite fonti docu-mentarie. Nei suoi appunti mons. Borgia ricorda diverse elargizioni per laristrutturazione e ampliamento del monastero (BCV, ms. VI.29).
23 Ibidem.24 P. PORTOGHESI 1966 (e edizioni seguenti); L. BARTOLINI SALIMBENI 1987;
A. BUSCHOW 1987; C. VARAGNOLI 1990-1992; S. PASQUALI 1996. 25 F. BELLINI 1995; C. VARAGNOLI 1995.26 S. PASQUALI 1996.27 A. DEGRASSI 1943; P. PENSABENE 1982.28 Le pergamene dell’archivio di S. Alessio vengono riordinate nel 1743-1747
(M. BEVILACQUA 1998b, p. 117, n. 58; un regesto manoscritto della secondametà del ’700 è in ASR, biblioteca, ms. 447).
29 F. Nerini 1752; un volume manoscritto della seconda metà del ’700 concopie di atti originali del XIII-XV secolo dall’archivio di S. Alessio è in ASR,biblioteca, ms. 447.
30 Il 19 agosto 1749 i Maestri di strade rilasciavano licenza per la rettificazio-ne del muro, dal filo di quello adiacente del Priorato all’antico protiro d’ingres-so di S. Alessio (ASR, Presidenza delle Strade, vol. 64, c. 98v: P. MICALIZZI 2003,II, p. 131).
31 A.M. PIRAS 1994; M. BEVILACQUA 1998a, pp. 32 La scala, che non compare nella Nuova Pianta di Roma di Nolli, dove inve-
ce sono riportate in modo preciso, nella rilavorazione delle matrici eseguita tra1743 e 1747, le aggiunte alla fabbrica del monastero, è citata come in esecuzionenel 1743 nell’“Indice generale delle Scritture che si trovano nell’Archivio di S.Alessio” in ASPS (vedi sopra, nota 15).
33 ASPS, “Indice generale delle Scritture che si trovano nell’Archivio di S.Alessio” (vedi sopra, nota 15); per l’iscrizione: V. Forcella.
34 S. JACOB 1975, n. 897; M. BEVILACQUA 1998b, p. 104; O. MURATORE
2004, pp. 91-93. In relazione alle differenze tra la struttura e il disegno, nonritengo plausibile che quest’ultimo possa essere considerato una proposta diintervento successivo a quanto già edificato.
35 M. BEVILACQUA 1998a, p. 149.36 G. LA MASTRA 2006, p. 158: nel 1746-1747 Nolli è pagato dal principe Sci-
pione Santacroce “per aver preso le misure del Casino della Villa fuori porta S.Giovanni, e formatane la pianta del pianterreno del casino vecchio col progettodell’ingrandimento di due stanze laterali una per parte in facciata colla piantadel piano nobile, e scala per renderla più agevole” (ASR, archivio Santacroce, b.1260, fasc. 10, ins. 5, Conti e apoche, 1568-1806, cc. non numerate). RingrazioMaria Barbara Guerrieri Borsoi per la segnalazione.
Mario Bevilacqua
135
37 Gli interventi al castello di Ceccano, comprendenti anche l’ala di edificisulla piazza, sono databili 1734-1736, e vengono assegnati a Nolli e ai suoi paren-ti capomastri dal contestabile Fabrizio Colonna (ringrazio Carlo Cristofanilliper l’importante segnalazione, da documentazione dell’archivio Colonna oggiconservato nella biblioteca abbaziale di S. Scolastica di Subiaco); la strutturaattuale, in corso di restauro, si presenta nella veste neo-gotica conferitagli allafine dell’800 da Antonio Cipolla su commissione del nuovo proprietario mar-chese Filippo Berardi.
38 Per Sezze vedi M. BEVILACQUA 1998a, pp. 151-152. A Ferentino lavori diriattamento settecenteschi sono ricordati nelle note di mons. Borgia (BCV, ms.VI.29), e, in termini più generali, da B. CATRACCHIA 1980, pp. 176-181. Nonresta purtroppo riscontro nelle poche carte del convento conservate presso l’Ar-chivio storico della Provincia romana dei Frati minori conventuali (ringraziopadre Piacentini per la gentile disponibilità).
39 “sic procet Insubriae, sic aedificatur apud nos. Ridicula est nobis eamagnificentia, quae non Commodo, et ornatus ornamentibus addit inanes”: F.DEVOTO, Epistola ad Reverendissimum Patrem D. Felicem Maria Nerinium SS. Boni-facii et Alexii Hiieronymianum Abbatem post editionem romanam, in appendice aNERINI 1752, e anche in edizione autonoma, Brescia 1752; F. DEVOTO 1763; sul-l’autore cfr. M. BEVILACQUA 1998b, pp. 112-114.
40 Sul complesso piranesiano di S. Maria del Priorato vedi il saggio di FabioBarry in questo volume; per un inquadramento essenziale, con estesi rimandibibliografici: J. WILTON-ELY 1976, 1992 e 2007; M. TAFURI 1978; D. GALLAVOT-TI CAVALLERO, R.U. MONTINI 1984; e i saggi di Joseph Connors, Bruno Contar-di e John Wilton-Ely in B. JATTA 1998.
41 P. PORTOGHESI 1966, p. 440; J. WILTON-ELY 1993, p. 114; F. BARRY 2006;vedi il saggio di Fabio Barry in questo volume.
42 M. BEVILACQUA 1998a, pp. 154-155. 43 Libro di stima dei lavori a S. Maria del Priorato, ottobre 1764-novembre
1766, conservato alla Avery Library della Columbia University, partita n. 51 ess.; 90; 726-729 (fotocopia del ms. presso la Biblioteca dell’American Academyin Rome).
44 Archivio Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta, Roma, M11,pubblicato da J.E. CRITIENS 1998.
45 ASR, Notai del Tribunale delle Acque e Strade, vol. 164 (anno 1765), c.196: appalto per il riattamento di via Marmorata dal fiume a porta S. Paolo.
46 S. PASQUALI 2009, p. 56.47 W. KÖRTE 1933; J. WILTON-ELY 1976, p. 222, F. BARRY 2006.48 F. BARRY 2006.49 È interessante rilevare come la creazione della nuova piazza sembri poi
innescare un rapido processo di sistemazione lungo il crinale dell’Aventino: a S.Alessio la costruzione del nuovo corpo d’ingresso a due ordini in sostituzione diquello antico, caratterizzato dal pronao medievale, viene avviata forse secondoun progetto attribuibile a Paolo Posi, anche se ancora in attesa di verifiche docu-mentarie (M. Bevilacqua 1998b). Il corpo di fabbrica è edificato prima degli anni
’70 del ’700, quando è raffigurato, a un unico ordine, nell’incisione di Giovan-ni Maria Cassini del 1779; nel primo ’800 venne sopraelevato di un piano. Ai pri-mi dell’800, come riportato dal catasto Piano (1819-1822), si apre lo slargo a ese-dra di fronte all’ingresso della chiesa, in asse col portale e il viale d’accesso dellavigna dei Girolamini, che diventerà, nel ’900, l’attuale piazza S. Alessio: un inter-vento di regolarizzazione secondo schemi di stretta simmetria e ortogonalità, bendifferenziato dall’irregolarità planimetrica del taglio piranesiano al Priorato.
50 Per Vasi cfr. B. JATTA 1998, pp. 144; il disegno di Thomas Jones è conte-nuto nel suo taccuino italiano, oggi al British Museum.
51 F. STRAZZULLO 1976-1977, II, p.52 Lettera dell’abate Amaduzzi a Giovanni Bianchi, 1765; l’ambasciatore di
Malta era il bali de Breteuil, già committente di Piranesi: S. PASQUALI 2006, p.194.
53 Archivio Magistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta, Roma, M11,pubblicato da J.E. CRITIENS 1998. Non è impossibile ipotizzare che il disegnodella facciata della chiesa, conservato oggi al Soane’s Museum di Londra (J. Wil-ton-Ely in B. JATTA 1998, pp. ), venisse realizzato per un’incisione da allegare auna pubblicazione celebrativa di questo genere.
54 J. SCOTT 1975, p. 220.55 A. VISENTINI 1771, p. 48.56 Venezia, Biblioteca del Museo Correr, ms. Cignogna 3656: A Visentini,
“Il Contra Rusconi”, cit. in E. BASSI 1977, pp. 440-441.57 BLL, Add. ms. 52497C c. 56, cit. in M. BEVILACQUA 2008, I, p. 288.58 Cfr. F. BARRY 2006.59 Nella seconda metà del ’700 nessuna pianta della città riporta l’interven-
to urbano piranesiano di piazza dei Cavalieri di Malta. La Pianta di Roma e delCampo Marzio pubblicata da Piranesi nel 1773, ricalca senza aggiornamenti quel-la piccola di Nolli. La piazza del Priorato è correttamente rilevata solo nella pian-ta del catasto Pio-Gregoriano del 1819-1822 (e quindi nella pianta della Direzio-ne Generale del Censo, pubblicata nel 1829), ma ancora ignorata dalla quasitotalità delle piante (fanno eccezione quelle di G.B. Cipriani del 1830 e di Filip-po Troiani del 1839) fino all’Unità d’Italia.
60 Per una lettura di sintesi su questi temi: M. FAGIOLO 1999.61 Sull’influenza di Ligorio su Piranesi vedi M. TAFURI 1972 E 1978; M.
FAGIOLO 1991 e 2009.62 M. BEVILACQUA 2008, I; M. BEVILACQUA 2009.63 G.G. BOTTARI 1756.64 PHILOGRAPHICUS 1811, p. 191.65 G. EROUART, M. MOSSER 1978, p. 248.66 “Observations” a Desgodetz, 1781 ca. (P. PINON 2007, p. 341).67 “Architecture. Essai sur l’art”, 1788 ca. (ed. a cura di J.M. Pérouse de
Montclos, Paris 1968; cit. in P. PINON 2007, p. 341).68 V. BIRKE, J. KERTESZ, IV, 1997, p. 2239, inv. 23640; penna, acquarello gri-
gio e bruno; mm. 140x192.69 Cfr. B. JATTA 1998.
Nolli e Piranesi all’Aventino