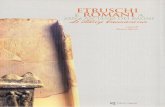La Collina dei Morti: Brevi Informazioni sulla Necropoli di Tuvixeddu
La necropoli di Villa Doria Pamphilj sulla via Aurelia antica
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of La necropoli di Villa Doria Pamphilj sulla via Aurelia antica
29ARCHEOLOGIA SOTTERRANEAn. 7 | ottobre | 2012
La necropoli di Villa Doria Pamphiljsulla via Aurelia antica
Il colombario di Scribonio Menofilo
La topografia antica di villa Doria Pamphilj può essere pienamente compresa se la si considera a diretto contatto con il quartiere sorto sulla riva destra del Tevere.
In particolare il Trastevere (Transtiberim = al di là del Tevere), entrato a far parte ufficialmente del-la città con la suddivisione augustea della stessa in regiones e la costituzione della XIV regio proprio con il nucleo abitato della riva destra, era caratte-rizzato da aree a forte densità abitativa frammiste ad aree a destinazione lavorativa da collegare stret-tamente con le attività e i traffici commerciali che si svolgevano lungo il fiume e che facevano capo al vecchio porto fluviale del Foro Boario sostituito, in età imperiale, dall’Emporium, scalo fluviale più ampio e attrezzato.
Ma anche gli assi viari sono coinvolti dalle stes-se attività; in particolare la via Campana–Portuense (attuale via della Magliana e via Portuense) che at-traversava un territorio ricco di horrea (magazzini per lo stoccaggio delle merci destinate ai mercati di Roma) e la via Aurelia che ricalcava una vecchia via di penetrazione nel territorio etrusco.
Resti di magazzini e di altri edifici con tracce di attività produttive sono stati rinvenuti lungo l’at-tuale via Portuense, nel cuore del quartiere Traste-vere, su via della Lungara e lungo la via Aurelia nel tratto urbano che si dirige verso la sommità del Gianicolo.
Certamente già alla fine della fase repubblicana
e, ancora maggiormente, in età imperiale, il quartie-re era abitato da piccoli commercianti ed artigiani: conciatori di pelli, falegnami, mugnai che sfruttava-no la forza motrice dell’acqua del fiume, lavoratori portuali impegnati negli scali lungo il fiume.
Soprattutto la materia prima che proveniva da alcune aree del Gianicolo e dei Monti Vaticani ren-deva possibile una intensa attività di vasai e di ope-rai delle fornaci (attività, peraltro, rimasta immuta-ta fino al XIX secolo e di cui rimane traccia nei resti di edifici di fornaci e nella toponomastica, via delle Fornaci, Porta Fabrica, Valle dell’Inferno, Quartiere dei Fornaciari, ecc.) e di cavatori di tufo e pozzola-na dalle aree di Monteverde.
Certamente in questa fase dobbiamo registrare la presenza cospicua di gruppi stranieri, tra cui ebrei (una sinagoga doveva esistere in vicolo dell’Atleta ed una catacomba comunitaria da localizzare nel quartiere di Monteverde), siriani e orientali (i resti di un tempio sono ancora visibili su via Dandolo).
L’importanza del quartiere dovette essere ben evidente nell’età di Aureliano se le sue mura dovet-tero includerlo e proteggerlo da incursioni nemiche con l’apertura di tre porte: la Portuense, lungo la omonima strada, oggi scomparsa ma posizionabile ad un centinaio di metri più avanti rispetto alla por-ta Portese delle mura di Papa Urbano VIII, la Aurelia nello stesso luogo dove fu ricostruita la porta delle nuove mura del Papa citato e la Settimiana sull’at-tuale via della Lungara, probabilmente ricavata da
di Fiorenzo Catalli *
SUMMARY. The necropolis of Villa Doria Pamphilj on the old Aurelia way. The area of ancient Rome spreading to the West of the Tiber river (Transtiberim) comprised densely inhabited nuclei as well as precincts devoted to production and commerce. This is attested by a network of roads, aqueducts, walls and cemeteries. In the necropolis of Villa Doria Pamphilj, a remarkable columbarium was discovered in 1984. Its construction dates back to the Julio-Claudian era and it was in use till the middle of the second century AD. It consists of a big central room and two smaller rooms. The whole structure could hold the remains of over 500 individuals. The pictorial wall decoration in between the niches shows floral motives, animals, theatrical masks. Interesting is the representation of a series of judgment scenes. The pavement made of small black tesserae inserted with pieces of marble of different colours and hues deserves special mention; along the west side the inscription C. SCRIBONI(V)S C.L. MEN(OPHI)LUS can be read.
* Direttore Archeologo. [email protected]
30 ARCHEOLOGIA SOTTERRANEA
un precedente arco trionfale posto sulla vecchia strada (certamente utilizzata come via dei trionfi), in onore di Settimio Severo.
Un ulteriore riconoscimento dell’importanza del quartiere sta nella decisione dell’imperatore Traiano di condurre un acquedotto da una sorgente nei pressi del lago di Bracciano fino alla mostra finale che non do-veva essere né distante né dissimile dall’attuale mostra dell’Acqua Paola (il Fontanone) monumento celebrativo a ricordo dei lavori di Papa Paolo V che volle riattivare il vetusto acquedotto traianeo.
Un precedente acquedotto, l’Alsietino, fatto costru-ire da Augusto, portava acqua dal lago di Martignano (l’antico Alsium), acqua non di qualità, secondo il re-sponsabile degli acquedotti, Frontino, e in quanto tale probabilmente utilizzata solo per rifornire la Naumachia augustea che doveva trovarsi dalle parti di S. Cosimato.
La via Aurelia di età romana, che coincide con l’at-tuale tracciato, era costellata su entrambi i lati, imme-diatamente fuori dall’area abitata, da aree sepolcrali sia fuori che sottoterra. Numerose, infatti, sono le aree ca-tacombali posizionate, per quanto mai completamente esplorate, lungo la via Vitellia e la via Aurelia antica e riferibili alla fase imperiale non precedente la fine del II secolo d.C. Tra queste le più note sono quelle al di sotto della Basilica di S. Pancrazio e quelle di S. Callisto o Ca-lepodio.
I resti delle necropoli fuori terra mostrano, invece, nuclei più antichi, almeno a partire dalla tarda età re-pubblicana. E fino al tardo impero.
Nell’area di Villa Doria Pamphilj si sono conservati resti di una necropoli composta quasi esclusivamente da edifici del tipo a colombario, ovvero destinati a raccoglie-re le ceneri del defunto, secondo il rito della cremazione, in apposite nicchie poste lungo le pareti degli ambienti.
Nei cimiteri romani le aree funerarie destinate ad accogliere le sepolture sono di proprietà privata e pro-vengono dalla suddivisione in piccoli lotti quadrati o ret-tangolari di terreni più ampi ai cui angoli il proprietario collocava cippi con le indicazioni delle misure dell’area espresse ovviamente in piedi romani (un piede corrispon-de a cm 29,7 circa): in fronte pedes …, in agro pedes …
I colombari rappresentavano la soluzione più pratica per riunire un numero a volte considerevole di urne cine-rarie economizzando al massimo sullo spazio. Le nicchie dei colombari che sono concepite, già nelle fase costrut-tiva, con una olla in terracotta all’interno della struttura munita del relativo coperchio, potevano restare aperte (ovvero le ceneri protette solamente dal coperchio), op-pure abbellite da stucchi colorati o chiuse e sigillate da una lastra di terracotta (un semplice mattone ritagliato a misura), una lastra di marmo incisa con il nome del de-funto.
In ogni necropoli dovevano esistere spazi comuni per il rito della sepoltura tra cui in particolare l’area ove at-trezzare la pira funebre per cremare i corpi. La non ele-vata temperatura raggiunta dal rogo non consentiva la totale riduzione in cenere del corpo per cui all’interno delle olle cinerarie è ancora possibile rinvenire, per quan-to completamente calcificati i resti ossei più resistenti: frammenti della colonna vertebrale, di vertebre, di teste di femore e del bacino. A rogo spento, per facilitare la se-parazione tra le ceneri della legna e quelle del corpo del defunto, è testimoniato l’uso di una coperta tessuta con fili di amianto posta tra la catasta della legna e il corpo.
IW ruderi degli edifici funerari di età romana anco-ra visibili in Villa Doria Pamphilj furono certamente già visti, ma non esplorati scientificamente, alla metà del XVII secolo in occasione della costruzione della Palazzina dell’Algardi e della sistemazione del parco circostante, direttamente conseguente alla nomina al soglio pon-tificio del Cardinale Giovan Battista Pamphilj, papa dal 1644 al 1655. La famiglia Pamphilj, solo alla fine del XVII secolo imparentata con i Doria, forse originaria dell’area umbra ed in particolare di Gubbio, riuscì nel tempo ad ingrandire l’area della Villa fino all’attuale estensione.
I resti della necropoli furono successivamente rimes-si in luce dalla stessa famiglia Doria Pamphilj nei primi decenni dell’Ottocento, tra cui un grande colombario comunitario capace di ospitare oltre 500 deposizioni ed uno più piccolo testimone con la sua struttura edilizia in-terna della trasformazione e del progressivo passaggio dal rito dell’incinerazione a quello dell’inumazione.
Il primo, ancora oggi denominato “Grande Colomba-rio” aveva le pareti interamente affrescate con soggetti che si distribuivano con un ritmo continuo tra un ordine ed un altro di nicchie in un alternarsi di scene tra loro in-dipendenti: ambientazioni di vita campestre o paesaggi con architetture fantastiche, nature morte, animazioni con uccelli, scene con sapore caricaturale cui partecipano pigmei in lotta con gru o che fuggono da un coccodrillo. Non mancano scene allusive a rappresentazioni di miti e leggende.
Gli affreschi, staccati dalle pareti agli inizi degli anni Cinquanta dello scorso secolo, sono conservati nel Mu-seo Nazionale Romano di Palazzo Massimo e solo par-zialmente esposti.
Il colombario che li accoglieva è costruito in opera re-ticolata di tufo organizzato in una unica sala sotterranea destinata alle sepolture ed una immediatamente sovra-stante a livello del piano di campagna, che consentiva lo svolgimento dei riti per ogni nuova cerimonia.
A breve distanza c’è un piccolo edificio realizzato in-teramente sopraterra con una bella cortina in laterizio, tipica dell’età adrianea, munito di due ingressi gemel-li con architravi in travertino e cornice modellata in la-
31ARCHEOLOGIA SOTTERRANEAn. 7 | ottobre | 2012
terizio che doveva ospitare il titulus, ovvero l’iscrizione funeraria contenente il nome del capostipite e l’indica-zione dei parenti cui era consentito l’accesso e l’uso del sepolcro. Dal punto di vista costruttivo è questo il tipo di sepolcro che testimonia il passaggio dal rito dell’incine-razione a quello della inumazione per la presenza sia di nicchie aperte e destinate ad accogliere urne cinerarie sia di arcosoli in grado di ospitare sarcofagi per inumati.
A poca distanza si erge la parete in blocchi di tufo e di peperino di un sepolcro in opera reticolata, che dove-va costituire la facciata dello stesso sepolcro lungo la via sepolcrale che dalla via Aurelia antica si inoltrava verso l’interno della necropoli. L’utilizzo dei blocchi di pepe-rino, materiale di origine vulcanica come il tufo ma di maggiore durezza tale da poter essere scolpito, si giusti-fica con la volontà di rappresentare una porta completa di architrave modanato con ovoli e dentelli mentre le specchiature mostrano due gorgoni, nella parte superio-re, due teste di leone munite di battente ad anello, come nelle porte reali, in quelle inferiori. Ai lati della porta, sui blocchi di tufo, vi sono le indicazioni delle misure dell’a-rea del sepolcro; in fronte pedes XXIVS in agro pedes XXIVS, ovvero un quadrato di 24 piedi e mezzo per lato, poco meno di m. 7,20.
Nell’area si conservano altre iscrizioni funerarie lati-ne relative quasi esclusivamente a liberti, ex schiavi af-francati, molto probabilmente impegnati nelle numero-se attività lavorative del quartiere trasteverino.
Di un certo interesse un cippo funerario relativo ad un certo Phoebus che, come indicato nella stessa epigra-fe, era di origine germanica, era una delle guardie del corpo (corporis custos) dell’imperatore Nerone, aveva fatto il militare per 8 anni (militavit annos VIII) ed era morto all’età di 25 (vixit annos XXV).
La scoperta più recente, effettuata nel 1984, riguar-da un altro colombario di tipo comunitario in grado di ospitare oltre 500 nicchie per incinerati. Anche in questo caso è stata scoperta la camera sotterranea ma assai pro-babilmente nella parte sovrastante a livello stradale an-tico vi era un altro ambiente per i riti funerari. Oggi una scala antica conduce ad un vasto ambiente e due piccoli vani adiacenti. (Fig. 1)
Su gran parte delle superfici parietali dei tre am-bienti e della scala di discesa si conserva ancora un intonaco bianco e compatto con varie figurazioni di-pinte ad affresco negli interspazi tra le file di nicchie. A partire dal basso sono rappresentate: una teoria di ghirlande, figure inanimate (maschere teatrali, pigne, fontane, vasi, cesti di fiori e di frutta) ed animate (vo-latili che beccano), rappresentazioni architettoniche di giardini e di paesaggi per la partecipazione attiva di figure umane, scene di giudizio secondo modelli in uso nell’età augustea e documentati anche in affre-
Fig. 1. Colombario di Scribonio Menofilo. L’accesso ad una delle stanze minori.
32 ARCHEOLOGIA SOTTERRANEA
schi di diversa destinazione come nella cd. Villa del-la Farnesina. Non mancano anche in questo sepolcro scene comiche con i pigmei in lotta con le gru. (Figg. 3,4,5,6,7,8,9)
Il pavimento dei tre ambienti è a mosaico ed in particolare quello della camera principale è del tipo scutulatum, ovvero una base di piccole tessere nere tra cui sono inserite lastrine regolari e non (cioè scarti del-la lavorazione) di tutto il campionario dei marmi del Mediterraneo commerciati a Roma. (Fig. 2)
Su un lato è l’iscrizione C. Scribonius C. f. Meno-philus […] che ci chiarisce che il personaggio segnalato aveva pagato a sue spese (l’indicazione doveva essere contenuta nella seconda riga andata perduta) la posa in opera del mosaico mentre per la spesa complessiva della costruzione e della decorazione del sepolcro do-vevano aver contribuito le diverse famiglie consorzia-
tesi, le stesse che poi avranno suddiviso le nicchie per ogni famiglia.
La documentazione epigrafica raccolta all’interno del sepolcro, la tecnica costruttiva, lo stile delle pittu-re ci consentono di datare la costruzione del sepolcro nella prima età augustea, tra il 20 e il 10 a.C., mentre una lastrina di marmo che chiudeva una nicchia con l’indicazione del nome di Smaragdo, servo dell’impe-ratore Tito, permette di definire il limite di utilizzo e dunque la chiusura del sepolcro stesso.
L’area archeologica di Villa Doria Pamphilj è situa-ta all’interno dell’area della stessa villa in uso alla Pre-sidenza del Consiglio dei Ministri e pertanto sottopo-sta a costante controllo ai fini della sicurezza. Le visite sono comunque consentite purché preventivamente concordate.
Fig. 2. La camera principale con il mosaico in opus scutulatum
33ARCHEOLOGIA SOTTERRANEAn. 7 | ottobre | 2012
Figg. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Particolari della decorazione pittorica parietale.
Fig. 3
Fig. 5
Fig. 7
Fig. 4
Fig. 6
Fig. 9
Fig. 8
34 ARCHEOLOGIA SOTTERRANEA
Bibliografia
Bendinelli G., Le pitture del Grande Co-lombario di Villa Doria Pamphilj, in Mo-numenti della Pittura Antica, III, 5, Roma, 1941.
Catalli F., La riva destra del Tevere in area urbana, in C. Benocci (a cura di), Villa Do-ria Pamphilj, Roma, 1996, pp. 9-51.
Catalli F., Nuove scoperte archeologiche a Villa Doria Pamphilj, in Palma Venetucci B.- Cacciotti B. (a cura di), Documenti per servire allo studio delle Collezioni Doria Pamphilj, Roma, 2002, pp.26-28.