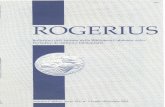M.Milanese (ed.), Monteleone Rocca Doria, Sassari, 2005
Transcript of M.Milanese (ed.), Monteleone Rocca Doria, Sassari, 2005
4 5
] colophon [
Progetto grafico
Stefano Serio
Editing
Simonetta Castia
Immagini
Tutte le foto sono degli autorieccetto:pp. 18, 34, 48 (Donatello Tore)p. 26 (Franco Ruiu)
Stampa
Stampacolor Muros SS
Edizioni
Mediando, Sassarivia Coradduzza 2707100 Sassari
Telefono 079 [email protected]
ISBN 88-89503-07
9
Con la pubblicazione di questa guida dedicata al territorio e alla storia di Monteleone Rocca Doria, l’Amministrazione comunale è lieta di inaugurare la fase divulgativa dell’itinerario deleddia-no disegnato grazie ai fondi POR 2000-2006, misura 2.1.Monteleone Rocca Doria, che ospita una delle tre porte del Parco di dieci comuni che nel 2001 diedero vita al Consorzio del Parco Grazia Deledda, ha di fatto realizzato, attraverso il sostegno della Comunità europea, un percorso integrato di conoscenza basato sul recupero delle tradizioni locali, della archeologia e dell’ambiente.Oltre ai lavori incentrati sulle testimonianze di età medievale legate alla signoria dei Doria (Intervento di valorizzazione del castello e della cinta muraria) è stato infatti appena concluso il Centro di documentazione sulla storia della panificazione in Sardegna e, ai piedi della rupe di su Monte, presso la riva del Temo, la Galleria dei paesaggi deleddiani. La guida è articolata in due sezioni: una prima parte descrive le caratteristiche del percorso deleddiano in quest’area del Parco, con approfondimenti specifici sui principali tematismi sviluppati da Grazia Deledda.Il seguito del volume contiene i risultati della ricerca e delle indagini archeologiche condotte nel castello di Monteleone e nell’intero centro abitato dalle Università di Pisa e di Sassari, insieme ad un utile inquadramento storico-ambientale del ter-ritorio e del paese.Si tratta di un primo importante passo mosso verso il recupero e la piena valorizzazione turistica delle splendide realtà del luogo, con il fine ultimo di comporre una gamma articolata di offerta in cui si fondono letteratura, etnografia, paesaggio e archeologia.Un motivo in più per frequentare il piccolo borgo, già noto per la bellezza e incontaminatezza della natura e la feconda nobile storia che lo sostiene verso un futuro di consapevole omaggio alla propria identità.
Il Sindaco Antonio Meloni
10 11
A seguito dell’acquisizione dell’area del castello da parte del Co-mune di Monteleone Rocca Doria, avvenuta alla metà degli anni Novanta, nel 1998 fu possibile avviare i primi interventi archeolo-gici in un sito che tanto rilevante appariva nella documentazione scritta della Sardegna medievale, quanto scarsamente percepibile sul terreno, al di là di qualche brandello murario e della sue straordinarie difese naturali, che ne hanno garantito per secoli un particolare isolamento.Da quel momento, quattro campagne di scavo, per un totale di circa 15 mesi di lavoro, hanno impegnato diversi Enti (oltre al Comune di Monteleone Rocca Doria), le Università di Pisa e di Sassari e la Soprintendenza Archeologica per le Province di Sassari e Nuoro, in un lungo e complesso lavoro di scavo, per il recupero e la valorizzazione di questo importante sito archeolo-gico medievale.Nel procedere dei lavori, sono stati portati alla luce due poli es-senziali della topografia del castello, quali un palazzo, la proba-bile residenza dei Doria e della corte ed una torre quadrangolare, nei pressi di uno degli accessi al castello.Nel cantiere, accanto alla presenza costante degli archeologi spe-cialisti in archeologia medievale delle Università di Sassari e di Pisa, autori di alcune parti della presente pubblicazione, si sono alternati un centinaio di studenti, che hanno maturato importanti esperienze formative ed hanno contribuito in modo determinante alla realizzazione dello scavo, accanto alle maestranze locali, che sono sempre state di fondamentale ausilio per il buon andamento del cantiere. Questa pubblicazione presenta in modo sintetico i principali ri-sultati delle ricerche svolte nel castello di Monteleone negli anni 1998-2004. Per una migliore comprensione del contesto storico del territorio ed ambientale, il volume raccoglie anche brevi sin-tesi sulle testimonianze archeologiche del territorio nel lungo pe-riodo ed approfondimenti specifici relativi alla signoria dei Doria a Monteleone.La parte archeologica della pubblicazione conclude dunque un significativo ciclo di ricerca, coronato anche dalla musealizza-zione delle strutture del castello rinvenute negli ultimi anni, un risultato che non deve però essere visto come punto d’arrivo, ma come stimolo per una più ampia pianificazione delle indagini e della valorizzazione del territorio, fondata su quel particolare momento storico in cui il castello di Monteleone fu davvero un nodo strategico negli equilibri politici e militari del Mediterraneo occidentale.
15
Una profonda vocazione etnografica pervade l’intera opera della scrittrice Grazia Deledda (1871-1936), tale da rendere il patrimonio culturale della Sardegna il fulcro centrale della sua poetica.La natura, le tradizioni popolari, gli usi e le credenze religiose, i molteplici ma dall’esterno unitariamente riconoscibili aspetti della sua Sardegna, furono per lei campo di ricerca e di sperimentazione scientifica, così come scenario delle proprie vicende familiari, divenendo in seguito immateriale ma essenziale palcoscenico di azioni, drammi e racconti trasfigurati in chiave letteraria.La “sardità” dei personaggi descritti, la vita di una comunità raffigurata nei suoi caratteristici atteggiamenti, quella degli accesi contrasti, linguistici e umorali, di una società a forte diversificazione interna, sono tutti elementi che si ritrovano nei sui scritti, talmente connotati in chiave etnica da renderli riconoscibili e quasi avvincenti. In lei “l’ethnos” assurge infatti, per parafrasare l’Angioni, a vera fantasia romantica.Per la stretta coerenza tematica e culturale con la poetica della scrittrice, il piccolo centro di Monteleone Rocca Doria è stato inserito all’interno del Parco Grazia Deledda insieme ad altri nove comuni dell’isola, divenendo dal 2001 sede di una delle tre Porte del Parco.Attraverso la valorizzazione del suo patrimonio storico-culturale ed etnografico è possibile infatti apprezzare ancora il fascino di un misterioso passato, consentendo il ripetersi di tradizioni e saperi peculiari.Nelle pagine che seguono una collana di offerte per andare a scoprire le memorie, i sentimenti e le emozioni legate ad un prodotto turistico particolare in cui si fondono letteratura, etnografia (Centro della documentazione della panificazione tradizionale), paesaggio (Galleria dei paesaggi deleddiani) e archeologia (Il castello dei Doria).Un vero e proprio viaggio alle radici dell’identità etnica della Sardegna, per rivivere i sentimenti e i valori autentici di una cultura millenaria immersa in un contesto paesaggistico di pregio. (S.C.)
1.1Monteleone e il Parco
16 17
L’archeologia sarda ha ispirato una delle tematiche cui la De-leddda dedicò particolare attenzione, rivestendola di significa-ti e suggestioni favolistiche.Le domus de janas o case delle fate, i nuraghi e i castelli, con i loro innumerevoli spunti di approfondimento immaginifico e di pura suggestione artistica, rappresentano di fatto uno dei leit motiv maggiormente caratterizzanti la dimensione letteraria della Sardegna descritta da Grazia Deledda.Nelle sue opere è dato trovare più di un riferimento a questa materia, sottolineando lo speciale senso di identità storica che emana dalle tracce di un millenario passato.La dimensione del mito e della leggenda costituisce così ma-teria frequente nei misteriosi e fiabeschi sviluppi degli scenari rappresentati nella sua opera, dove viene felicemente ripropo-sto, in una trasposizione autobiografica maturata soprattutto nella più tarda età, lo struggente ricordo adolescenziale di un’Isola primitiva pervasa di magia e tradizione.Attingendo dal ricco patrimonio popolare e nell’ambito di un consapevole riferimento narrativo riemergono ambientazioni dominate da personaggi non reali (folletti, fate, gnomi...) o da personaggi fiabeschi della storia sarda, quali i principi e le donne regali, forti e sventurate che hanno abitato i pochi castelli presenti nell’isola, come quelli dei Doria (si veda il caso di Adelasia di Torres, rievocato nella novella “Il sigillo d’amore”). Anche a Monteleone Rocca Doria storia, letteratura e leggenda si fondono insieme per rievocare in modo inequivocabile il paesaggio della memoria di un’Isola mitica.Dal suo Belvedere e dal’area del Castello e della Rocca si ammira una tra le più belle e incantevoli vedute dell’Isola, in posizione centrale e di totale visibilità rispetto ai luoghi del Nurcara. Risaltano la collinetta conica con in cima i ruderi del castello di Bonvehì (Mara) incombenti sul Santuario di Bonu Ighinu, le vallate di Romana, il Monte Minerva, il lago del Temo e l’abitato di Villanova Monteleone.Ricco e consistente è il suo patrimonio archeologico, enorme-mente valorizzato da un glorioso passato che lega la storia di
1.2castelli, gnomi e folletti
16 17
questo piccolo borgo alle travagliate quanto celebri vicende del potente casato medievale dei Doria.Che si mescola con il fascino della magia e della leggenda, come quella che racconta che nell’agro della Rocca trovassero dimora i mitici cavalli verdi e che solo un monteleonese sia riuscito a possederne uno. (S.C.)
Servizi disponibili
- servizi di divulgazione, con grandi pannelli didattici lungo il
percorso di visita dell’area archeologica.
Grazia Deledda
18 19
Il paesaggio costituisce probabilmente il nocciolo della nar-rativa deleddiana. Il vento, i grandi spazi aperti, i silenzi, le montagne e la natura della sua Sardegna sono presenti e rico-noscibili in tutte le sue opere. Più che luoghi fisici e concreti divengono nell’artificio della narrazione stazioni dell’anima.Il paesaggio è soprattuto una condizione per far emergere il flusso dei ricordi, come luogo della memoria, dell’anima e del-le percezioni connesse alle esperienze sensoriali:“La luna saliva davanti a lui, e le voci della sera avvertivano l’uomo che la sua giornata era finita. Era il grido cadenzato del cuculo, il zirlio dei grilli precoci, qualche gemito d’uccello; era il sospiro delle canne e la voce sempre più chiara del fiume: ma era sopratutto un soffio, un ansito misterioso che pareva uscire dalla terra stessa”. (Canne al vento) Indicatore di presagio:“Del resto, anche il perire, in questo soggiorno fiabesco, non dovrebbe essere agitato e pauroso: morire, appunto come nei racconti delle antiche genti, alla più tarda età; andarsene per l’ultima passeggiata in carrozza verso la pineta una sera di ottobre, accompagnati dall’inno sacro del mare, fra i cande-labri accesi dei pioppi d’oro: fermarsi nel piccolo camposanto all’ombra glauca dei pini, tra i fiori azzurri del radicchio e le pigne spaccate che sembrano rose scolpite nel legno. Alla più tarda età”. (Agosto felice, “Il cedro del Libano”) Rievocazione degli “ambienti” appartenuti al “vissuto” dell’au-trice, ad esempio alla sua infanzia:“Dalla finestra presso lo scaffale si dominava il paese; una scacchiera di tetti rossi e verdastri, alti e bassi, dai quali emer-gevano tre campanili tutti eguali, sottili e bianchi, mentre in fondo, quasi all’orizzonte, le torri della cattedrale si innalzava-no scure e massicce.D’inverno era scuro ed umido anche il colore del paese: brucia-to e rossiccio d’estate: di primavera, invece, e dopo le prime pioggie di autunno, i vecchi tetti coperti di musco ricordavano qualche cosa di preistorico, come appunto un villaggio costrui-to sui macigni, sui quali rimaneva il verde di una vegetazione
1.3galleria dei paesaggi deleddiani
18 19
tenace e vergine di alta montagna.Anche la strada stretta e pietrosa che vedevo sporgendomi dalla finestra, pareva un viottolo di montagna: e montagne e montagne apparivano nel vano dell’altra finestra, verdi, azzur-re, bianche, grigie e viola, secondo il piano della lontananza: tutto l’orizzonte ne era cinto, eppure rimaneva ampio, aereo, come se le montagne fossero nuvole. Le più vicine, sorgenti dalla valle che io non vedevo perché un argine di orti e di giardini mi ci separava, erano in parte verdi di boschi, con larghe macchie argentee di granito e zone dorate di felci e di asfodelo”. (Il paese del vento)
o all’assegnazione del premio Nobel:“La traversata del Baltico, di questo mare che la fantasia vedeva mortalmente nero e tempestoso, si è mutata in una pacifica notte di sonno; la Scania, la Lombardia svedese, ha steso, da una parte e dall’altra del caldo e soffice treno, i suoi paesaggi chiarissimi sotto il cielo di metallo appannato, coi profili vaporosi delle città, la nota rossa delle case dei conta-dini, le foreste d’abeti fiorite delle prime nevi, i campi d’orzo e di grano già verdi sotto un velo di brina, i mulini a vento che sull’orizzonte delle fertili pianure addormentate giocano come i bambini irrequieti nelle sere di luna estiva, quando la madre stanca sonnecchia sulla soglia della porta.Poi il lungo e lento crepuscolo ha dorato e confuso il cielo, la terra e le cose; le muricce lungo i margini dei prati e sui rialti al confine dei boschi, rassomigliano a quelle delle “tancas” della Sardegna…”. (Due giorni a Stoccolma) Come non considerare inoltre l’importanza degli scenari de-scritti nelle opere di Grazia Deledda: le feste religiose, le sagre paesane, i riti ancestrali della Sardegna, tradizioni e natura insieme:“Sono grata alla Sardegna perché è per merito di quest’isola diversa dal resto dell’Italia, dei suoi costumi, dei suoi caratte-ri, dei suoi paesaggi che i miei lavori interessano il pubblico (…) il suo popolo è ancora primitivo, ma possiede tradizioni bellissime, impeti di passioni profonde ed è generoso come nessun altro popolo d’Europa (…) Ho vissuto coi venti, coi boschi, con le montagne, ho guardato per mesi ed anni il lento svolgersi delle nuvole sul cielo sardo, ho mille e mille volte ap-
20 21
poggiato la testa ai tronchi degli alberi, alle pietre, alle rocce, per ascoltare la voce delle foglie, ciò che dicevano gli uccelli, ciò che raccontava l’acqua corrente; ho visto l’alba il tramonto il sorgere della luna nell’immensa solitudine delle montagne; ho ascoltato i canti e le musiche tradizionali e le fiabe e i di-scorsi del popolo, e così si è formata la mia arte”. Il Parco Grazia Deledda, che incarna la poetica e i principi ispiratori della narrativa del nobel nuorese, consente di far rivivere la bellezza e compiutezza del “paesaggio” sardo attra-verso l’allestimento a Monteleone Rocca Doria della “Galleria dei Paesaggi deleddiani” presso la riva del Temo, ai piedi del-l’imponente rupe del rilievo di “Su Monte”.All’interno della piccola casa cantoniera di “Reinamare” è possibile ritrovare una galleria di ambientazioni del Parco, per accostarsi al fascino delle antiche tradizioni e dell’arcaicità di una cultura millenaria, quello ineffabile dei santuari campestri e delle campagne circostanti.L’edificio storico recentemente ristrutturato ospita un’esposi-zione integrata, dove è possibile godere di un ampio percorso per immagini o immergersi nella dimensione totale garantita dal mezzo multimediale: qui, in particolare, attraverso l’inte-razione tra i suoni della natura/storia e le tematiche/luoghi de-leddiani, sono ricreate le atmosfere e i tanti “paesaggi” sardi, per una fruizione libera da parte del visitatore. (S.C.)
Servizi disponibili
- area didattico-divulgativa con mostra fotografica permanente, piccola
biblioteca deleddiana e postazione multimediale multipla, con funzione
di laboratorio per la progettazione e creazione di prodotti didattici svolti
in collaborazione con le scolaresche o con un’utenza differenziata.
- servizio infomazioni sul territorio, sulla fruizione dei servizi del parco
letterario e dei servizi turistici.
- area riservata alla ricreazione ed alla degustazione di prodotti eno-ga-
stronomici della cultura del luogo.
20 21
Entro gli ampi spazi di una bella casa tardo-ottocentesca con antico forno situata nel centro storico del paese, di fronte alla chiesa di Santo Stefano e alla Porta del Parco Grazia Deledda, si dispiega l’allestimento del Centro di documentazione sulla storia della panificazione in Sardegna. Sul retro è presente un vasto patio che consente la vista della valle del Temo e il suggestivo panorama dell’intero Nurcara.Si tratta di una struttura di approfondimento tematico della cultura materiale locale inserita a sua volta nell’itinerario integrato del Parco deleddiano, che ha tra le sue principali finalità la valorizzazione e la riscoperta delle antiche tradizioni e saperi dell’isola.Al suo interno è visitabile la ricca esposizione museale, dove si possono ammirare e apprendere le pratiche e tecniche di lavo-razione del pane e dei dolci di Monteleone Rocca Doria e della Sardegna. Parte saliente del progetto è infatti la presenza di spazi per la didattica, la ricreazione e la degustazione, insieme ad un Laboratorio tradizionale dove sarà possibile sperimenta-re direttamente sia la conoscenza che la realizzazione dei più importanti pani sardi. Le tradizioni locali della Sardegna costituscono uno dei prin-cipali motivi ispiratori delle peculiari ambientazioni presenti nell’opera di Grazia Deledda.Il lavoro dei campi, la vita del pastore, l’avvicendarsi delle stagioni in relazione anche al ciclo produttivo agrario sono un elemento narrativo ricorrente, filtro e metro di valutazione delle fatiche della vita e dell’autenticità e arcaicità degli stessi costumi.Attraverso la loro descrizione e quella del consueto trascorre-re del tempo alla luce di queste scene di vita rivive il mito di un’isola nella quale l’uomo ha dignità d’essere per ciò che fa e che possiede e, verrebbe da dire, per il modo in cui ribadisce, nell’accettarlo, il proprio ruolo sociale e familiare.Assume un’importanza cruciale il tema parallelo del cibo, in particolare, come abbiamo visto, del pane, che assieme al formaggio era alla base dell’alimentazione sarda sino a non pochi decenni fa. Si tratta di temi presenti in modo costante
1.4l’antico rito del pane
22 23
nell’opera deleddiana, dove è riposta particolare attenzione verso i prodotti tipici della Sardegna, insieme al mito della cucina e dell’ospitalità sarda.L’intero «ciclo del pane» segna lo scorrere del tempo e delle stagioni, agrarie e della vita.Il pane assurge in molti brani a indicatore sociale e simboli-co:“– Di razza buona siamo, figlia cara, – diceva la matrigna, – e il tempo e la sorte possono fare e disfare tutto, fortune ed eventi, ma non cambiare le razze. Il pane bianco rimane pane bianco anche nella bertula del pezzente, e la sorgente d’acqua dolce rimane tale anche se vi si abbeverano i maiali”. (Chiaroscuro) L’antico rito del fare il pane in casa viene sottolineato con attenta minuziosità dall’autrice, che indugia volentieri nel re-cuperare il valore quasi sacro delle varie fasi di lavoro, attin-gendo anche dai propri ricordi adolescenziali:“Fare il pane in casa, come tuttora si usa in moltissime case anche borghesi delle provincie italiane, non è una cosa facile e semplice quale si potrebbe credere. Ma la fatica e la pa-zienza, oltre alla responsabilità necessaria alla buona riuscita dell’opera, sono alleviate dal senso quasi religioso col quale le nostre buone massaie compiono il rito. Basta osservare gli spontanei, eppur coscienti segni di croce col quale esse lo accompagnano. Mia madre, nella nostra casa di Nuoro, giunto il momento d’iniziare la faccenda, prendeva un aspetto più del solito attento, serio, quasi sacerdotale. Delle fatiche più gravose avrebbe potuto incaricare le serve; ma se ne guardava bene. Era, si direbbe, gelosa della sua prerogativa, della sua antica iniziazione. Si legava un fazzoletto in testa, come un cappuccio monacale, ed entrata nella dispensa attingeva, – è la giusta parola, – il frumento dal sacco. […] Versava il fru-mento nelle corbule, i flessibili e resistenti cesti di asfodelo, e lo portava sotto la tettoia del cortile: in un lucente e capace paiuolo di rame brillava l’acqua limpida anch’essa appena at-tinta dal pozzo familiare. Seduta su uno sgabello, mia madre lavava il grano: un po’ per volta lo lavava, dentro un vaglio di giunchi, immergendolo con cautela nell’acqua, mescolandolo con la mano sottile, agile, abituata a finissimi ricami di seta e d’oro come ad ogni sorta di lavoro domestico; indi sollevava il
22 23
vaglio, lo faceva sgocciolare, lo scuoteva, con un’arte che divi-deva nettamente il contenuto dalle pietruzze e dalle scorie: e queste faceva saltare da una parte, mentre dall’altra versava l’umido frumento in un largo canestro esso pure d’asfodelo. E così finché tutto il grano era lavato e messo ad asciugare. Una volta asciutto veniva di nuovo mondato, quasi chicco per chicco, sulla grande tavola di cucina accuratamente pulita.[…]Veniva poi fuori il lievito, dal ripostiglio dove, entro una sco-della dorata che sembrava un vaso sacro, lo si conservava dall’una all’altra cottura del pane; e sopra il mucchio che lo accoglieva e seppelliva, sciolto come una linfa vitale, la mano bianca di farina segnava una croce: croce che veniva ripetuta sul viso prono come a specchiarsi nel cerchio della corba pre-ziosa” (Pane casalingo) Pane e formaggio sono l’alimento principe dei personaggi deleddiani, umili e potenti, nobili e servi, che non fanno mai mancare nella propria tavola ciò che serve a cementare l’in-distruttibile sacro mito dell’ospitalità locale e l’inarrivabile intima semplicità del suo concretarsi. Il formaggio e il pane possono talora assumere l’aspetto d’impressionante rendita familiare, custodita nel silenzio notturno e quasi spettrale del-l’antro segreto del tempio domestico, la dispensa:[...]“Anche lei accese il fuoco e andò a prendere il pane nella di-spensa a pian terreno. Un finestrino munito d’inferriata dava luce alla stanza vasta e nera; sacchi di frumento e d’orzo, cestini di fagiuoli e di pomi di terra, vasi d’olio, centinaia di pezze di formaggio nerastre e grigie la ingombravano: dal soffitto pendevano grappoli di formaggelle giallognole e ve-sciche di strutto bianche come palle di neve. Entro la tinozza della salamoia galleggiavano nell’acqua che pareva coperta di squame di pesce alcune forme di cacio fresco; altre bianche e dure come il marmo stavano su un tavolo stretto fra due ceppi. Nonostante le sue preoccupazioni, Columba, che s’in-caricava di manipolare il formaggio principale rendita della famiglia, appena entrò nella dispensa guardò nella tinozza, accomodò uno dei ceppi, fece un giro anche nei camerini atti-gui per assicurarsi che tutto era in ordine. La luce moriva nel vano del finestrino e nella penombra della lunghissima stanza
24
che pareva la stiva d’un bastimento gli oggetti prendevano aspetti fantastici; qualche paiuolo di rame rosseggiava fra le olle nere dell’olio, un sacco di farina d’orzo sorgeva bianco, in mezzo a tutto quel nero, come un fantasma panciuto. Columba — che per paura di attaccar fuoco girava alla sera senza lume per tutta la casa trovando a tastoni ogni oggetto — prese dal canestro il pane rotondo sottile, e all’improvviso ricordò la storia di Margherita. Ella non credeva agli spiriti e non aveva paura dei morti né dei vivi; eppure quella sera provava una certa inquietudine: i paiuoli rossi, il sacco bianco, le olle nere, il lucicchio metallico della salamoia, tutto le pareva alquanto strano. E il suo cuore ogni tanto batteva forte senza ragione”. (Colombi e sparvieri ) Che finisce per farci calare nella ben nota dimensione fiabesca del ricordo adolescenziale e autobiografico, dove i beni sono lo strumento d’intima comunione con il meraviglioso rivelarsi dell’identità sarda:“Cosima, con la sua scodella vuota, era incerta se seguire la serva nella breve uscita mattutina, o eseguire un suo proget-to. Voleva penetrare nella camera della mamma e vedere la bambina; profittò quindi del momento in cui la nonna attinge-va l’acqua dal pozzo, per infilarsi nelle scale silenziose. Dopo la prima rampata, tutta di scalini di granito, su un piccolo pia-nerottolo si apriva l’uscio di una specie di dispensa, col pavi-mento di legno e il soffitto, come quello della cucina, di canne che formavano un graticcio solido e fresco. Di solito l’uscio era chiuso a chiave: questa volta, nella confusione della notte, era stato lasciato aperto. E prima di proseguire verso la sua mèta, Cosima non esitò ad esplorare la grande stanza, che anch’essa rappresentava per lei un ripostiglio di misteri. E ce n’era ragio-ne: poiché le cose e gli oggetti più disparati stavano raccolti là dentro, in una vaga luce che penetrava dallo sportello di una finestra tutta d’un pezzo, aperto su un lontano sfondo di orizzonte montuoso.Mucchi di frumento, di orzo, di mandorle, di patate, occupa-vano gli angoli, mentre una tavola lunga era sovraccarica di lardo e di salumi, e intorno i cestini di asfodelo pieni di fave, fagiuoli, lenticchie e ceci, facevano corte agli orci di strutto, di conserve, di pomidori secchi e salati”. (Cosima) (S.C.)
24
Servizi disponibili
- servizio infomazioni sul territorio, sulla fruizione dei servizi del parco
letterario e dei servizi turistici.
- area didattico-divulgativa con esposizione per immagini permanente.
- area riservata alla ricreazione ed alla degustazione di prodotti eno-
gastronomici della cultura del luogo, con funzione di laboratorio per la
progettazione e creazione di prodotti didattici svolti in collaborazione
con le scolaresche o con un’utenza differenziata.
L’infornata
27
Il territorio comunale di Monteleone Rocca Doria presenta flo-ra e vegetazione di notevole ricchezza ed interesse. Essendo compreso tra 100 e 400 m s.l.m., ricade nel bioclima Mediter-raneo Pluvistagionale Oceanico (piano fitoclimatico mesome-diterraneo inferiore subumido), per cui la flora è tipicamente mediterranea, costituita da diverse centinaia di specie, trale quali alcune endemiche del settore sardo-corso, come Ge-nista corsica, Stachys glutinosa, Crocus minimus e Romulea requienii.La vegetazione potenziale è sempre costituita da comunità forestali, tra le quali sono maggiormente diffuse quelle sem-preverdi dominate da olivastro (Olea europaea subsp. sylve-stris), leccio (Quercus ilex) e sughera (Quercus suber), mentre la vegetazione caducifoglia è rappresentata nei versanti set-tentrionali e negli impluvi più umidi da boschi di querce ca-ducifoglie (Quercus gr. pubescens) e lungo i corsi d’acqua più importanti da boschi a pioppo bianco (Populus alba), salice bianco (Salix alba), ontano (Alnus glutinosa) e olmo (Ulmus minor). Le attività umane hanno differenziato il paesaggio ve-getale, portando alla diminuzione dei boschi e alla diffusione di comunità vegetali di sostituzione (secondarie) quali la mac-chia mediterranea, le garighe, i pascoli. È possibile riconoscere nel territorio 6 comunità forestali pre-valenti. Nei versanti soleggiati ad esposizione meridionale, con suoli scarsi, si sviluppano boscaglie ad olivastro (asso-ciazione Asparago albi-Oleetum sylvestris), che in taluni casi derivano da antichi oliveti abbandonati. La degradazione di queste boscaglie porta alla costituzione di una macchia ad Euphorbia dendroides e pratelli a Sedum coeruleum sulla nuda roccia, che assumono un caratteristico colore rosso alla fine della primavera.Nei versanti a prevalente esposizione settentrionale, su suoli più evoluti dei precedenti, si sviluppano invece boschi di lec-cio (associazione Prasio majoris-Quercetum ilicis), dalla cui degradazione si sviluppano macchie alte a Erica arborea e Ar-butus unedo, macchie basse a Pistacia lentiscus e Calicotome villosa, garighe a Cistus monspeliensis e pratelli a Tuberaria guttata.
2.1flora, vegetazione e paesaggio vegetale
29
Sugli altipiani vulcanici, caratterizzati da suoli argillosi, si sviluppano le sugherete, al posto delle quali, in seguito al passaggio del fuoco, si formano arbusteti a Myrtus commu-nis, garighe a Cistus monspeliensis e pascoli ovini a Trifoliumsubterraneum e Poa bulbosa.Nei versanti settentrionali e poco soleggiati, in impluvi umidi con suoli profondi, si stabiliscono boschi caducifogli a roverel-la (associazione Ornithogalo pyrenaici-Quercetum ichnusae), che sui substrati sedimentari miocenici sono sostituiti dai querceti calcicoli e termofili dell’associazione Lonicero im-plexae-Quercetum virgilianae. Il taglio o l’incendio di questi boschi porta alla formazione di cespuglieti spinescenti a rovo (Rubus ulmifolius), rose selvatiche (Rosa canina e Rosa sempervirens), biancospino (Crataegus monogyna) e perastro (Pyrus amygdaliformis), che costituiscono le siepi in tutta la Sardegna nord-occidentale e praterie a Dactylis hispanica e Anemone hortensis.Lungo i corsi d’acqua si sviluppano boschi igrofili a Ulmus mi-nor, Populus alba, Salix atrocinerea, S. alba, Alnus glutinosa, Fraxinus oxycarpa e Ulmus minor (associazione Allio triquetri-Ulmetum minoris). L’eliminazione di queste comunità forestali su suoli alluvionali profondi in prossimità dei corsi d’acqua, spesso per realizzare colture orticole, porta alla formazione, in seguito all’abbandono delle attività agricole, di praterie di erbe alte con Phalaris coerulescens e Hordeum bulbosum e cespuglieti spinescenti a prevalenza di Rosacee.Infine il paesaggio vegetale dell’area è completato dalla pre-
Corbezzolo (Arbutus unedo) nella veste autunnale
29
Glossario
Endemica: specie animale o vegetale esclusiva di un territorio limitato.
Flora: insieme di tutte le specie vegetali presenti in una data area.
Igrofila: specie o comunità vegetale amante dell’acqua.
Vegetazione: insieme di tutte le comunità vegetali (boschi, arbusteti,
siepi, garighe, pascoli, praterie) presenti in una data area.
Vegetazione caducifoglia: comunità vegetali costituite in prevalenza da
specie che perdono le foglie in inverno.
Vegetazione potenziale: comunità vegetale che si svilupperebbe stabil-
mente in un dato luogo in assenza di azioni di disturbo.
senza di comunità azonali, tra le quali le più diffuse sono quelle igrofile effimere delle pozze temporanee che si formano in inverno sugli altipiani, le comunità a giunchi, carici, tife e Phragmites australis nei fiumi e le comunità rupicole che si stabiliscono sulle falesie vulcaniche al margine degli altipiani. (E.F.)
Quercia da sughero (Quercus suberis)
-
-
-
-
-
-
31
Il territorio del comune di Monteleone Rocca Doria occupa una superficie di circa 13 km2, risultando il penultimo comune della Sardegna dal punto di vista demografico con 134 abitanti nel 2000, mentre dal punto di vista di estensione territoriale vi sono ben 37 comuni più piccoli (ISTAT, 2001). Si sviluppa intorno al lago artificiale dell’Alto Temo la cui realizzazione, conclusa con la costruzione dell’omonima diga nel 1984, ha profondamente modificato il paesaggio agrario, avendo sommerso i terreni di fondo valle che erano certamente i più fertili. Il comune ha una orografia collinare, geologicamente è formato da rocce eruttive del terziario, trachiti, tufi trachitici, mentre il centro abitato si erge su un rilievo di tufo calcareo di circa 400 m s.l.m.Dall’analisi delle foto aeree si osserva un paesaggio abbastan-za omogeneo in cui spiccano ampie aree con la vegetazione arborea piuttosto rada e prevalenza del pascolo permanente, mescolate ad aree di minore estensione dove le componenti boschiva ed arbustiva sono preponderanti. In questo conte-sto, gli appezzamenti coltivati rappresentano un elemento minoritario e risultano individuabili dalla forma pressoché regolare, sono spesso circondati da siepi, oppure da muretti a secco fatti per lo più di blocchi di trachite.
2.2il paesaggio agrario
Piccoli appezzamenti coltivati a vite ormai quasi abbandonati
31
Pascoli delimitati da muretti a secco
Il sistema dei muretti a secco è tuttavia più frequentemente associato alle superfici occupate dal pascolo facendole somi-gliare alle cosiddette tancas pastorali, particolarmente diffuse nella Sardegna centro-occidentale, sebbene di estensioni me-diamente inferiori. Nella campagna le poche costruzioni presenti assolvono so-prattutto alla funzione di ricovero animali ed attrezzi; non è diffusa l’abitazione in senso stretto se non piccoli spazi dedi-cati alla vita rurale.Il paesaggio agrario risulta quindi caratterizzato quasi esclu-sivamente da pascoli, utilizzati prevalentemente da ovini da latte, che rappresentano la componente zootecnica predomi-nante con circa 4000 capi, seguiti da bovini e da caprini. Le superfici pascolive rappresentano poco meno del 70% della SAU (Superficie Agricola Utilizzata) ed insieme alla macchia mediterranea occupano circa 550 ettari in cui l’intervento an-tropico si limita alla sola utilizzazione dell’erba (ISTAT, 2000). Negli ultimi decenni, anche come conseguenza della crisi del settore lattiero-caseario, le pratiche agronomiche di miglio-ramento del pascolo, quali fertilizzazione fosfo-azotata e de-cespugliamento, sono state completamente abbandonate così come alcune superfici normalmente destinate alla coltivazione risultano ormai incolte e trasformate anch’esse in pascoli.
32 33
Sullo sfondo del lago aree aperte destinate al pascolo
Lo spazio lasciato alla coltivazione è limitato al 30% della SAU ed è comunque legato prevalentemente all’attività zootecnica. Oltre il 90% delle aree coltivate corrisponde infatti ad erbai a ciclo autunno-invernale di loiessa e prati di trifogli annuali autoriseminanti che vengono pascolati e/o sfalciati a fine pri-mavera per produrre scorte di fieno. In alcune annate, piccole superfici irrigue sono destinate ad erbaio estivo di mais, altre, di estensione molto modesta, sono coltivate con orti familiari. Nell’ambito delle colture arboree, le sole specie ad assumere un ruolo significativo in termini di superfici occupate sono l’olivo per la produzione di olive da mensa e da olio e la vite. Le due colture insieme non superano 8 ha. In entrambi i casi, la coltivazione è molto estensiva e la viticoltura è in fase di progressivo abbandono. Le formazioni boschive occupano estensioni piuttosto limitate, sono generalmente molto aperte e mescolate alla macchia.Secondo il V Censimento Generale dell’Agricoltura (ISTAT, 2000) i boschi occupano circa 180 ha di cui oltre il 65% rappre-sentati da latifoglie ed in particolare da querceti caducifogli di roverella (Quercus pubescenses Willd.) ed in minore misura
32 33
da sugherete (Quercus suber L.) e da boscaglie ad olivastro (Olea europaea L. subsp. sylvestris Brot.). La scarsa densità e la mancanza di vigore delle essenze boschive, comuni a mol-te formazioni forestali della Regione, vengono generalmente attribuite all’eccessivo sfruttamento avviato soprattutto dalla seconda metà del XIX secolo per la costruzione delle ferrovie isolane e la produzione di carbone. Tuttavia, anche altri fattori che possono aver influito sulla scarsa copertura boschiva del territorio di Monteleone Rocca Doria, tra i quali le pratiche millenarie del nomadismo pastorale come l’incendio, lo sfrut-tamento a fini agricoli delle aree boscate e l’influenza della geomorfologia naturale.Il paesaggio agrario del territorio di Monteleone Rocca Doria sinora descritto rispecchia la situazione attuale che deriva dalle complesse interdipendenze tra potenzialità e vincoli delle caratteristiche ambientali, del contesto socio-culturale, delle politiche economiche. Il suo aspetto è perciò mutabile, dinamico, probabilmente orientato in futuro verso una ulte-riore estensivizzazione dell’uso delle risorse ed una sempre maggiore diffusione dei pascoli permanenti a discapito delle coltivazioni, già molto limitate. (G.S.)
img?
La Rocca
34 35
La geologia di Monteleone Rocca Doria, nonostante l’esigua estensione del suo territorio comunale, presenta diversi tipi di affioramenti rocciosi, formatisi in tempi geologici differenti.Al Miocene sono attribuibili le vaste formazioni di calcari or-ganogeni, testimonianza di ambienti costieri, e sopravvissuti come residui di antiche erosioni sul rilievo di Su Monte, sulla cui sommità si sviluppa l’abitato di Monteleone Rocca Doria.Questi calcari sono stati sfruttati come materiale da costruzio-ne almeno a partire dalla fase fenicio-punica, poi nel periodo romano, in quello medievale e postmedievale, grazie all’aper-tura di cave di varia estensione i cui fronti di coltivazione si identificano con chiarezza ancora oggi in diversi punti dei versanti di Su Monte.Uno studio dei diversi tipi di calcare e l’utilizzo di questi litoti-pi nelle architetture storiche del luogo potrà in futuro consen-tire di comprendere quali cave siano state sfruttate nei vari periodi storici e per la costruzione di quali edifici. È già stato verificato che per la costruzione di alcuni edifici privilegiati o di particolare committenza (come il palazzo dei Doria, le chie-se di Santo Stefano e di Sant’Antonio) le maestranze medievali avevano individuato calcari della migliore qualità e durezza fra quelli reperibili localmente e a tal fine vennero riaperte cave antiche o inaugurati nuovi luoghi di coltivazione.
2.3la geologia e le cave
L’altura di Su Monte
34 35
Piazzale e fronte di cava sul versante meridionale di Su Monte
L’impatto prodotto sul paesaggio dalle attività di cava di epoca contemporanea (esauritesi nei primi anni ’80 del Nove-cento), con i terrazzi e fronti di coltivazione in cui sono ben leggibili le varie fasi di estrazione dei blocchi, si può in una certa misura considerare ormai un vero e proprio monumen-to di archeologia industriale, una ferita nel paesaggio, ma al contempo un segno importante della storia del lavoro della comunità locale. I calcari di Monteleone Rocca Doria coprono, nella successio-ne della stratigrafia geologica, rocce di origine vulcanica con matrice costituita da ceneri e pomici, che risultano erose dal Temo e ridepositate sotto forma di argille, che sono state con ogni probabilità sfruttate in vari periodi per la produzione di manufatti fittili, quali vasellame e tegole.In questo senso alcune indicazioni provengono dalle prime analisi petrografiche condotte su campioni di ceramiche grez-ze medievali dallo scavo del castello e dalle fonti orali, che suggeriscono l’esistenza di fornaci per tegole attive fino ai primi decenni del XX secolo nell’area attualmente occupata dal bacino artificiale del Temo. (M.M.)
36 37
“Sono nel territorio di Monteleone sei norachi, e nominati Nu-raghe-mannu, Nuraghe-curtu, Nuraghe-Calvia, Nuraghe-pa-stinos, Nuraghe-Tudèra, Nuraghe-nie, in gran parte disfatti”. Così riferiva Vittorio Angius, nella prima metà del XIX secolo, nell’articolo su Monteleone Rocca Doria compilato per il Dizio-nario di Goffredo Casalis sugli Stati del Regno di Sardegna.L’Elenco degli Edifici Monumentali, pubblicato nel 1922 dal Mi-nistero per la Pubblica Istruzione, riporta solamente i nuraghi Mannu e Nie, mentre nell’edizione archeologica del Foglio 193 dell’IGM, edita nel 1940, Antonio Taramelli poteva censire al-meno cinque dei sei nuraghi del Dizionario del Casalis: due nu-raghi Tudèra (alto e basso), uno dei quali forse corrispondente al Pastinos dell’Angius, ed inoltre i nuraghi Nie, Mannu, Tanca ‘e sa Mura o Calvia (che nel Taramelli diventa “Caloia” per un errore di trascrizione). Il nuraghe Curtu elencato dall’Angius è probabilmente il nuraghe “Culzu”, ubicato presso il confine; Emanuele Melis, nella sua Carta dei Nuraghi, lo attribuisce al territorio di Monteleone Rocca Doria, ma in realtà esso appar-tiene senza dubbio al comune di Villanova Monteleone.Al Taramelli si deve anche la prima segnalazione dell’unico monumento prenuragico di Monteleone Rocca Doria: la domus de janas di Monte Airadu, o Furrighesos. La tomba fa parte di un gruppo di due ipogei preistorici (Cultura di Ozieri, Neoli-tico Recente, seconda metà del IV-inizi del III millennio a.C.), scavati entrambi sui versanti del Monte Airadu, ma in territori comunali diversi: la seconda domus, nota col nome di Sos Aladervos, è situata infatti entro i confini di Romana.La tomba di Monte Airadu, scavata su una parete calcarea, si compone di quattro ambienti. L’ingresso, sormontato da un in-cavo trapezoidale, è stato notevolmente manomesso; introdu-ce in una piccola anticella quadrangolare (m 1,50 x 1,60 x 0,80 h.). Sulla parete opposta all’ingresso, un portello da accesso alla cella principale, di forma rettangolare irregolare (m 3,20 x 1,95 x 1,00 h.) e disposta trasversalmente rispetto all’anti-cella, in uno schema a “T”. Ai due lati della cella principale, si aprono i portelli che comunicano con altri due ambienti: a sinistra, una piccola cella di pianta semiellittica, con volta a forno (m 1,40 x 1,45); a destra, un grande vano quadrango-
3.1il territorio in età preistorica e protostorica
38 39
lare di m 4,70 x 2,25 x 0,90 h. Il portello di accesso presenta una singolare decorazione in rilievo, costituita da una fascia orizzontale superiore che si prolunga, alle estremità, in due appendici verticali che vanno ad incorniciare la parte superiore del portello, analogamente a quanto avviene nel portello della cella F della tomba dei “vasi tetrapodi” di Santu Pedru (Alghe-ro-SS); per questo particolare, Ercole Contu avanza l’ipotesi che possa trattarsi della stilizzazione di un motivo taurino a corna ribassate.Non si ha notizia certa di insediamenti del Neolitico nel ter-ritorio di Monteleone Rocca Doria, ma dalla collezione Spano provengono due accette litiche levigate, databili più o meno a questo periodo, rinvenute nel 1873 in località Mudeju Longu.Più consistenti paiono essere, invece, le tracce degli inse-diamenti di età nuragica. Ben quattro dei cinque nuraghi di Monteleone Rocca Doria si dispongono, a breve distanza l’uno dall’altro, nel raggio di un chilometro, in un’area immediata-mente a nord della grande ansa del Temo, presso la diga che sbarra l’omonimo bacino artificiale. Si tratta dei nuraghi Tanca ‘e sa Mura (o Calvia), Tudèra alto, Tudèra basso e, leggermen-te più distante, Sa Nie. A sud, invece, il nuraghe Mannu, unico all’interno del territorio comunale di Monteleone, fa parte di una lunga schiera di torri nuragiche disposte lungo l’asse nordovest-sudest, a controllo delle alture che circondano i contrafforti orientali del Monte Minerva (Pedrosu, Carchina, Culzu, Funtana s’Elighe, etc.).Fra i nuraghi, uno dei più interessanti è forse il Mannu, situato in località Badde Chelcu (o Santu Migali), sulla cima di uno stretto tavolato a m 367 di quota, nell’estremità settentrio-nale, da cui si ha un perfetto dominio visuale sulla valle del Temo e sull’altura dove sorge l’attuale abitato di Monteleone Rocca Doria. Il nuraghe parrebbe un monotorre (diametro m 13, altezza residua m 4), in trachite, anche se nei pressi si osservano tracce di altri muri affioranti dal suolo, forse però pertinenti a capanne del villaggio. L’ingresso, orientato a sud-est, è crollato ed occultato dalla vegetazione: residua l’ultimo tratto di corridoio, dalla probabile scala d’andito sino alla ca-mera, coperto a lastre trasversali.La camera circolare (diametro m 5, altezza residua m 1,70) presenta tracce di tre nicchie disposte in croce, pressoché ina-gibili perché il riempimento della camera le ha praticamente
38 39
occultate. Quella centrale è abbastanza sgombra, e ci si può calare dall’alto, dal pertugio risultante dalla parte superiore dell’ingresso, in quanto il piano della camera, a causa del riempimento, è notevolmente sollevato rispetto a quello della nicchia. Singolare la nicchia destra, che è in realtà l’accesso ad una scala di camera che girava in senso orario ritornan-do verso il corridoio di accesso, sul quale presumibilmente incombeva con una botola o un piombatoio, forse ubicato in una piccola celletta sussidiaria ricavata nello spessore murario al di sopra dell’ingresso. Più in basso, leggermente a destra, affiora appena dal suolo un’apertura, che potrebbe essere lo spiraglio di scarico dell’ingresso di una nicchia sottostante, o forse un pertugio per l’alloggiamento di un soppalco ligneo, che in genere si associa agli ingressi sopraelevati di scale di camera.Fra i nuraghi del gruppo ubicato a nord del lago, è giustamen-te noto il nuraghe Tanca ‘e sa Mura (o Calvia), soprattutto per essere stato fatto oggetto di uno scavo archeologico d’urgen-za, in quanto destinato ad essere sommerso dalle acque del bacino artificiale. Il nuraghe, notevolmente distrutto, è un mo-notorre di m 14 di diametro, che presenta ancora ben leggibili gli elementi della planimetria. L’ingresso, ancora sormontato dall’architrave, introduce nel corridoio, attualmente scoperto, su cui si affacciano la consueta nicchia d’andito, a destra, ed il vano della scala a sinistra.La camera, priva della copertura a tholos, si articola nelle consuete tre nicchie in schema cruciforme; analogamente al nuraghe Mannu, dalla nicchia di sinistra si diparte una scala sussidiaria che gira in senso orario ritornando nella zona del-l’ingresso, con il quale forse il vano era in comunicazione con un piombatoio o canale acustico, anche se l’estrema rovina delle strutture rende solo ipotizzabile questo particolare. Attorno al nuraghe si sviluppava un villaggio di capanne, abitato sin dal Bronzo Medio II (XVI-XIV sec. a.C.) come testi-moniato dai materiali rinvenuti durante gli scavi (ceramica ad ornato “metopale”). Tuttavia, l’abitato di sa Tanca ‘e Sa Mura è importante soprattutto per la fase di frequentazione di epo-ca punica, quando il villaggio e gli stessi ruderi del nuraghe furono riutilizzati, e nell’area venne impiantato un complesso insediativo di almeno 2000 metri quadri, prevalentemente legato alle esigenze produttive (soprattutto agricole), che
40 41
ebbe una durata ininterrotta dalla metà del IV secolo a.C. sino all’età romana repubblicana.Il vicino nuraghe Tudèra alto (circa 150 metri in linea d’aria), in posizione leggermente più elevata, è anch’esso un monotorre di oltre m 12 di diametro, per un’altezza residua superiore ai 5 metri. Era noto anche con il nome di Pastinos. È notevolmente crollato il lato dell’ingresso, ma il resto della struttura è anco-ra abbastanza ben leggibile nella sua stesura planimetrica; il corridoio (oggi completamente ingombro di macerie) introduce in una camera di m 4 di diametro (altezza residua delle mura-ture m 3), che si articola, come è comune per i nuraghi della zona, in tre nicchie disposte in perfetto schema a croce.Ad una distanza maggiore è il terzo nuraghe della serie, sicura-mente il meglio conservato fra quelli del territorio, rispetto al quale i due visti in precedenza si disponevano in un rapporto di dipendenza diretta. Si tratta del nuraghe Tudèra basso: un edificio in origine monotorre, che venne in seguito rinforzato con l’aggiunta di una piccola torre in addizione frontale e di un rifascio parziale, di oltre due metri di spessore, per tre lati e ad eccezione del retroprospetto.L’ingresso ancora integro, con architrave e stipiti ben lavorati, si apre sul rifascio: introduce in un lungo corridoio coperto a lastre trasversali, di oltre 6 metri di lunghezza, di cui poco più di due nello spessore del rifascio e gli altri quattro nella torre originaria; vi si affacciano a destra la nicchia d’andito ed a sinistra il vano della scala, quest’ultima interrotta dal crollo dopo un breve tratto.L’andito conduce alla camera a tholos, ancora integra, di oltre tre metri di diametro e con un’altezza sul riempimento di m 5. Contrariamente agli altri nuraghi, dove prevale lo schema delle tre nicchie in croce, nel Tudèra basso la camera è marginata da due solo nicchie, a destra e a sinistra, non molto profonde ed alte al massimo un metro sul riempimento, a testimonianza del notevole stato di interro del monumento.Attorno al nuraghe si estendeva un villaggio nuragico, il quale, analogamente a quello del vicino nuraghe Sa Tanca ‘e sa Mura, ebbe anch’esso una lunga fase di riuso dall’età punica a quella romana. Mulas riferisce, a tal proposito, della presenza di filari di pietre affioranti dal terreno, e in cui “una di queste pietre è a bugnato”.Ancora sulla sponda nord del fiume Temo, a circa un chilome-
40 41
tro a nord-ovest del Tudèra basso, è ubicato l’ultimo dei nura-ghi conosciuti di Monteleone Rocca Doria: il nuraghe Su Nie, o Chercu Manna. Doveva trattarsi di un nuraghe complesso, forse la fortezza principale della zona; purtroppo, il suo stato di rovina è notevole ed attualmente non si osservano che dei ruderi completamente invasi dalla fitta vegetazione. Si distin-gue, tuttavia, una torre principale (del diametro di 12 metri, per un’altezza residua di m 2,50 su due filari di pietre) inglo-bata probabilmente in un bastione dall’incerta articolazione planimetrica, in cui tuttavia sono evidenti, nella zona frontale, le tracce di un cortile con muri ad andamento rettilineo.Per quanto riguarda l’aspetto funerario di età nuragica, Fulvia Lo Schiavo segnala la presenza di una tomba di giganti su una collina nei pressi dei nuraghi Tudèra, senza tuttavia specificar-ne esatta ubicazione e caratteristiche strutturali. (P.M.)
Il Nuraghe Mannu
42 43
Negli anni ’80, soprattutto a cura di Marcello Madau e di Giu-seppina Manca di Mores, è stato posto in luce l’insediamento di Sa Tanca ‘e Sa Mura, in prossimità di Monteleone Rocca Doria. Le ricerche effettuate hanno permesso di documentare un complesso rurale di notevole importanza. Ciò perché, oltre all’interesse intrinseco della struttura, si unisce la presenza di un agglomerato rurale in un periodo storico -il momento di passaggio dal governo cartaginese alla signoria romana- rara-mente documentato in Sardegna. Il complesso prima punico e poi di età romana repubblicana si addossa ad un nuraghe e a due capanne del medesimo orizzonte cronologico, creando in tal modo una continuità cul-turale non nuova per l’isola. Una numero considerevole di torri nuragiche complesse presenta nelle sue immediate vicinanze gruppi di strutture riferibili soprattutto alla prima età romana: si citano a titolo di esempio i nuraghi più noti quali il Santu Antine di Torralba e il Losa di Abbasanta.I centri di riferimento del complesso sembrano essere costitui-ti da Alghero e da Bosa, dai cui antichi insediamenti tuttavia non scaturiscono numerose notizie relative al periodo che ci interessa in questa sede. In particolare, l’antico insediamento di Alghero è totalmente sottoposto alla città moderna, mentre per quel che riguarda Bosa, l’impianto in località San Pietro, si avvicina cronologicamente a quello di Sa Tanca ‘e Sa Mura. Quello che sembra caratterizzare il nostro complesso archeolo-gico è la precocità del primo insediamento di età storica -il IV secolo a.C.- che in genere non è soverchiamente documentato, ma che nel nostro caso è reso palese dai materiali più antichi. Numerosi ambienti con murature rettilinee si addossano alla struttura nuragica monotorre e la assorbono all’interno del complesso. Nel caso del nostro insediamento si tratta di un palese precedente delle numerose villae rusticae che, espres-sione del latifundium caratteristico dell’età romana imperiale, occuperanno il contado della Sardegna, in un’attività produtti-va assai complessa e differenziata.Il momento di maggiore frequentazione sembra attestato tra i prodromi dell’occupazione romana (238 a.C.) e la metà del secolo successivo, nel momento in cui la pressione dell’eser-
3.2Cartaginesi e Romani
42 43
cito romano contro la guerriglia tardo-punica andava via via scemando.I materiali conservati all’interno del complesso contribuiscono ad avvalorare la cronologia suggerita. Accanto a numerose scorie ferrose, che suggeriscono una lavorazione dei metalli, nel momento più antico si possono notare ceramiche di mani-fattura punica accanto a quelle di produzione attica.Seguono poi le anfore commerciali puniche e di tradizione cartaginese accanto a manufatti in vernice nera o in ceramica acroma locale.In definitiva, l’insediamento di Sa Tanca ‘e Sa Mura documen-ta in modo egregio tutti gli aspetti peculiari di un complesso agricolo in attività nel corso di circa trecento anni e in buona parte autonomo, ma non slegato dalla vita e dai contatti con i maggiori centri dell’isola. (P.B.)
L’insediamento di Sa Tanca ‘e Sa Mura
44 45
In età romana il territorio di Monteleone Rocca Doria si trovava collocato in una posizione non distante da importanti vie di collegamento, come la strada a Turre Karales, asse portante della viabilità della Sardegna romana, che scorreva ad est con un percorso di collegamento Porto Torres – Cagliari, seguito anche dalla moderna strada “Carlo Felice”.Ad ovest, il limitrofo territorio di Villanova Monteleone era attraversato da un’altra strada romana (nota dall’Itinerario Antoniniano del III secolo d.C.), che, provenendo anch’essa da Porto Torres, si sviluppava, in prossimità della costa occiden-tale, con un andamento quasi parallelo al precedente, toccava Nure e Carbia nel territorio algherese e poi, oltrepassato il Monteleonese, si indirizzava a meridione verso Bosa, Cornus e Tharros, per poi riunirsi alla strada a Turre Karales nel raccor-do di Othoca – Santa Giusta.La presenza, a sud di Monteleone, dell’importante centro de-mico di Gurulis Vetus (l’attuale Padria), su cui esiste una fio-rente produzione di studi e ricerche, determinava in quest’area un nodo di collegamento tra la viabilità occidentale, Bosa e l’asse Porto Torres – Cagliari.Il territorio rurale di Monteleone, compreso quindi fra le strade appena ricordate, doveva essere solcato da strade minori, che ricalcavano in parte la preesistente viabilità fenicio-punica e romana ed i cui tracciati possono essere in parte sopravvissuti fino ad oggi.Anche la distribuzione degli insediamenti lungo la valle del fiume Temo può rappresentare un’indicazione indiretta del passaggio delle strade, così come il Ponte Ettori tra Padria e Villanova Monteleone, ma una puntuale identificazione della viabilità minore non può essere attuata in altro modo che con tecniche diagnostiche ed indagini mirate ed approfondite, a causa delle trasformazioni avvenute nel territorio nei secoli seguenti.Solo in periodi di particolare siccità riemergono dall’invaso artificiale del Temo i resti dell’insediamento pluristratificato di Sa Tanca ‘e Sa Mura, indagato da M. Madau e G. Manca di Mores nel 1984, prima che il sito fosse sommerso dalle acque del bacino. Qui è stato possibile identificare, in un contesto
3.3il territorio in età romana
44 45
di occupazione nuragica e punica, una fase di età romana tardo-repubblicana, databile al II-I secolo a.C., con tecniche edilizie di qualità, definite “di cultura edilizia di tipo urbano”. Fra i reperti, ceramica a vernice nera, anfore vinarie di area campano-laziale e ceramica comune da cucina della medesi-ma provenienza, che hanno suggerito un abbandono del sito nel corso del I secolo a.C. Alcuni graffiti punici su ceramiche romane del II secolo a.C. testimoniano infine l’uso della lingua punica in età romana. Come Sa Tanca ‘e Sa Mura, anche altri nuraghi del territorio di Monteleone Rocca Doria mostrano tracce di un utilizzo nel corso dell’età romana, com’è il caso del nuraghe di Tudèra basso, utilizzo citato dal Taramelli nella sua Carta Archeologi-ca, un fenomeno diffuso, comune anche nei limitrofi territori di Padria e di Villanova Monteleone e che appare con grande evidenza nelle osservazioni sul campo, ma che attende ancora di essere studiato in modo sistematico.Sui versanti sommitali di Su Monte, ai margini del paese at-tuale, alcune cisterne, segnalate già da tempo come “romane”, potrebbero essere in buona parte medievali, come suggerisce il recente scavo di una di queste strutture ipogee, avvenuto in Piazza Convento nel 2004 in occasione di lavori di ripavi-mentazione del centro storico di Monteleone Rocca Doria. La struttura si è poi rivelata essere un silos per la conservazione di grano ed orzo, databile ad epoca tardo-medievale.Nel corso delle campagne di scavo nell’area del castello di Monteleone, sulla sommità di Su Monte, sono stati rinvenuti discreti quantitativi di reperti ceramici di epoca romana, pre-valentemente in giacitura secondaria, cioè rimossi in epoca medievale o postmedievale dalla loro originaria posizione di abbandono o scarico avvenuta in età romana.Le ceramiche rinvenute descrivono un ampio orizzonte crono-logico, a partire almeno dalla media e tarda età repubblicana (III-II secolo a.C.) fino alla tarda età imperiale (IV-V secolo d.C.): si tratta di ceramiche a vernice nera con decorazioni a rotella dentata, anfore vinarie di provenienza italica per l’età repubblicana, mentre frammenti di ceramiche da mensa (Sigil-lata Chiara) ed anfore di provenienza nord-africana costitui-scono gli indicatori cronologici della fase più avanzata.Le tracce archeologiche di età romana rinvenute sulla sommità di Su Monte, non risultano in associazione a strutture murarie,
46 47
ma, come si è detto, sono ridepositate nei periodi successivi e pertanto non è al momento possibile costruire su di essi inter-pretazioni definitive: in un solo caso, uno strato con materiale romano è stato rinvenuto a contatto diretto con la roccia, ma in prossimità del ciglio del versante del rilievo e sembra pertanto trattarsi di uno strato depositato con il dilavamento delle piogge e degli agenti atmosferici.La quantità rilevante di ceramiche di tarda età imperiale sug-gerisce comunque la possibilità di un fenomeno di risalita dell’insediamento dalle pendici del rilievo, con una rioccu-pazione della sommità (certamente già occupata nei periodi precedenti, come suggeriscono i ritrovamenti di strumenti litici preistorici e ceramici di epoca nuragica) e l’organizzazione di un insediamento accentrato e difeso anche dalla natura stessa del luogo, secondo una dinamica il cui studio dovrà essere oggetto di ricerche future. (M.M.)
46 47
Già dal tardo Millecento e dal Duecento, un ceppo della fami-glia genovese dei Doria riuscì a consolidare la propria presen-za in Sardegna grazie ad un’abile politica matrimoniale perse-guita in modo sistematico, proprio come, sempre in Sardegna, fece anche un’altra famiglia ligure, originaria della Lunigiana, i Malaspina: infatti, nel 1180 Susanna de Lacon, figlia del giudi-ce Barisone (uno dei re sardi) sposò Andrea Doria, sancendo il legame tra le due casate.Questa unione, come i successivi matrimoni strategici tra esponenti dei Doria e donnikelle sarde (queste nobili ragazze locali portavano in dote estesi patrimoni fondiari) determi-narono la formazione di una potente signoria Doria nel nord ovest della Sardegna, in quel territorio che ancor’oggi si chia-ma Logudoro, un nome che numerosi studiosi interpretano come Logu de Auria, territorio dei Doria.Non disponiamo tuttavia, ad oggi, di documenti scritti ante-riori alla metà del Duecento, per meglio ricostruire le vicende di Monteleone, sede della curatoria di Nurcara, in un’epoca in cui possiamo comunque supporre essere stata una delle sedi della signoria fondiaria dei Doria, dove probabilmente era presente una delle loro residenze nel territorio rurale facente parte del patrimonio familiare.
3.4il castello tra storia ed archeologia
La chiesa di Sant’Antonio, ai margini dell’attuale abitato
49
La chiesa romanica di Sant’Antonio abate (Sant’Antoni de su fogu) è tuttavia attribuita alla prima metà del XIII secolo e quindi costituisce un importante indicatore di una certa consi-stenza demografica del villaggio in quel periodo e di possibili investimenti locali da parte de potere signorile.
Chiesa di Sant’Antonio, lato est
Carta dei villaggi della curatoria medievale di Nurcara
49
È probabile pertanto che già nella prima metà del Duecento Monteleone avesse assunto una posizione privilegiata rispetto agli altri villaggi presenti nel territorio di Monteleone (come Tudèra, indicato dal Day come sede di un villaggio medievale abbandonato) e a quelli della curatoria di Nurcara (Minutades, Muntcort, Avellanis, Curos, oltre a Villanova, Romana e Mon-tresta).La signoria sarda dei Doria si consolidò ulteriormente nel corso del Duecento, in particolare dopo l’estinzione, avvenuta nel 1259, con la morte della regina Adelasia, della dinastia dei Lacon del giudicato o regno di Torres.È a partire da questi anni, negli ultimi decenni del Duecento, che i Doria, rimasti di fatto padroni del territorio, poterono controllare ampie porzioni del Giudicato di Torres, l’Anglona, parte del Meilogu e l’area di Alghero. Per meglio difendere il territorio della loro signoria sarda, essi rinforzarono il loro scacchiere strategico con la fondazione di un vera e propria rete di castelli (l’attuale Castelsardo-Castelgenovese nel Medioevo, Alghero e Monteleone) che erano al contempo residenze fortificate e simboli del potere che ormai dominava sulle popolazioni locali: un vero e proprio sistema territoriale, che disponeva anche di numerosi porti, come Alghero, Porto Leone (il Porto di Monteleone, l’attuale Porto Tangone) ed altri approdi.
Panoramica dell’area di Porto Leone
50 51
È dunque questo il significato del castello di Monteleone, che lo scavo archeologico ha iniziato a restituirci nel suo aspetto materiale, dopo la distruzione avvenuta nel 1436, l’abbando-no e lo spoglio durato per lunghi secoli, fino agli anni 50 del Novecento.Lo scavo archeologico ha rivelato aspetti sconosciuti dell’as-setto delle fortificazioni del castello, che appartengono alme-no a due periodi distinti. Quello più antico è provvisoriamente databile al tardo Duecento, un momento fondamentale per il consolidamento dei Doria in Sardegna: il ritrovamento di maggiore interesse è un grande edificio, interpretabile come residenza fortificata, di planimetria rettangolare (m 16 x m 10) con murature dello spessore da m 1,50 a m 2, suddiviso in due ambienti, probabilmente magazzini, con copertura a volta a botte, comunicanti fra loro con un’apertura ad arco. La residenza signorile vera e propria poteva essere ospitata ai piani superiori, organizzati su solai in legno e pavimenti in mezzane di terracotta. Le strutture sono realizzate con grandi blocchi rettangolari di calcare, perfettamente tagliati e legati con malta estremamente tenace, opera di maestranze specializzate nella scelta e nella lavorazione dei materiali. Basti pensare che negli strati di crollo dell’edificio, sono stati rinvenuti parti di murature crollate al momento della distruzione della struttura, che ancora conservavano, legati
Vista del “palazzo” al termine della campagna di scavo 2004.
50 51
Blocco di muratura di crollo della facciata del “palazzo”
tra di loro dalla malta, numerosi blocchi: la scelta di que-sto particolare legante si deve con ogni probabilità alla funzione difensiva del palazzo ed alla necessità di resistere ad eventuali attacchi con strumenti e macchine da guer-ra, così come attestato da alcuni verettoni per balestra, testimonianza di assalti al palazzo, rimasti incastrati nel-la facciata, negli spazi di connessione tra i vari blocchi.
Blocco di crollo recante graffite le “orme del pellegrino”
52 53
Particolare di un graffito raffigurante “orma del pellegrino”
Su alcuni blocchi del paramento murario esterno del palazzo, crollati al momento della distruzione della struttura e su altri delle murature ancora nella loro originaria posizione, si con-servano, graffiti, innumerevoli segni, fra i quali croci e graffiti a forma di calzare. Si tratta delle cosiddette “orme del pelle-grino”, che i pellegrini incidevano sulle pareti delle chiese, per testimoniare, con il simbolismo del calzare, il loro passaggio in quella località: il fatto che desta particolare interesse nel ritrovamento di Monteleone è che questi segni, in Sardegna, erano noti finora solo su chiese (come nella stessa chiesa di Sant’Antonio a Monteleone), mentre qui li possiamo documen-tare su un’architettura civile, inserita nelle fortificazioni del castello.Particolare suggestione suscitano infine alcuni graffiti con lo stemma del Comune di Genova, forse dovuti ai balestrieri ge-novesi che ingannavano in tal modo la noia di lunghi turni di guardia al castello, la cui fama risuona frequentemente anche nella storia della Sardegna.A questo stesso periodo (seconda metà XIII secolo) viene attri-buita la chiesa di Santo Stefano, importante fabbrica romanica (alla quale è dedicato uno specifico approfondimento), proba-bilmente utilizzata anche con funzioni di cappella signorile, anch’essa riferibile a maestranze specializzate.
Particolare di un graffito raffigurante lo stemma di Genova
54 55
Particolare di un graffito raffigurante l’insegna dei Doria
L’attributo del leone, che nel Medioevo contraddistinse alcuni membri della casata dei Doria, recanti il nome di Brancaleone
54 55
Nei pressi della chiesa è presente (ma ricollocata di recente) una lastra recante a rilievo un’aquila con le ali spiegate, recu-perata dalla demolizione di una casa del paese: il rilievo è di particolare interesse in quanto si tratta dell’insegna dei Doria (a partire dall’inizio del Trecento), unitamente ad un altro ri-lievo con un leone di profilo di ancor più esplicita allusione: è probabile che in origine, al di là delle più recenti vicissitudini, questi rilievi fossero murati sulle pareti del palazzo, a simbo-leggiare il casato signorile che dominava il luogo.Nella seconda metà del XIV secolo (questa la datazione emer-sa finora dai reperti) il castello viene interessato da un con-sistente potenziamento delle difese e il palazzo duecentesco viene inglobato in un nuovo percorso difensivo, costituito da una cinta muraria e da alcune torri (Figg. 23-24), realizzate con tecniche differenti rispetto al primo impianto. Una di queste torri, a pianta quadrata, che aveva il delicato compito di pro-teggere la “Porta Fontana”, è stata completamente posta in luce dallo scavo, che ne ha definito la cronologia trecentesca.
Queste nuove difese si possono forse attribuire all’opera di
Panoramica generale della cinta trecentesca
56 57
riorganizzazione effettuata a partire dal 1366 da Brancaleo-ne III Doria, in un periodo nel quale, a seguito della caduta di Alghero nel 1354, il ruolo strategico di Monteleone cresce d’importanza nello scacchiere politico-militare dei Doria in Sardegna, diventando, a fianco di Castel Genovese (l’attuale Castelsardo) il quartier generale della signoria. L’aggiunta di una seconda navata alla chiesa di Santo Stefano, che quasi raddoppia la capienza dell’edificio ecclesiastico, è una tra-sformazione attribuita al Trecento (vedi l’approfondimento seguente), che potrebbe trovare una sua interpretazione nel nuovo ruolo di Monteleone dalla metà del secolo e da un possibile incremento demografico, di cui non abbiamo tuttavia riscontri di altra natura. Lo stato di guerra pressoché permanente, nonostante periodi di tregua, a fianco di Arborea ed in opposizione alle forze della Corona aragonese, chiarisce il senso di questo ulteriore impe-gno di risorse finanziarie indirizzato dai Doria al potenziamen-to delle difese del castello, che, dopo la caduta del Giudicato arborense nel 1410, dovrà reggere un lungo assedio negli anni 1434-36, conclusosi con la resa finale e la distruzione totale di questo significativo polo strategico. (M.M.)
Porta Fontana
56 57
La facciata della chiesa di S. Stefano
Interno della chiesa di S. Stefano, a destra la navata aggiunta nel XIV secolo
58 59
L’ingresso dei Doria nella Sardegna dei giudicati è da ricollega-re inizialmente all’iniziativa del Comune di Genova, del quale spesso ricoprirono le massime cariche istituzionali. Tuttavia, come nel caso di altre casate nobili continentali, l’autonoma politica familiare, di indirizzo signorile, finì per divergere in più occasioni da quella della madrepatria. Inoltre, la grande rami-ficazione della casata fece sì che, col tempo, si distinguessero i Doria impegnati nell’espansione signorile in Sardegna da quelli al vertice delle istituzioni genovesi.Durante il XII secolo appaiono legati in particolare ai giudici di Arborea e Torres, ma le tormentate vicende del giudice orista-nese Barisone finirono per indirizzare la politica di espansione dei Doria verso il giudicato di Torres, dove rivestirono un ruolo attivo all’interno della casa regnante, grazie anche ad una oculata strategia matrimoniale. Nonostante i solidi legami fa-miliari e diplomatici instaurati, non sono tuttavia documentate acquisizioni territoriali: recenti studi hanno, infatti, dimostrato l’infondatezza di cronache quattro-cinquecentesche che attri-buivano ai Doria la fondazione di Castelgenovese e di Alghero nel 1102.È a partire dalla terza decade del Duecento che le fonti comin-ciano a registrare con puntualità il dominio dei Doria in alcuni territori del giudicato di Torres, nel periodo in cui, in rapida successione, morirono i giudici Mariano II (1232), Barisone III (1235) e Ubaldo II Visconti (1238), mentre l’ultimo, Enzo di Svevia, abbandonò ben presto la Sardegna (1239), affidando il governo del regno a dei vicari. Si trattava di un’instabile si-tuazione politico-istituzionale nella quale vennero a scontrarsi gli interessi pisani e genovesi e le aspirazioni autonomistiche della città di Sassari, a fronte di un giudicato ormai agoniz-zante.I Doria non paiono subire gli effetti dei frequenti cambi al ver-tice del potere, ma, al contrario, dimostrano di riuscire a trar-ne significativi benefici, tanto da alimentare più di un sospetto su un loro coinvolgimento diretto o indiretto nelle questioni di successione. Se si dà credito ad una cronaca duecentesca, sarebbero stati, infatti, Manuele, Federico e Percivalle Doria, insieme all’arcivescovo turritano Opizzo, genovese, a propizia-
3.5i Doria, signori di Monteleone
58 59
re l’unione di Adelasia di Torres con Enzo. Non è da escludere, dunque, che per questo motivo i Doria fossero stati beneficiati con l’assegnazione di territori.L’amministrazione dei vicari di Enzo nel Logudoro non resse alle sempre più pressanti manovre espansionistiche che muo-vevano da più fronti. Nel 1259 la scomparsa senza eredi di Adelasia, la quale in punto di morte aveva indicato la Santa Sede quale erede dei diritti sul regno di Torres, decretò la fine di fatto del giudicato (Enzo sarebbe morto in prigionia a Bologna nel 1272). Nei decenni successivi i Doria, così come Pisani, Genovesi, giudice di Arborea, Comune di Sassari, Spì-nola e Malaspina, si resero protagonisti di aspre lotte per la conquista dei territori del giudicato o la difesa dei privilegi acquisiti.Alla data del 1287 il complesso dei beni sardi dei Doria era cre-sciuto enormemente e comprendeva, da ovest verso est e da nord a sud: parte dell’isola dell’Asinara; parte dell’ex curatoria di Nurra; il castello di Mondragone; numerosi villaggi della Flumenargia (Cherchi, Ardu, Save, Taverna, Lenza, Lequilo e Gennano); terre nell’ex curatoria di Nulauro e nella corte di Curcascho e di Titari; il castello di Monteleone (Castel Leone) e terre nell’ex curatoria di Nurcar (Nuduno, Porto Leone); terre presso Sassari e presso il villaggio di Geridu; Castelgenovese, Casteldoria e l’ex curatoria di Anglona; la curia di Bisarcio.A cavallo tra XIII e XIV secolo, Brancaleone I Doria si affermò quale principale esponente della casata. Egli chiese ed ottenne nel 1299 da parte del papa Bonifacio VIII la conferma della le-gittimazione della madre Preziosa, al fine di vedere riconosciu-ti i propri beni sardi dalla Sede Apostolica. Altrettanto ottenne Brancaleone nel 1312 dall’imperatore Enrico VII. La strategia del Doria era legata alla volontà, se non di proporsi come an-tagonista di Giacomo II d’Aragona nel ruolo di possibile “re di Sardegna”, di salvaguardare i diritti sui possedimenti sardi in vista della conquista catalano-aragonese. Questo nonostante avesse stipulato nel 1308 con lo stesso Giacomo II dei preci-si accordi diplomatici, che confermavano a Brancaleone e al figlio Bernabò, che si dichiaravano vassalli del re d’Aragona, castra et loca ac terras que vos habere et possidere dicitis in Turritano sive Logodorio, sita in regno Sardinie, ovvero: 1) Ca-stelgenovese e Casteldoria, con la ex curatoria di Anglona ed il territorio del villaggio di Viddalba (situato nel, confinante,
60 61
ex giudicato di Gallura); 2) il castello e il villaggio di Ardara; 3) il villaggio di Bisarcio; 4) l’ex curatoria di Meilogu; 5) l’ex curatoria di Caputabbas; 6) il castello di Monteleone con l’ex curatoria di Nurcar; 7) Alghero con l’ex curatoria di Nulauro, la corte di Curcas e l’ex curatoria di Nurra. Tali territori veni-vano concessi in feudo ai Doria iuxta Usaticos Barchinone e secondo il mos Cathalonie, con mero e misto imperio ed ogni giurisdizione, dietro prestazione di omaggio, giuramento di fedeltà e il servizio di cento cavalli armati da prestare per tre mesi all’anno, a proprie spese.Le vicende dei Doria in Sardegna successivamente all’arrivo dei Catalano-Aragonesi si presentano estremamente comples-se e caratterizzate da una posizione non univoca della casata genovese nei confronti della Corona. Nel luglio del 1323 Berna-bò, figlio di Brancaleone, confermò l’atto di vassallaggio nelle mani dell’infante d’Aragona Alfonso. Tuttavia, già dall’anno successivo cominciarono a manifestarsi chiari segni di contra-sto tra alcuni esponenti dei Doria ed il governo catalano-ara-gonese, che sfociarono più volte in aperte rivolte armate.Lo stato pressoché costante di guerriglia ebbe il suo momen-to cruciale nel 1347 nella battaglia di Aidu de Turdu, dove furono clamorosamente sconfitte le truppe regie guidate da Guillem de Cervelló. La constatazione della forza militare dei Doria e l’infuriare della peste nera (1348-49) consigliarono ai Catalano-Aragonesi la ricerca di un accordo diplomatico. Un documento aragonese presenta l’inventario di numerosi villag-gi allora appartenenti ai Doria, che il re d’Aragona intendeva infeudare a Mariano IV di Arborea e al fratello Giovanni. La fonte è esemplificativa della ramificazione della casata ge-novese e della conseguente distribuzione dei possedimenti in aree corrispondenti ad altrettante signorie territoriali: 1) ventuno villaggi dell’Anglona, insieme a quello di Bisarcio; 2) ventuno villaggi situati in Caputabbas e Nurcar, pertinenti a Brancaleone II Doria; 3) dieci villaggi in Ardar e Meilogu, di Damiano Doria, figlio di Salado; 4) sei villaggi di Balarano o Valarano Doria, figlio di Salado; 5) sei villaggi in Caputabbas, di Moruello Doria; 6) tre villaggi in Caputabbas, di Galeazzo Doria; 7) due villaggi in Nurcar, di Manfredi Doria.Lo scontro aperto fra Corona d’Aragona e Genova per il dominio del Mediterraneo, scatenatosi fin dal 1331, ebbe naturalmente dei riflessi in Sardegna, in cui ai Doria realisti
60 61
si contrapponevano altri esponenti della famiglia più vicini a Genova, alla quale il 15 febbraio 1353 cedettero i propri diritti. Nell’agosto dello stesso anno la città di Alghero fu occupata dall’esercito regio in seguito ad una battaglia navale svoltasi presso la baia di Porto Conte. Accanto alla famiglia genovese si schierò allora il giudice di Arborea Mariano IV, che in tal modo ruppe la trentennale alleanza con la Corona. Alghero fu riconquistata, ma l’anno successivo una grossa spedizione guidata dal re Pietro IV pose fine, almeno provvisoriamente, al conflitto, destinato in realtà a protrarsi per tutto il secolo.Nel 1366 circa Brancaleone III Doria, figlio naturale di Branca-leone II, sposò Eleonora di Arborea, figlia del giudice Mariano IV, ponendo le basi per la futura unificazione dei suoi posse-dimenti sardi con quelli giudicali arborensi. Dopo la morte, nel 1383, di Ugone III, primogenito di Mariano, in virtù delle disposizioni in materia di successione dinastica stabilite dalla casa regnante di Arborea, la donnikella Eleonora trasmise il titolo di giudice non al marito Brancaleone ma ai figli Federico e Mariano, che nel 1383 erano ancora minorenni. La cattura di Brancaleone nel 1384 e l’oggettivo momento di difficoltà attraversato dal giudicato di Arborea (l’erede al trono Federi-co morì nel 1387) agevolarono il raggiungimento di un nuovo accordo di pace tra Aragona e Arborea, stipulato nel 1388 dal re Giovanni I il Cacciatore e dalla giudicessa Eleonora, la quale avrebbe retto il giudicato fino al 1402, quando salì al potere l’altro figlio, Mariano.La morte di Brancaleone III, nel 1409, segnò la separazione fra i Doria e la casa di Arborea. Al governo del giudicato salì, infatti, Guglielmo visconte di Narbona, nipote francese di Eleonora, che nello stesso 1409 venne sconfitto a Sanluri da Martino il Giovane, re di Sicilia ed erede d’Aragona. Castelge-novese divenne allora l’estremo baluardo della resistenza an-ticatalana, sotto la guida prima di Cassano Doria ed in seguito di Nicolò, figlio naturale di Brancaleone III, il quale capitolò nel 1448. La sconfitta di Nicolò pose fine alla secolare signoria dei Doria, consentendo alla Corona d’Aragona di conquistare definitivamente la Sardegna. (A.S.)
62 63
Il paese di Monteleone Rocca Doria sorge sul versante me-ridionale di un piccolo altopiano calcareo inclinato da nord verso sud, dominando l’intera vallata dell’alto Temo che fin da epoca nuragica fu importante via di comunicazione tra la costa nord-occidentale e l’interno della Sardegna.La sua topografia attuale potrebbe in parte ricalcare quella medievale, pianificata dai Doria (signori di questo territorio a partire dal XII secolo) con l’incastellamento dell’area del tardo Duecento.La sua poderosa cinta fortificata eretta lungo il versante me-ridionale del colle, quello più accessibile, proteggeva l’intero borgo e il castello, localizzato nella parte sud-occidentale.Questo, protetto dai venti di maestrale e in stretto contatto visivo con il castello di Bonvehì, altra roccaforte genovese si-tuata su un aspro rilievo che oggi si trova in Comune di Mara, controllava l’intero territorio e la sua importante viabilità.Nell’organizzazione spaziale del castello medievale di Mon-teleone, l’area signorile si differenziava da quella religiosa e da quella civili, per le loro caratteristiche ben definite sia dal punto di vista funzionale che topografico.L’area del castello, soggetta a indagine archeologica dal 1998 fino al 2004, in origine doveva risultare molto più estesa rispetto alle strutture emerse durante le ricerche, perciò si
3.6la topografia dell’abitato
Panoramica di Monteleone dal monte “Su Bastione”
62 63
potrebbe ipotizzare un suo sviluppo a nord dell’area di scavo fino agli ex edifici scolastici, i quali probabilmente furono co-struiti sulle antiche strutture.Questo era il centro principale del potere, accoglieva gli al-loggi per il signore e per la corte, gli edifici per le guarnigioni militari e per gli armamenti e probabilmente, nella seconda metà del Trecento, l’archivio signorile con i documenti relativi alla famiglia ed ai possedimenti nel territorio.
Strutture residenziali del castello emerse con gli scavi archeologici
Castello di Bonvehì
64 65
La fortificazione proteggeva tutto il versante meridionale del colle denominato oggi Su Monte, ma che in passato, e ancora nel medioevo veniva chiamato Tutar, mentre le porzioni set-tentrionali erano difese naturalmente grazie ai bruschi salti di quota che ancora oggi ne caratterizzano il paesaggio.Gli accessi al borgo erano localizzati nella parte sud-occiden-tale e sud-orientale dalla fortificazione, esattamente ai suoi estremi.Questa, in continuità fisica con le strutture rinvenute nell’area di scavo, si sviluppava dal castello, in prossimità del quale una torre a pianta quadrangolare controllava la porta di acces-so chiamata ancor oggi “Porta Fontana”.Proseguiva lungo la parte meridionale del pianoro per oltre ottocento metri, intervallata da circa 10-11 torri a pianta circo-lare, utilizzate come punti di avvistamento e riparo per il corpo di guardia, giungendo nella parte occidentale del colle, dove sotto l’altra torre a pianta quadrangolare chiamata de s’istrìa chiudeva il suo tragitto ad appoggiandosi alle pareti naturali verticali ed inaccessibili del Monte Tutar.
Torre nei pressi de sa Porta de Sant’Antoni
64 65
La viabilità di risalita e gli accessi al castello
I due ingressi al borgo, controllati dalle due torri a pianta quadrangolare, poste in prossimità delle due porte d’accesso, permettevano l’accesso nei due versanti, quello est e quello ovest.Il primo di questi collegava la rocca di Monteleone con la viabilità che da Alghero e Villanova portava a Padria, fino a Bonorva e da lì fino al Goceano, quella occidentale invece ar-rivava fino a San Lussorio, Romana, Ittiri, e da lì al nord-ovest dell’isola.All’interno del borgo, gli unici centri religiosi documentati fino ad ora sono relativi alle due chiese ancora oggi esistenti.Nel Medioevo la chiesa di Santo Stefano era certamente l’edificio religioso più importante dove si svolgevano, oltre le normali funzioni religiose, anche importanti riunioni relative alla vita politica del territorio. Nel corso del XIV secolo, la
Tracciato del sistema difensivo del castello
66 67
chiesa di Santo Stefano, venne raddoppiata nella planimetria con l’aggiunta all’impianto originale di una navata sul lato meridionale. Questa chiesa fu uno dei pochi edifici che non venne raso al suolo dopo la conquista di Monteleone da parte degli Aragonesi nel 1436.A questa era forse annesso un convento, del quale è rimasta una chiara traccia nella toponomastica della piazza situata immediatamente a nord della chiesa. Nel Medioevo la chiesa di Sant’Antonio Abate, situata alla periferia settentrionale del paese, in prossimità dell’attuale Via degli Orti, era probabil-mente il centro religioso maggiormente utilizzato dai contadi-ni e dagli abitanti del castello appartenenti alle classi sociali meno agiate.Oltre queste due, esisteva nel versante orientale del colle di Monteleone Rocca Doria, una presunta terza chiesa, di cui però oggi esiste solamente il toponimo. La chiesa di Santa Barbara non sembra attualmente documentata da nessuno scritto, anche se nella memoria locale esiste ancora oggi il mito di questo edificio sacro.Diverse ricognizioni effettuate nell’area, hanno permesso di rinvenire e documentare alcune tracce di strutture e numerosi
La facciata della chiesa di S. Stefano con il raddoppio dell’edificio
66 67
tagli nella roccia che potrebbero, con uno studio più detta-gliato fornire maggiori dettagli, anche se attualmente e senza un’adeguata indagine archeologica quest’area rimane di diffi-cile interpretazione.Nelle strutture del castello e in alcuni tratti della cinta for-tificata sono stati individuati diversi reimpieghi di materiale proveniente da strutture più antiche, probabilmente di epoca classica, anche se il problema è ancora in corso di studio. Que-sta ipotesi è supportata dal rinvenimento di numerosi reperti di epoca romana in diverse aree dello scavo e nelle ricognizio-ni e ricerche svolte nel territorio.Un’altra area documentata durante le ricognizioni nel territorio del colle di Monteleone Rocca Doria riguarda le aree di approv-vigionamento e stoccaggio delle risorse alimentari.Sono stati individuati, fotografati e rilevati diversi silos, cono-sciuti erroneamente nella zona come “cisterne romane”; alcuni sono ancora ispezionabili, altri invece sono stati distrutti dai diversi lavori di cava di materiale edile che durante tutti gli anni ’80 sono intervenuti in tutta la parte settentrionale del colle.
Le due absidi della chiesa di S. Stefano
68 69
Uno di questi, situato all’interno del paese ed individuato nel 2004 grazie a dei lavori di sistemazione stradale, è stato sca-vato interamente ed ha restituito materiale di XV secolo.L’analisi e lo studio del Castello di Monteleone Rocca Doria è stato completato anche dallo studio, seppur in fase prelimi-nare, della topografia del paese e del suo territorio. A questo proposito è stata effettuata una ricognizione estensiva, con i fini di capire la viabilità e individuare le vie di accesso al castello.Il lavoro è stato sviluppato in tre momenti diversi, i primi due relativi al rilievo del castello ed alla cinta fortificata hanno riguardato principalmente il lavoro sul campo, il terzo invece ha riguardato l’elaborazione e la rappresentazione dello studio attuato nei primi due momenti. (M.A.D.), (M.M.), (L.S.)
Tratto di cinta difensiva sul versante nord del castello
68 69
Circa un secolo dopo l’abbandono forzato di Monteleone a se-guito della conquista aragonese del 1436, Carlo V re di Spagna concedette il permesso di ricostruire un insediamento stabile nella parte meridionale della sommità del colle.Ai fini di acquisire dati relativi a queste fasi, sono state utiliz-zate le metodologie dell’Archeologia dell’Architettura che, ap-plicate a un centro storico, permettono di condurre un’indagi-ne non distruttiva basata sull’analisi delle evidenze e l’utilizzo del metodo comparativo.Dalle indagini di scavo è infatti emerso che, a seguito della definitiva distruzione del castello, le uniche frequentazioni dell’area sono dirette alla spoliazione delle strutture sepolte. L’analisi degli elementi riutilizzati presenti nelle case del borgo ha permesso di evidenziare almeno due sistemi di prelievo: ac-canto ad un’azione di spoglio occasionale per la costruzione di muri di terrazzamento o di recinzione, si colloca un intervento sistematico mirato alla commercializzazione dei blocchi meglio lavorati utilizzati come materiale da costruzione.Un buon campionario è raccolto in una parete con un’apertura architravata situata a ovest della chiesa di S. Stefano realiz-zata interamente in blocchi recuperati da edifici rasati per la sistemazione della piazza negli anni ’70 del XX secolo, prove-nienti dal castello. Un dato interessante è rappresentato dalla
3.7il borgo e lo spoglio del castello
Blocco di spoglio proveniente dalle rovine del castello
70 71
presenza di tre altorilievi su fondo neutro, immediatamente al di sopra dell’architrave, di probabile appartenenza al palazzo signorile dato il contesto in cui si trovano e il soggetto rap-presentato.Sul prospetto orientale sono infatti state inserite una lastra di medie dimensioni con un leone di profilo volto verso sinistra e un’altra di piccole dimensioni, a ridosso dell’angolo meridio-nale della prima, raffigurante un’aquila ad ali spiegate proba-bilmente in volo, mentre sul prospetto occidentale è presente una lastra di medie dimensioni con un rapace acefalo stante di prospetto ad ali aperte. Si attesta nel borgo anche la presenza di edifici di epoca postmedievale in bozzette e pietre selezionate legate con malta di terra, che continuano una tradizione già attestata a Monteleone nelle murature attribuibili alle fasi più antiche documentate dagli scavi stratigrafici e in alcune delle strutture pertinenti alle fortificazioni bassomedievali del castello.La presenza di tratti pertinenti alla cinta nella parte meridiona-le e occidentale del monte a ridosso dell’attuale centro storico, l’assenza di tracce di fortificazione nell’area settentrionale e orientale, nonché la fonte perenne nell’estremità sud del colle, suggeriscono una continuità nella posizione dell’insediamento confermata da indicatori archeologici (manufatti ceramici e liti-ci), ma non con altrettanta chiarezza nelle strutture murarie. (M.F., A.M.)
Sa funtana, particolare
70 71
Numerose case storiche del borgo di Monteleone ancora conservate perché in abbandono o non pesantemente ristrut-turate, sono state sottoposte negli ultimi decenni a continue ed incontrollate distruzioni, senza alcuna documentazione preventiva delle strutture storiche cancellate, un processo che lascia ben poche speranze per uno studio dell’architettura sto-rica di questo centro negli anni futuri. Il modello architettonico più semplice della casa, rappresentativo dell’edilizia popolare fino agli anni Cinquanta del Novecento, è riconducibile ad una tipologia elementare, basata su un unico ambiente al piano terra, con arcate che ripartiscono lo spazio interno ed è pro-prio questa tipologia che è quasi scomparsa. Esistono tuttavia anche tipologie differenti di case, che, dal tardo Ottocento, ispirandosi a modelli urbani, impiegano non soltanto materiali locali, ma più costosi materiali d’importazio-ne, come tegole toscane o francesi per i tetti ed ardesia ligure per scale e davanzali.Nelle case più semplici, invece, il focolare, al centro della stanza, liberava fumi che si disperdevano nell’ambiente (la porta dell’abitazione e l’unica finestra potevano contribuire al miglioramento del tiraggio del fumo), con una risalita verso l’incannicciato della copertura, dove trovavano una parziale via d’uscita. Il tetto, grazie ad uno spiovente a falda unica, coinvolgeva le acque piovane sulla strada, ma in alcuni casi è documentabile il doppio spiovente: le travi maggiori suppor-tavano i travetti e l’incannicciato, sul quale era poggiata la copertura in coppi di terracotta, prodotti nelle fornaci locali. Il pavimento era in terra battuta, la porta era composta da sti-piti e da un architrave monolitico, talora solo sommariamente lavorato, in altri casi recanti invece alcuni elementi decorativi: un censimento sistematico di queste testimonianze presenti nel centro storico di Monteleone potrebbe consentire la defini-zione di una cronotipologia utile per lo studio dell’evoluzione dell’abitato.I muri perimetrali sono realizzati in doppio filare di pietre calcaree solo sommariamente lavorate, legate con solo fango argilloso e riempimento a sacco con argilla e scaglie litiche: nell’impasto del legante dei muri è frequente identificare fram-
3.8la casa
72 73
Portale di abitazione storica
Particolare dell’intonaco argilloso con paglia
menti ceramici, ossa, carboni, che potrebbero, se documen-tati, costituire importanti elementi per datare la costruzione delle strutture murarie.In numerose di queste case storiche del paese non manomes-se negli ultimi 50 anni, si nota un intonaco a base di argilla e paglia tritata, assai diffuso negli ambienti rurali della Sarde-gna medievale e postmedievale, ma riconducibile più esten-sivamente ad una koinè mediterranea, con ampissimi estremi cronologici. (M.M.)
72 73
Al centro dell’abitato di Monteleone Rocca Doria sorge la chiesa di Santo Stefano, eretta in forme romaniche secondo un primo impianto mononave e successivamente ampliata e modificata, fino al XIX secolo.L’edificio dovette essere edificato entro la seconda metà del XIII secolo; si trattava di una chiesa ad aula con tetto a ca-panna ed abside a semicatino orientata ad est, secondo un modello molto frequente nell’isola.La teoria di archetti a sesto vagamente acuto, che compone la decorazione in cornice dell’abside, mostra un repertorio formale evoluto, con peducci e specchiature variamente e geo-metricamente decorati; entro due archetti, simmetricamente, si conservano due visi umani in altorilievo. La porzione di fac-ciata afferente al primo impianto, conserva invece le austere caratteristiche di un edificio romanico, con teoria di archetti a tutto sesto che corona le due falde; unica nota caratteristica l’alloggio residuo per ospitare un catino ceramico in apice del prospetto, oggi scomparso e che doveva certamente rimarcare il tema simbolico dell’accesso al luogo sacro. Dell’originario portale si intravedono parte dei piedritti e dell’arco lunettato tamponato. Dell’interno si può solo supporre che fosse a ca-priate lignee.Durante il XIV secolo, forse per mutate esigenze di culto ed a seguito di un incremento della frequentazione del sito, l’edi-ficio fu ampliato con il raddoppio della navata e dell’abside;
3.9la chiesa di santo Stefano
Particolare della facciata della chiesa di S. Stefano
74 75
cosicché, come la vediamo oggi, la chiesa di Santo Stefano mostra una icnografia gemina perfettamente strutturata. Non può ingannare l’osservatore, tuttavia, lo scarto di registro nel repertorio decorativo utilizzato, particolarmente nell’abside, dove la teoria di archetti di coronamento mostra un reper-torio decorativo ormai goticheggiante, con arco ogivale e ghiera trilobata su peducci a foglie d’acqua, tutti uguali. La facciata aggiunta, anch’essa con profilo a capanna, scarica su una parasta aggettante che divide il prospetto in due ampie specchiature; nonostante le dimensioni più modeste del corpo aggiunto e l’evidente asimmetria complessiva, il fronte ci ap-pare oggi magistralmente ricomposto e reinterpretato. D’altro canto reinterpretati (o certamente di recupero) sono anche gli archetti di coronamento utilizzati per questo secondo prospet-to. È probabile infatti che durante il XV-XVI secolo, per quanto risulta da raffronti su edifici analoghi nell’isola, il fronte princi-pale fosse nuovamente riprogettato per una razionalizzazione degli elementi romanici in facciata, fino all’innalzamento della stessa culminante con un prospetto rettilineo che obliterava scenicamente la sequenza delle falde (si pensi ai modelli ca-talani o dell’Italia centrale). Un oculo illuminava questo vano;
L’abside meridionale di S. Stefano, con archetti e volti umani
74 75
oggi rimodellato conserva una singolare decorazione con rilievo di una mano. Non meno rimaneggiato sembra il muro d’ambito del fronte orientale, che mostra leggibili tra i corsi dei conci lapidei, le tracce di successivi rialzamenti e modifi-che della copertura.Oggi i due vani interni sono in completa connessione, tale che lo spazio dilatato in larghezza si percepisce nella sua dualità soltanto nella parte tergale con le absidi affiancate. L’ambiente è diaframmato da pilastri tozzi e massicci attraverso ampie arcate che alludono ad un livello pavimentale successivo note-volmente rialzato. La copertura del vano meridionale è a botte con sottarchi ed unghie, mentre il vano settentrionale è risolto in maniera più complessa per la presenza di setti ad arcate che delimitano quattro cappelle laterali, frutto di successive manomissioni (XVIII e XIX secolo).Contribuisce a conferire all’edificio uno straordinario aspet-to di omogeneità, l’utilizzo costante della calcarenite locale pezzata, nelle parti arcaiche residue, in blocchi lapidei per-fettamente squadrati ed apparecchiati quasi a secco in corsi pseudo-regolari alti circa cm 30. Nella facciata a nord è pos-sibile apprezzare la commistione delle tecniche costruttive utilizzate, le tracce di una meridiana. (G.F.)
Abside meridionale della chiesa di S. Stefano (interno)
77
I primi interventi archeologici nell’area del castello di Monte-leone, avviati nel 1998, furono per lungo tempo indirizzati allo scavo delle discariche del borgo, che, in particolare nel XX secolo, avevano interessato la zona archeologica, in quanto questa risulta tuttora ubicata ai margini del paese attuale.Da quel momento, quattro campagne di scavo, per un totale di circa 15 mesi di lavoro, hanno infatti impegnato diversi Enti, le Università di Pisa e di Sassari, il Comune di Monteleone Rocca Doria e la Soprintendenza Archeologica per le Province di Sassari e Nuoro, in un lungo e complesso lavoro di scavo, per il recupero e la valorizzazione di questo importante sito archeologico medievale, che è il castello di Monteleone.Nel procedere dei lavori, sono stati individuati due poli essen-ziali di questa parte del sito, quali un palazzo, con probabili funzioni residenziali e una torre quadrangolare, nei pressi di uno degli accessi al castello.Nel cantiere, accanto alla presenza costante degli archeologi a cui si devono i testi seguenti ed altri contributi presenti in que-sta pubblicazione, si sono alternati un centinaio di studenti, che hanno contribuito in modo determinante alla realizzazione del lavoro, accanto alle maestranze locali, di fondamentale ausilio per il buon andamento del cantiere. (M.M.)
4.1le indagini archeologiche
La torre di Porta Fontana in corso di scavo
78 79
L’analisi della stratificazione archeologica indagata in tre adiacenti aree di scavo, strettamente congiunta a quella delle strutture murarie conservate in elevato, ha permesso di com-prendere l’articolazione degli interventi costruttivi nella parte meridionale del castello. Il dato più evidente è quello relativo ad una complessità prima inimmaginabile, cronologicamente scandita e, di conseguenza, maggiormente confrontabile con i dati conosciuti attraverso le fonti storiche. Sulle tracce di un preesistente insediamento romano, testimo-niato da alcune labili impronte in negativo lasciate sulla roccia e dall’ elevato numero di reperti ceramici residuali, riferibili ad un orizzonte cronologico compreso tra il IV ed il VI secolo d.C, i Doria, nel tardo XIV secolo impiantano il cantiere di amplia-mento della fortezza.In primo luogo viene eretta la torre quadrata, secondo una tecnica costruttiva organizzata nella progressiva elevazione a vista dei muri in bancate successive. Questo criterio costrut-tivo si adegua alla situazione morfologica dell’area, permet-
Scavo delle fasi di fondazione della torre di Porta Fontana
4.2la torre di Porta Fontana
78 79
tendo, simultaneamente, la realizzazione delle fondazioni e la regolarizzazione del pendio. La struttura, che doveva rag-giungere un’altezza considerevole, aveva un tetto in tegole e permetteva di avere a disposizione un punto fortificato con una visuale sorprendente su tutta la vallata sottostante e sul vicino castello di Bonu Ighinu, uno degli altri presidi fortificati del complesso sistema di controllo territoriale dei Doria.A sud la torre si lega ad un muro di cinta, di cui rimangono labilissime tracce, che doveva percorrere il limite estremo me-ridionale dell’area. A nord invece viene addossata alla torre un’altra grossa strut-tura muraria, che, salendo in direzione del castello parallela-mente ad un altro muro, visibile solo in parte lungo il limite ovest dell’area, doveva creare un asse viario sud-nord, di cui sono state scavate e documentate due sovrapposte pavimen-tazioni. Lo stretto sentiero scavato nella roccia che si inerpica sul pendio, raggiunta la sommità viene convogliato in un pas-saggio obbligato, abbastanza largo da permettere il transito di carri o di truppe e facile da controllare.È presumibile che nei pressi della torre si trovasse una delle porte del castello.Nell’area compresa tra la residenza fortificata e i muri di cin-ta si estendeva un ampio spazio aperto, una piazza d’armi, adibita alle più svariate attività, come sembra dimostrare il rinvenimento di resti di un forno da pane addossato al muro di cinta occidentale.La scoperta, nei depositi archeologici della torre, di pedine in ceramica, dadi in osso, punte di freccia e di balestra, monete, ci ha fatto infine immaginare i militari che, armati sino ai denti, nelle interminabili ore delle guardie, trovavano anche il tempo per giocare e magari per scommettere anche un po’… (S.S.)
80 81
L’area denominata “del palazzo”, sorge sul versante sud-orientale del colle di Monteleone Rocca Doria, anticamente chiamato Monte Tutar, capoluogo militare ed amministrativo della curatoria medievale del Nurcara. Protetto dai venti di Maestrale, si erge a controllo della viabi-lità che mette in collegamento la costa nord-occidentale con l’entroterra logudorese, in diretto contatto visivo con l’altra roccaforte genovese di Bonu Ighinu, oggi nel territorio di Mara.Le fonti documentarie conosciute fino ad oggi e riguardanti il castello, sono ancora molto scarse e lacunose nel loro insie-me, difatti non si conosce il periodo esatto in cui la famiglia ligure dei Doria inizia la costruzione del castello. I pochi dati a disposizione sul periodo giudicale (secoli X-XII) offrono notizie generiche, e più in generale solo sulla curatoria di Nurcara (distretto amministrativo) nella quale era inserito il probabile centro di localizzabile sul colle. I primi documenti pertinenti nello specifico al sito fortificato di Monteleone, con citazione esatta del suo toponimo, sono datati solo a partire dalla seconda metà del secolo XIII, dove compare associato al termine castellum anche se non si fanno accenni alla struttura monumentale, né alla sua organizza-zione topografica interna, né al suo possibile rapporto con il villaggio di supporto alla struttura militare. Fortificazione che all’interno dei documenti non è esplicitata nella sua destinazione residenziale o sola di guarnigione, an-che se la sua posizione ai margini orientali della collina, ne attesta palesemente per l’edificio una tangibile qualificazione di struttura destinata all’immediato controllo territoriale e alla viabilità presente nella valle sottostante. Il “palazzo”, emerso dopo lo scavo archeologico faceva parte del nucleo del castello vero e proprio dal quale partiva un grosso impianto fortificato che cingeva l’intero monte me-diante delle invalicabili protezioni naturali e delle poderose strutture che correvano lungo tutto il versante meridionale del colle.Benché in questa fase la stratigrafia delle aree non sia stata indagata completamente, questo primo momento dello scavo
4.3il palazzo
80 81
è stata fondamentale al fine di comprendere la reale estensio-ne del complesso archeologico e la possibile estensione del castello oltre gli attuali confini catastali.Una seconda campagna di scavo è stata realizzata nel 2002, permettendo di terminare lo scavo di uno degli ambienti del palazzo e comprendere l’evoluzione planimetrica dell’intero complesso, compreso il collegamento fisico tra l’area del “pa-lazzo” e la torre.L’ultima indagine svolta nel 2004 ha permesso di ultimare gli scavi stratigrafici nei due settori, 1.000 e 2.000, di sondare stratigraficamente l’intera particella catastale e di definire in maniera univoca la cronologia del sito.La parte dell’edificio rinvenuto nell’area 1.000 documenta una struttura a pianta semplice, rettangolare, divisa all’interno in due ambienti voltati a botte e comunicanti mediante un’aper-tura sormontata da un arco a tutto sesto.Le enormi porzioni delle volte a botte rinvenute, ancora ben conservate, documentano la presenza di almeno un primo piano, mentre gli ambienti inferiori rinvenuti dovevano essere adibiti a magazzini o cantine.I muri perimetrali esterni dell’edificio sono formati, nella parte inferiore dell’alzato, da enormi blocchi di cui non si esclude si tratti di materiali di recupero da strutture più antiche, mentre nelle parti elevate rinvenute vengono utilizzati blocchi di cal-care locale lavorati e ben squadrati.All’esterno del palazzo sono presenti degli avancorpi relativi, quasi certamente, ad una scala per accedere al piano supe-riore, due ingressi mettevano in comunicazione l’ingresso del palazzo con l’esterno.Uno portava al cortile, una sorta di piazza d’armi localizzata immediatamente a sud, ed alla quale si accedeva mediante una scalinata ancora in situ ed una porta, testimoniata ancor oggi dalla presenza di due grossi alloggiamenti per i cardini, l’altro invece attraversava una stretta porta, probabilmente costruita così per ragioni di sicurezza, mettendo in comuni-cazione il piano terra del palazzo con il lato ovest, che dava immediatamente su una strada acciottolata. Questa correva tra due altissime e robuste mura, parallele e molto strette, costruite apposta così affinché avrebbero co-stretto un eventuale esercito nemico a passare piano e pochi soldati per volta, così da poter essere facilmente sopraffatti
82 83
e annientati. In questo modo il nucleo principale del castello era protetto da una doppia fortificazione che permetteva una maggiore protezione al signore nel caso che il nemico riuscisse ad en-trare nel borgo.Con questo sistema erano in comunicazione tutte le vie di fuga e di comunicazione col paese, nel modo più rapido e sicuro.Queste strutture collegavano inoltre il palazzo con la torre a pianta quadrata che controllava la Porta Fontana, una delle due che permettevano l’accesso al borgo fortificato.L’estensione del complesso signorile non era però limitato solamente a questa zona, infatti l’area su cui si è intervenuti riguarda l’estremità meridionale del mastio che dovrebbe com-prendere molti altri ambienti, ancora sepolti nella particella catastale immediatamente a nord.Lo scavo archeologico realizzato, ha prodotto una consistente quantità di documenti che, man mano che la ricerca prosegui-va, schiariva sempre più la situazione, fino a consegnarci un quadro d’insieme estremamente definito.È plausibile supporre che la particella catastale immedia-tamente a nord dell’area 1.000 contenga ancora la maggior parte delle strutture relative al castello, formate, probabil-mente, da diversi ambienti contigui e necessari per la vita di una consistente guarnigione di soldati, del signore con il suo seguito e delle aree politico–amministrative fondamentali per l’amministrazione dell’intera curatoria e territori di pertinenza al castello.I mesi di indagine e studio, hanno restituito una cronologia molto precisa in tutte le aree indagate, e collocano le strutture emerse ed i suoi piani di vita in una fase relativa alla fine del XIII sec.È verosimile, a questo punto, che i Doria costruiscano il castel-lo a Monteleone quando ormai il potere del giudicato di Torres non esiste più e i vari signori che hanno ottenuto privilegi e possedimenti in Sardegna inizino la loro politica insediativa nella Sardegna settentrionale.La vita del castello non dura così più di 150 anni. Infatti la sto-riografia è molto precisa in questo senso, e confermata anche dall’archeologia, ci informa che il castello, dopo due anni di assedio strettissimo da parte degli aragonesi, nel 1436 viene conquistato e distrutto.
82 83
Le fonti storiche raccontano ancora che il castello venne con-quistato grazie all’assedio e non vi furono delle feroci batta-glie che interessarono il territorio di Monteleone.Così pare anche dalle fonti archeologiche, le quali testimo-niano azioni distruttive all’interno dell’area indagata, ma non sono stati rinvenuti strati che documentassero grosse situa-zioni di incendio o di abbandono di armi e suppellettili.Certamente in una fase successiva all’assedio ed alla distru-zione del castello e del borgo di Monteleone gli abitanti stes-si rifrequentarono i luoghi a loro appartenuti e, pian piano ripopolarono il colle, probabilmente prima quasi in silenzio, poi quando fu ormai una cosa assodata, gli stessi aragonesi concessero nuovamente la ricostruzione del paese e la risiste-mazione del castello.Le fonti bibliografiche ci informano che ciò accadde solo dopo un secolo, ma non sappiamo nulla di come avvenne questo processo di ripopolamento del borgo, anche perché ormai il colle aveva perso completamente la sua funzione strategico-militare.Nemmeno le fonti archeologiche ci aiutano in questo, soprat-tutto perché l’area fu da sempre usata come cava di materiale edile e perciò spogliata di tutto ciò che si potesse prelevare, ed infine come discarica, fino a cancellare quasi completamen-te ciò che la storia e l’ingegno dell’uomo erano riusciti a creare in un periodo della storia della Sardegna incredibilmente ricco di avvenimenti ed estremamente affascinante. (L.S.)
84 85
L’indagine sulle strutture del castello di Monteleone Rocca Doria è stata condotta su base stratigrafica, secondo un pro-cedimento basato sul concetto di Unità Stratigrafica Muraria (USM), definibile come il minimo intervento antropico o natu-rale riconoscibile all’interno dell’apparecchiatura muraria.Il castello è caratterizzato da una pianta quadrata divisa a metà al piano terra da un tramezzo con andamento N/S, che viene ripetuta ai livelli superiori almeno fino all’imposta delle due volte a botte collocabili dal primo piano in su.La tecnica costruttiva prevede nella parte inferiore l’uso di blocchi di grandi dimensioni all’esterno e pietre spaccate al-l’interno, mentre nel resto dell’edificio sono impiegate bozze a faccia quadra di misure omogenee, lavorate direttamente nelle cave situate nelle immediate vicinanze e poste in opera su corsi orizzontali secondo moduli di tre filari.In questa fase vengono utilizzati anche elementi di reimpiego in materiale locale attribuibili difficilmente, allo stato attuale delle indagini, ad un contesto cronologico ben definito dato che non si esclude la presenza di un insediamento punico e/o romano seguito da un’occupazione anteriore al XIII secolo (di epoca giudicale?).Le strutture denunciano un notevole impegno economico in termini di uomini e di mezzi, essendo state realizzate da mae-stranze specializzate e, in parte, da manodopera locale, con
4.4le strutture murarie
Edificio residenziale del castello
84 85
materiali e leganti fatti per durare.Alla fine del XIV secolo si provvede a chiudere l’area del pa-lazzo a Sud con una torre a pianta quadrangolare connessa ad una nuova (?) cinta, in materiale selezionato e/o spaccato posto in opera in bancate regolarizzate e a Nord con la rea-lizzazione, sempre con la stessa tecnica, di un muro di colle-gamento tra castello e vecchia cortina muraria dotato di una porta d’accesso al nuovo cortile.Per la realizzazione di questo elemento architettonico sono stati impiegati blocchi squadrati disposti su filari di altezza costante.Anche il mastio è oggetto di una serie di interventi interni quali un’intonacatura e cambio delle ferramenta, mentre all’esterno l’ingresso viene monumentalizzato sostituendo la scala lignea (?), che permetteva di raggiungere la porta principale al primo piano, con una struttura in pietre squadrate e modanate che doveva sorreggere ballatoi ai livelli superiori. Si investe soprattutto nell’impiego di maestranze altamente specializzate (scalpellini e modanatori) per conferire al castel-lo un aspetto formale più curato attraverso materiali scelti e lavorati accuratamente.Agli inizi del XV secolo si assiste a un potenziamento delle difese del complesso, attraverso la costruzione di nuove strutture rinvenute nella parte nord-ovest del palazzo e ad una risistemazione dei locali inferiori del mastio utilizzando materiale di recupero legato a terra, dove viene realizzato un setto di andamento est-ovest a dividere l’ambiente orientale in due parti e un tamponamento che riduce l’ampiezza origi-naria della porta del tramezzo.Queste opere testimoniano uno scarso investimento di denaro in termini progettuali e di manodopera costituita forse dagli stessi abitanti del villaggio o dai soldati. (M.F., A.M.)
86 87
Gli scavi dell’area del castello hanno restituito reperti relativi al periodo di vita dello stesso, dalla fine del Duecento ai primi decenni del Quattrocento. Nell’area del “palazzo” non sono state rinvenute elevate concentrazioni di frammenti o di manu-fatti scartati nella vita quotidiana, in quanto gli ambienti, trat-tandosi dell’area signorile, frequentata e con ogni probabilità anche abitata dai Doria, erano tenuti puliti ed i rifiuti venivano periodicamente portati alla discarica. Nonostante questo, nel-le macerie del palazzo crollato, sono stati rinvenuti manufatti ceramici frantumati ed oggetti metallici corrosi, quali punte di freccia per balestra (un’arma leggera, precisa e molto efficace) e molti chiodi appartenenti ai solai di legno (di cui è stato tro-vato qualche frammento carbonizzato) dei piani superiori. Fra i reperti rinvenuti, quelli più numerosi sono rappresentati dalle ceramiche, per la loro fragilità e la conseguente facilità di rottura: spesso sono decorati e riconducibili a tipi noti in Sardegna e nel Mediterraneo e per questo motivo sono data-bili con una certa precisione e spesso è stato possibile identi-ficare la loro area di produzione.Le pentole ed i tegami per cucinare erano in parte prodotti nel-le vicinanze, dove l’affiorare di argille di natura vulcanica for-niva una materia prima sufficientemente adatta per contenitori che dovevano resistere al contatto con le braci incandescenti. Sulla tavola, invece, oltre alle ceramiche che sono state rinve-nute, era probabilmente presente (come su ogni tavola ricca del tempo) vasellame metallico, che però, in quanto veniva fuso nuovamente dopo un eventuale danneggiamento, non veniva mai gettato tra i rifiuti e pertanto non è stato ritrovato nello scavo. Le ceramiche ci propongono comunque un quadro di un inse-diamento agiato, con scodelle prodotte a Barcellona ed a Va-lenza: si tratta di maioliche con decorazioni in bruno e verde, in monocromia turchese o in blu e dorature metalliche, che arrivavano a Monteleone portate da commercianti ambulanti che si rifornivano nel non lontano porto di Alghero (controllato dai Doria fino alla metà del Trecento) o dal più vicino Porto Leone. Giare d’olio catalano e valenzano testimoniano il rifornimento
4.5i reperti
88
Frammento di scodella di graffita arcaica savonese (prima metà XIV secolo)
Scodella di maiolica valenzana con decorazione floreale (prima metà XV secolo)
88
di questi prodotti negli approdi ed il loro consumo nella vita quotidiana.Tra tardo Duecento e primi decenni del Trecento, si utilizza-vano anche scodelle decorate prodotte a Savona e boccali di maiolica provenienti da Pisa, così come nello stesso periodo avveniva anche ad Alghero ed a Bosa. Al di là degli oggetti della tavola, altri indicatori economici devono essere valutati per caratterizzare il livello di benessere dei Doria e della loro corte, ovvero la loro dieta, che appare pesantemente basata sul consumo di carni di bovini, suini, pecore, capre, cervi, daini, cavalli ed asini, derivate sia dalle principali specie allevate, sia anche da un rilevante apporto della caccia, un’alimentazione integrata anche da pesce, no-nostante la relativa distanza dal mare. (M.M.)
Frammento di scodella di maiolica arcaica savonese (prima metà XV secolo)
90 91
- Vittorio Angius in G. Casalis, Dizionario geografico, storico, statisti-
co, commerciale degli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna, I-XXVIII,
Torino 1833-1856 (alla voce “Monteleone Rocca Doria”).
- Domenico Arru, Monteleone Roccadoria, Sassari, 1980.
- Roberto Coroneo, schede su “Santo Stefano di Monteleone”, “San-
t’Antonio”, in R. Coroneo, Architettura romanica dalla metà del Mille
al primo ‘300, Nuoro, 1993, pp. 244-245.
- Francesca Galli, Padria (Sassari). Censimento archeologico, 2002.
- M. Le Lannou, Pastori e contadini di Sardegna. Tradotto e presenta-
to da Manlio Brigaglia, 1979.
- Fulvia Lo Schiavo, lI materiale preistorico della Collezione Spano, in
Aa.Vv. Contributi su Giovanni Spano, Sassari 1979, pp. 67-69.
- Fulvia Lo Schiavo, Nuraghe Sa Tanca ‘e sa Mura, Monteleone Roc-
cadoria (SS), in Aa.Vv. Archeologia e territorio, guida alla mostra,
Sassari 16 giugno-15 luglio 1990, Milano 1990, pp. 85-86.
- Giuseppina Manca di Mores, Osservazioni sulla ceramica da cucina
da Monteleone Roccadoria (Sassari), “Rivista di Studi Fenici”, 16
(1988), pp. 65-72.
- Marcello Madau, Centri di cultura punica all’interno della Sardegna
settentrionale: Sa Tanca ‘e sa Mura (Monteleone Roccadoria-Sassa-
ri), in “Atti del II Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici”,
volume terzo, Roma 1991, pp. 1001-1009.
- Marcello Madau, Popolazioni rurali tra Cartagine e Roma: Sa Tanca
‘e sa Mura a Monteleone Roccadoria, in P. Bernardini, R. D’Oriano,
P.G. Spanu. (a cura di), Phoinikes b shrdn. I fenici in Sardegna, cata-
logo della mostra, Oristano 1997, pp. 143-145.
- Emanuele Melis, Carta dei nuraghi della Sardegna, Spoleto 1967.
- Ministero della Pubblica Istruzione, Elenco degli edifici monumenta-
li, vol. LXIX (Provincia di Sassari), Roma 1922.
- Tomasino Mulas, Saggio di catalogo archeologico del f. 193 q. III
Nord-Ovest Monteleone Roccadoria e IV Sud-Ovest Villanova Mon-
teleone, Università di Cagliari, anno accademico 1971-72 (tesi di
laurea).
- Rita Rivò, Scavi a Monteleone Roccadoria, in “Rivista di Studi Feni-
ci”, XIII, 2, 1985, pp. 269-273.
- Antonio Taramelli, Edizione della Carta Archeologica d’Italia. Foglio
193 (Bonorva), Firenze 1940.
92 93
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
9
11 1415
16
18
21
2627
30
34
3637
42
44
47
58
62
69
71
73
7677
78
80
84
87
90
94
Presentazione
Il progetto Monteleone
Il Parco Grazia Deledda
Monteleone e il Parco
Castelli, gnomi e folletti
Galleria dei Paesaggi deleddiani
L’antico rito del pane
L’ambiente
Flora, vegetazione e paesaggio vegetale
Il paesaggio agrario
La geologia e le cave
L’abitato e il territorio
Il territorio in età preistorica e protostorica
Cartaginesi e Romani
Il territorio in età romana
Il castello tra storia ed archeologia
I Doria, Signori di Monteleone
La topografia dell’abitato
Il borgo e lo spoglio del castello
La casa
La chiesa di Santo Stefano
Lo scavo del castello
Le indagini archeologiche
La torre di Porta Fontana
Il palazzo
Le strutture murarie
I reperti
Bibliografia
Autori dei testi
94 95
(P.B.)Piero Bartoloni
(S.C.)Simonetta Castia
(M.A.D.)Maria Antonietta Demurtas
(E.F.)Emmanuele Farris
(M.F.)Mara Febbraro
(G.F.)Gabriela Frulio
(P.M.)Paolo Melis
(A.M.)Antonino Meo
(M.M.)Marco Milanese
(S.S.)Simone Sacco
(L.S.)Luca Sanna
(G.S.)Giovanna Seddaiu
(A.S.)Alessandro Soddu