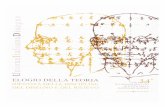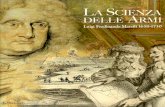Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di...
Transcript of Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di...
IL TERRORISMO SUICIDA NEL CASO PALESTINESE: UNARICERCA EMPIRICA (1993-2005)
di Francesco Marone
Though this be madness, yet there is method in ’tWilliam Shakespeare, Hamlet (1601?)
Our jihad action has exposed the enemy weakness, confusion, and hysteria. Ithas become clear that the enemy can be defeated, for if a small faithful groupwas able to instill all this horror and panic in the enemy through confronting itin Palestine and southern Lebanon, what will happen when the nation confrontsit with all its potential...Martyrdom actions will escalate in the face of all pressures... [they] are a rea-listic option in confronting the unequal balance of power. If we are unable toeffect a balance of power, we can achieve a balance of horror.
Fathi Shiqaqi, Segretario Generaledella Jihad Islamica Palestinese, 1995 (1)
Negli ultimi anni il fenomeno della violenza terroristica ha acquisitoun’indubbia rilevanza politica, specialmente nella forma degli attacchisuicidi.
Numerosi studi hanno recentemente dimostrato che, a differenza diquanto riporti una vulgata piuttosto diffusa, gli attacchi suicidi non sonoopera di singoli individui irrazionali o addirittura folli; al contrario,costituiscono azioni strumentalmente razionali condotte da organizzazio-ni che perseguono scopi politici piuttosto precisi attraverso una strategia
(1) Citato in Robert A. PAPE, The Strategic Logic of Suicide Terrorism, in «AmericanPolitical Science Review», XCVII, 2003, pp. 343-61 (il passo citato è a p. 354). Shiqaqi,fondatore e leader della Jihad Islamica Palestinese, fu assassinato a Malta nel 1995, pre-sumibilmente dai servizi segreti israeliani.
definita (2). Gli attacchi suicidi, come tutti gli atti di terrorismo, posso-no essere visti come l’espressione di una strategia politica, soggetta adun calcolo di costi e benefici (3).
Uno degli aspetti più significativi delle scelte strategiche delle orga-nizzazioni terroristiche riguarda la selezione delle vittime che, lungi dal-l’essere totalmente casuale, risponde a precisi criteri connessi alla stra-tegia adottata dall’organizzazione. Questo tema ha ricevuto finora scar-sa attenzione, nonostante la sua evidente importanza (4). La letteraturapertinente è esigua e dominata da studi di caso (5), solitamente privi direspiro teorico.
In questo articolo intendo esaminare la logica politica della selezionedelle vittime della violenza terroristica nel caso degli attacchi suicidipalestinesi. Il testo si divide in cinque sezioni. Nella prima sezione pre-sento concisamente i concetti di terrorismo e di attacco suicida; nellaseconda sezione esamino l’impiego degli attacchi suicidi nel conflitto
(2) Si vedano, tra gli altri, Ehud SPRINZAK, Rational Fanatics, in «Foreign Policy»,CXX, 2000, pp. 66-73; Robert A. PAPE, The Strategic Logic of Suicide Terrorism, cit.;ID., Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism, New York, Random House,2005; Jim WINKATES, Suicide Terrorism: Martyrdom for Organizational Objectives, in«Journal of Third World Studies», XXIII, 2006, pp. 87-115.
(3) Riferimento d’obbligo è Martha CRENSHAW, The Logic of Terrorism: TerroristBehavior as a Product of Strategic Choice, in Walter REICH (a cura di), Origins ofTerrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind, Cambridge, CambridgeUniversity Press, 1990, pp. 7-24.
(4) Ancora recentemente due studiosi di terrorismo si sono chiesti «come le organizza-zioni terroristiche scelgono i loro destinatari, dati gli scopi strategici e i vincoli sotto i qualiagiscono? Questo è un argomento in qualche modo trascurato nella letteratura sul terrori-smo» (Luis DE LA CALLE e Ignacio SÁNCHEZ-CUENCA, The Production of TerroristViolence: Analyzing Target Selection within the IRA and ETA, Estudio/Working Paper2006/230, Madrid, Instituto Juan March, Dicembre 2006, p. 1). Gli stessi autori, alla con-clusione del loro studio sull’IRA e l’ETA, sollecitano un’analisi della selezione delle vit-time della violenza terroristica palestinese: «Lo schema teorico che abbiamo sviluppatopotrebbe essere esteso in numerose direzioni. Una comparazione naturale è Israele, doveabbiamo un conflitto nazionalista con parametri molto diversi da quelli dell’Irlanda delNord e del Paese Basco: maggiori risorse, maggiore repressione, sostenitori con prefe-renze radicali ed una reale competizione tra organizzazioni terroristiche» (ibidem, p. 27).
(5) La maggior parte degli studi di caso sulla selezione delle vittime riguarda il terrori-smo europeo. Tra i contributi più interessanti segnalo Donatella DELLA PORTA, Il terrori-smo di sinistra, Bologna, Il Mulino, 1990, pp. 209-19 e 245-50; Robert W. WHITE, TheIrish Republican Army: An Assessment of Sectarianism, in «Terrorism and PoliticalViolence», IX, 1997, pp. 20-55, e la replica di Steve BRUCE, Victim Selection in EthnicConflict: Motives and Attitudes in Irish Republicanism, in «Terrorism and PoliticalViolence», IX, 1997, pp. 56-71; Luis DE LA CALLE e Ignacio SÁNCHEZ-CUENCA, La selec-ción de víctimas en ETA, in «Revista Española de Ciencia Política», VI, 2004, pp. 53-79.
FRANCESCO MARONE208
israelo-palestinese dal 1993 al 2005, servendomi di un database da mecompilato; dedico la terza sezione all’analisi della selezione delle vitti-me degli attacchi suicidi palestinesi, soffermandomi sul numero di mortie feriti provocati, sul tipo di vittime e sui loro caratteri socio-demogra-fici; nella quarta sezione esploro la logica politica della violenza indi-scriminata contro i civili; nella quinta sezione espongo alcune riflessio-ni conclusive (6).
1. Il terrorismo e gli attacchi suicidi
Il concetto di terrorismo è certamente uno dei più problematici dellescienze sociali. Gli studiosi hanno proposto moltissime definizioni diver-se senza raggiungere un accordo comune (7). In effetti, la definizione delterrorismo si rivela particolarmente disagevole, per almeno due ragioniche di fatto tendono a rafforzarsi a vicenda. La prima ragione è concet-tuale: il concetto di terrorismo è vago, non stabilendo confini precisi allasua estensione, e perciò soggetto al rischio di «stiramento concettuale»(conceptual stretching) nel senso definito da Sartori (8). La secondaragione è valutativa: l’espressione, seguendo un curioso percorso stori-co, ha assunto nel Novecento una profonda valenza denigratoria.
(6) L’appendice presenta una descrizione sintetica del database originale di cui mi sonoavvalso.
(7) Nella vasta letteratura sulla concettualizzazione del terrorismo si vedano, a titoloesemplificativo, Martha CRENSHAW, The Concept of Revolutionary Terrorism, in «Journalof Conflict Resolution», XVI, 1972, pp. 383-96; Luigi BONANATE, Dimensioni del terro-rismo politico, in ID. (a cura di), Dimensioni del terrorismo politico. Aspetti interni einternazionali, politici e giuridici, Milano, Franco Angeli, 1979, pp. 99-179; Jack P.GIBBS, Conceptualization of Terrorism, in «American Sociological Review», LIV, 1989,pp. 329-40; Alex P. SCHMID, The Response Problem as a Definition Problem, in«Terrorism and Political Violence», IV, 1992, pp. 7-13; Donatella DELLA PORTA,Terrorismo. 2. Il terrorismo nel mondo contemporaneo, in Enciclopedia delle scienzesociali, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. VIII, 1998, pp. 597-604; CharlesTILLY, Terror, Terrorism, Terrorists, in «Sociological Theory», XXII, 2004, pp. 5-13;Leonard WEINBERG, Ami PEDAHZUR e Sivan HIRSCH-HOEFLER, The Challenges ofConceptualizing Terrorism, in «Terrorism and Political Violence», XVI, 2004, pp. 777-94. Da ultimo, Neil J. SMELSER ha autorevolmente ribadito i «problemi infernali delladefinizione e della designazione» del terrorismo (The Faces of Terrorism: Social andPsychological Dimensions, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 2007,Appendix, pp. 229-50).
(8) Giovanni SARTORI, Concept Misformation in Comparative Politics, in «AmericanPolitical Science Review», LXIV, 1970, pp. 1033-53.
IL TERRORISMO SUICIDA NEL CASO PALESTINESE 209
In assenza di termini sostitutivi degni di nota, si può comunque pro-porre una definizione utile, collocabile ad un livello piuttosto alto dellascala di astrazione, secondo cui il terrorismo è una strategia di violenzapolitica organizzata perseguita da attori non statuali allo scopo di piega-re la volontà e la resistenza di uno stato (9). Il terrorismo si differenziada altre strategie di violenza organizzata ribelle, come la guerriglia, l’in-surrezione rivoluzionaria ed il colpo di stato, per la sua natura indiretta,volta ad alterare le motivazioni dell’avversario senza intervenire diretta-mente sulle sue risorse e capacità (10).
La strategia del terrorismo può assumere diverse forme, tra cui quel-la, appunto, degli attacchi suicidi. Tale forma, fino a poco tempo fa lar-gamente trascurata nella letteratura sul terrorismo (11), è meritevole diattenzione per la straordinaria rilevanza politica che ha assunto negliultimi anni. Inoltre, appare particolarmente adatta allo studio della sele-zione delle vittime, perché, minimizzando la componente casuale del-l’attacco, rivela con chiarezza le scelte strategiche dell’organizzazione.
Per attacco suicida si intende un atto di violenza politica organizza-to e premeditato, condotto in maniera clandestina contro obiettivi nemi-
(9) Come hanno argomentato numerosi studiosi, è opportuno distinguere il terrorismonon statuale dal terrore statuale, riconoscendo che le due classi di violenza politica pre-sentano logiche nettamente diverse, nonostante la presenza di alcuni tratti comuni, comela volontà di intimidazione.
(10) Per questa interpretazione prendo spunto dal pregevole articolo di Ariel MERARI,Terrorism as a Strategy of Insurgency, in «Terrorism and Political Violence», V, 1993,pp. 213-51.
(11) In modo non sorprendente la letteratura scientifica sugli attacchi suicidi con finali-tà terroristiche si è sviluppata soltanto dopo i drammatici eventi dell’11 settembre 2001;cfr. Ami PEDAHZUR, Arie PERLIGER e Alexander BIALSKY, Explaining Suicide Terrorism,in Christopher ANKERSEN (a cura di), Understanding Global Terror, Cambridge, PolityPress, 2007, pp. 37-56. Probabilmente i contributi pionieristici più stimolanti sono ArielMERARI, The Readiness to Kill and Die: Suicidal Terrorism in the Middle East, in WalterREICH (a cura di), Origins of Terrorism, cit., pp. 192-207; Martin KRAMER, Sacrifice andFratricide in Shiite Lebanon, in «Terrorism and Political Violence», III, 1991, pp. 30-47.Tra i volumi più influenti si possono citare almeno Farhad KHOSROKHAVAR, Les nouveauxmartyrs d’Allah, Paris, Flammarion, 2002: trad. it., I nuovi martiri di Allah, Milano,Bruno Mondadori, 2003; Christoph REUTER, Mein Leben ist eine Waffe, München,Bertelsmann, 2002: trad. it., La mia vita è un’arma. Storia e psicologia del terrorismosuicida, Milano, TEA, 2006; Mia M. BLOOM, Dying to Kill: The Allure of SuicideTerror, New York, Columbia University Press, 2005; Robert A. PAPE, Dying to Win,cit.; Ami PEDAHZUR, Suicide Terrorism, Cambridge, Polity Press, 2005; DiegoGAMBETTA (a cura di), Making Sense of Suicide Missions, expanded and updated edition,Oxford, Oxford University Press, 2006; Ami PEDAHZUR (a cura di), Root Causes ofSuicide Terrorism: The Globalization of Martyrdom, London, Routledge, 2006.
FRANCESCO MARONE210
ci in cui l’esecutore della violenza sacrifica intenzionalmente e consa-pevolmente la propria vita (12). Gli attacchi suicidi combinano volontà diuccidere e volontà di morire nel medesimo atto: l’obiettivo è quindi“morire per uccidere” (13). Occorre, peraltro, sottolineare che se lamorte dell’esecutore dell’atto di violenza costituisce un requisito neces-sario degli attacchi suicidi, la morte dei destinatari è un fatto contin-gente, che può verificarsi oppure no: nel contesto palestinese, per esem-pio, gli attentatori suicidi, pur sacrificando la propria vita, talvolta nonraggiungono lo scopo prefissato di uccidere altre persone. La combina-zione di volontà di uccidere e volontà di morire differenzia ovviamentegli attacchi suicidi dagli attacchi non suicidi, enormemente più frequen-ti, in cui si uccide senza morire, da una parte, e dalle auto-immolazio-ni (i semplici suicidi per scopi politici) in cui si muore senza uccidere,dall’altra (14); gli attacchi suicidi sommano così elementi degli uni edelle altre.
Secondo alcuni studiosi, l’attacco suicida rappresenta «l’atto di vio-lenza politica che contraddistingue la nostra epoca» (15). Questa tattica,pur avendo alcuni antecedenti storici (16), è stata adottata nel contesto di
(12) Sulla definizione di attacco suicida si vedano, tra gli altri, gli importanti contributidi Assaf MOGHADAM, Defining Suicide Terrorism, in Ami PEDAHZUR (a cura di), RootCauses of Suicide Terrorism, cit., pp. 13-24, e di Diego GAMBETTA (a cura di), MakingSense of Suicide Missions, cit.
(13) Come ricorda il titolo di un noto volume sull’argomento: Mia M. BLOOM, Dying toKill, cit.
(14) Sulle auto-immolazioni Michael BIGGS, Dying without Killing: Self-Immolations,1963-2002, in Diego GAMBETTA (a cura di), Making Sense of Suicide Missions, cit., pp.173-208.
(15) Diego GAMBETTA (a cura di), Making Sense of Suicide Missions, cit., p. v: «the defi-ning act of political violence of our age».
(16) Sugli attacchi suicidi dei Sicari - Zeloti nella Palestina sotto occupazione romana delI secolo d. C. e della setta sciita degli Assassini attiva in Persia e in Siria dall’XI al XIIIsecolo si veda l’ottimo articolo di David C. RAPOPORT, Fear and Trembling: Terrorismin Three Religious Traditions, in «American Political Science Review», LXXVIII, 1984,pp. 658-77 (specialmente pp. 664-72). Sugli attacchi suicidi di alcune comunità musul-mane dell’Asia sud-orientale contro l’occupazione coloniale è d’obbligo citare Stephen F.DALE, Religious Suicide in Islamic Asia: Anticolonial Terrorism in India, Indonesia andthe Philippines, in «Journal of Conflict Resolution», XXXII, 1988, pp. 37-59. NelNovecento le operazioni suicide dei kamikaze giapponesi e dei membri di alcune forma-zioni paramilitari iraniane non hanno manifestato una strategia terroristica; al contrario,sono state comprese in guerre convenzionali tra stati (la Seconda Guerra Mondiale ed ilconflitto tra Iran e Iraq). Cfr. rispettivamente Peter HILL, Kamikaze, 1943-5, in DiegoGAMBETTA (a cura di), Making Sense of Suicide Missions, cit., pp. 1-42, e FarhadKHOSROKHAVAR, I nuovi martiri di Allah, cit., pp. 79-128.
IL TERRORISMO SUICIDA NEL CASO PALESTINESE 211
una strategia terroristica soltanto recentemente, durante la guerra civilelibanese negli anni Ottanta del secolo scorso. Dal Libano la forma diviolenza si è via via diffusa in Sri Lanka, nell’area del conflitto israelo-palestinese, in India, in Turchia, in Cecenia, in Afghanistan, inPakistan, in Iraq ed in molte aree del mondo ad opera di vari movimen-ti jihadisti (17).
Il numero degli attacchi suicidi eseguiti nel mondo è cresciuto inmaniera esponenziale nel corso del tempo, soprattutto dal 2003, annodell’invasione dell’Iraq (18). Nondimeno, a tutt’oggi non esiste un data-base pubblico, completo e affidabile degli attacchi suicidi nel mondo; ilconteggio dal 1980 al 2007 include, secondo una stima prudente, nonmeno di 1000 episodi (19).
La ragione principale della sensibile crescita di attacchi suicidi nelmondo risiede nei considerevoli vantaggi tattici che questa forma di vio-lenza assicura. Può essere utile delineare questi vantaggi distinguendodue funzioni della violenza politica e, in particolare, della violenza ter-roristica: una funzione materiale, relativa alla causazione di danni fisiciimmediati, ed una funzione simbolica, concernente la comunicazione orappresentazione di messaggi con determinati significati (20).
Gli attacchi suicidi si rivelano molto efficaci. Sotto il profilo dellafunzione materiale, garantiscono almeno tre benefici importanti.Innanzitutto, consentono di superare con maggior facilità le misure disicurezza, potendo così colpire anche obiettivi altamente protetti.Assicurano poi un controllo perfetto sul tempo ed il luogo dell’attacco;questa capacità di controllo permette, da una parte, di aumentare lechances di esecuzione della missione e, dall’altra, di massimizzarne gli
(17) Per alcuni cenni storici sulla diffusione degli attacchi suicidi rinvio, tra gli altri, aChristoph REUTER, Mein Leben ist eine Waffe, cit.; Mia M. BLOOM, Dying to Kill, cit.;Robert A. PAPE, Dying to Win, cit.; Ami PEDAHZUR, Suicide Terrorism, cit.
(18) L’Iraq è certamente l’area geografica colpita dal maggior numero di attacchi suici-di: almeno 400 dal 2003 al 2007. Cfr. Mohammed M. HAFEZ, Suicide Terrorism in Iraq:A Preliminary Assessment of the Quantitative Data and Documentary Evidence, in«Studies in Conflict and Terrorism», XXXIX, 2006, pp. 591-619.
(19) Per alcune stime degli attacchi suicidi nel mondo meritevoli di attenzione si veda-no Diego GAMBETTA, Epilogue to the Paperback Edition, in ID. (a cura di), Making Senseof Suicide Missions, cit., pp. 301-33; Domenico TOSINI, Terrorismo e antiterrorismo nelXXI secolo, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 54-58.
(20) Sulle conseguenze e gli scopi politici della violenza si veda la fine disamina diMario STOPPINO, Potere e teoria politica, terza edizione riveduta e accresciuta, Milano,Giuffrè, 2001, pp. 87-97.
FRANCESCO MARONE212
effetti, tra cui solitamente il livello di letalità (21). Infine, riducono amonte i rischi per la clandestinità dell’organizzazione anche dopo l’at-tacco, legati, per esempio, all’eventualità della cattura dell’attentatore.
Rilevanti sono anche i benefici sotto il profilo della funzione simbolica.In primo luogo, gli attacchi suicidi consentono di attirare l’attenzione e dipubblicizzare la causa politica promossa. In secondo luogo, possono cor-roborare la legittimità della causa rivendicata, esprimendo, attraverso ilgesto estremo del suicidio, la gravità della situazione di ingiustizia perce-pita e la genuinità e nobiltà della causa. In terzo luogo, incoraggiano e favo-riscono la coesione dell’organizzazione e della comunità di sostegno, impo-nendo alla prima e alla seconda obblighi morali nei confronti dei “marti-ri”, il cui sacrificio è spesso celebrato attraverso un’articolata serie di riticollettivi (22). Last but not least, accrescono il potere di intimidazione con-tro l’avversario, suscitando il timore che non vi siano comuni mezzi dideterrenza nei confronti di individui decisi a morire per la propria causa.
Gli attacchi suicidi sono anche molto efficienti in termini di costi per-ché di solito non richiedono competenze e abilità particolari da parte deisingoli attentatori (quantomeno laddove siano adeguatamente sostenutida un’organizzazione) e non esigono risorse, informazioni o capacitàlogistiche cospicue nemmeno da parte delle organizzazioni (23).
L’impiego sistematico e continuativo di questa forma di violenza politi-ca richiede la partecipazione attiva di tre soggetti: l’individuo disposto asacrificare deliberatamente la propria vita in una missione senza possibilitàdi ritorno; l’organizzazione politica che assume la responsabilità degli attac-chi; l’ambiente circostante che comprende, in particolare, la società di rife-rimento di cui l’organizzazione pretende di rappresentare gli interessi (24).
(21) Gli attacchi suicidi possiedono un formidabile potere distruttivo. Secondo una notaosservazione di Robert A. PAPE, «il terrorismo suicida è diventato la forma di terrorismopiù letale. Gli attacchi suicidi costituiscono solo il 3% di tutti gli episodi di terrorismo dal1980 al 2003, ma sono responsabili del 48% di tutte le morti, rendendo l’attacco terrori-sta suicida medio dodici volte più letale delle altre forme di terrorismo – anche senza con-tare le immense perdite dell’11 settembre» (Dying to Win, cit., p. 6). I dati di Pape, ben-ché inesatti, sono indicativi.
(22) Tra gli altri, segnalo l’eccellente articolo di Ivan STRENSKI, Sacrifice, Gift and theSocial Logic of Muslim “Human Bombs”, in «Terrorism and Political Violence», XV,2003, pp. 1-34, ispirato alla sociologia della scuola di Durkheim.
(23) Per questo aspetto i clamorosi attentati suicidi dell’11 settembre 2001 contro gliStati Uniti costituiscono una significativa eccezione. Tra gli altri, cfr. lo stimolante sag-gio di Stephen HOLMES, Al-Qaeda, September 11, 2001, in Diego GAMBETTA (a cura di),Making Sense of Suicide Missions, cit., pp. 131-72.
(24) L’identificazione di questi tre livelli analitici, già piuttosto diffusa nella letteratura
IL TERRORISMO SUICIDA NEL CASO PALESTINESE 213
In sintesi, l’organizzazione responsabile degli attacchi suicidi perperseguire i propri scopi politici necessita, da una parte, dell’adesione diindividui che mettano a disposizione la loro vita, in virtù di diversemotivazioni personali (non necessariamente di carattere politico), e, dal-l’altra, del sostegno di una parte significativa della società di riferimen-to in modo tale che l’attacco suicida sia riconosciuto socialmente e legit-timato come gesto onorevole ed addirittura doveroso, di solito attraver-so la pratica del “martirio” (25).
Credo che il soggetto più rilevante da un punto di vista politologico siaquello dell’organizzazione. Infatti è in capo a questo soggetto che si puòravvisare la logica politica degli attacchi suicidi, con i suoi scopi e le suescelte strategiche, comprese quelle relative alla selezione delle vittime.
2. Gli attacchi suicidi palestinesi
Il caso palestinese appare cruciale per lo studio della logica politicadegli attacchi suicidi. L’area del conflitto israelo-palestinese è la terza almondo per numero complessivo di episodi, dopo l’Iraq e lo Sri Lanka.Inoltre, presenta alcune peculiarità salienti, come la presenza di benquattro organizzazioni rivali responsabili di attacchi suicidi, due dellequali frequentemente associate al fenomeno del fanatismo religioso. Èanche un caso importante per indagare la razionalità strategica di questaforma di violenza terroristica; tale indagine può consentire di approfon-dire la comprensione di questo fenomeno nel quadro di una considere-vole difformità di interpretazioni presenti in letteratura (26).
accademica sul terrorismo, è ora riconosciuta dalla maggior parte degli studiosi degliattacchi suicidi. Per una presentazione efficace, ma non ancora esaustiva, si vedanoMohammed M. HAFEZ, Rationality, Culture, and Structure in the Making of SuicideBombers: A Preliminary Theoretical Synthesis and Illustrative Case Study, in «Studies inConflict and Terrorism», XXIX, 2006, pp. 165-85; Assaf MOGHADAM, The Roots ofSuicide Terrorism: A Multi-Causal Approach, in Ami PEDAHZUR (a cura di), Root Causesof Suicide Terrorism, cit., pp. 81-107; Paul GILL, A Multi-Dimensional Approach toSuicide Bombing, in «International Journal of Conflict and Violence», I, 2007, pp. 142-59; Domenico TOSINI, Terrorismo e antiterrorismo nel XXI secolo, cit., capitolo 4.
(25) In ambito islamico, attraverso un elaborato processo di interpretazione della tradizio-ne, l’attacco suicida viene contrapposto al comune gesto del suicidio, massimamente ripro-vevole e proibito dall’Islam, e viene definito socialmente come atto di “martirio” (spesso conil nome di “operazione di auto-martirio”), massimamente onorevole e legittimato dalla reli-gione. Per le origini culturali e le condizioni sociali del martirio islamico in Medio Orienterinvio all’interessante saggio di Farhad KHOSROKHAVAR, I nuovi martiri di Allah, cit.
(26) Robert A. PAPE, per esempio, ha sostenuto che le campagne di attacchi suicidi di
FRANCESCO MARONE214
Il caso palestinese è riconducibile ad un modello di terrorismo suici-da tradizionale e locale, per dirla con Assaf Moghadam (27), connesso alproposito di liberare dall’occupazione militare un territorio specifico, incontrapposizione ad un nuovo modello transnazionale, esemplificatodalla galassia dei movimenti jihadisti.
In questa sezione esamino le campagne di attacchi suicidi palestinesi,avvalendomi di un database originale degli episodi dal 1993 al 2005. Il1993 è l’anno del primo attacco suicida, eseguito da Hamas (16 aprile),mentre il 2005 può essere considerato un anno di svolta nel conflitto,caratterizzato dal progressivo esaurimento dell’ondata di violenza dellaSeconda Intifada (in arabo “scuotimento”), dalla fine della lunga fasestorica di preponderanza di al-Fatah sulla scena politica palestinese (28) e
Hamas e della Jihad Islamica Palestinese contro Israele degli anni ’90 sono «test crucia-li» per verificare l’ipotesi che il «terrorismo suicida paga», «perché questi sono i gruppipiù frequentemente citati come rivolti verso scopi irrealistici e perciò come fondamental-mente irrazionali» (Dying to Win, cit., p. 66). Tra i contributi più rilevanti sugli aspettipolitici degli attacchi suicidi palestinesi, oltre a quelli già menzionati, si vedano AssafMOGHADAM, Palestinian Suicide Terrorism in the Second Intifada: Motivations andOrganizational Aspects, in «Studies in Conflict and Terrorism», XXVI, 2003, pp. 65-92;Dipak K. GUPTA e Kusum MUNDRA, Suicide Bombing as a Strategic Weapon: AnEmpirical Investigation of Hamas and Islamic Jihad, in «Terrorism and PoliticalViolence», XVII, 2005, pp. 573-98; Edward H. KAPLAN et al., What Happened toSuicide Bombings in Israel? Insights from a Terror Stock Model, in «Studies in Conflictand Terrorism», XXVIII, 2005, pp. 225-35; Mohammed M. HAFEZ, ManufacturingHuman Bombs: The Making of Palestinian Suicide Bombers, Washington, The UnitedStates Institute of Peace Press, 2006; Mark HARRISON, Bombers and Bystanders inSuicide Attacks in Israel, 2000 to 2003, in «Studies in Conflict and Terrorism», XXIX,2006, pp. 187-206; Ami PEDAHZUR e Arie PERLIGER, The Changing Nature of SuicideAttacks: A Social Network Analysis, in «Social Forces», LXXXIV, 2006, pp. 1987-2008;Luca RICOLFI, Palestinians, 1981-2003, in Diego GAMBETTA (a cura di), Making Senseof Suicide Missions, cit., pp. 77-129; Yoram SCHWEITZER, Palestinian Istishhadia: ADeveloping Instrument, in «Studies in Conflict and Terrorism», XXX, 2007, pp. 667-89.
(27) Assaf MOGHADAM, Suicide Terrorism, Occupation, and the Globalization ofMartyrdom: A Critique of ‘Dying to Win’, in «Studies in Conflict and Terrorism», XXIX,2006, pp. 707-29; cfr. anche Farhad KHOSROKHAVAR, I nuovi martiri di Allah, cit.
(28) Nel marzo del 2005 Hamas ha deciso di partecipare per la prima volta alle elezio-ni per il Consiglio Legislativo dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP), ha sospeso atempo indeterminato ogni attività militare, concordemente con altri gruppi armati, e hapreso in considerazione l’idea di entrare a far parte dell’Organizzazione per laLiberazione della Palestina (OLP), la confederazione di partiti nazionalisti fondata nel1964, oggi riconosciuta dalla comunità internazionale come la legittima rappresentantedel popolo palestinese. Com’è noto, nelle elezioni politiche del gennaio 2006, il movi-mento radicale islamista ha poi ottenuto una vittoria tanto netta quanto inaspettata. Cfr.Khaled HROUB, Hamas, London, Pluto Books, 2006: trad. it., Hamas, Milano, BrunoMondadori, 2006, p. 9 e ss.
IL TERRORISMO SUICIDA NEL CASO PALESTINESE 215
dal ritiro unilaterale di Israele dalla Striscia di Gaza. In effetti, dopo il2005 si sono registrati pochi episodi, perlopiù ad opera della JihadIslamica Palestinese (29).
Dal 1993 al 2005 si contano 153 attacchi suicidi palestinesi. Tutti gliattacchi, a parte quattro episodi dubbi, hanno previsto l’impiego di con-gegni esplosivi, spesso contenuti in apposite cinture (30). Secondo leinformazioni disponibili, tutti i 153 attacchi suicidi possono essere attri-buiti a un’organizzazione politica. Infatti, i singoli individui, da soli, nonsono sempre in grado di assicurare legittimità postuma al proprio gestoestremo (si pensi al riconoscimento sociale del “martirio” rispetto alcomune suicidio) e, soprattutto, di solito non possiedono le risorse, lecompetenze tecniche, le informazioni e le capacità logistiche per piani-ficare ed eseguire un attacco suicida contro obiettivi israeliani (31).
Come accennato, una delle peculiarità più interessanti del caso pale-stinese consiste nella presenza di quattro organizzazioni, di vario orien-tamento politico, responsabili di attacchi suicidi, in periodi diversi e conscopi parzialmente diversi: Hamas dal 1993, la Jihad IslamicaPalestinese (JIP) dal 1994, il Fronte Popolare per la Liberazione dellaPalestina (FPLP) dal 2001 ed alcuni gruppi armati legati o vicini ad al-Fatah dal 2002.
(29) È evidente che concentrare l’attenzione sulla violenza palestinese sotto forma di attac-chi suicidi non significa in alcun modo ignorare o minimizzare il ruolo della violenza israe-liana. Di fatto ciascuna parte, a suo modo, promuove attivamente la propria immagine divittima ed è riluttante a riconoscerla all’avversario; sull’articolata definizione sociale e poli-tica dello status di vittima nel conflitto israelo-palestinese si veda Edna EREZ, ProtractedWar, Terrorism, and Mass Victimization: Exploring Victimological/CriminologicalConcepts and Theories to Address Victimization in Israel, in Uwe EWALD e KsenijaTURKOVIC (a cura di), Large-Scale Victimisation as a Potential Source of TerroristActivities, Washington, IOS Press, 2006, pp. 89-102, in particolare pp. 90-91. Ovviamenteil presente articolo si attiene al presupposto metodologico della wertfreiheit weberiana.
(30) Gli attacchi suicidi eseguiti per mezzo di congegni esplosivi (suicide bombings) rap-presentano la più nota ed importante modalità tecnica di attacchi suicidi. Come rilevaAssaf MOGHADAM (Defining Suicide Terrorism, cit., p. 16), «tutti i suicide bombings sonoattacchi suicidi [suicide attacks], ma non tutti gli attacchi suicidi sono suicide bombings.In senso stretto, gli attacchi dell’11 settembre non furono suicide bombings poiché nes-sun dispositivo esplosivo convenzionale fu usato nell’uccisione di quasi 3000 persone.Essi furono, comunque, attacchi suicidi».
(31) In effetti, a differenza delle auto-immolazioni (cfr. Michael BIGGS, Dying withoutKilling, cit.), gli attacchi suicidi richiedono quasi sempre l’intervento di un’organizza-zione. Per esempio, secondo i dati di Domenico TOSINI, «quasi tutti gli attacchi suicidi trail 1982 e il 2005 (818 su 845 attacchi, pari a circa il 96%) non sono opera di attentatoriisolati, ma parte di campagne condotte da gruppi organizzati» (Terrorismo e antiterrori-smo nel XXI secolo, cit., p. 58).
FRANCESCO MARONE216
Hamas (in arabo “zelo”, nonché acronimo di “Movimento diResistenza Islamica”) è una potente organizzazione di ispirazione isla-mista che lotta per la liberazione di tutta la Palestina storica (Territoripalestinesi ed Israele). Formalmente rifiuta qualsiasi accordo di pace conIsraele e non accetta la soluzione dei due stati. Hamas venne fondatadallo Sceicco Ahmed Yassin a Gaza nel 1987, allo scoppio della PrimaIntifada, come ala militante palestinese dei Fratelli musulmani. Dallafine degli anni ’80 avviò un’intensa campagna di violenza contro Israelecon mezzi sempre più sofisticati, culminata nell’impiego sistematicodegli attacchi suicidi attraverso il suo braccio militare, le Brigate Izz al-Din al-Qassam. Oltre all’attività militare, si segnala per l’impegno poli-tico, la propaganda religiosa e l’assistenza sociale alla popolazione (32).
La Jihad Islamica Palestinese (JIP) è una formazione politica e milita-re islamista che, come Hamas, rifiuta la pace con Israele e la soluzione deidue stati, rivendicando per i musulmani tutta la Palestina storica. Il grupponacque a Gaza alla fine degli anni ’70 per iniziativa di Fathi Shiqaqi e dialtri militanti palestinesi che si opponevano ai partiti nazionalisti secolari.Meno potente e meno radicato sul territorio di Hamas, è costituito da pic-cole cellule clandestine relativamente autonome. Si dedica principalmentealla violenza politica attraverso il braccio militare delle Brigate al-Quds (ilnome arabo di Gerusalemme), senza impegnarsi in attività pubbliche.
Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP) è unpartito secolare di ispirazione marxista, contrario alla soluzione dei duestati. Venne fondato nel 1967 da George Habash, sulla base di una com-binazione di nazionalismo pan-arabo e di dottrina marxista-leninista, conlo scopo di liberare la Palestina storica e di instaurare uno stato sociali-sta. Fu responsabile di numerosi atti di violenza contro obiettivi israe-liani, tra cui alcuni clamorosi dirottamenti aerei negli anni ’60 e ’70.Con il fallimento dell’esperienza del nazionalismo pan-arabo e, piùtardi, il collasso del blocco comunista, da una parte, e la vigorosa cre-scita dei movimenti religiosi, dall’altra, il FPLP ha perso molto consen-so nella società palestinese ed il suo contributo alla lotta armata controIsraele, attraverso le Brigate Abu Ali Mustafa, è al momento limitato.
Al-Fatah (in arabo “conquista”, nonché acronimo inverso di“Movimento per la Liberazione della Palestina”) è un partito nazionalistasecolare, per lungo tempo il più rilevante della causa palestinese. Fondato
(32) Cfr. Khaled HROUB, Hamas, cit.
IL TERRORISMO SUICIDA NEL CASO PALESTINESE 217
da Yasser Arafat nel 1954, dopo la Guerra dei Sei giorni del 1967 diven-ne la fazione predominante all’interno dell’OLP. Nel 1988 abbandonò ilproposito di distruggere Israele e nel 1993 promosse il Processo di pace diOslo con lo Stato Ebraico. Dopo lo scoppio della Seconda Intifada conob-be una fase di declino, anche a causa delle frequenti accuse di corruzioneed inefficienza, culminata nella sconfitta alle elezioni politiche del 2006.Al-Fatah non soltanto non ha mai rivendicato direttamente alcun attaccosuicida, ma ha generalmente condannato questa pratica. Nondimeno nume-rosi attacchi suicidi sono opera di gruppi armati secolari contigui al partitoe spesso composti da suoi membri, principalmente Tanzim e le Brigate deiMartiri di al-Aqsa. Tanzim (in arabo “organizzazione”) è una fazione radi-cale di al-Fatah, nata nel 1995 per distinguersi dalla “vecchia guardia” pro-tagonista degli accordi di pace e del compromesso con Israele. Le Brigatedei Martiri di al-Aqsa sono un gruppo armato secolare vicino ad al-Fatah,dedito alla violenza, ma favorevole alla soluzione dei due stati. Il livello diautonomia di questi gruppi armati dall’organizzazione madre fondata daArafat è ambiguo e controverso; in particolare, non è chiara l’effettivanatura dei rapporti tra il partito e le Brigate di al-Aqsa.
La Fig. 1 visualizza la distribuzione degli attacchi suicidi palestinesidal 1993 al 2005 per organizzazione. Hamas è responsabile di 69 attac-chi suicidi su 153 (pari al 45,1%) ed è seguita rispettivamente dalla JihadIslamica Palestinese con 39 episodi (25,5%), dai gruppi legati o viciniad al-Fatah con 28 (18,3%) e dal Fronte Popolare per la Liberazione
FRANCESCO MARONE218
Fig. 1 – Distribuzione degli attacchi suicidi palestinesi per organiz-zazione (1993-2005)
della Palestina con 7 (4,6%); 10 attacchi suicidi (6,5%) sono stati rea-lizzati congiuntamente da due o più organizzazioni, perlopiù nella fasefinale della Seconda Intifada (2004-2005).
Nell’arco di tempo considerato la frequenza assoluta degli attacchisuicidi palestinesi per anno varia notevolmente, come mostra la Fig. 2.
(33) All’origine del Processo di pace di Oslo tra lo Stato di Israele e l’Autorità NazionalePalestinese (ANP) vi furono la Conferenza di pace di Madrid del 1991 ed una serie diincontri tra le delegazioni delle due parti a Washington e poi, in maniera segreta, nellacapitale norvegese. Questi incontri condussero all’approvazione degli Accordi di Oslo del
IL TERRORISMO SUICIDA NEL CASO PALESTINESE 219
Fig. 2 – Distribuzione degli attacchi suicidi palestinesi per anno(1993-2005)
Atta
cchi
sui
cidi
Anni
Si possono scorgere chiaramente due ondate distinte nell’evoluzione sto-rica del fenomeno. La prima ondata dal 1993 al 1999 (in realtà, fino al1998, dato che nel 1999 non si sono registrati attacchi), cui si può assegnareil nome di ondata di Oslo, con riferimento all’omonimo processo di pacetra Israele e l’Autorità Nazionale Palestinese (33), è caratterizzata da un
impiego modesto degli attacchi suicidi (24 episodi). Al contrario, la secon-da ondata dal 2000 al 2005, che collima con il dispiegarsi della fase di vio-lenza della Seconda Intifada o Intifada di al-Aqsa (dal nome della Moscheaal-Aqsa, cioè “ultima” o “più lontana”, la più grande di Gerusalemme),denominata per questo ondata di al-Aqsa, include ben 129 eventi (34).
Lo spartiacque tra le due ondate, che corrispondono a due stagionipolitiche differenti, è costituito proprio dallo scoppio della SecondaIntifada nel mese di settembre del 2000, dopo il sostanziale esaurimen-to del processo di pace con il fallimento, in luglio, del summit di CampDavid tra il Presidente degli Stati Uniti Clinton, il Primo ministro israe-liano Barak ed il Presidente palestinese Arafat.
Come è evidente, le due ondate sono caratterizzate da una frequenzadegli attacchi suicidi ben diversa: se nell’ondata di Oslo si registranoappena 24 episodi in 7 anni (1993-1999), con una media di poco più di3 episodi all’anno, l’ondata di al-Aqsa include 129 eventi in 6 anni(2000-2005), con una media di oltre 21 eventi l’anno.
Nell’ondata di Oslo questa forma di violenza è stata adottata soltantodalle due organizzazioni religiose estremiste di Hamas e della JihadIslamica Palestinese, principalmente allo scopo di ostacolare il processodi pace in corso e di reagire alla violenza israeliana. Più tardi, nel corsodell’ondata di al-Aqsa, anche le due organizzazioni secolari del FrontePopolare per la Liberazione della Palestina e di al-Fatah hanno deciso diricorrere agli attacchi suicidi. Infatti, come ha rimarcato Mia M.Bloom (35), gli attacchi suicidi palestinesi, quantomeno nella fase centra-le della Seconda Intifada (2002-2003), sono diventati uno strumento diconquista del sostegno politico nell’arena interna e pertanto le quattro
1993 che prevedevano la cessazione della violenza e l’instaurazione di uno stato palesti-nese. Il processo di pace subì un forte rallentamento a metà degli anni ’90 con l’uccisio-ne del capo del governo laburista Rabin nel 1995 e la vittoria del Likud nel 1996 e fuostacolato, da una parte, dagli atti di violenza delle organizzazioni estremiste palestinesi(specialmente attacchi suicidi) e, dall’altra, dall’espansione delle colonie israeliane neiTerritori Occupati.
(34) Cfr. Luca RICOLFI, Palestinians, 1981-2003, cit.; Luca RICOLFI e Paolo CAMPANA,Suicide Missions: A New Database on the Palestinian Area, in «Polena: Political andElectoral Navigations», II, 2005, pp. 29-51; Yoram SCHWEITZER, Palestinian Istishhadia,cit., pp. 668-70.
(35) Mia M. BLOOM, Palestinian Suicide Bombing: Public Support, Market Share, andOutbidding, in «Political Science Quarterly», CXIX, 2004, pp. 61-88; EAD., Dying toKill, cit. Nondimeno, diversamente da quanto sembra sostenere la studiosa, il meccani-smo dell’outbidding non può spiegare tutte le campagne di attacchi suicidi realizzate nelconflitto israelo-palestinese né, tanto meno, in altri contesti.
FRANCESCO MARONE220
organizzazioni rivali si sono lanciate in un “gioco al rilancio” (outbid-ding) della violenza, dal quale non hanno voluto sottrarsi nemmeno dueorganizzazioni tradizionalmente poco sensibili al richiamo religioso dellajihad e del martirio come al-Fatah ed il FPLP. Come illustra la Fig. 3, il
IL TERRORISMO SUICIDA NEL CASO PALESTINESE 221
Fig. 3 – Distribuzione degli attacchi suicidi per organizzazione e peranno (1993-2005)
Atta
cchi
sui
cidi
Anni
1993199419951996199719981999200020012002200320042005
Totale
Hamas
1434210421131222
69
JIP
01403100711615
39
FPLP
0000000014110
7
Al-Fatah
00000000020530
28
Congiunti
0000000011170
10
Totale
15745204304925147
153
Tab. 1 – Distribuzione degli attacchi suicidi per organizzazione e peranno (1993-2005)
FPLP ed, in modo più evidente (date le maggiori capacità organizzative),al-Fatah hanno subito tentato di compensare, per così dire, il ritardoaccumulato con un impiego consistente di questa forma di violenza.
Lo scopo ufficiale delle campagne di attacchi suicidi è la liberazioneterritoriale per tutte e quattro le organizzazioni, ancorché declinata insensi diversi: al-Fatah dichiara di lottare per la liberazione dei Territoridella Cisgiordania e della Striscia di Gaza occupati da Israele nella guer-ra del 1967, mentre Hamas, la Jihad Islamica Palestinese ed il FrontePopolare per la Liberazione della Palestina rivendicano tutta la Palestinastorica dal Fiume Giordano fino al Mar Mediterraneo. In vista di questoscopo finale, ricercato attraverso una strategia sistematica di intimida-zione e disorientamento dell’avversario, le quattro organizzazioni perse-guono una molteplicità di fini intermedi. Schematicamente si può affer-mare che nell’ondata di Oslo i fini prevalenti di Hamas e della JIP sonostati l’opposizione al processo di pace e la rappresaglia, mentre nel corsodell’ondata di al-Aqsa alla rappresaglia si è aggiunto, per tutte e quattrole organizzazioni, il gioco al rilancio nell’arena interna (36).
La seconda ondata si differenzia nettamente dalla prima, oltre che peril maggior numero di episodi e di organizzazioni coinvolte, anche perl’allargamento della base di reclutamento degli attentatori suicidi (spe-cie, rispetto al livello sociale ed economico e al sesso) e, come si vedrà,per la crescita del sostegno popolare per questa forma di violenza (37).
Tutti gli attacchi suicidi palestinesi hanno interessato obiettivi israe-liani (38). Gli obiettivi fisici più colpiti sono stati, in ordine decrescente,i mezzi e le strutture del trasporto pubblico (principalmente il sistema deibus), gli obiettivi militari (postazioni militari, checkpoint), le attivitàcommerciali (negozi, centri commerciali, mercati all’aperto) ed i luoghidi intrattenimento (bar, ristoranti, discoteche e così via).
(36) Sullo scopo del «sabotaggio della pace» cfr. Andrew H. KYDD e Barbara F.WALTER, Sabotaging the Peace: The Politics of Extremist Violence, in «InternationalOrganization», LVI, 2002, pp. 263-96. Sulla rappresaglia Robert J. BRYM e Bader ARAJ,Suicide Bombing as Strategy and Interaction: The Case of the Second Intifada, in «SocialForces», LXXXIV, 2006, pp. 1969-86. Sul gioco al rilancio si veda la nota precedente.
(37) Yoram SCHWEITZER, Palestinian Istishhadia, cit., pp. 669-70.(38) Come ha notato Matthew LEVITT (Could Hamas Target the West?, in «Studies in
Conflict and Terrorism», XXX, 2007, pp. 925-45), l’eventualità che la stessa Hamas,l’organizzazione palestinese più pericolosa per motivazioni e capacità, possa attaccareobiettivi occidentali appare poco probabile, almeno nel breve periodo.
FRANCESCO MARONE222
A differenza delle altre forme di violenza palestinesi, la maggior partedegli attacchi suicidi è avvenuta all’interno dello stato di Israele, diretta-mente nella “casa dei nemici”, se così si può dire; questa tattica, infatti,non richiedendo un piano di ritorno, è particolarmente adatta a colpire gli«obiettivi difficili» (hard targets) e più salienti posti al di là della LineaVerde che separa lo Stato Ebraico dai Territori palestinesi (39).
3. Le vittime degli attacchi suicidi palestinesi
La selezione delle vittime rappresenta un aspetto fondamentale del-l’attività terroristica. Essa non è lasciata al caso, ma riflette gli scopi ele strategie politiche delle organizzazioni violente. In particolare, negliattacchi suicidi, la selezione può essere applicata con maggior efficacia,grazie al livello elevato di precisione di controllo e di flessibilità chequesta forma di violenza generalmente assicura; in questo modo, la com-ponente casuale dell’attacco, sottratta alle decisioni dell’organizzazione,può essere minimizzata.
La presente sezione è divisa in tre paragrafi: nel primo paragrafoindago il potere distruttivo degli attacchi suicidi palestinesi, osservandoil numero di morti e feriti provocati; nel secondo paragrafo esamino iltipo di vittime prescelte; nel terzo paragrafo, infine, esploro i caratterisocio-demografici delle vittime.
3.1. I morti e i feriti
Sebbene nella varietà di informazioni e di dati, tutti gli osservatoriconcordano sull’elevato potere distruttivo degli attacchi suicidi rispettoalle altre forme di violenza palestinesi (40). In particolare, gli attacchi sui-cidi hanno offerto un contributo determinante alla sensibile riduzione delrapporto nel numero di vittime tra le due parti: per esempio, secondo
(39) Eli BERMAN e David D. LAITIN, Hard Targets: Theory and Evidence on SuicideAttacks, NBER Working Paper No. 11740, Cambridge (Mass.), National Bureau ofEconomic Research, Novembre 2005.
(40) Per un’utile comparazione tra le «opzioni tattiche» a disposizione delle organizzazio-ni violente palestinesi si veda Adam DOLNIK e Anjali BHATTACHARJEE, Hamas: SuicideBombings, Rockets or WMD?, in «Terrorism and Political Violence», XIV, 2002, pp. 109-28. Gli autori evidenziano la superiorità tattica degli attacchi suicidi rispetto ai razzi Qassame alle (eventuali) armi di distruzione di massa (weapons of mass destruction, WMD).
IL TERRORISMO SUICIDA NEL CASO PALESTINESE 223
fonti citate da Weinberg, Pedahzur e Canetti-Nisim (41), nei sei anni dellaPrima Intifada (1987-1992) il rapporto tra vittime palestinesi ed israelia-ne era di 6,7 a 1, mentre nei primi sei mesi della Seconda Intifada il rap-porto era di 5 a 1 e nei primi sei mesi del 2002 era calato a 1,7 a 1.
Gli attacchi suicidi dal 1993 al 2005 hanno provocato 691 morti(esclusi gli attentatori suicidi), di cui 165 nell’ondata di Oslo e 526 nel-l’ondata di al-Aqsa, con una media aritmetica complessiva di oltre 4morti per episodio (4,5). L’attacco suicida più sanguinoso, eseguito daHamas in un hotel di Netanya in Israele il 27 marzo 2002 (giorno dellaPasqua ebraica), ha provocato 30 morti; d’altra parte, ben 58 attacchisuicidi su 153 (37,9%) non hanno provocato alcun morto, oltre all’at-tentatore stesso.
I feriti sono stati 4438 (rispettivamente 1026 e 3412 nelle due onda-te) con una media di 29 feriti per episodio.
Se ci si sofferma sul numero dei morti per anno, si può scorgere un’in-teressante differenza nel livello di letalità tra l’ondata di Oslo e l’ondatadi al-Aqsa: durante la prima ondata, la media dei morti provocati da cia-scun attacco suicida è di poco inferiore a 7, durante la seconda, è vicinaa 4, mentre la mediana è rispettivamente di 3 e di 1 morto per attacco (42).Il valore modale è pari a 0 morti per entrambe le fasi; nel complesso, gliepisodi che non hanno causato morti (a parte gli attentatori suicidi) sono7 su 24 (29,2%) nella prima fase e 51 su 129 (39,5%) nella seconda; lacomponente dell’auto-immolazione sembra quindi conservare una suaautonoma rilevanza nell’atto di “morire per uccidere”. Insomma, gliattacchi suicidi della prima fase sono decisamente meno numerosi e menofrequenti, ma tipicamente più letali. Si può pertanto sostenere che le dueondate siano caratterizzate da uno stile diverso, dove per stile si intendeil rapporto tra frequenza e letalità degli attacchi suicidi (43).
Le quattro organizzazioni presentano responsabilità differenti rispet-to al numero delle vittime, come mostrano la Tabella 2 e la Fig. 4.
(41) Leonard WEINBERG, Ami PEDAHZUR e Daphna CANETTI-NISIM, The Social andReligious Characteristics of Suicide Bombers and Their Victims, in «Terrorism andPolitical Violence», XV, 2003, pp. 139-53 (citazione a p. 141). In altre fonti si possonoreperire stime diverse; ciononostante, la tendenza è chiara.
(42) La comparazione tra le medie di morti per attacco suicida nelle due ondate deveessere valutata con la necessaria cautela, a causa del numero limitato di episodi nellaprima ondata.
(43) Cfr. l’importante articolo di Luca RICOLFI, Palestinians, 1981-2003, cit., in cui siusa l’espressione «tecnologia».
FRANCESCO MARONE224
Anche le quattro organizzazioni violente adottano differenti stili diattacchi suicidi. Ad un estremo troviamo Hamas con una frequenza diattacchi suicidi consistente ed una letalità relativamente elevata, soprat-tutto durante la prima ondata; all’estremo opposto si colloca il FrontePopolare per la Liberazione della Palestina con una frequenza bassa eduna letalità molto bassa.
Le altre organizzazioni responsabili di attacchi suicidi nel mondo pre-sentano stili sensibilmente diversi: per esempio, il PKK curdo si caratteriz-
IL TERRORISMO SUICIDA NEL CASO PALESTINESE 225
HamasJIP
Al-FatahFPLP
Congiunti
Totale
Organizzazione Numero di morti
Ondata di Oslo(1993-1999)
Ondata di al-Aqsa(2000-2005)
Periodo complessivo(1993-2005)
13332000
65
303103891318
526
436135891318
691
Tab. 2 – Numero di morti provocati dagli attacchi suicidi palestine-si per organizzazione nelle due ondate
Fig. 4 – Numero di morti provocati dagli attacchi suicidi per orga-nizzazione (1993-2005)
za per livelli di frequenza e di letalità decisamente modesti, mentre la retedi al-Qaeda associa una frequenza notevole ad una letalità molto elevata (44).
In definitiva, le organizzazioni violente palestinesi, non potendoadottare una strategia di guerriglia o di insurrezione rivoluzionaria, acausa della marcata inferiorità militare rispetto al potente avversarioisraeliano, e non potendo disporre di altre armi efficaci, si avvalgonodegli attacchi suicidi per condurre una guerra di attrito contro Israele,volta ad imporre al nemico costi così elevati da costringerlo a conces-sioni funzionali allo scopo finale della liberazione territoriale e dell’in-staurazione dello stato palestinese (45). I continui attacchi suicidi, soprat-tutto durante la Seconda Intifada, rendono la minaccia penosa e credibi-le, anche senza richiedere livelli eclatanti di letalità. Come ho notato,l’adozione di questa forma di violenza ha contribuito a ridurre lo squili-brio tra le parti in conflitto, almeno in termini di numero dei morti.
3.2. I tipi di vittime
Si possono distinguere quattro tipi principali di vittime degli attacchi sui-cidi: i militari, i civili, gli esponenti politici e diplomatici e i rivali interni.
Come mostra la Fig. 5, la grande maggioranza degli episodi ha coin-volto i civili (92 episodi), una parte rilevante i militari (48), mentre non siè registrato alcun evento contro esponenti politici e diplomatici né contromembri di organizzazioni rivali palestinesi. 13 attacchi non hanno interes-sato i quattro tipi principali di vittime oppure sono di attribuzione dubbia.
Rispetto alla selezione delle vittime le organizzazioni palestinesi si allon-tanano così dal modello libanese, cui si sono inizialmente ispirate, privile-giando gli attacchi suicidi contro i civili, analogamente ai movimenti qaedi-sti e jihadisti.
D’altronde, per correttezza, è opportuno un invito alla cautela su que-sto argomento, poiché di solito nella selezione delle vittime, oltre alla di-
(44) Cfr. Luca RICOLFI, Palestinians, 1981-2003, cit.; Ami PEDAHZUR, Suicide Terrorism, cit.(45) Si consideri la seguente dichiarazione di Khaled Mashal, oggi leader di Hamas resi-
dente a Damasco, contenuta in un’intervista del 1998: «Noi sappiamo che l’attuale equili-brio di potere nella regione non ci consente una vittoria decisiva contro i Sionisti; comun-que, crediamo con fiducia che ci stiamo muovendo sulla giusta strada – la strada della resi-stenza. Questa scelta ci condurrà al successo in virtù delle nostre conquiste cumulative,della nostra abilità sostanziale a resistere, della nostra volontà e profondità strategica» (cita-to in Mia M. BLOOM, Palestinian Suicide Bombing, cit., p. 77). Da una prospettiva israe-liana, si può consultare Avi KOBER, From Blitzkrieg To Attrition: Israel’s Attrition Strategyand Staying Power, in «Small Wars and Insurgencies», XVI, 2005, pp. 216-40.
FRANCESCO MARONE226
mensione predominante delle scelte strategiche delle organizzazioni, gio-cano un ruolo non trascurabile anche il caso e l’arbitrarietà dell’attentato-re suicida: infatti, da una parte, le contingenze imprevedibili della missio-ne possono alterare il piano di attacco originario e, dall’altra, l’attentato-re suicida, pur seguendo le indicazioni delle organizzazioni (che possonoandare dalle istruzioni generiche agli ordini particolareggiati), nella con-citazione del momento, è di fatto il responsabile ultimo della selezionedelle vittime (46). Nondimeno, questo invito alla cautela vale più per laselezione degli obiettivi fisici (strutture e spazi) che per la selezione dellevittime, tanto più nel caso degli attacchi suicidi, grazie alla precisione dicontrollo che garantiscono. In ultima analisi, la selezione delle vittimedegli attacchi suicidi palestinesi mostra una chiara logica politica che nondipende né dal caso né dall’arbitrarietà dei singoli attentatori suicidi.
Dei 153 attacchi suicidi palestinesi dal 1993 al 2005 48 si sono rivol-ti contro militari (membri dell’esercito e della polizia), 6 nell’ondata diOslo e 42 nell’ondata di al-Aqsa, principalmente nei Territori Occupati.Come si vedrà, questo tipo di vittime è prevalente nella fase iniziale delleondate di violenza. I militari non sono il tipo di vittime prediletto dalleorganizzazioni palestinesi, tanto più se si considera che verosimilmente
(46) È plausibile congetturare, per esempio, che almeno una buona parte degli attenta-tori suicidi non abbia conoscenza del e familiarità con l’ambiente in cui porterà a termi-ne l’attacco; presumibilmente molti giovani “martiri” palestinesi non sono mai entrati inuna città israeliana prima della loro missione suicida.
IL TERRORISMO SUICIDA NEL CASO PALESTINESE 227
Fig. 5 – Distribuzione degli attacchi suicidi per tipo di destinatari
non pochi attacchi suicidi portati a termine per necessità presso posti diblocco o checkpoint presidiati da militari erano originariamente diretticontro civili all’interno di Israele. L’interesse limitato per questo tipo divittime è connesso a due motivazioni principali: da una parte, i militariisraeliani, ben protetti e ben equipaggiati, costituiscono solitamente unobiettivo impegnativo per le organizzazioni violente e, dall’altra, nonassicurano un potere di coercizione sulla società e sullo stato israelianiparagonabile a quello esercitato attraverso l’uccisione di civili.
Ben 92 attacchi suicidi hanno coinvolto civili ordinari, cioè soggetti chenon partecipano al conflitto. Di questi episodi 15 si sono verificati nel-l’ondata di Oslo e 77 nell’ondata di al-Aqsa. Certamente i civili israelianirappresentano un obiettivo facile per il loro alto numero e per la scarsitàdi protezioni, quantomeno rispetto ai destinatari militari (47). Nondimeno,la violenza indiscriminata contro i civili sottintende ragioni strategiche piùprofonde che esaminerò nella quarta sezione del testo.
Gli attacchi suicidi palestinesi non hanno mai colpito esponenti politici ediplomatici. Occorre sottolineare che questo tipo di vittime è raro in tutte leforme di violenza impiegate da individui o organizzazioni palestinesi controgli israeliani; per esempio, durante la stagione, pure così sanguinosa, dellaSeconda Intifada, si può menzionare soltanto l’assassinio di RehavamZe’evi, fondatore del piccolo partito nazionalista di destra Moledet e Mini-stro del Turismo di Israele, vittima di un colpo di arma da fuoco ad operadi alcuni militanti del FPLP il 17 ottobre 2001 a Gerusalemme. Verosimil-mente le organizzazioni violente palestinesi considerano poco convenientequesta opzione in base ad un calcolo di costi e benefici: si tratta di azionipiuttosto impegnative e costose e, nello stesso tempo, scarsamente remune-rative per la promozione della propria causa politica.
Al contrario dei gruppi palestinesi, le Tigri per la Liberazione dell’Ee-lam [Patria] Tamil (LTTE), una potente organizzazione secolare indipen-dentista dello Sri Lanka, hanno colpito frequentemente questo tipo di vit-time nelle loro campagne di attacchi suicidi (circa un quarto del totaledelle vittime, secondo Ami Pedahzur), riuscendo ad uccidere, tra gli altri,il Presidente dello Sri Lanka, Ranasinghe Premadasa, il 1 maggio 1993,ed, ancor prima, l’ex-Primo ministro dell’India, Rajiv Gandhi, il 21 mag-gio 1991. Anche le fazioni ribelli irachene, il PKK e la rete di al-Qaeda
(47) Incoraggiando l’uso della violenza contro i civili, un manuale di addestramento diHamas annota: «è sciocco cacciare la tigre quando ci sono tante pecore in giro» (citato inMia M. BLOOM, Palestinian Suicide Bombing, cit., p. 79).
FRANCESCO MARONE228
hanno condotto un numero cospicuo di attacchi suicidi contro esponentipolitici e diplomatici (rispettivamente il 20, 18,8 e 12,5 percento, secon-do Pedahzur); vale la pena di ricordare almeno l’attacco suicida di al-Qaeda contro Ahmad Shah Massoud, il leader dell’Alleanza del Nord inAfghanistan, avvenuto due giorni prima degli attentati dell’11 settembre2001. Appare, infine, marginale l’impiego di attacchi suicidi contro espo-nenti politici e diplomatici dei gruppi ceceni e di Hezbollah (rispettiva-mente l’8,7 e il 2,9 percento) (48).
All’opposto, Israele, soprattutto durante l’Intifada di al-Aqsa, hadeciso di attaccare sistematicamente i dirigenti delle organizzazioni vio-lente palestinesi attraverso la pratica degli assassini mirati (targetedassassinations), con tutti i suoi effetti ambigui e controversi (49). Per dipiù, com’è noto, l’occupazione israeliana dei Territori palestinesi haprovocato un alto numero di morti tra la popolazione civile (50).
Gli attacchi suicidi palestinesi, infine, non hanno mai colpito membri dialtri gruppi rivali, benché gli episodi di violenza interna non siano trascu-rabili (51). Le ragioni di questa assenza vanno probabilmente ricercate nelcarattere estremo e clamoroso della violenza suicida: questi atti trovereb-
(48) I dati sono tratti da Ami PEDAHZUR, Suicide Terrorism, cit., pp. 18-20, per il perio-do dicembre 1981 - giugno 2005.
(49) Sugli assassini mirati israeliani si vedano, tra gli altri, Steven R. DAVID, FatalChoices: Israel’s Policy of Targeted Killing, in Efraim INBAR (a cura di), Democracies andSmall Wars, London, Frank Cass, 2003, pp. 138-58; Mohammed M. HAFEZ e Joseph M.HATFIELD, Do Targeted Assassinations Work? A Multivariate Analysis of Israel’sControversial Tactic during Al-Aqsa Uprising, in «Studies in Conflict and Terrorism»,XXIX, 2006, pp. 359-82. Per una presentazione delle misure antiterroristiche di Israele,soprattutto durante la Seconda Intifada, rinvio a Sergio CATIGNANI, The Security Imperativein Counterterror Operations: The Israeli Fight Against Suicidal Terror, in «Terrorism andPolitical Violence», XVII, 2005, pp. 245-64; ID., The Strategic Impasse in Low-IntensityConflicts: The Gap between Israeli Counterterrorism Strategy and Tactics during the Al-Aqsa Intifada, in «The Journal of Strategic Studies», XXVIII, 2005, pp. 57-75; HillelFRISCH, Motivation or Capabilities? Israeli Counterterrorism against Palestinian SuicideBombings and Violence, in «The Journal of Strategic Studies», XXIX, 2006, pp. 843-69.
(50) Cfr. Michael L. GROSS, Killing Civilians Intentionally: Double Effect, Reprisal, andNecessity in the Middle East, in «Political Science Quarterly», CXX, 2005-2006, pp. 555-79. Gross osserva che generalmente la violenza israeliana contro i civili palestinesi è nonintenzionale, ma prevedibile.
(51) Per dirla con Luis DE LA CALLE e Ignacio SÁNCHEZ-CUENCA (The Production ofTerrorist Violence, cit.), gli attacchi suicidi palestinesi perseguono lo scopo dell’«attrito»ai danni dell’avversario, ma non sono impiegati per il «controllo» della popolazione;peraltro, la violenza a fini di controllo è solitamente più selettiva. La distinzione tra attri-to e controllo si rifà all’idea di un trade-off tra vincoli di «influenza» e vincoli di «sicu-rezza» nell’attività terroristica proposta da Gordon H. MCCORMICK, Terrorist DecisionMaking, in «Annual Review of Political Science», VI, 2003, pp. 473-507 (pp. 495-97).
IL TERRORISMO SUICIDA NEL CASO PALESTINESE 229
bero ben poche opportunità di giustificazione qualora venissero realizzaticontro destinatari della medesima comunità nazionale, impegnati nella lottacontro il comune nemico israeliano, pur con finalità differenti. In partico-lare, un eventuale attacco suicida da parte di un’organizzazione palestinesecontro un’organizzazione rivale difficilmente potrebbe essere “inquadrato”attraverso la pratica del “martirio” con le sue norme, i suoi rituali ed i suoidiscorsi che tendono a coinvolgere l’intera società di riferimento. Lo scon-tro tra fazioni opposte, pertanto, viene condotto con altre forme di violen-za tatticamente meno costose e, soprattutto, socialmente meno impegnati-ve. D’altra parte, occorre sottolineare che le fasi occasionali di lotta, anchesanguinosa, tra gruppi palestinesi sono solitamente affiancate da fasi dicooperazione e di unione (come possono dimostrate anche le esecuzioni diattacchi suicidi congiunti) (52), almeno nell’arco di tempo considerato.
La selezione delle vittime degli attacchi suicidi palestinesi presentaalcune differenze significative nel corso del tempo, come può mostrare laFig. 6. Vale almeno la pena di notare che sia l’ondata di Oslo sia l’onda-ta di al-Aqsa iniziano con modesti attacchi contro i destinatari militari perpoi concentrarsi prevalentemente sui civili con l’intensificarsi della vio-lenza: il primo attacco suicida palestinese, nell’aprile del 1993, era rivol-to contro un gruppo di soldati israeliani in Cisgiordania, forse su imita-
(52) Cfr. Luca RICOLFI, Palestinians, 1981-2003, cit.
FRANCESCO MARONE230
Fig. 6 – Distribuzione degli attacchi suicidi palestinesi per tipo di vit-time e per anno (1993-2005)
zione del modello libanese, ed anche i primi quattro episodi della SecondaIntifada hanno coinvolto membri delle forze armate di Israele (IDF, IsraelDefense Forces) nella Striscia di Gaza ed in Israele. Dopo il primo episo-dio del 1993, Hamas, in alcune dichiarazioni, ha giustificato la decisionedi eseguire attacchi suicidi contro civili all’interno di Israele come formadi rappresaglia contro il massacro di Hebron del 1994 (53).
Le quattro organizzazioni violente presentano modalità di selezionedelle vittime analoghe, con circa il 60 percento di attacchi suicidi controcivili, il 30 percento contro militari e la parte restante contro altri tipi divittime. L’unica eccezione vistosa è rappresentata dai pochi attacchi con-giunti alla fine della Seconda Intifada che hanno interessato prevalente-mente destinatari militari (Tabella 3).
(53) Il 25 febbraio 1994 il colono israeliano Baruch Goldstein, sostenitore del partitoestremista Kach, uccise a colpi di fucile ventinove fedeli musulmani raccolti in preghie-ra nella moschea di Ibrahim (il nome arabo di Abramo) presso la Tomba dei Patriarchidi Hebron in Cisgiordania, un luogo di culto sia per gli ebrei sia per i musulmani, consale riservate agli uni e agli altri. Per una descrizione del massacro rinvio a MarkJUERGENSMEYER, Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence,Berkeley, University of California Press, 2000: trad. it., Terroristi in nome di Dio. Laviolenza religiosa nel mondo, Roma-Bari, Laterza, 2003, in particolare pp. 52-56.
IL TERRORISMO SUICIDA NEL CASO PALESTINESE 231
HamasJIP
Al-FatahFPLP
CongiuntiTotale
693928710153
Organizzazione
Civili Militari Altri o dubbi Totale
Tipo di vittime
Tab. 3 – Distribuzione degli attacchi suicidi palestinesi per tipo divittime per organizzazione (1993-2005)
3.3. I caratteri socio-demografici delle vittime
In questa sezione presento alcuni riscontri preliminari sui caratterisocio-demografici delle vittime degli attacchi suicidi palestinesi, unargomento generalmente trascurato nella letteratura in materia.
44231843
92
(63,8%)(59,0%)(64,3%)(57,1%)(30,0%)
2010926
47
(29,0%)(25,6%)(32,1%)(28,6%)(60,0%)
56111
14
(7,2%)(15,4%)(3,6%)(14,3%)(10%)
Come hanno notato alcuni studiosi (54), le vittime degli attacchi suici-di palestinesi non costituiscono un campione rappresentativo della popo-lazione israeliana, nonostante la natura apparentemente casuale degliattacchi. Il proposito di uccidere una notevole quantità di personeinfluenza la selezione degli obiettivi fisici, orientandola a favore di luo-ghi pubblici (come bus, fermate e stazioni dei mezzi di trasporto, mer-cati e negozi) e conducendo di conseguenza ad una sovra-rappresenta-zione, nel totale delle vittime, degli individui che, per i loro stili di vita,sono frequentemente esposti a questo tipo di obiettivo: per esempio,attraverso una dipendenza dai trasporti pubblici. Per effetto di questadistorsione, le vittime degli attacchi suicidi spesso appartengono ai livel-li medio-bassi della scala socio-economica o sono studenti delle scuoleelementari e superiori. Si può quindi rilevare che, per una macabra iro-nia, gli attentatori suicidi (quantomeno nei primi anni) (55) e le vittimeprovenivano non di rado da strati sociali con una posizione simile all’in-terno delle rispettive società.
Queste prime osservazioni sono state approfondite ed, in parte, con-fermate in un’originale ricerca di Canetti-Nisim, Mesch e Pedahzur (56)
in cui sono state esplorate le principali interpretazioni criminologichedella vittimizzazione da attentati suicidi palestinesi. I test empirici con-dotti dagli autori attraverso regressioni logistiche confutano l’«ipotesidella casualità» (randomness hypothesis), secondo la quale il rischio divittimizzazione da terrorismo è uguale in tutti i segmenti della società, afavore dell’«approccio delle attività di routine» (routine activitiesapproach), basato sulla «teoria dell’esposizione agli stili di vita» (lifesty-le-exposure theory) che connette le differenze nei tassi di vittimizzazio-ne allo status socio-economico delle vittime. In particolare, Canetti-
(54) Leonard WEINBERG, Ami PEDAHZUR e Daphna CANETTI-NISIM, The Social andReligious Characteristics of Suicide Bombers and Their Victims, cit.
(55) Come accennato, nel corso del tempo la base di reclutamento degli attentatori sui-cidi si è notevolmente allargata, includendo anche individui di livello sociale ed econo-mico medio-alto. Tra i motivi di questa diversificazione, oltre alla crescente domanda (edofferta) di candidati al “martirio”, probabilmente vi è anche il proposito deliberato difacilitare il superamento delle misure di sicurezza israeliane, rendendo praticamenteimpossibile l’identificazione di profili tipici degli attentatori. Cfr. Bruce HOFFMAN, TheLogic of Suicide Terrorism, in «The Atlantic Monthly», CCXCI, 2003, pp. 40-47.
(56) Daphna CANETTI-NISIM, Gustavo MESCH e Ami PEDAHZUR, Victimization fromTerrorist Attacks: Randomness or Routine Activities?, in «Terrorism and PoliticalViolence», XVIII, 2006, pp. 485-501. Cfr. anche Edna EREZ, Protracted War,Terrorism, and Mass Victimization, cit.
FRANCESCO MARONE232
Nisim, Mesch e Pedahzur mostrano che i caratteri della residenza al dilà della Linea Verde (ovvero in Israele), del sesso femminile, della pro-fessione di studente, dello status di celibe o nubile, del modo di vitasecolare accrescono le probabilità di essere coinvolti in attacchi suicidi.
Questa prospettiva di fatto pone in discussione la nota asserzionesecondo cui in una campagna di violenza terroristica tutti i membri diuna collettività sono ugualmente soggetti al rischio di un attacco, a causadella natura apparentemente casuale della violenza; su questa percezio-ne, che appare inesatta, si fonda, almeno in parte, la stessa capacità delleorganizzazioni terroristiche di esercitare un’influenza profonda su tuttala collettività avversaria.
4. La logica politica della selezione delle vittime
In questa sezione esploro la logica politica della selezione delle vittimedegli attacchi suicidi palestinesi, un tema che finora non è stato adeguata-mente approfondito. Mi soffermo, in particolare, sulle ragioni della vio-lenza indiscriminata contro i civili; si tratta di una condotta che spesso ègiudicata irrazionale, ma che, in realtà, riflette una chiara strategia politi-ca. Nel primo paragrafo indico le opportunità e i vincoli della violenzaindiscriminata contro i civili, mentre nel secondo paragrafo presento alcu-ni meccanismi di giustificazione di questa modalità di violenza estrema.
4.1. Le opportunità e i vincoli
Si possono distinguere tre tipi principali di violenza terroristica inrelazione alle motivazioni politiche della selezione dei destinatari: la vio-lenza selettiva per individuo è indirizzata contro alcune persone in baseal loro comportamento e alle loro responsabilità specifiche; la violenzagenerica per ruolo interessa soggetti che occupano determinate posizio-ni (per esempio, membri dell’esercito e della polizia o altri rappresen-tanti dello stato); mentre la violenza indiscriminata per collettività sidirige contro individui anonimi in virtù della loro presunta appartenen-za ad una collettività definita da criteri come la nazionalità, l’etnia, lareligione, la classe sociale (57). I tre criteri di selezione dei destinatari
(57) La tripartizione si trova già in Luis DE LA CALLE e Ignacio SÁNCHEZ-CUENCA, TheProduction of Terrorist Violence, cit.
IL TERRORISMO SUICIDA NEL CASO PALESTINESE 233
sono pertanto l’attuazione di un comportamento, l’occupazione di unruolo liberamente scelto e l’appartenenza ad una collettività definita dacaratteri ascrittivi. Chiaramente nemmeno la violenza terroristica indi-scriminata è totalmente arbitraria e casuale; al contrario, di solito è, percerti versi, altamente discriminante perché si rivolge soltanto controindividui appartenenti ad una collettività attentamente selezionata, anchese poi non è interessata all’identità personale delle singole vittime.
Come ho rilevato, gli attacchi suicidi palestinesi si sono affidati prin-cipalmente alla violenza indiscriminata per collettività, ai danni dei civi-li, in base ad un calcolo razionale di costi e benefici, rispetto al rappor-to con l’avversario, con la propria società di riferimento e con le partiterze (58).
Con riferimento all’avversario, questa opzione presenta importantielementi di efficacia tattica. È noto che le vittime effettive della violen-za terroristica tipicamente non coincidono con gli avversari reali, cioè lostato o il governo nemico, ma si limitano, per così dire, a rappresentar-lo (59); attraverso la violenza i terroristi tentano di piegare la volontà e laresistenza dell’avversario reale, allo scopo di ottenere concessioni favo-revoli alla propria causa politica. Il terrorismo è una strategia indirettache mira ad alterare le motivazioni dell’avversario, non volendo o, piùspesso, non potendo intervenire direttamente sulle sue risorse e capaci-tà. Evidentemente la forza della violenza terroristica di solito non risie-de tanto nell’entità del danno immediato procurato a persone o a cosequanto nella sua capacità di intimidire e disorientare un elevato numerodi individui e, al limite, un’intera società. Insomma, il terrorismo èsoprattutto una forma di guerra psicologica, come è stato spesso notato.In questo senso, la violenza terroristica indiscriminata contro i civiliconsente di esercitare la massima pressione possibile sul governo o sullostato nemico perché minaccia di gettare l’intera società in uno stato didisorientamento e, appunto, di terrore, alimentato dall’idea che tutti gliindividui possano essere coinvolti in atti di violenza, proprio a causadella natura imprevedibile degli attacchi.
(58) Cfr. Mario STOPPINO, Potere e teoria politica, cit., pp. 87-97.(59) Si veda, tra gli altri, la lucida interpretazione del «terrore agitatorio» (agitational
terror) contenuta nel pionieristico saggio di Thomas Perry THORNTON, Terror as aWeapon of Political Agitation, in Harry ECKSTEIN (a cura di), Internal War: Problemsand Approaches, Westport, Greenwood Press, 1964, pp. 71-99.
FRANCESCO MARONE234
Inoltre, la violenza indiscriminata contro civili è anche la più effi-ciente perché generalmente meno impegnativa e dispendiosa in terminidi risorse, di informazioni e di capacità logistiche richieste (60).
D’altra parte, la violenza indiscriminata contro i civili può presen-tare alcuni effetti controproducenti. In questo caso, infatti, le vittimesono selezionate soltanto per la loro presunta appartenenza ad una col-lettività, non perché occupano ruoli che comportano la partecipazioneattiva al conflitto o, comunque, il supporto e l’impegno diretto a favo-re del governo nemico né tanto meno perché hanno posto in esserecomportamenti specifici giudicati dannosi per la causa delle organizza-zioni terroristiche. Per questo, possono essere percepite come vittimeinnocenti (61), oltre che inermi. La giustificazione di tale violenza appa-re pertanto disagevole e complicata. E vi è di più: la violenza indiscri-minata contro i civili rischia di provocare l’alienazione della simpatiaverso le organizzazioni terroristiche nelle parti terze o addirittura nellastessa comunità di sostegno, danneggiando la causa politica promossadalle organizzazioni. Per esempio, le Tigri Tamil in Sri Lanka hannodiretto quasi tutti i propri attacchi suicidi contro destinatari militarioppure contro esponenti politici e significativamente non hanno mairivendicato la responsabilità degli attacchi che hanno provocato vittimecivili (62).
In molti casi i terroristi non intendono attaccare indiscriminatamen-te tutti i civili, perché possono essere interessati ad acquisire il consen-so e il sostegno di alcuni di loro. Seguendo la prospettiva del «terrori-smo categoriale» (categorical terrorism) delineata da Jeff Goodwin (63),si può argomentare che i terroristi adottino la violenza indiscriminataper collettività soltanto contro una popolazione civile che venga perce-pita come «complice» del governo o dello stato nemico perché conti-nuativamente beneficia delle sue azioni, lo sostiene e ha la capacità diinfluenzare le sue decisioni politiche. Nel caso del conflitto israelo-pale-
(60) Cfr. Stathis N. KALYVAS, The Paradox of Terrorism in Civil War, in «The Journalof Ethics», VIII, 2004, pp. 97-138.
(61) Cfr. Victor T. LE VINE, On the Victims of Terrorism and their Innocence, in«Terrorism and Political Violence», IX, 1997, pp. 55-62.
(62) Bruce HOFFMAN e Gordon H. MCCORMICK, Terrorism, Signaling, and SuicideAttack, in «Studies in Conflict and Terrorism», XXVII, 2004, pp. 243-81 (pp. 261-62).
(63) Jeff GOODWIN, A Theory of Categorical Terrorism, in «Social Forces», LXXXIV,2006, pp. 2027-46, specialmente pp. 2036-42.
IL TERRORISMO SUICIDA NEL CASO PALESTINESE 235
stinese, la forte identificazione tra tutti i civili israeliani e lo stato israe-liano sotto questi tre aspetti consente di fatto un trasferimento dellecolpe dal secondo ai primi; in altri termini, le organizzazioni palestine-si reputano che i civili israeliani beneficino della, appoggino, richieda-no o tollerino la violenza indiscriminata e di ampia portata esercitatadallo stato israeliano contro le organizzazioni palestinesi e la loro socie-tà di riferimento.
In particolare, due dispositivi istituzionali del sistema politico israe-liano si rivelano salienti al riguardo: il voto politico e la leva universa-le (64). Da una parte, la partecipazione alle elezioni democratiche riducenotevolmente la distanza percepita tra i cittadini israeliani e lo stato. Agliocchi delle organizzazioni palestinesi, i civili sono complici dello statoperché lo sostengono e soprattutto lo influenzano con il loro voto e perquesto possono essere considerati obiettivi legittimi degli attacchi suici-di. La natura democratica del regime israeliano ha l’effetto indiretto dirafforzare il potere di coercizione delle organizzazioni palestinesi perchéimplica un’influenza ampia, stabile ed istituzionalizzata dei civili, ogget-to della violenza, sul governo nemico; uno degli obiettivi principali dellaviolenza terroristica è proprio quello di esercitare una pressione sui civi-li tale da indurli a richiedere al proprio governo un cambiamento politi-co favorevole alle organizzazioni violente (65). Le organizzazioni sonoben consapevoli di questa dinamica (66), come dimostra, tra l’altro, lacampagna di attacchi suicidi eseguita da Hamas alla vigilia delle elezio-
(64) Cfr. ibidem, pp. 2039-40.(65) Il tema della relazione tra regime democratico e violenza terroristica è complesso e
finora ha stimolato interpretazioni discordanti in letteratura. Schematicamente si può affer-mare che le democrazie forniscono mezzi di azione politica alternativi alla violenza, ma,nello stesso tempo, presentano condizioni che favoriscono l’insorgenza del terrorismo, comela vulnerabilità alla coercizione, le opportunità di visibilità e pubblicità, i vincoli nella rea-zione antiterroristica. Tra i contributi più recenti, Quan LI, Does Democracy Promote orReduce Transnational Terrorist Incidents?, in «Journal of Conflict Resolution», XLIX, 2005,pp. 278-97. Per la forma degli attacchi suicidi si vedano Robert A. PAPE, Dying to Win, cit.,capitolo 4, e Sara JACKSON WADE e Dan REITER, Does Democracy Matter? Regime Type andSuicide Terrorism, in «Journal of Conflict Resolution», LI, 2007, pp. 329-48.
(66) Hillel FRISCH, Between Bullets and Ballots: The Palestinians and IsraeliDemocracy, in Efraim INBAR (a cura di), Democracies and Small Wars, cit., pp. 171-86.Secondo Frisch, dalla fine degli anni ’70 l’Organizzazione per la Liberazione dellaPalestina (OLP) ha acquisito sempre più consapevolezza della rilevanza della naturademocratica del regime israeliano per la formulazione della propria strategia politica,giungendo ad affiancare lo strumento dell’influenza politica (ballots) al più consuetostrumento della lotta armata (bullets).
FRANCESCO MARONE236
ni israeliane del 1996, volta ad alimentare la sfiducia nei confronti delgoverno laburista guidato da Shimon Peres, allora impegnato in un pro-cesso di pace che Hamas ha sempre avversato (67).
Dall’altra parte, la leva universale, oltre ad accentuare l’identificazio-ne tra cittadini e stato, attenua la distinzione tra civili e militari. In Israeleil servizio militare è obbligatorio per tutti i cittadini ebrei (ed anche drusie circassi di sesso maschile) che abbiano compiuto diciotto anni, per unperiodo rispettivamente di tre anni per gli uomini e di due anni per ledonne, con esoneri per ragioni religiose, oltre che fisiche e psicologiche;inoltre, gli uomini possono essere richiamati come riservisti fino all’etàdi 43-45 anni. Le organizzazioni violente interpretano questo dispositivoistituzionale come un segno dell’assenza di distinzione tra civili e milita-ri, nonché della complicità oggettiva dei civili nelle violenze e nelleingiustizie subite dai palestinesi. Si consideri, per esempio, il seguentebrano tratto da un’intervista di Muhammad Nazzal, dirigente di Hamas:
«In una guerra tra due stati quelli che combattono sono combattenti e quelliche non lo fanno sono civili. Nel caso dell’occupazione israeliana, questonon vale. Non è una lotta tra due stati o tra due eserciti. È una lotta tra unapotenza colonizzatrice con forze potenti ed un arsenale moderno e un popo-lo indifeso con armi modeste. Questa potenza coloniale non è altro che unesercito che possiede uno stato, non uno stato che ha un esercito. La socie-tà israeliana è intensamente militarizzata con pochi civili autentici. Noi defi-niamo i civili come quelli che non portano armi e non combattono. Nel casodi Israele, questo si applica a quelli che hanno meno di 18 anni e a quellivecchi; gli altri sono combattenti. Noi non uccidiamo i bambini. Potremmoandare facilmente negli asili o nei luoghi pubblici frequentati dai bambini oattaccare i vecchi, ma non lo facciamo. Gli altri, comunque, uomini odonne, sono obbligatoriamente arruolati nell’esercito e una volta all’annosono richiamati per almeno 40 giorni ed in casi di guerra o emergenza» (68).
(67) Cfr. Claude BERREBI e Esteban F. KLOR, On Terrorism and Electoral Outcomes:Theory and Evidence from the Israeli-Palestinian Conflict, in «Journal of ConflictResolution», L, 2006, pp. 899-925.
(68) Citato in Mohammed M. HAFEZ, Moral Agents, Immoral Violence: Mechanisms ofMoral Disengagement in Palestinian Suicide Terrorism, in Jeff VICTOROFF (a cura di),Tangled Roots: Social and Psychological Factors in the Genesis of Terrorism,Washington, IOS Press, 2006, pp. 292-307 (il passo citato è a p. 305). Le parole diNazzal plasmano così la rappresentazione di una lotta tra uno stato militarizzato quasiprivo di civili (Israele) ed un popolo costituito soltanto da civili (i palestinesi), con pre-vedibili conseguenze in termini di pretese di giustificazione morale della violenza.
IL TERRORISMO SUICIDA NEL CASO PALESTINESE 237
Le organizzazioni palestinesi preferiscono rinunciare alla violenzaselettiva, più costosa, perché non si aspettano alcun possibile sostegnorealmente utile da parte dei civili israeliani, rappresentati come un bloc-co monolitico fortemente identificato con lo stato e, come si vedrà, privodi differenziazioni interne, in virtù di un processo di deindividualizza-zione. Questa decisione è certamente favorita dalla distanza sociale (69) eculturale percepita tra palestinesi e israeliani. Il processo di definizionee riconoscimento sociale del nemico enfatizza la differenza etnica, reli-giosa, linguistica, economica tra le due collettività. In particolare, comeha rilevato Robert A. Pape, la differenza di religione esaspera la distan-za tra le due parti in conflitto, anche alla luce del suo carattere esclusi-vo: un individuo può parlare due lingue, ma difficilmente può apparte-nere a due confessioni religiose (70). Evidentemente la religione, oltre adaccentuare la distanza rispetto all’avversario in qualità di tratto rilevan-te dell’identità collettiva (71), può ispirare direttamente le motivazioni dialcune organizzazioni terroristiche, come Hamas e la Jihad IslamicaPalestinese (72).
(69) Si vedano le originali riflessioni sul rapporto tra distanza sociale e distanza fisicanel terrorismo di Donald BLACK, The Geometry of Terrorism, in «Sociological Theory»,XXII, 2005, pp. 14-25. Nondimeno, l’approccio della “sociologia pura”, propugnato daquesto studioso, ha il grave limite di negare dichiaratamente la definizione sociale del-l’avversario, assumendo che «le strutture uccidono e mutilano, non gli individui o le col-lettività» (ibidem, p. 15).
(70) Robert A. PAPE, Dying to Win, cit., capitolo 6. Secondo Pape, «sotto le condizionidi un’occupazione straniera, la differenza religiosa – più che l’Islam o qualsiasi altra reli-gione particolare – rafforza i confini tra le comunità nazionali e rende così più facile peri terroristi ritrarre il conflitto in termini di somma zero, demonizzare l’avversario e con-quistare la legittimità per il martirio dalla comunità locale. In altre parole, la differenzareligiosa contribuisce a creare le condizioni che incoraggiano i movimenti di resistenzaad usare il terrorismo suicida» (ibidem, p. 80, corsivo nel testo).
(71) Cfr. Jonathan FOX, The Ethnic-Religious Nexus: The Impact of Religion on EthnicConflict, in «Civil Wars», III, 2000, pp. 1-22.
(72) Per un’interpretazione stimolante, anche se non priva di limiti, della violenza ter-roristica di ispirazione religiosa rinvio a Mark JUERGENSMEYER, Terroristi in nome diDio, cit. Si vedano anche David C. RAPOPORT, Fear and Trembling, cit.; ID., SomeGeneral Observations on Religion and Violence, in «Terrorism and Political Violence»,III, 1991, pp. 118-40; Bruce HOFFMAN, “Holy Terror”: The Implications of TerrorismMotivated by a Religious Imperative, in «Studies in Conflict and Terrorism», XVIII,1995, pp. 271-84; Audrey Kurth CRONIN, Behind the Curve: Globalization andInternational Terrorism, in «International Security», XXVII, 2003, pp. 30-58.Specificamente sul fenomeno degli attacchi suicidi, Robert J. BRYM, Religion, Politics,and Suicide Bombing: An Interpretative Essay, in «Canadian Journal of Sociology»,XXXIII, 2008, pp. 89-108, in cui si sostiene in maniera convincente la maggior rilevan-za delle ragioni politiche rispetto alle motivazioni religiose.
FRANCESCO MARONE238
Nel caso del conflitto israelo-palestinese assume poi rilevanza laposizione dei cittadini arabi di Israele, pari a circa il 20 percento del-l’intera popolazione; molti dei quali divisi, in special modo durante laSeconda Intifada, tra il conferimento di lealtà allo stato israeliano e l’of-ferta di solidarietà al mondo arabo e alla causa palestinese (73). Non sor-prendentemente, gli arabi israeliani, nel complesso, sono raramente vit-time di attacchi suicidi (74). Vale la pena di notare che in Israele i citta-dini arabi non hanno l’obbligo del servizio militare e, per certi versi,recentemente hanno assunto un atteggiamento particolare anche rispet-to all’altro dispositivo istituzionale sopra richiamato, il voto politico,boicottando in modo consistente varie tornate elettorali e specialmentele elezioni per il Primo ministro del 2001 (75). Nel complesso, la posi-zione dei cittadini arabi, soggetti a varie forme di discriminazione defacto nel paese, riflette la tensione esistente in Israele tra il principiouniversalistico dello stato democratico ed il principio etnico dello statoebraico (76).
Come ho notato, l’impiego sistematico e continuativo della formadegli attacchi suicidi richiede solitamente il sostegno di una parte cospi-cua della società di riferimento, non foss’altro per ragioni associate alreclutamento degli aspiranti suicidi e all’esigenza di legittimazione dellapratica di morire per uccidere. In molti casi le comunità di sostegnomostrano atteggiamenti più moderati rispetto a quelli delle organizza-zioni terroristiche nei confronti del ricorso a forme di violenza estreme,per motivi valoriali oppure per motivi strategici: da una parte, la comu-nità di sostegno può giudicare queste forme di violenza moralmenteinaccettabili; dall’altra, può considerarle pericolose per i membri della
(73) Tra gli altri, cfr. Hillel FRISCH, Positions and Attitudes of Israeli Arabs Regardingthe Arab World, 1990-2001, in «Middle Eastern Studies», XXXIX, 2003, pp. 99-120;ID., Israel and its Arab Citizens in «Israel Affairs», XI, 2005, pp. 207-22.
(74) Per esempio, secondo Daphna CANETTI-NISIM, Gustavo MESCH e Ami PEDAHZUR(Victimization from Terrorist Attacks, cit., p. 491), soltanto il 2,6% delle vittime israe-liane degli attacchi suicidi palestinesi è di religione musulmana. L’evidenza empiricamostra che gli attacchi suicidi palestinesi sono concentrati nelle aree abitate in prevalen-za da ebrei.
(75) Da ultimo, cfr. As‘ad GHANEM e Muhannad MUSTAFA, The Palestinians in Israeland the 2006 Knesset Elections: Political and Ideological Implications of ElectionBoycott, in «Holy Land Studies: A Multidisciplinary Journal», VI, 2007, pp. 51-73.
(76) Cfr. Sammy SMOOHA, The Model of Ethnic Democracy: Israel as a Jewish andDemocratic State, in «Nations and Nationalism», VIII, 2002, pp. 475-503, cui rinvio perl’indicazione della bibliografia rilevante.
IL TERRORISMO SUICIDA NEL CASO PALESTINESE 239
comunità (per esempio, a causa di possibili rappresaglie da parte del-l’avversario) o controproducenti per la causa politica (per esempio, perle ripercussioni internazionali negative) (77).
Al contrario, nel caso palestinese questo vincolo appare piuttostodebole. Molti palestinesi condividono non soltanto gli scopi perseguitidalle organizzazioni violente, ma anche i mezzi adottati, compresi i piùestremi. Secondo sondaggi di opinione condotti nei Territori palestinesi,il sostegno per gli attacchi suicidi contro civili israeliani ha raggiuntolivelli molto elevati, soprattutto durante la Seconda Intifada, con puntesuperiori al 70 percento della popolazione (78). La società palestinese hamostrato segni non trascurabili di radicalizzazione, almeno in certe fasistoriche come la Seconda Intifada. All’origine di questo processo vi sonole difficili condizioni di vita, il senso di frustrazione e di disillusioneseguito al fallimento del processo di pace e, soprattutto, gli effetti del-l’intensa attività violenta condotta da Israele, in particolare contro i civi-li. Una società di riferimento che presenti simili atteggiamenti e prefe-renze può accettare ed addirittura incoraggiare la decisione delle orga-nizzazioni di servirsi degli attacchi suicidi indiscriminati contro i civili,una forma di violenza doppiamente estrema: per il ricorso all’atto del
(77) Stathis N. KALYVAS e Ignacio SÁNCHEZ-CUENCA, Killing Without Dying: TheAbsence of Suicide Missions, in Diego GAMBETTA (a cura di), Making Sense of SuicideMissions, cit., pp. 209-32, soprattutto pp. 218-23.
(78) Come ha sintetizzato Hafez, «durante gli anni del processo di pace di Oslo (1993-2000), la maggior parte dei palestinesi rifiutava gli attacchi suicidi contro civili israelia-ni. Comunque, durante l’Intifada di al-Aqsa, la grande maggioranza ha sostenuto taliattacchi, nonostante i livelli fluttuanti di favore. Per esempio, in un sondaggio del marzodel 1996 condotto dal Palestinian Center for Policy and Survey Research solo il 21,1percento dei palestinesi della Cisgiordania e di Gaza esprimeva sostegno per gli attenta-ti suicidi [suicide bombings]. Il sostegno più alto per gli attentati suicidi durante il pro-cesso di pace non ha mai superato il 32,7 percento, nel settembre 1997, quando era incarica Benjamin Netanyahu, il leader “falco” del Likud. Al contrario, un sondaggio del-l’ottobre 2003 dello stesso centro di ricerca ha trovato che il 74,5 percento dei palesti-nesi sosteneva gli attentati suicidi [...] Soltanto nel marzo del 2005, dopo che palestine-si ed israeliani hanno raggiunto un accordo sul cessate il fuoco reciproco, il sostegno pergli attentati suicidi è calato sostanzialmente: il 29,1 percento ha continuato a sostenerli»(Mohammed M. HAFEZ, Manufacturing Human Bombs, cit., p. 19; si veda il grafico 2a p. 20). Per i sondaggi di opinione del Palestinian Center for Policy and SurveyResearch (PCPSR) si può consultare il relativo sito internet: http:// www.pcpsr.org.Dati non dissimili sono riportati da Bloom (Mia M. BLOOM, Dying to Kill, cit.,Appendix, p. 193) rifacendosi ai sondaggi del Jerusalem Media and CommunicationCentre (JMCC): http://www.jmcc.org. Per una comparazione tra i differenti campionidi riferimento dei due centri di ricerca palestinesi si veda Luca RICOLFI, Palestinians,1981-2003, cit., pp. 128-29.
FRANCESCO MARONE240
sacrificio di sé e per la modalità di selezione delle vittime. Si può quin-di ipotizzare che tanto più le preferenze della comunità di sostegno sonoradicali, tanto più è alta la propensione delle organizzazioni a ricorrereagli attacchi suicidi ed, in particolare, agli attacchi suicidi eseguiti inmaniera indiscriminata contro i civili. Si può poi pensare ad una secon-da ipotesi che instaura un nesso di causazione tra l’intensità della vio-lenza contro i civili da parte dell’avversario e il carattere radicale di talipreferenze (79). È evidente, inoltre, che alcune organizzazioni violente, aloro volta, possono essere interessate a radicalizzare l’atteggiamentodella comunità di sostegno: per esempio, la stessa provocazione consa-pevole di violenza indiscriminata da parte dell’avversario può servire aquesto scopo. È possibile formulare un’ulteriore ipotesi secondo cui lacompetizione tra organizzazioni rivali nell’arena politica interna stimolauna sorta di gioco al rilancio a favore di forme di violenza estrema,come dimostra l’effetto di contagio subito dalle organizzazioni secolaridi al-Fatah e del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina.
Le reazioni sulla scena internazionale costituiscono spesso un vinco-lo consistente al ricorso agli attacchi suicidi. Questa forma di violenza,pur garantendo visibilità e pubblicità alla causa politica promossa, fini-sce per ammantarla, per così dire, di un aspetto profondamente negati-vo. Gli attacchi suicidi, infatti, vengono percepiti come un’arma inam-missibile e ripugnante dalla maggioranza della comunità internazionalee dell’opinione pubblica mondiale (80). Ciononostante, le organizzazionipalestinesi, avvalendosi frequentemente di questa forma di violenza,verosimilmente stimano che i benefici inerenti alle sorti del conflittosuperino i costi sulla scena internazionale.
4.2. Le giustificazioni
Apparentemente gli orientamenti ideologici esercitano un’influenzanotevole sull’attività terroristica ed, in particolare, sulla selezione delle
(79) Cfr. Stathis N. KALYVAS e Ignacio SÁNCHEZ-CUENCA, Killing Without Dying, cit.,pp. 218-23; Luis DE LA CALLE e Ignacio SÁNCHEZ-CUENCA, The Production of TerroristViolence, p. 13 e ss. Tra l’altro, questi contributi sottolineano come, in effetti, le prefe-renze relativamente moderate delle comunità di sostegno dell’IRA e dell’ETA abbianolimitato il livello di estremismo della violenza esercitata dalle due organizzazioni. Si vedaanche Jeff GOODWIN, Review Essay: What Do We Really Know About (Suicide)Terrorism?, in «Sociological Forum», XXI, 2006, pp. 315-30, specie pp. 326-29.
(80) Stathis N. KALYVAS e Ignacio SÁNCHEZ-CUENCA, Killing Without Dying, cit., p. 218.
IL TERRORISMO SUICIDA NEL CASO PALESTINESE 241
vittime (81). È difficile negare l’influsso del radicalismo islamista diHamas e della Jihad Islamica Palestinese sui loro atti di violenza (82).
Va però considerato che le preferenze normative e gli orientamentiideologici delle organizzazioni terroristiche relativi alla selezione dellevittime costituiscono, al massimo, vincoli relativamente deboli ed elasti-ci, lasciando ampio spazio alla razionalizzazione ex post. La stessaHamas agli inizi degli anni ’90 si era impegnata a non uccidere civili;quando nel 1994 l’organizzazione ha rinnegato questo impegno, in basead un calcolo dei costi e dei benefici, ha trovato rapidamente numeroseragioni per giustificare questa svolta (83), tra cui il richiamo al massacrodi Hebron.
In questo paragrafo intendo rintracciare i meccanismi di giustifica-zione degli attacchi suicidi palestinesi che operano spesso ad un livello,per così dire, più profondo dei condizionamenti ideologici e dottrinaliproclamati ufficialmente.
Le organizzazioni violente mostrano di interpretare gli attacchi suici-di come mezzi legittimi per promuovere una causa politica giusta; inparticolare, l’atto del sacrificio estremo, ridefinito nella pratica del“martirio”, è permeato da una profonda tensione morale. Al tempo stes-so, la violenza, in specie la violenza indiscriminata contro i civili, poneseri problemi di giustificazione e di legittimazione per le organizzazioniresponsabili, per i singoli attentatori suicidi e per la comunità di soste-gno (84). Nel caso palestinese si può ricordare che l’Islam proibisce laviolenza contro i non combattenti (in particolare, donne, vecchi e bam-bini) e che tutti gli attentatori suicidi sono musulmani, molti dei quali distretta osservanza (85).
(81) Per alcune considerazioni generali si veda C. J. M. DRAKE, The Role of Ideology inTerrorists’ Target Selection, in «Terrorism and Political Violence», X, 1998, pp. 53-85.
(82) Rimando ancora una volta a Mark JUERGENSMEYER, Terroristi in nome di Dio, cit.(83) Stathis N. KALYVAS e Ignacio SÁNCHEZ-CUENCA, Killing Without Dying, cit., p. 215.(84) Sulle pretese di giustificazione della violenza indiscriminata contro i civili da parte di
al-Qaeda cfr. Quintan WIKTOROWICZ e John KALTNER, Killing in the Name of Islam: Al-Qaeda’s Justification for September 11, in «Middle East Policy», XX, 2003, pp. 76-92.
(85) Tra gli altri, cfr. Leonard WEINBERG, Ami PEDAHZUR e Daphna CANETTI-NISIM,The Social and Religious Characteristics of Suicide Bombers and Their Victims, cit.;Shaul KIMHI e Shemuel EVEN, Who Are the Palestinian Suicide Bombers?, in «Terrorismand Political Violence», XVI, 2004, pp. 815-40; Revital SELA-SHAYOVITZ, SuicideBombers in Israel: Their Motivations, Characteristics, and Prior Activity in TerroristOrganizations, in «International Journal of Conflict and Violence», I, 2007, pp. 160-68.
FRANCESCO MARONE242
Il processo di giustificazione assume grande rilievo nel caso degliattacchi suicidi, una forma di violenza che implica la vicinanza fisicadell’attentatore con le proprie vittime e consente fino all’ultimo la loroselezione deliberata e precisa. Per portare a termine la missione gliattentatori suicidi stessi devono innalzare, in qualche modo, una sorta dibarriera morale ed emotiva tra sé e le vittime (86).
Molti studi hanno dimostrato che la grande maggioranza dei terrori-sti non è affatto costituita da individui anormali, affetti da psicopatolo-gie (87) o palesemente privi di moralità. All’opposto, i terroristi sono ingrado di ricostruire selettivamente i propri codici morali relativi all’ese-cuzione di condotte generalmente considerate inumane.
Albert Bandura ha indicato otto «meccanismi di disimpegno morale»(mechanisms of moral disengagement) riguardanti l’attività terroristica:la giustificazione morale, le comparazioni vantaggiose e l’etichettaturaeufemistica riguardano la condotta violenta; il trasferimento dellaresponsabilità e la diffusione della responsabilità toccano le responsabi-lità della condotta; la minimizzazione, cancellazione o distorsione delleconseguenze coinvolge le conseguenze della condotta; la deumanizza-zione e l’attribuzione di colpa, infine, interessano le vittime (88).Attraverso i meccanismi di disimpegno morale condotte altrimenti giu-dicate immorali vengono ricostruite a livello cognitivo come atti moral-mente e socialmente accettabili. Bandura è interessato principalmentealle dinamiche psico-sociali degli individui coinvolti nelle attività terro-ristiche. Al contrario, in questa sede l’attenzione è rivolta alla defini-zione sociale e, ancor più, all’uso politico dei meccanismi rispetto allaselezione delle vittime; ambiti nei quali il ruolo dei leader delle orga-nizzazioni, in qualità di imprenditori della violenza, appare attivo e spes-so determinante. Fattori simili, peraltro, possono essere individuatianche nell’esercizio della violenza da parte di Israele contro obiettivipalestinesi (89).
(86) Cfr. Mohammed M. HAFEZ, Moral Agents, Immoral Violence, cit., pp. 292-93.(87) Per un’apprezzabile rassegna critica degli approcci psicologici alla violenza terrori-
stica si veda Jeff VICTOROFF, The Mind of the Terrorist: A Review and Critique ofPsychological Approaches, in «Journal of Conflict Resolution», XLIX, 2005, pp. 3-42.
(88) Albert BANDURA, Mechanisms of Moral Disengagement, in Walter REICH (a curadi), Origins of Terrorism, cit., pp. 161-207.
(89) Per esempio, sui tiratori scelti israeliani in servizio durante la Seconda Intifada cfr.Neta BAR e Eyal BEN-ARI, Israeli Snipers in the Al-Aqsa Intifada: Killing, Humanity andLived Experience, in «Third World Quarterly», XXVI, 2005, pp. 133-52.
IL TERRORISMO SUICIDA NEL CASO PALESTINESE 243
Nel caso degli attacchi suicidi palestinesi quattro meccanismi di di-simpegno morale appaiono salienti (90): la giustificazione morale trasfor-ma gli attacchi suicidi in azioni legittime di difesa contro l’oppressioneisraeliana; le comparazioni vantaggiose enfatizzano l’estensione e glieffetti della violenza israeliana e rimarcano l’asimmetria militare tra ledue parti; rispetto alla selezione delle vittime i meccanismi di disimpe-gno morale più importanti sono la deumanizzazione e l’attribuzione dicolpa, cui si può aggiungere lo stratagemma della deindividualizzazione.
Per quanto riguarda la deumanizzazione, si può notare che le vittimeisraeliane della violenza palestinese vengono rappresentate frequente-mente come esseri sub-umani, di solito con riferimento al mondo ani-male: in numerose dichiarazioni e raffigurazioni palestinesi gli israelia-ni sono visti come “cani”, “maiali” o “scimmie” (91). Da un lato, l’at-tribuzione di qualità sub-umane all’avversario produce una distanzaincolmabile tra le due parti, favorendo così il proseguimento e addirit-tura la radicalizzazione del conflitto; dall’altro, e soprattutto, priva levittime delle prerogative morali normalmente associate agli esseriumani, rendendole così immeritevoli di trattamenti compassionevoli:non si può uccidere legittimamente un uomo, ma si può uccidere un ani-male. D’altronde, occorre notare che gli israeliani vengono spesso rap-presentati, allo stesso tempo, come esseri quasi sovra-umani (92), talvol-ta alla luce di una visione cospiratoria del ruolo degli ebrei nelmondo (93).
Ancora più frequente della deumanizzazione è un secondo meccani-smo, non presente nello schema interpretativo di Bandura, che chiamodeindividualizzazione. Attraverso questo stratagemma le vittime degliattacchi suicidi palestinesi perdono i loro tratti e le loro responsabilità
(90) Cfr. Mohammed M. HAFEZ, Moral Agents, Immoral Violence, cit., p. 293 e ss.(91) Si veda, tra gli altri, Anne Marie OLIVER e Paul STEINBERG, The Road to Martyrs’
Square: A Journey into the World of the Suicide Bomber, Oxford, Oxford UniversityPress, 2005, specialmente pp. 101-7.
(92) Cfr. Mark JUERGENSMEYER, Terroristi in nome di Dio, cit., pp. 188-204.(93) Si veda, per esempio, Amandeep SANDHU, Islam and Political Violence in the
Charter of the Islamic Resistance Movement (Hamas) in Palestine, in «The Review ofInternational Affairs», III, 2005, pp. 1-12, in cui si rintraccia e descrive la strategia delladeumanizzazione espressa nella Carta costitutiva di Hamas (1988) per giustificare la vio-lenza politica, insieme con i processi di appello all’autorità e di invocazione del senso divergogna, rafforzati da una continua re-interpretazione e assimilazione della memoria sto-rica. Peraltro, oggi Hamas mostra, nel complesso, una posizione politica più articolata epragmatica di quella fissata nella Carta del 1988; cfr. Khaled HROUB, Hamas, cit.
FRANCESCO MARONE244
individuali e vengono considerate come parti di un tutto organico edastratto, come la “Entità Sionista”. La collettività nemica a cui le vitti-me appartengono viene quindi rappresentata come un blocco monoliticocon caratteristiche evidenti, inevitabilmente condivise da tutti i suoimembri e immutabili nel tempo. La collettività, in altri termini, subisceun processo di reificazione che fornisce una giustificazione morale allaviolenza indiscriminata; i singoli civili, in qualche modo, non hanno piùvalore in sé, ma sono semplici rappresentanti della collettività nemica epertanto possono essere legittimamente uccisi. Evidentemente il legametra i singoli civili e l’intera collettività è rafforzato agli occhi delle orga-nizzazioni violente dai due nessi di complicità precedentemente esami-nati, il voto politico e la leva universale.
Il terzo meccanismo è l’attribuzione di colpa. Tutte le organizzazionipalestinesi condannano Israele almeno per l’occupazione della Cisgior-dania e della Striscia di Gaza (fino al 2005), giudicata non soltanto ille-gittima, ma anche oppressiva e umiliante. L’attribuzione di colpa nei con-fronti dell’avversario è molto frequente nei conflitti violenti, tanto più neiconflitti prolungati, come quello tra israeliani e palestinesi, dove nessunodei due antagonisti appare totalmente esente da colpe. Ciascuna delle dueparti pertanto può sempre isolare in modo selettivo da una catena com-plessa di eventi un’azione dell’avversario che sembri colpevole (94): peresempio, definendo come offensivo ed aggressivo un intervento che, a suavolta, era concepito dall’avversario come un semplice atto di ritorsione;in particolare, l’uccisione di civili israeliani è giustificata come legittimaazione di rappresaglia per la morte di civili palestinesi da parte del nemi-co. In questo caso, all’attribuzione di colpa si accompagnano i meccani-smi della giustificazione morale e delle comparazioni vantaggiose. In virtùdel processo di deindividualizzazione e per mezzo dei nessi di complicitàmenzionati, le presunte colpe dell’avversario tendono a ricadere su tutte levittime israeliane in quanto appartenenti alla collettività avversaria; agliocchi delle organizzazioni violente, le colpe diventano collettive e con-sentono quindi l’uso legittimo di attacchi suicidi indiscriminati. Comeaccennato, non di rado l’attribuzione di colpa all’avversario si intrecciacon altri meccanismi di disimpegno morale.
(94) Albert BANDURA, Mechanisms of Moral Disengagement, cit., p. 185.
IL TERRORISMO SUICIDA NEL CASO PALESTINESE 245
Conclusioni
In questo articolo ho concentrato l’attenzione sulla logica politicadella selezione delle vittime della violenza terroristica prendendo in con-siderazione il caso degli attacchi suicidi palestinesi; un aspetto, dunque,parziale di questo fenomeno, ma di grande rilievo.
Nella prima sezione ho affrontato il tema delle definizioni e ho ten-tato di precisare il rapporto tra la strategia del terrorismo e la formadegli attacchi suicidi. Mi sono poi soffermato sui benefici tattici degliattacchi suicidi, evidenziando, da una parte, la loro efficacia rispetto allafunzione materiale ed alla funzione simbolica della violenza e, dall’al-tra, la loro efficienza in termini di costi. In particolare, rispetto alla sele-zione delle vittime, questa forma di violenza consente di minimizzare lacomponente casuale dell’atto di violenza.
Nella seconda sezione ho esaminato l’impiego degli attacchi suicidinel conflitto israelo-palestinese lungo un arco temporale che va dal 1993al 2005, rilevando come ben quattro organizzazioni palestinesi di varioorientamento politico abbiano deciso di ricorrere a questa forma di vio-lenza contro il comune nemico israeliano, in tempi diversi e con finali-tà parzialmente diverse.
Nella terza sezione ho indagato la selezione delle vittime degli attac-chi suicidi. Dopo averne documentato l’elevata capacità distruttiva, hopresentato alcune osservazioni sulla tipologia delle vittime selezionatedalle organizzazioni, sottolineando che la preferenza va ai destinataricivili, ed, infine, ho esplorato i caratteri socio-demografici delle vittime,mostrando che esse non costituiscono un campione rappresentativo del-l’intera popolazione israeliana.
Nella quarta sezione ho esplorato la logica politica della selezionedelle vittime, ponendo mente alle ragioni della violenza indiscriminatacontro i civili. Dalla disamina è emersa la conferma dei vantaggi tatticidi questa modalità di selezione nel quadro della struttura delle opportu-nità delle organizzazioni violente palestinesi, nonché l’indicazione dialcuni fattori che la favoriscono. Le risultanze possono essere così sin-tetizzate. In primo luogo, in capo a chi subisce la violenza, i fattori cheincentivano la violenza indiscriminata contro i civili sono, da un lato, l’i-dentificazione percepita tra civili e stato nemico, specialmente comedefinita dai dispositivi istituzionali del voto democratico e della leva uni-versale, e, dall’altro, la distanza culturale e sociale tra le parti in con-flitto. In secondo luogo, in capo a chi esercita e sostiene direttamente la
FRANCESCO MARONE246
violenza, si possono indicare gli atteggiamenti e le preferenze radicalidella comunità di sostegno, connessi alle caratteristiche della violenzaesercitata dall’avversario, e la presenza di una reale competizione traorganizzazioni rivali. In terzo luogo, in capo a chi assiste alla violenza,vi è la valutazione del maggior peso dei benefici inerenti alla gestionedel conflitto rispetto ai vincoli esercitati dalle parti terze.
Considerando l’influenza dei fattori appena presentati, soprattutto deiprimi due relativi all’avversario, si può formulare un’ipotesi finale: ilterrorismo etno-nazionalista, com’è quello palestinese, finalizzato acambiare o, meno frequentemente, a preservare i confini della comuni-tà politica (95), è propenso in modo spiccato ad erogare violenza indi-scriminata contro la popolazione civile perché è questa collettività, com-posta da membri accomunati dall’essere appunto tutti nemici, che rap-presenta l’entità da abbattere per raggiungere gli scopi che questo tipodi terrorismo persegue (96).
(95) Sulle peculiarità del terrorismo etno-nazionalista si veda Daniel BYMAN, The Logicof Ethnic Terrorism, in «Studies in Conflict and Terrorism», XXI, 1998, pp. 149-69; cfr.anche Rogers BRUBAKER e David D. LAITIN, Ethnic and Nationalist Violence, in «AnnualReview of Sociology», XXIV, 1998, pp. 423-52.
(96) Questa ipotesi può avere un corollario che qui soltanto accenno. Se vi è un nessotra i fini che le organizzazioni terroristiche perseguono ed i tipi di vittime selezionate,variando i fini varieranno anche i criteri di selezione delle vittime. Si pensi, per esempio,al terrorismo ideologico (volto a trasformare il regime politico) delle Brigate Rosse e dialtri gruppi armati che certamente non era indiscriminato.
IL TERRORISMO SUICIDA NEL CASO PALESTINESE 247
Appendice
Il database di cui mi sono avvalso per questa ricerca sulla selezionedelle vittime costituisce una versione ridotta di un database degli attac-chi suicidi palestinesi eseguiti dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre inIsraele e nei Territori Occupati, da me compilato presso il Dipartimentodi Studi politici e sociali dell’Università di Pavia. Gli episodi inclusisono 153.
Fonti. Il database integra le informazioni e i dati provenienti da settefonti diverse:
1) il database degli atti terroristici della Terrorism Knowledge Basedel Memorial Institute for the Prevention of Terrorism (MIPT)statunitense per il periodo 1 gennaio 1993-31 dicembre 2005 (97);
2) il database degli atti terroristici dell’Institute for Counter-Terrorism (ICT) israeliano per il periodo 1 gennaio 1993-31dicembre 2005 (98);
3) un rapporto sui suicide bombings palestinesi dell’Intelligence andTerrorism Information Center israeliano per il periodo 28 settem-bre 2000-31 dicembre 2005 (99);
4) il database degli attacchi suicidi nell’area del conflitto arabo-israeliano di Luca Ricolfi per il periodo 1 gennaio 1980-31 dicem-bre 2003 (100);
5) il database degli attacchi suicidi nel mondo di Ami Pedahzur peril periodo dicembre 1981-giugno 2005 (101);
6) il database degli attacchi suicidi nel mondo di Robert Pape per ilperiodo 1 gennaio 1980-31 dicembre 2003 (102);
(97) Terrorism Knowledge Base (TKB), National Memorial Institute for the Preventionof Terrorism (MIPT), Oklahoma City, USA, consultabile sul sito internet:http://www.tkb.org.
(98) International Policy Institute for Counter-Terrorism (ICT), Herzliya, Israele,http://www.ict.org.il.
(99) Suicide Bombing Terrorism during the Current Israeli-Palestinian Confrontation(September 2000 – December 2005), Gelilot, Israele, Intelligence and TerrorismInformation Center, Israel Intelligence Heritage and Commemoration Center (IICC),http://www.terrorism-info.org.il.
(100) Luca RICOLFI e Paolo CAMPANA, Suicide Missions, cit. Cfr. anche Luca RICOLFI,Palestinians, 1981-2003, cit.
(101) Ami PEDAHZUR, Suicide Terrorism, cit.(102) Robert A. PAPE, Dying to Win, cit.
FRANCESCO MARONE248
7) la cronologia del Ministero degli Affari Esteri di Israele per ilperiodo settembre 1993-31 dicembre 2005 (103).
Criteri di inclusione. Il database include tutti gli attentati suicidi conauto-esplosione (suicide bombings), gli attacchi suicidi portati a terminecon successo o falliti durante l’esecuzione (purché abbiano provocatoalmeno la morte dell’attentatore suicida) o che si siano chiaramente risol-ti in missioni senza via di fuga, purché soddisfino i seguenti requisiti:
a) essere menzionati da almeno due fonti;b) essere avvenuti in un tempo e in un luogo noti (104).
Regole di codificazione. Nella sua versione ridotta il database pren-de in considerazione 8 variabili: data, area geografica, organizzazioneresponsabile, obiettivo fisico, metodo di esecuzione, numero dei morti,numero dei feriti, tipo di vittime.
In caso di conflitto tra fonti, si considera la modalità più frequente,salvo che una fonte non si dimostri più affidabile delle altre.
(103) Ministero degli Affari Esteri di Israele, Gerusalemme, Israele, “Suicide and OtherBombing Attacks in Israel Since the Declaration of Principles (Sept 1993)”,http://www.mfa.gov.il.
(104) Cfr. Luca RICOLFI, Palestinians, 1981-2003, cit., specialmente pp. 78-80; LucaRICOLFI e Paolo CAMPANA, Suicide Missions, cit.
IL TERRORISMO SUICIDA NEL CASO PALESTINESE 249
![Page 1: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010809/63128fd63ed465f0570a497e/html5/thumbnails/44.jpg)