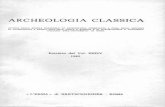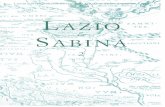Il santuario periurbano settentrionale di Cuma
Transcript of Il santuario periurbano settentrionale di Cuma
Il Denaro Progetti
Il Progetto è stato realizzatocon il cofinanziamento dell’Unione Europea.POR FESR Campania 2007- 2013.Asse 1- Obiettivo Operativo 1.9
La foto di copertina riproduce un dettaglio del muro in laterizi del Capitolium
evidenziato dal restauro del m
onumento finanziato dal presente progetto
racconti di fondazioni mitiche, forma e funzioni delle cittàcampane.santa maria capua vetere - paestum
a cura di carlo rescigno, francesco sirano
immaginando città
Immaginando CittàRacconti di fondazioni mitiche, forma e funzioni delle città campane.Santa Maria Capua VeterePaestum
Mostra a cura diAdele Campanelli, Carlo Rescigno, Francesco Sirano
Comitato ScientificoAdele Campanelli, Luca Cerchiai, Marina Cipriani, Angela Pontrandolfo, Carlo Rescigno, Francesco Sirano, Maria Josè Strazzulla
Attività scientifica e di ricercaDaniela Maiorano, Michele Scafuro, Anna Salsano, Rosaria Sirleto
Contributi scientificiCaterina Cicirelli, Emanuela Citera, Serena De Caro, Angela De Filippis, Laura Ficuciello, Ida Gennarelli, Elena Laforgia, Fausto Longo, Amodio Marzocchella, Valeria Sampaolo, Alfonso Santoriello, Luigina Tomay, Alessandra Villone
Progetto del restauro architettonico del CapitoliumRosalba De Feoassistenti: Gaetano Callisto, Raffaele Donnarumma, Amedeo Palmieri
Restauro archeologico Giuseppe D’Amodio Carmine D’AndreaCiro NapolitanoLuigi RussoRomeo BassoFelicia Maio Giuseppina BifulcoSalvatore De SioAnnamaria ScognamiglioVincenzo RosolinoMarina VecchioConsegnatari Daniela MaioranoAngela Petito
AmministrazioneRiccardo CapuanoMaria Carla Turco
Organizzazione e segreteriaMaria BoffaGiovanna LaudandoGioia PaciniAnna Maria Pagliaro
AllestimentoPercorsi di Luce – Francesco Capotorto
Enti prestatoriSoprintendenza per i Beni Archeologici di NapoliSoprintendenza per i Beni Archeologici dell’AbruzzoSoprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei Ercolano e Stabia
Immagine e ComunicazioneUfficio StampaIl Denaro Progetti Srl
Progettazione graficaDario Volpe per Il Denaro Progetti Srl
Sito webGiuseppe Ariano per Il Denaro Progetti Srl
Catalogo a cura diCarlo Rescigno, Francesco Sirano
Editing e impaginazionearte’m per Il Denaro Progetti Srl
Immagine di copertina Dario Volpe per Il Denaro Progetti Srl
Bibliografia a cura di Saverio De Rosa per Il Denaro Progetti srl
Si ringrazianoSilvano Agostini, Nadia Barrella, Emilio Castaldo, Teresa Elena Cinquantaquattro, Angela De Filippis, Giovanni Di Maio, Biagio Di Muro, Lello Giulivo, Adriano La Regina, Fabrizio Magani, Massimo Osanna, Alessio Viscione, Italo Voza, Associazione Mitreo Film Festival e i fotografi Ortensio Fabozzi e Giorgio Giampiccolo e il personale tutto della Soprintendenza.
Autori delle schedeGiuliana Boenzi [G.B.]Caterina Cicirelli [C.C.]Emanuela Citera [E.C.]Daniela Citro [D.C.]Serena De Caro [S.D.C.]Saverio De Rosa [S.D.C.]Laura Ficuciello [L.F.]Daniela Maiorano [D.M.]Natascia Pizzano [N.P.]Anna Salzano [A.S.]Michele Scafuro [M.S.]Francesco Sirano [F.S.] Rosaria Sirleto [R.S.] Ida Stanislao [I.S.]Eliana Vollaro [E.V.]
Progetto promosso dalla Soprintendenza per i Beni archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta in partenariato con la Seconda Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Lettere e Beni Culturali e l’Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale, con il patrocinio dei Comuni di Santa Maria Capua Vetere e Capaccio-Paestum e realizzato con il cofinanziamento dell’Unione Europea. POR FESR CAMPANIA 2007-2013. Asse 1 – Obiettivo Operativo 1.9
ISBN 978-88-569-0454-3stampato in italiaprinted in italy© copyright 2014 bySoprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Casertaprismi editrice politecnica srltutti i diritti riservati all rights reserved
Sommario
7 Storie di città Adele Campanelli
11 1. La Pianura Campana. Prima della città
12 La Campania settentrionale in età protostorica Claude Albore Livadie
19 Il villaggio del Bronzo Antico nel Comune di Afragola, Napoli Giuliana Boenzi, Elena Laforgia
22 Le evidenze archeologiche nell’area dello Us Navy Support Site di Gricignano d’Aversa Natascia Pizzano
26 Il villaggio protostorico di Poggiomarino, località Longola Caterina Cicirelli 30 Architettura, tecnica e tecnologia delle capanne in località Longola Emilio Castaldo
34 Prima della città / Schede 43 La Pianura Campana. Storie di città
44 Il popolamento campano della I età del Ferro. Il villanoviano campano Bruno d’Agostino
49 Considerazioni sull’avvio del processo di urbanizzazione in Italia e sulle origini di Capua Marco Pacciarelli
54 La Piana Campana: le fonti letterarie Alfonso Mele
57 Intorno al tema della migrazione e all’arrivo dei Greci sulle coste della Campania Giovanna Greco
66 La Campania degli Etruschi Luca Cerchiai 68 Modelli e archetipi di fondazione tra Greci, Italici e Romani Maria José Strazzulla 74 Popolamento e insediamenti nella mesogaia campana tra IX e VII secolo a.C. Teresa Elena Cinquantaquattro
79 La Pianura Campana. Cuma e Capua 80 Cuma, da città greca a città italica Giovanna Greco
87 Cuma,Capua.Origini 88 La fondazione di Cuma Carlo Rescigno 93 Il processo di formazione di Capua Francesco Sirano 99 Le necropoli di Capua nell’età del Ferro Gianluca Melandri 102 Cuma, Capua. Origini / Schede 107 Lastagionedellecittà:lapiana campanainetàarcaica
108 Cuma. La città al tempo degli aristocratici Carlo Rescigno
112 Capua. Il comporsi della città dall’età arcaica a quella classica Francesco Sirano
117 Le necropoli di Capua tra l’età Orientalizzante e l’inizio del V secolo Marco Minoja 121 Culture in contatto: le produzioni artigianali Michele Scafuro
125 Gli Etruschi in Campania: la scrittura e la Tabula Capuana Vincenzo Bellelli 130 La stagione delle città / Schede
136 TraCampanieRomani 137 Cuma italica Carlo Rescigno 140 Il santuario periurbano settentrionale di Cuma Priscilla Munzi
144 Capua. Ancora novità dal santuario del Fondo Patturelli Valeria Sampaolo, Paolo Poccetti 149 Tra Campani e Romani / Schede 160 CapuaeCumainetàromana
161 Il Foro di Cuma: dalle tabernae alla monumentalizzazione imperiale Carmela Capaldi
164 Cuma: continuità e trasformazioni del quartiere residenziale tra il Foro e le mura settentrionali Matteo D’Acunto
Il Progetto è stato realizzatocon il cofinanziamento dell’Unione Europea.POR FESR Campania 2007- 2013.Asse 1- Obiettivo Operativo 1.9
STORIE DI CITTÀ 7
Storie di città
Adele Campanelli
Aimieimaestri,AdrianoLaRegina,GiovanniScichiloneePaoloSommella,augurandoallegenerazionifuturedipoterneaveredisimili.
Patrimoni taciutiLo scavo archeologico produce, insieme ai dati sulla storia del territorio, una grande quantità di materiali, interi e frammenta-ri, di ogni specie: organici e inorganici, e tra essi conchiglie e os-sa umane, semi e resti di animali, ceramiche e avori, vetri e roc-ce, marmi e legni, monete e armi, sepolti nelle terre secondo stra-ti che, una volta scavati, producono a loro volta fotografie, dise-gni, relazioni, schede. Tutto questo è il patrimonio invisibile che lo Stato conserva (ma anche ignora) negli archivi e nei magaz-zini archeologici. Frutto di ondate di accumuli progressivi, i ma-gazzini archeologici giacciono impolverati, gelidi, accatastati di meraviglie che hanno goduto delle attenzioni della Stampa, del-la curiosità dei cittadini solo nel giorno del ritrovamento; que-sti sono anche oggetto di progetti incompiuti e studi interrotti. Ma anche quando non è l’eccezionalità dell’opera ad averne con-dizionato il destino, i “frammenti” depositati in cassette docu-mentano storie non scritte. Gli archeologi sostengono giusta-mente che tutto questo deve essere integralmente conservato poiché, seppure se non è stata data l’occasione, il tempo, le risor-se per avviare o completare lo studio di queste tracce meno leg-gibili, queste sono ciò che lo scavo ha prodotto durante la fase di smontaggio/distruzione delle terre che le contenevano. Il conte-sto archeologico che definisce le loro caratteristiche qualitative e quantitative e i dati registrati, costituiscono la base informativa che dovrà, nel tempo, essere utile a capire di più della vicenda che ne ha consentito la conservazione, attraverso nuovi metodi, nuovi
confronti, nuove analisi. Eppure, parallelamente al procedimento scientifico di acquisizione delle conoscenze che il materiale arche-ologico fornisce allo studioso, c’è una sorta di procedimento poe-tico che sottintende il mestiere dell’archeologo che, come il poeta, deve immergersi ne “il porto sepolto” per trovare il segreto della storia, di cui riporta a galla frammenti: “...e poi torna alla luce con i suoi canti e li disperde” (Ungaretti, Ilportosepolto).È forse propria della seconda stagione di vita degli archeologi (solo di alcuni ovviamente) la passione civile. Questa li guida, do-po aver cercato la storia tra i frammenti del passato, a restitui-re alla comunità il senso di ciò che hanno compreso. La neces-sità di ridare vita alle “ossa senza carne” si sostituisce, allora, o raddoppia con forza l’impegno e la fatica del lavoro di scavo e studio scientifico che contraddistingue la pratica di questa disci-plina austera, che assorbe interamente tempo, energie, relazio-ni affettive, condizionando il tempo quotidiano di chi la pratica. È in questo momento che si torna nei magazzini archeologici a cercare, a selezionare parole scavate per riunirle in un discorso, per narrarne il divenire, per mostrarle allo stupore dei giovani, per comporre la poesia del loro essere stati.
Dal silenzio dei depositi Così, anche in questo caso, le due sezioni della mostra, di cui que-sto catalogo rappresenta il corredo scientifico, nascono dal desi-derio dei curatori di trasferire alla comunità cittadina e ai turisti che la visiteranno, un complesso di informazioni storiche che so-no state acquisite in gran parte grazie ai lavori di scavo archeolo-gico preventivo per la realizzazione di opere pubbliche, ma anche in proprietà private, che hanno sostanzialmente arricchito il qua-dro delle conoscenze sulla preistoria e la Storia della Campania
168 L’acropoli cumana Carlo Rescigno 172 I Fori e le aree monumentali di Capua Francesco Sirano
177 Capua. Testimonianza di vita pubblica, privata e di attività commerciali Rosaria Sirleto
179 Capua: il “Capitolium” Simone Foresta 182 Capua e Cuma in età romana / Schede
196 Antologiadellecittàcampane197 Calatia Elena Laforgia 200 Atella Elena Laforgia 203 Avella. Ricerca e valorizzazione Ida Gennarelli 207 Avella. Nuovo documento di Maio Vestirikio. Notizia preliminare Ida Gennarelli, Rosalba Antonini
210 Nocera. La città fondata da un dio Matilde Lombardo
213 Nola Giuseppe Vecchio 218 Gricignano di Aversa: un frammento di Ager Campanus Elena Laforgia
220 Antologia delle città campane / Schede
222 ArcheologiaurbanainCampania223 Benevento Luigina Tomay 229 2. Poseidonia - Paestum. Una città rifondata
230 Fondazioni di città nel mondo greco in età arcaica Fausto Longo
234 Prima di Poseidonia Marina Cipriani, Angela Pontrandolfo
236 Fondare e rifondare la città Marina Cipriani, Angela Pontrandolfo
240 Poseidonia - Paestum. Una città rifondata / Schede 244 La città greca Laura Ficuciello 248 Il sacello ipogeico Laura Ficuciello 252 Poseidonia - Paestum. Una città rifondata / Schede
254 La città lucana e romana: continuità e trasformazioni Fausto Longo
258 Poseidonia - Paestum. Una città rifondata / Schede
261 3. La Campania dei musei e gli spazi della mostra
262 Città e musei nella Campania settentrionale Stefano De Caro 264 Prime ipotesi di individuazione della torre S. Erasmo Rosalba De Feo
268 Bibliografia
IL SANTUARIO PERIURBANO SETTENTRIONALE DI CUMA 141
L’evidenza archeologicaLe ricerche condotte dal Centre Jean Bérard tra il 2005 e il 2006 fuori alla Porta Mediana delle mura settentrionali della città di Cuma hanno portato alla luce un complesso di strutture perti-nenti ad un’area sacra. L’area è situata nell’angolo formato a est dall’asse stradale nord-sud che esce dalla Porta e a sud dal tracciato delle fortificazioni. Tutti gli elementi strutturali che lo compongono nel tempo si inseriscono in un più ampio e articola-to sistema. In questa sede, si propone una sintesi delle principali fasi costruttive, databili dal VI al I secolo a.C. (Bats-Brun-Munzi 2009; Dewailly-Munzi 2011; Brun-Cavassa-Leguilloux-Munzi, in corso di stampa).Prima dell’arrivo dei Greci, l’area era occupata da un nucleo di sepolture dell’età del Ferro (IX secolo-prima metà dell’VIII seco-lo). È solo nel corso del VII secolo inoltrato che sono documenta-te nuove forme di frequentazione. Le indagini condotte dall’Uni-versità L’Orientale di Napoli hanno individuato una prima fase costruttiva delle mura, riferibile ai decenni iniziali del VI secolo (Dewailly in Museo archeologico dei Campi Flegrei 1, 2008; Resci-gno 2011). È a partire da questo periodo che bisogna ipotizzare la presenza di un’area santuariale fuori della Porta Mediana. L’i-potesi sembra essere avvalorata dal rinvenimento di una serie di terrecotte architettoniche di età arcaica, recuperate durante lo scavo di alcuni contesti stratigrafici più recenti (Dewailly in Museo archeologico dei Campi Flegrei 1, 2008; Rescigno 2011).Nella seconda metà del VI secolo, in un periodo compreso tra i due interventi di potenziamento delle fortificazioni intorno alla metà e alla fine del VI secolo, lo spazio antistante alla Por-ta subisce delle trasformazioni a causa della realizzazione di un nuovo asse viario in terra battuta che dalla porta corre in dire-
zione nord. Contemporaneamente, a poca distanza dalle mura e in prossimità dei margini occidentali del nuovo asse, si assiste alla costruzione di nuovi edifici. Le strutture documentano l’esi-stenza per lo meno di un edificio al quale sono collegati quattro pozzi di captazione delle acque di falda. Lo studio analitico del materiale ceramico rinvenuto, in partico-lare nei livelli di obliterazione dei pozzi, colloca al secondo quar-to del V secolo l’ultima fase di frequentazione delle strutture. Non ci sono elementi strutturali o rinvenimenti particolari che permettano di definire la destinazione d’uso del complesso. Verso la metà del V secolo a.C., l’area è radicalmente trasforma-ta e nuove strutture sono edificate riutilizzando, in fondazione, parte dei setti murari della fase edilizia precedente. Del nuovo edificio si conserva una successione, in senso est-ovest, di al-meno quattro vani a pianta quadrangolare e parte di un gran-de spazio aperto a sud. Al centro di uno degli ambienti meglio conservati, il secondo da est, era ancora in posto una struttura bassa di forma quadrangolare. Il blocco presentava importanti tracce di combustione e sul piano era ancora deposto uno stra-to di cenere. In prossimità dell’angolo nord-est della struttura era infissa nel terreno la parte inferiore di un’anfora colma di cenere. All’interno dell’ambiente, lo scavo ha mostrato un piano pavimentale la cui assenza lungo le pareti lascia supporre la pre-senza di strutture in materiale deperibile. Una situazione simile, anche se meno conservata, è stata messa in luce negli ambienti ad est e ad ovest dove, al centro delle stanze, erano ancora in situ i resti dei focolari.Malgrado lo stato di conservazione delle strutture e l’impossi-bilità a poter disporre della pianta completa dell’edificio, è ap-parso plausibile ipotizzare che il complesso fosse destinato a
Il santuario periurbano settentrionale di Cuma
Priscilla Munzi
funzioni ausiliarie allo svolgimento di banchetti (hestiatorion?) (Bats-Brun-Munzi 2010).Negli ultimi decenni del IV secolo a.C. l’edificio è defunzionaliz-zato. Lo smantellamento è accompagnato dalla spoliazione di alcuni setti murari e gli ambienti sono obliterati da un grande scarico composto da terra, pietre, frammenti ceramici e resti os-sei animali. Preponderante risulta la ceramica comune, attesta-ta principalmente da ollae in ceramica da cucina. Il contesto ha restituito anche numerosi recipienti a vernice nera, vasi minia-turistici e alcuni vasi a figure rosse. Il materiale a vernice nera è costituito essenzialmente da vasi di uso potorio e si colloca cro-nologicamente nella seconda metà del IV secolo a.C. Nello spes-so strato di obliterazione delle strutture era presente un’ingente quantità di ossa animali, riferibile ad avanzi di pasti che potreb-bero corrispondere ai resti di consumi rituali (quarti di maiale e di gallina domestica, resti di bovini e di piccoli ruminanti). Contemporanea o di poco successiva, è una fossa – FS700114 – che è ricavata in corrispondenza dell’angolo sud-ovest dell’ambiente con focolare e riempita con vasi interi e terrecotte architettoni-che frammentarie. Nessun segnacolo esterno è stato evidenzia-to dallo scavo. Il vasellame era composto da ventiquattro ollae e una caccabè in ceramica da cucina, un’olpetta e due anfore in ce-ramica da mensa (Basile in Museo archeologico dei Campi Flegrei 1, 2008). Il materiale ceramico appare di cronologia sostanzial-mente unitaria e rinvia ad un orizzonte cronologico dell’ultimo quarto del IV secolo. Un dato interessante proviene dal lotto di terrecotte architettoniche. Nella fossa, infatti, erano stati deposti un acroterio a disco con maschera di Gorgo e quattro antefisse nimbate, di cui una a testa femminile, una a palmetta rovescia e due a palmetta diritta, datati alla metà del VI secolo a.C. (Dewail-ly, op. cit.) Nell’associazione dei materiali, colpisce il contrasto tra le terrecotte architettoniche e il vasellame, sia per lo scarto cro-nologico (quasi due secoli) sia per il loro significato. Nel corso della prima metà del III secolo, dopo un breve perio-do di abbandono, sui livelli che sigillano la chiusura dell’edificio della fase precedente, è messo in opera un nuovo complesso di strutture che utilizza la tecnica costruttiva “a telaio”. Del com-plesso fanno parte due aree strette e lunghe a est e uno spazio aperto a ovest, al centro del quale è una struttura rettangolare composta da quattro lastre di tufo infisse nel terreno. Sebbene l’interpretazione di questo contesto non sia del tutto chiara, è significativo come la costruzione sia impostata in corrisponden-za della fossa in fase con l’abbandono dell’edificio precedente (fig. 5). Anche in questo caso, sembra possibile ipotizzare una relazione delle strutture con un’area sacra.Il complesso cessa di funzionare nel corso della prima metà del I secolo a.C. e i setti murari sono in parte rimossi. Nello spazio aperto, inglobati nello strato di abbandono, vi erano undici gros-si blocchi di tufo, verosimilmente basi di cippi o di stele. Di par-ticolare interesse si è rivelata una fossa – FS700091 – ricavata a ridosso del paramento orientale del muro nord-sud. Al suo inter-no erano seppelliti alcuni thymiateria frammentari, due olpette in ceramica acroma, una lekythos a reticolo, un certo numero di terrecotte architettoniche, alcune statuette e diversi frammenti di tegole. Sia le terrecotte che la coroplastica sono ascrivibili ad
un ampio arco cronologico che va dal primo quarto del VI alla seconda metà del IV secolo. Tale materiale, conservato in stato frammentario, comprendeva un’antefissa a testa femminile di tipologia dedalica (inizi del VI secolo), un’antefissa nimbata a te-sta femminile (metà del VI secolo o poco prima), due antefisse nimbate con cavaliere (seconda metà del VI secolo), un’antefis-sa nimbata con sfinge (seconda metà del V secolo), un’antefissa con testa di Athena con elmo frigio (prima metà del IV secolo), una statuetta femminile di offerente con porcellino (fine V-IV secolo), tre protomi femminili con polos (fine del V secolo), una statuina maschile (IV secolo), un piccolo bovino (V secolo) e un piccolo cavallo (V secolo) (Dewailly, op. cit.).Un’altra piccola fossa – FS700103 – messa in luce qualche me-tro più a sud, ha restituito alcuni vasetti miniaturistici, statuet-te e terrecotte votive in parte frammentarie. In questo secondo caso, il materiale votivo copre un arco cronologico più ristretto. Quest’ultimo comprendeva un busto femminile acefalo con col-lana plastica (seconda metà del IV secolo), una statuina maschi-le (IV secolo), quattro statuette femminili panneggiate acefale (IV-III secolo) e una maschera maschile in terracotta (IV secolo). Nella prima metà del I secolo a.C., forse anche dovuto all’avvi-cinamento alla città dei margini del lago di Licola, tutta l’area cambia totalmente aspetto e destinazione: da spazio sacro di-venta terreno libero e piatto attraversato da una grande fogna; dalla metà del I secolo anche l’area a ovest dell’asse viario nord-sud è progressivamente occupata da edifici funerari.
Note sulle architetture del santuario periurbano settentrionale di CumaNel corso dei secoli, l’area antistante la Porta Mediana delle for-tificazioni settentrionali conosce numerose trasformazioni. Nel-la seconda metà del VI secolo è costruito un primo edificio che viene abbandonato nel secondo quarto del V secolo. Poco dopo, sfruttandone parte dei setti murari, ne viene edificato un secon-do. Nella seconda metà del IV secolo quest’ultimo è abbando-nato e la sua “chiusura” è accompagnata da una cerimonia e da una serie di azioni rituali. Le stesse dinamiche sembrano rico-noscibili anche nell’abbandono del complesso più recente. “Ce-rimonie di chiusura” che comportano un rito collettivo, spesso un banchetto, sono già state riconosciute nella stessa Cuma e in altri contesti di abitato (Greco 2008; Tomeo 2008).I riti di chiusura sembrano nelle varie fasi essere attestati, in particolare, dalla realizzazione di scarichi intenzionali – la fos-sa FS700114 per la chiusura dell’edificio di V-IV secolo e le fosse FS700091 e FS700103 per l’abbandono definitivo dell’area – nel-le quali la funzione votiva di ogni oggetto seppellito è indubbia (Bats-Brun-Munzi 2010). Di recente queste “operazioni di sele-zione e di scarico intenzionale” sono state ipotizzate anche per Fondo Patturelli da C. Rescigno, il quale prende a confronto il contesto cumano (Rescigno 2009a).È particolarmente rilevante il contrasto cronologico del contenu-to di ognuna delle tre fosse tra il materiale ceramico, le terrecotte architettoniche e la coroplastica. I dati sembrano mostrare una volontà di conservare attraverso i secoli una selezione di oggetti, e nel caso specifico, gli elementi pertinenti ad edifici ormai spa-
140 TRA CAMPANI E ROMANI / PRISCILLA MUNZI
riti, come memoria di un luogo di culto in tutte le sue fasi di vita. I materiali votivi recuperati in giacitura primaria sembrano con-fermare il legame nel tempo degli edifici indagati con un’area sacra al di fuori delle mura, anche se gli spazi riservati al culto non sono stati individuati. Le terrecotte architettoniche rinve-nute negli scarichi delle diverse fasi coprono un arco cronologico ampio che va dal VI al IV secolo e si riferiscono, anche per lo stes-so periodo cronologico, a diversi edifici. Il loro esame permette di fare alcune osservazioni su quelle che dovevano essere le ar-chitetture del santuario periurbano settentrionale di Cuma. La più antica è l’antefissa a testa femminile di tipologia dedali-ca, rinvenuta nello scarico più recente, ricavata da una matrice di qualità eccezionale e datata al primo quarto del VI secolo a.C. (fig. 1). Quest’ultima trova confronti a Naxos, a Taranto ma soprat-tutto a Capua e nel santuario di Marica e secondo C. Rescigno “si pone, quasi organicamente, a monte del primo blocco di antefisse nimbate a testa femminile” (Dewailly, op. cit.; Rescigno 2011).Successive di qualche decennio sono le due antefisse a testa femminile nimbata della metà del VI secolo o poco prima, pro-venienti da matrice della stessa generazione e rinvenute in en-trambe le fosse votive (fig. 2) (Dewailly, op. cit.) I due esemplari appartengono a una delle prime serie nimbate a testa femmi-nile, dal sapore ancora dedalico (Rescigno 1998). Il trattamento del viso trova confronti con una testa femminile proveniente da Pithekoussai (Lacco Ameno) e con un’antefissa da Satricum. Esemplari simili, coevi, provengono anche da Capua e da Fratte (Rescigno 1998; 2002a)Riferibile alla prima metà del VI secolo è l’acroterio fittile a disco con gorgoneion conservato in due frammenti, purtroppo lacuno-so nella parte centrale (fig. 3) (Dewailly, op. cit.; Dewailly, Munzi 2011). Dell’acroterio è possibile ricostruire la cornice decorata con due grandi serpenti che si affrontano al suo apice e, sul meda-glione, il viso frontale di una gorgone con i suoi capelli resi da due serie di serpenti ritti, ognuna orientata verso il centro della fronte. La raffigurazione del viso di Gorgo su vari tipi di terrecotte architettoniche arcaiche è molto frequente in Magna Grecia e in Sicilia ma non trova confronti puntuali e coevi per questo tipo di acroterio. Da Capua, pur se molto diversi, provengono tre acroteri a disco con la raffigurazione di Gorgone (Koch 1912). Il tema era particolarmente diffuso a Capua come dimostrano diverse ante-fisse nimbate a maschera gorgonica (Rescigno 2010b).Associate all’acroterio con gorgoneion e all’antefissa nimbata con testa femminile, nella fossa che segna la chiusura dell’edi-ficio di V-IV secolo, erano altre tre antefisse nimbate, una a pal-metta diritta (Rescigno 1998) e due a palmetta rovescia (Resci-gno 1998), databili verso la metà del VI secolo e appartenenti a gruppi particolarmente diffusi a Cuma e nei centri campani come Pithekoussai, Capua e Satricum (Dewailly, op. cit.). Nel sistema di copertura campana, come più volte sottolineato da C. Rescigno, questi tipi di lastre chiudevano la luce dei coppi di prima fila e si alternavano ad altre con rappresentazioni di gorgoni e volti fem-minili, come gli esemplari dell’area sacra della Porta Mediana appena citati. Tra i materiali architettonici rinvenuti nello stesso settore, purtroppo decontestualizzati, si segnalano anche alcuni frammenti di tegole fittili di gronda databili al VI secolo.
A una fase successiva del santuario, inquadrabile tra la fine del V e la prima metà del IV secolo, rimandano alcune terrecotte architettoniche provenienti dallo scarico votivo più recente. Si tratta di due serie di antefisse nimbate raffiguranti un cavaliere (Dewailly, op. cit.) e una sfinge (fig. 4) (Dewailly, op. cit.). Diversi esemplari di antefissa con cavaliere sono già note a Capua, dal fondo Paturelli, ma sono di generazione successiva (scadere del IV secolo) e di qualità inferiore nell’esecuzione. Un esemplare completo con cavaliere è conservato al Museo del Louvre (colle-zione Campana 5816) (Koch 1912), mentre un’antefissa completa del tipo con la sfinge alata, proveniente da Capua, è conservata al British Museum di Londra (Koch 1912). C. Rescigno restituisce l’associazione delle antefisse nimbate con sfinge femminile ala-ta con le antefisse nimbate con cavaliere in un unico sistema campano di copertura di tetti (Rescigno 2009b; 2010)Dallo stesso contesto proviene anche un’antefissa con testa di Athena con elmo frigio entro racemi (fig. 5). Realizzato da ma-trice stanca, l’esemplare è di generazione avanzata e simile ad esemplari capuani (Dewailly, op. cit.). Il tipo iconografico, oltre ad essere già noto a Cuma, è attestato nell’area della Porta Me-diana, dallo strato di abbandono dell’edificio in opera “a telaio”, anche con esemplari tra le prime generazioni databili entro la prima metà del IV secolo (Rescigno 2009b). La “raffinatezza clas-sica” della testa di Athena e la qualità d’esecuzione di questa antefissa cumana e di altri tre esemplari identici suggeriscono la loro appartenenza ad un prototipo analogo e forse precedente a quello da cui derivano gli esemplari del tempio dorico di Pompei, del santuario di Castellammare di Stabia in località Privati e da quello di Fondo Patturelli a Capua (Dewailly, op. cit.). Il tipo cono-sce, infatti, una grande diffusione nei centri campani nel primo periodo ellenistico (Scatozza 2001).Come sottolineato recentemente da C. Rescigno, “i nuovi scavi restituiscono lentamente, ma con un’inesorabilità quasi preve-dibile, volto e fisionomia alla “maniera” architettonica cumana” (Rescigno 2009b; 2011).
1. Antefissa a testa femminile di tipo dedalicoprimo quarto del VI secolo a.C.inv. 700091.01
3. Frammento di acroterioa disco con gorgoneionprima metà del VI secolo a.C.inv. 700114.01
5. Antefissa con testa di Athenacon elmo frigio entro racemimetà del IV secolo a.C.inv. 700080.01
2. Antefissa a testa femminile nimbatametà del VI secolo a.C. o poco primainv. 700114.02
4. Antefisse nimbate con cavaliere e sfinge, integrazionifine del V-prima metà del IV secolo a.C.invv. 700091.1-3
IL SANTUARIO PERIURBANO SETTENTRIONALE DI CUMA 143142 TRA CAMPANI E ROMANI / PRISCILLA MUNZI