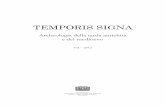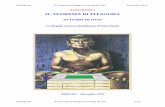Il Petraro di Villasmundo e la Timpa Ddieri. Archeologia.
Transcript of Il Petraro di Villasmundo e la Timpa Ddieri. Archeologia.
Italo Russo
IL PETRARO DI VILLASMUNDO (Melilli)
*****
__1__
LA « TIMPA DDIERI » Da: Jean Houel- VOYAGE PITTORESQUE
DES ILES DE SICILE, DE MALTE ET DE LIPARI, 1782. “Après avoir fait quelques milles, j’ai vu une de ces merveilles antiques, dont le Val de Noto, où je voyageois depuis quelque temps, est rempli, & dont les details sont aussi curieux que leur origine est peu connue.
Celle-ci est dans un endroit qu’on appelle Deluderi, & se nomme La Timpa. Jusqu’à present j’ai beaucoup parle de grotte taillèes dans la roche; grottes qui attestent par les tombeaux dont elles sont remplies, qu’il y eut dans leur voisinage des villes & des bourgs: d’autres ont ètè habitées par des vivans.
Il paroît même qu’on prèferoit ces habitations à celles qu’on auroit pu construire: il étoit plus commode de n’avoir qu’à creuser. Celles dont je veux parler maintenant sont d’un autre genre. Elles ont été disposées par étages les unes au dessus des autres.
Elles se communiquent par des trappes, des ouvertures faites aux planchers qui sont entre elles, & par des escaliers. On voit avec plaisir que les habitans de ce grottes les avoient pratiquées de manière ‘a jouir des principales commodites de la vie. Pleusieurs sont devenues inaccessibles: toujours on trouve pres des grottes quelque riviere d’un bonne eau, bien limpide. Celles qui sont en ce lieu sont remarquables par des trous carrés, creuses dans la face verticale de la roche. Ces trous servoient de fenêtres aux différes etages pour eclairer les chambres.
On m’assura qu’il y avoit dans celles de la Timpa un puits qui descenduit dans l’intérieur de ces grottes au niveau de la rivière qui coule au pied de la roche: qu’on l’avoit pratiqué pour y puiser de l’eau sans être inquiété par les brigands maîtres de la plane. J’ai vu en Sicile plusiers exemples de ces précautions”.
2
Da A. Holm: STORIA DELLA SICILIA NELL’ANTICHITÀ, 1896-1901
“Vi è in Sicilia una quantità di grotte scavate nelle rupi dalla mano dell’uomo, che, in parte almeno, appartengono ad un’antichità assai remota. (omissis)
Ricco di grotte è quindi il territorio che si stende tra le foci del Teria e dell’Anapo, vale a dire la regione del Capo di Santa Croce e del golfo megarese. (omissis) ...Lungo la via che da Lentini porta ad Augusta, l’Houel, tra le molte, trovò una grotta specialmente degna di osservazione, chiamata la Timpa, nella località Deluderi, formata di parecchi piani”.
(In nota 8, si precisa come Italia-Nicastro, RICERCHE PER L’ISTORIA DEI
POPOLI ACRENSI, Comiso 1873, pag. 7, affermi che i Ddieri, in generale, sono “punte inaccese”; perciò non denotano veramente grotte).
Da: V. Strazzulla: STORIA E ARCHEOLOGIA DI TROTILON,
XIPHONIA ED ALTRI SITI PRESSO AUGUSTA DI SICILIA, 1899.
“Nel secolo scorso l’Houel diè notizia della Timpa Ddieri, lungo la via che da Augusta mena a Lentini, nella località Deluderi, la quale si estende in quel tratto di feudo che forma parte della stretta e tortuosa valle del Molinello. Una altissima rupe da levante a ponente si erge poco men che perpendicolarmente, con aspetto quasi piano e levigato, e per la sua forma è quasi unica in Sicilia, proprio quella che, come osservarono Dal Lago e Graziadei nella traduzione dell’Holm, può chiamarsi Ddieri, parola del dialetto siciliano di Val di Noto, non applicabile a qualsiasi sito inaccessibile che sia pieno di grotte, nel modo che asserirono Italia-Nicastro e Schubring, ma solamente “a quel complesso di grotte disposte in linea orizzontale e con ordine alle quali si accede (non molto) comodamente per una specie di terrazza naturale formata dallo sporgere della rupe a guisa di cornicione che gira tutt’ all’intorno”. Se l’uso di tali grotte fa pensare ad epoca remotissima e preellenica, nulladimeno nel saccheggio che l’ elemento saraceno apportò nella Sicilia Orientale, la Timpa Ddieri fu molto probabilmente un sito solitario e opportuno per i giacimenti (?) di quel popolo devastatore; ed una stanza con muratura che era incavata nel più occidentale tratto, conservando vestigi di carattere Arabo, indecifrabile, fa pensare al ricovero del capo di una di quelle nomadi corporazioni.
3
Non dirò altro in proposito, e non dovevo però tacere che, avendovi ravvisato un acquedotto che occupa molto dello sventramento interiore, nonché alcune fialette e lucerne con frammentini figulini a colori, ritengo che la Timpa del Molinello meriti speciale considerazione”.
Da: P. Orsi- MOLINELLO PRESSO AUGUSTA, III. Periegesi archeologica,
estratto dalle Notizie degli Scavi,1902.
“Salendo a ritroso la valle del Molinello, a tratti incassata fra rupi serrate, a tratti un po' aperta per depressione dei ciglioni laterali, ed oltrepassato il Cozzo Ddiero, si arriva ad un gruppetto di tombe sicule, aperte sull’alta fiancata sinistra del fiume, che nulla presentano di speciale, né invitano allo scavo. Un poco più a monte, sotto la contrada Petraja, un’eccelsa rupe a piombo, volta a mezzodì, vi presenta scavato nel vivo a guisa d’alveare un numeroso gruppo di abitazioni trogloditiche, di cui ho la fortuna di presentare due buone vedute fotografiche.
A chi arrivi per la prima volta sotto il villaggio, percorrendo il fondo della valle, esso sembra assolutamente inaccessibile, senza l’aiuto di lunghe scale che mettano ai gruppi più bassi, dai quali, per passaggi assai pericolosi ed inavvertibili, si accede ai superiori (omissis).
Il sito si chiama Timpa Ddieri, e sino dalla fine del sec. XVIII era noverato dall’Houel, che lo visitò e lo riprodusse, fra le grandi curiosità archeologiche dell’isola; oggi invece nessuna guida lo segna, e ben di rado vi accede qualche visitatore straniero, o qualche paesano alla ricerca del tesoro. In una grandiosa parete di roccia, con debolissima inclinazione, alta quasi un centinaio di metri si aprono fra brevi sporgenze, molte diecine di grotte artificiali di abitazione, tra mezzo alle quali si riesce qua e là ad afferrare col binocolo anche qualche tomba sicula a forno. In antico, come oggi, accedeva al villaggio solo chi ne conosceva i secreti viottolini, larghi un palmo e mezzo, tracciati da punta a punta, ed interrotti da tratti a picco, scavalcati da ponticelli mobili di legno, di cui restano oggi solo le intaccature nelle rupi per fissarvi i travicelli di sostegno; levati i quali, in momento di pericolo, tutta la parte alta era affatto inaccessibile. Alle più basse abitazioni che danno sul fiume si montava con scale di legno e con gradinate aperte nella roccia, ora in parte franate; ma di qui con pochi sassi la difesa era assai facile, la larghezza della valle essendo tanta che, nella peggior ipotesi, solo la parte bassa del villaggio esponeva ai tiri d’arco, ma non di maggiori proiettili (omissis). Sono cameroni rettangolari od ellittici, di grandi dimensioni, pochi di piccole, con nicchie, loculi quadri per armadi e ripostigli, conche d’acqua nelle quali, mediante canaliculi, si raccoglievano le piovane e gli stillicidi delle rocce. Numerosi sono i fori, per infissi di ogni
4
maniera, tanto interni (per palchetti o tramezzi), come esterni per chiudere mediante travicelli, canne e frasche, le ampie bocche. L’abitazione principale si trova verso il centro della roccia; è un camerone rettangolare, che in fondo ha un tramezzo di fabbrica; nella parete a sinistra della porta è aperta una bocca svasata, da cannoniera, né escludo l’uso della colubrina, perché di là, prima di recenti frane si batteva d’infilata tutta la mezza costa (omissis).
Tutto sommato, la mia opinione intorno a questo pittoresco e misterioso abitato non è per nulla diversa da quella che io professo intorno ai consimili di Pantalica, di Cava d’Ispica, di Cava Porcheria ecc. Gente rusticana che nei secoli dell’alto medioevo, quando la campagna era malsicura, si raccoglieva dentro le cave riposte ed insidiose e si annidava nelle inaccessibili pareti, chiudendovisi nei momenti del pericolo; quivi essa abitò dal VI fin verso il XII secolo, menando vita grama e stentata, dedita all’agricoltura, alla pastorizia ed in date occasioni forse anche alle rapine. Né ho difficoltà a credere che questi trogloditi fossero discendenti, come gli odierni modicani abitanti nelle grotte del quartiere della Vignazza, dagli antichi Siculi, dimostrando il tipo antropologico vivente, come buona parte della popolazione attuale dell’interno, e soprattutto delle montagne del sud-est dell’isola, abbia conservato i caratteri fisici e craniali dell’antichissima stirpe preellenica. Nell’interno, sotto Greci, Romani, e anche dopo, i Siculi viventi fuori delle rare città, nella campagna, rimasero attaccati alle loro rupi, alle loro cave; e se subirono superficialmente l’influenza delle maggiori civiltà, quelli delle aspre montagne rimasero sempre una razza semibarbara e inferiore” (omissis).”
__________________________________________________________ L’Orsi, contemporaneo e quasi conterraneo del Lombroso, l’Orsi che non omette mai nei suoi scritti di evidenziare la superiore civiltà dei Greci, che non riconosce ai “barbari” siculi la capacità di scalpellare nella roccia delle carraie dove far transitare agevolmente dei carri o di levigare degli ossi per farne ornamento od altro, poteva esprimersi diversamente?
5
__2__
L’ “ACQUEDOTTO” GRECO Da: P. Orsi- MOLINELLO PRESSO AUGUSTA,
III. Periegesi archeologica, estratto dalle Notizie degli Scavi,1902.
“Prima di lasciare la enigmatica Timpa Ddieri, attorno alla quale l’archeologo potrà ancora a lungo studiare, rimasi fortemente colpito dalla presenza in essa di un manufatto, che porta netta l’impronta di una gente e di una età diversa da tutto il resto; in tre punti diversi del villaggio ed a piccoli dislivelli notai tre brani o tratti di un bellissimo acquedotto in galleria, che alla sagoma fortemente trapezia ed al taglio accurato non esitai a riconoscere per greco.
La luce fino alla linea di interramento era di cm. 86x35x68, ed ogni tratto di galleria, del percorso di m. 6 a 10, finiva in una parete verticale, cioè erano gallerie cieche; in altri termini trattasi di ripetuti tentativi non riusciti, o per errori di livello, o per difficoltà tecniche nel collegare i vari tronchi iniziati. In uno di essi scavai una quantità di avanzi ceramici del III e II secolo, i quali sembrano precisare l’epoca dell’opera. Ma come mai e perché artefici greci si aggrapparono lassù, tentando e poi abbandonando un sì arduo lavoro? Sono poco o punto studiate le installazioni idrauliche greche, così delle città come della campagna in Sicilia; e se ad esse fossero rivolte accurate indagini, come quelle dei Francesi per le analoghe opere romane in Tunisia, si vedrebbe con quanto amore intesero i Greci a fornire non solo le città di acque potabili, ma anche le campagne di irrigatorie. A Timpa Ddieri si tentò di raccogliere e incanalare una massa d’acqua, prendendola più a monte, probabilmente presso l’attuale masseria Valletta (un buon chilometro più ad ovest), dove oggi ancora l’acqua, che sgorga abbondante dal suolo cretoso, è raccolta in fontane. Si cercò dunque di convogliare abbasso una massa d’acqua, destinata non sappiam bene, se ad irrigare un predio, una villa, un rus, o ad alimentare una città (e la luce dell’acquedotto sarebbe più che sufficiente); la quale, dove fosse e come si denominasse, è davvero misterioso, perché Xiphonia e Megara erano nel III sec. se non estinte, ridotte a umili borghi; se non sia Stiela o Kalauria, sulla cui precisa ubicazione, malgrado i tentativi fatti, nulla di preciso ancora ne consta. Preferisco adunque pensare a qualche grossa fattoria o tenuta nel corso inferiore del Molinello (Damyrias), confortato dalle assicurazioni della mia guida che affermava, avanzi di antico acquedotto in muratura, esistere anche più a valle; segno che falliti i trafori nella roccia, i tentativi vennero ripresi con miglior successo, segnando all’acquedotto un altro tracciato, che io non ebbi tempo di ricercare negli anfratti del monte scosceso e pericoloso.
6
Attribuisco tale impianto idrico ai tempi di Ierone II, sotto il quale, per mezzo secolo, il piccolo stato di Siracusa godette di molta prosperità e vi fu in fiore l’agricoltura; allora, come oggi per la coltura dei giardini, si cercò di sfruttare le abbondanti acque della vallata del Damyrias, impedendone la dispersione”. _____________________________________________________________________
Non possiamo non sottolineare che sia lo Strazzulla che l’Orsi errarono nello interpretare il cunicolo come un acquedotto greco. Si tratta in effetti di un “camminamento” che unisce alcune grotte del villaggio rupestre, quelle almeno più grandi ed appariscenti. Lungo il tracciato del cunicolo si notano, dalla parte del burrone, delle canalette di scolo dell’ acqua piovana che senza alcun dubbio doveva invadere il condotto rendendolo impraticabile.
Ancora oggi esiste, ad ovest della cinta fortificata e lontana da questa circa un chilometro, una sorgente che sgorga tra le calcareniti e le argille giallo-azzurre pleistoceniche, ma si tratta di poca acqua, utile tutt’al più a rifornire un abbeveratoio, e non abbastanza abbondante da aver bisogno per il suo trasporto di una canalizzazione della portata indicata dall’ Orsi.
____3__
I LUOGHI
A chi percorre la strada provinciale Augusta-Villasmundo, superato il ponte sulla statale 114, è possibile immettersi sulla sinistra, dopo circa un chilometro, su una strada carreggiabile con fondo in macadam, la quale costeggia la masseria Petraro ed alcune cave di pietra. La strada, dopo un breve tratto in piano, seguendo la naturale pendenza del terreno si dirige a sudest verso valle per una serie di tornanti fino a raggiungere la riva sinistra del fiume Mulinello, dove si interrompe.
In prossimità della omonima masseria, l’area archeologica del Petraro (in cui si trovano le strutture e da cui provengono i materiali presentati in questa nota), confina a sud con la parete che quasi perpendicolarmente si affaccia su un’ansa a gomito del fiume da una altezza di circa 100 metri; lì, nella vallata, la vegetazione, ed il gorgoglio della pochissima acqua, alla quale gli impianti intercettori della grande industria che opera a valle talvolta permettono di scorrere verso il mare, evidenziano l’esistenza di un micro - ecosistema di ineffabile bellezza, dove la macchia mediterranea, in cui prevalgono l’ulivo, il carrubo, il rovo delle more ed il cappero, fa da cornice ai giardini di agrumi.
7
Sulla vallata si affacciava, alcune migliaia di anni addietro (circa 4.000/ 3.500 anni fa), un villaggio fortificato fiorito nell’età del Bronzo Antico, del quale rimangono, abbandonate au ravages du temps, delle strutture in pietra facenti parte di una cortina muraria preistorica.
Oggi quasi tutto il Petraro funge da cava di pietre; la c.d. cinta fortificata castellucciana, assediata da profonde cave, si è ridotta a convivere e a sopravvivere con e in un contesto paesaggistico che è lo specchio di un degrado inarrestabile, ed il visitatore, qualora una valorizzazione della località archeologica ne sollecitasse l’interesse e ne facilitasse l’accesso, stenterebbe a capire e ad accettare i motivi del vistoso degrado.
La contrada Petraro, una antica spianata di abrasione marina secondo Bordonaro ed Altri (1984), i cui confini sono definibili sul riquadro identificato dal WB116235 della carta IGM 25.000, BRUCOLI, foglio 274, IV NE- è, a conferma del toponimo, un’arida piatta pietraia di calcari pre-pliocenici, alta sul livello del mare poco meno di 150 metri, delimitata a nord dalla ruotabile Augusta-Villasmundo e a sud dal fiume Mulinello; ad ovest confina con le terre dell’ex feudo S. Giuliano e con la tenuta Mandre, mentre ad est viene delimitata dalla statale 114 Catania-Siracusa. Nella parete a picco, la c.d. Timpa Ddieri, si aprono a varie altezze decine di grotte in parte naturali ed in parte adattate dall’uomo ad abitazione o a luoghi di sepoltura, le quali sono collegate da impervi camminamenti naturali e da scalinate intagliate nella roccia, e da quell’altro più esteso e razionale camminamento, che Paolo Orsi interpretò, come abbiamo scritto più sopra, come acquedotto greco.
Del Petraro si conosceva, fino al 1959, quello che ne avevano scritto l’Houel, l’Orsi, l’Holm, lo Strazzulla e pochi altri in relazione all’ esistenza nell’alta parete, la Timpa, di una nutrita serie di grotte sia di abitazione che funebri, la cui spettacolarità aveva richiamato l’attenzione del viaggiatore e dello studioso; la più antica presenza abitativa in zona era stata segnalata dall’Orsi, il quale aveva notato sia all’ interno delle grotte che lungo il camminamento, la presenza di frammenti di ceramica greca di terzo e secondo secolo a.C.
Nella primavera del 1959 una fortunata circostanza ci portò sul Petraro, dove apparve evidente una frequentazione molto più antica di quella vista dall’Orsi: in superficie e per una vastissima area si notavano frammenti di selce, nei quali si riconoscevano strumenti interi o frammentari, frammenti di rozza ceramica d’impasto e ancora numerose asce e macine di basalto, intere e frammentarie. Inoltre, un tratto dell’area da noi esplorata evidenziava la presenza di numerose buche scavate nella roccia calcarea, di varia forma e grandezza, comunque circolari o ellissoidali, mai poligonali, concentrate in maggior parte in un tratto di terreno interessato dalla presenza di alcuni cumuli di pietre, ma presenti, sebbene in minor numero, anche lontano da tali cumuli.
8
Su un più vasto raggio si aprivano nella parete calcarea, lì dove le condizioni delle falesie più o meno alte lo permettevano, numerose tombe a grotticella artificiale.
Un fatto inusitato era rappresentato dagli ammassi di pietre, disposti lungo un regolare e razionale tracciato: un tratto, quello più lungo, si svolgeva nel senso est-ovest, impostato sui margini di un basso gradino morfologico che delimitava naturalmente una ristretta area, mentre ad est e ad ovest due brevi bretelle intuibili nelle macerie sembravano raggiungere i margini dello strapiombo. Questi elementi, sottoposti all’ attenzione del prof. Luigi Bernabò Brea, dovevano portare più tardi, per i rilievi dell’Istituto di Archeologia dell’Università di Firenze, ad una più organizzata ed esaustiva esplorazione della struttura.
__4__
LA CINTA FORTIFICATA Da: ATTI DEL II CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI SULLA
SICILIA ANTICA, in Kokalos, XIV-XV 1968-1969. (Intervento di G. Voza).
“Il villaggio occupa un’area che ha una estensione di circa 2500 mq. e che ha una forma presso a poco trapezoidale. Esso su tutto il lato sud è protetto naturalmente dalla parete rocciosa che cade quasi a picco sul Mulinello e credo che nessuna opera di difesa dovette essere approntata dall’uomo su quel lato.
Della parte occidentale del muro di fortificazione è conservata solo parte della cortina esterna che ha, precisamente, andamento nord-est/ sud-ovest, una lunghezza di circa 30 metri, ed è interrotta per qualche metro in due punti. Una torre semicircolare, avente il diametro di circa 15 metri, si trova all’inizio del lato nord, partendo da ovest. Essa ha forma di tronco di cono molto schiacciato (la sua altezza massima non supera i due metri) ed è costituita da due serie, pressoché concentriche, di blocchi molto irregolarmente squadrati. Una di esse è posta alla base della torre, l’altra a metà circa del suo sviluppo. Le fasce abbracciate dalle due serie di blocchi sono coperte da una compatta massicciata di pietrame informe, in funzione di materiale di riempimento.
Questa torre, in base agli accertamenti che si sono eseguiti nel punto in cui si connette con la cortina esterna del muro di fortificazione, risulta addossata e non collegata con quest’ ultimo. 25 metri ad est di questa prima torre se ne incontra un’altra. Nello spazio fra l’una e l’altra si segue con chiarezza lo sviluppo della cortina esterna del muro e, in un punto, anche un
9
breve tratto della cortina interna, cosa che ha permesso di rilevare anche la larghezza del muro: m. 1,20-1,50. Inoltre, sempre lungo il tratto di muro che si sviluppa tra la prima e la seconda torre, si è messa in luce un’opera avanzata che definirei un torrioncino, ad est del quale si coglie lo sviluppo di una cortina chiaramente addossata al muro originario.
La seconda torre presenta le medesime caratteristiche strutturali della prima: è, cioè, semicircolare in pianta, con ossatura costituita da due serie concentriche di blocchi che abbracciano fasce coperte da fitta massicciata di pietrame informe. Anche le strutture di questa torre non si innestano ma si addossano alla cortina esterna del muro di fortificazione. In questa parte centrale del suo sviluppo si è potuto esaminare il piano roccioso su cui è direttamente impostato il muro, immediatamente a sud o al di sotto di esso. Si è potuto constatare che la roccia è tempestata da un gran numero di fori circolari artificiali di varie dimensioni, certamente in relazione con l’abitato che in epoca neolitica si stabilì nella zona. Pochi metri dopo la seconda torre il muro di fortificazione piega decisamente verso sud-est, punto in cui è conservato un tratto di cortina muraria chiaramente aggiunta all’originaria; raggiunge poi il punto in cui il piano roccioso fa un salto e, dopo una soluzione di continuità, arriva quasi a toccare il limite sud dell’area del villaggio, cioè a lambire la balza rocciosa.
E’ probabile che una terza torre sia nell’angolo nord-est del muro, in una zona nella quale non si sono ancora estese le opere di scavo”.
__5__
LE PRIME RICERCHE SUL PETRARO
Buona parte dei materiali litici provenienti dal Petraro di Villasmundo e da noi proposti in questo od in altri lavori (RUSSO et Alii, 1996), sono stati recuperati in superficie. Si può affermare che la riscoperta del Petraro preistorico nella sua reale estensione ed organizzazione sia stata possibile proprio per la presenza, in superficie, di una notevole quantità di materiali litici (selci, diaspri, quarziti, elementi in calcare siliceo, ossidiana, basalti, etc.), nei quali è stato possibile identificare forme la cui tipologia era già nota dai panorami castellucciano e stentinelliano della Sicilia sud-orientale. Pochi, invece, e fortemente deteriorati, i reperti fittili provenienti dalla superficie.
Il discorso può essere meglio precisato: più che la notevole quantità dei materiali litici, è stata la loro varietà che ha permesso di confermare e consolidare i dati conoscitivi di cui già si disponeva circa la tipologia dell’ industria litica del Bronzo Antico e del Neolitico Arcaico rilevata nell’area
10
siracusana. Alcuni saggi esplorativi preliminari, da noi eseguiti all’interno dell’area protetta dalla struttura muraria, ed all’ esterno della stessa, dei quali diremo più avanti, confermavano comunque le impressioni che erano emerse da una sommaria analisi tipologica dei primi ritrovamenti in superficie.
Materiali rinvenuti ad una notevole distanza dall’area recintata confermano anche che il villaggio preistorico castellucciano del Petraro di Villasmundo si estendeva su una superficie più vasta di quella fino ad oggi ritenuta come la vera area del villaggio; la giacitura di tali materiali su aree piane, forse mai soggette a traumi provocati dall’aratro o dalla vanga, ma da sempre note come aree da pascolo, per cui se ne può escludere la provenienza, per il fenomeno della dispersione, da un più lontano ipotetico centro originario, suggerisce l’esistenza di una organizzazione abitativa sparsa su vasto raggio, rappresentata da isolate abitazioni, comunque collegata ad un nucleo abitativo centrale.
E’ possibile ipotizzare che la presenza preistorica abbia impegnato, a cominciare dal Neolitico a ceramiche impresse e incise e per tutto il Bronzo antico, più di mezzo milione di metri quadrati di territorio, sia ad est che ad ovest dell’area impegnata dalla cinta muraria; a nord della cinta e per largo tratto la presenza castellucciana è anche nota, sebbene meno consistente, per alcune tombe a grotticella artificiale apparentemente smembrate dal contesto castellucciano che gravita attorno alla cinta, ma anche per la consistente presenza di elementi litici, tra cui una notevole quantità di strumenti di basalto, interi o frammentari.
__6__
I SAGGI DI SCAVO All’interno dell’area recintata dal muro fortificata abbiamo eseguito tre saggi di scavo, che abbiamo numerato da 1 a 3.
La prima trincea (n. 1), la quale fu aperta quasi per caso, fu iniziata ai margini dello strapiombo su un terreno notevolmente inclinato la cui copertura umica non raggiungeva i cinque centimetri di potenza; era stato notato qualche frammento di ceramica la quale, almeno per l’ impasto, poteva essere attribuita alla c.d. cultura castellucciana, e si decise di saggiare il terreno.
Dapprima fu la ceramica a rivelarsi, per pochi frustoli, frammista a poche schegge di selce: si era quasi sull’orlo dello strapiombo che dà sul Mulinello, su un terreno dall’accentuato pendìo, ed appariva evidente, dalla composizione della terra, che i materiali erano lì giunti per naturale smottamento. Questa circostanza lasciò supporre che nella parte più alta,
11
dove il pendìo del terrazzo, o in ogni caso della terra, era meno accentuato, era possibile incontrare degli strati in posto, i quali avrebbero permesso di rilevare una definibile e attendibile stratigrafia.
Abbandonando l’idea di utilizzare una fronte larga due metri, fu deciso per una trincea larga ca. un metro e profonda tre. Man mano che lo scavo avanzava verso la parte superiore della spianata, e la potenza del terreno aumentava sensibilmente, veniva a delinearsi una stratigrafia perfettamente leggibile, la quale metteva in evidenza come a un complesso e caotico strato superficiale, seguivano altri strati perfettamente conservati, la cui lettura indicava un castellucciano classico, sovrapposto ad un Neolitico Arcaico a ceramiche incise e impresse attribuibili, per la sintassi decorativa, alla fase culturale stentinelliana.
In complesso, fu possibile evidenziare almeno cinque strati: - I Terreno umico sub aereo, con notevole presenza di elementi
calcarei. Macine ed asce di basalto; rara ceramica castellucciana fortemente abrasa; industria litica su selce e pochissima ossidiana.
- II Terreno umico, dalla potenza di una decina di centimetri, frammisto a ciottoli calcarei; infiltrazioni di industria litica su selce e quarzite, e di frammenti di ceramica castellucciana, inornata per abrasione e corrosione; assenza di ossidiana.
- III Terreno umico, dalla potenza di ca. 20 cm, frammisto ad elementi calcarei. Industria litica su selce e quarzite; ceramica castellucciana anch’essa inornata tranne pochissimi frammenti; ossi a globuli, rifiuti dei pasti; denti di Equus e Capra. Rari manufatti di basalto; rarissima ossidiana.
- IV Terreno umico, dalla potenza di ca. 10 cm con elementi calcarei. Infiltrazioni di ceramica castellucciana (rara); rara presenza di ceramica incisa e impressa stentinelliana; industria litica su selce e ossidiana.
- V- Terreno umico, dalla potenza variabile da 10 a 25 cm a seconda che nella roccia di base si trovassero o meno asperità naturali. Buche per palificazione. Notevole la presenza di ciottoli calcarei, in modo più consistente a livello della roccia di base e all’interno delle buche, dove era possibile isolare quelle servite per rincalzare i pali. Industria litica su selce e ossidiana; ceramica incisa, impressa ed excisa della cultura di Stentinello; rifiuti dei pasti, con Capra. Frammenti ossei, anche bruciati. All’interno delle buche circolari e variamente profonde, ceramica neolitica stentinelliana, rifiuti dei pasti con ossa anche bruciate, industria litica su selce e ossidiana. Rarissimi manufatti, anche frammentari, di basalto.
Nelle trincee 2 e 3, aperte a destra e a sinistra della 1, entrambe delle dimensioni di metri 1 x 2, si notavano le medesime condizioni stratigrafiche notate nella prima trincea. La potenza dello strato umico, compatibilmente
12
con le asperità della platea rocciosa, si manteneva costante, allo stesso modo della presenza delle buche per pali, le quali anche qui si evidenziavano per la varietà nella larghezza e nella profondità. Nella occasione, ed in attesa di più estese prospezioni, le buche non furono rilevate in pianta, ma dall’insieme era già possibile ipotizzare delle strutture abitative dalla forma poligonale molto irregolare, così come ne furono poi viste sul territorio neolitico a nord di Siracusa (Stentinello, Cozzo del Monaco, Gisira, Punta Tonnara, Brucoli).
__7__
BUCHE PER PALI E ABITAZIONI
Si sa, per numerosi esempi, che il popolo castellucciano costruiva capanne dalla forma sub-circolare; talvolta, come in Gisira 3 di Brucoli, il disegno era perfettamente circolare.
La “casa” castellucciana era in effetti una struttura elementare: in presenza di terreni rocciosi, si scavavano delle buche dove venivano allocati dei pali di legno, i quali venivano fissati con pietre; è da presumere che in terreni non rocciosi i pali venissero piantati nella terra. Le pareti erano molto probabilmente costituite da muri a secco, impostati sui pali laterali (la cui struttura, a prescindere dai ritrovamenti di Thapsos, che riguardano già il Bronzo Medio, comunque ci è sconosciuta nella sua interezza), mentre la copertura era probabilmente composta da incannucciate intonacate con argilla, o da pelli di animali.
Tale tipo di tecnica costruttiva ha origini più antiche. Nell’area siracusana, la struttura abitativa realizzata con pali di legno è già presente nel Neolitico. A Punta Bonico, nell’area di nordest di Gisira di Brucoli, dove l’elemento neolitico costruiva capanne con pali di legno piantati in buche scavate nella tenera roccia calcarea, sono stati rinvenuti frammenti di argilla utilizzata per intonacare le incannucciate (RUSSO et Alii, 1995); ma le capanne neolitiche presentano una struttura poligonale talvolta molto irregolare. Nella successiva Età del Rame, sempre in Gisira, la casa, realizzata sempre a struttura portante con pali di legno, è ormai perfettamente rettangolare e di maggiori dimensioni (SPIGO, 1984-85); qui si nota inoltre che i vari ambienti sono collegati l’uno all’altro.
E’ stato ipotizzato che l’evoluzione della casa verso la forma circolare o ellissoidale sarebbe da connettere, molto probabilmente, all’ arrivo in Sicilia di nuovi popoli le cui tecniche costruttive divergevano da quelle neolitiche e da quelle della primissima età dei metalli. Infatti, nessun confronto può essere fatto tra le strutture neolitiche di Punta Bonico e quelle dell’Età del
13
Rame sul Banco, nel settore nord di Gisira, con quelle della successiva età del Bronzo Antico nel settore sud della stessa area. Qui le capanne si sviluppano su un disegno perfettamente circolare.
Sul Petraro di Villasmundo sembrano affollarsi, sulla stessa area, buche riferibili sia al Bronzo Iniziale che al più antico Neolitico; dei rilievi definitivi comunque non sono ancora disponibili. Non è da escludere che anche l’uomo dell’Età del Rame del Petraro abbia scavato, come quello di Gisira, buche per palificazione; ma non è neppure da escludere l’ utilizzo, da parte di questa Cultura, delle preesistenti buche neolitiche, oppure delle grotte e solo di esse.
L’ipotesi che anche le capanne castellucciane del Petraro abbiano potuto avere una forma sub-circolare, è suffragata dalla presenza di sistemi di buche che richiamano, seppur debolmente, a tale forma. Ma rimane sempre il dubbio che l’elemento castellucciano possa aver utilizzato delle preesistenti buche neolitiche, e probabilmente solo queste. Infatti, le strutture rilevate al Petraro non possono essere confrontate con quelle castellucciane di Gisira 3; qui il disegno sembra essere stato eseguito con un compasso.
Attinenti ad una trincea costruita con pali di legno, sono da ritenere numerose buche di varia forma, profondità e larghezza che si sviluppano disordinatamente accanto e talvolta al di sotto della cinta muraria castellucciana, e che possono essere attribuite al Neolitico. Tale tipo di trincea non trova riscontri nell’area provinciale, dove le trincee, come è stato possibile rilevare a Stentinello, a Mégara Hyblaea e a Matrensa, furono scavate sia nella terra che nella roccia.
.
__8__
I MATERIALI Selce, ossidiana, quarzite La materia prima utilizzata è prevalentemente la selce, nei colori bruno, grigio, avana chiaro, bianco-crema. Nei livelli superficiali ed in quelli castellucciani si osserva una debole presenza di quarzite, mentre l’ossidiana, debolmente presente in superficie, nei livelli castellucciani sembrerebbe assente. I livelli neolitici registrano all’opposto una forte presenza di ossidiana, mentre vi mancherebbe la quarzite.
Il calcare siliceo, ben rappresentato nei livelli castellucciani, in quelli neolitici annovera pochissimi elementi, ma elementi in diaspro sanguigno, presenti nei livelli neolitici, sembrano mancare in quelli del Bronzo Antico.
14
Si osservano nell’industria litica del Petraro di Villasmundo strumenti ricavati da supporti essenzialmente laminari, sia che si tratti di elementi provenienti dai livelli neolitici che da quelli castellucciani; in entrambe le culture gli elementi ricavati da schegge non laminari si notano con pari scarsa frequenza, ma l’industria proveniente dai livelli neolitici si presenta tipometricamente più piccola di quella castellucciana. Tale condizione avrebbe la sua origine nei diversi tipi di nuclei utilizzati dalle due entità culturali presenti sul Petraro: mentre l’elemento castellucciano avrebbe utilizzato in prevalenza nuclei tratti da liste e arnioni di selce, reperibili presumibilmente nell’area iblea, nel Neolitico, pur non trascurandosi il rifornimento di materia prima da tale area, la maggiore attenzione sarebbe stata rivolta ai piccoli ciottoli selciferi presenti lungo i fiumi ed i torrenti, dove arnioni di buona selce erano reperibili con estrema facilità. Notare, in proposito, che tutta la selce utilizzata negli insediamenti neolitici di Gisira, Brucoli e Punta Tonnara proviene proprio dai corsi d’acqua o dalle spiagge del mare, mentre Mégara Hyblaea e Stentinello utilizzavano la selce prevalentemente iblea o in ogni caso proveniente da strati selciferi delle formazioni calcaree locali.
Che l’elemento castellucciano del Petraro abbia potuto attingere anche alla selce iblea è evidenziato da una nota dei geologi S. Chilardi e A. Gilotti, i quali, analizzando un frammento di selce laminare proveniente dai livelli aceramici del Vallone Maccaudo, vi hanno visto una componente faunistica a macroforaminiferi immersi in gel siliceo (la cui origine è da cercarsi nei giacimenti selciferi di Licodia Eubea e Monterosso Almo), confrontabile con analoga componente faunistica rilevata in un frammento di selce del Petraro, recuperato in superficie.
Riportiamo parte della relazione dei due geologi: “...Il campione presenta una tipica associazione faunistica del Terziario
inferiore riferibile ad un ambiente di mare basso, caldo, e con un elevato idrodinamismo (condizioni tipiche delle scogliere)...i generi individuati sono: NUMMULITES sp. (si notano le spesse pareti a struttura fibrosa raggiata con fibre disposte perpendicolarmente alla parete del guscio); DISCOCYCLINA sp. (si notano le camere equatoriali con la sovrapposizione irregolare delle camere secondarie); ASSILINA (frammenti?). Questa associazione faunistica ha una collocazione stratigrafica che va dal Paleocene all’Eocene medio...
Il campione, vista la componente faunistica, la collocazione stratigrafica ed il materiale costituente (macroforaminiferi immersi in gel siliceo) potrebbe appartenere alla parte superiore della Formazione Amerillo (Cretaceo - Eocene medio), affiorante a Licodia Eubea (contrada Boschetto) e nei pressi di Monterosso Almo...”
Per il rifornimento di materia prima da giacimenti diversi da quelli iblei, l’elemento castellucciano è possibile che abbia utilizzato, nell’area a nord di Siracusa, una brutta selce bianco- giallastra reperibile in zona, perché
15
presente in forma lenticolare nei c.d. Calcari a Rudiste esistenti anche a sud di Cozzo Telegrafo, tra Cozzo Porte Rosse e Frandanisi di Sopra.
Come in tutti gli altri insediamenti neolitici dell’area provinciale, anche al Petraro si avverte un notevole consumo di ossidiana.
Come è noto, l’ossidiana è un vetro naturale di origine vulcanica a frattura concoide, di colore grigio tendente al nero, semitrasparente, talvolta con inclusioni di pomice, ed è reperibile in determinate aree geografiche: Ungheria, Sardegna, Lipari, Pantelleria, isola di Melo nell’ Egeo, Turchia, Messico ecc. L’analisi spettrografica degli elementi componenti permette di distinguere i luoghi di provenienza dell’ossidiana e quindi di tracciare delle vere e proprie vie di diffusione commerciale di quel prodotto. L’ossidiana presente sul territorio augustano sembra provenire tutta da Lipari.
Al Petraro i livelli neolitici hanno restituito, assieme alle comuni lame e punte di ossidiana, anche dei segmenti di cerchio di tale materia, i quali, assieme ad uno sparuto numero di segmenti trapezoidali di selce, rappresentano le uniche forme microlitiche geometriche dei livelli neolitici.
Un veloce excursus sui tipi porta a definirne le forme essenziali, quali: - LAME: a sezione triangolare o trapezoidale, talvolta ritoccate su
uno o entrambi i bordi; di norma si rinvengono frammentarie, raramente integre con piano e bulbo di percussione; il loro numero è notevole in entrambe le culture.
- PUNTE: non si registra al Petraro una apprezzabile quantità e varietà di punte, se si prescinde da pochissimi esemplari su supporti a dorso abbattuto nei livelli neolitici, e, nei livelli castellucciani e superficiali, da alcune punte foliate triangolari a ritocco esteso, bifacciali e monofacciali, sessili, e ancora da alcune schegge triangolari, ritoccate marginalmente o non, provenienti anch’esse dai livelli del Bronzo antico.
- BULINI: normalmente laterali su frattura, raramente assiali. - GRATTATOI: in apprezzabile quantità, normalmente frontali
corti, e limitatamente ai livelli castellucciani. - RASCHIATOI: pochi e affatto specializzati, normalmente su
lame e su frammenti laminari, prevalentemente nei livelli castellucciani.
- GEOMETRICI: segmenti di cerchio e rari triangoli nei livelli neolitici; il trapezio, o tranciante trasversale, in tali livelli è attestato da due soli esemplari. Segmenti di cerchio e segmenti trapezoidali nei livelli castellucciani.
- ELEMENTI A DORSO ABBATTUTO: presenza poco significante, per quantità e tipologia, sia nei livelli castellucciani che in quelli neolitici.
- NUCLEI: prevalentemente liste di selce da cava e forme ameboidali nei livelli castellucciani; prevalentemente piccoli nuclei ovoidali fluitati e rare liste da cava in quelli neolitici.
16
Basalto Ponendosi Villasmundo ai margini delle estese colate di lave basaltiche plio-pleistoceniche che caratterizzano l’area a sud della Piana di Catania, il reperimento di tale materia prima non rappresentava un problema per le comunità che si sono susseguite sul vicino Petraro. Sia l’elemento neolitico che quello castellucciano hanno potuto infatti utilizzare ciottoli basaltici di varia grandezza per costruire strumenti, ma mentre nel Bronzo Antico il consumo era notevole, nel Neolitico, almeno per quello che si è potuto dedurre dai saggi di scavo, la produzione di strumenti di basalto era molto limitata. Tale condizione è avvertibile anche nel Neolitico di Punta Bonico, Punta Tonnara e Brucoli.
La notevole quantità di strumenti di basalto recuperati in superficie sul Petraro (ma in minor quantità nei saggi di scavo) ha permesso di ipotizzare un commercio di strumenti basaltici con altre comunità coeve, le quali, evidentemente, devono aver fornito prodotti la cui entità e qualità ci sfugge, se si esclude proprio la selce che in ogni caso doveva essere importata da luoghi relativamente lontani: Licodia Eubea, per esempio, che comunque per il proprio fabbisogno di pietra basaltica poteva attingere alle colare laviche presenti subito ad est di Vizzini.
Si sono recuperati centinaia di martelli, picconi, levigatoi, macine e macinelli, asce levigate e scheggiate, anche a doppio margine attivo, ma anche lame e raschiatoi, su un’estesissima area all’esterno della cinta fortificata, associati ad elementi di selce e di quarzite (minima la presenza di ossidiana in superficie), il che ci ha permesso di ipotizzare che, se l’insediamento neolitico impegnava una minima parte all’interno della cinta fortificata, il villaggio castellucciano doveva estendersi su un più vasto raggio, strutturato su moduli abitativi sparsi e apparentemente disorganizzati, così come suggeriscono le sparse buche per pali di capanna, numericamente poco consistenti quelli a vista, ma alla fine tutti organizzati per rispondere ad un unico centro direzionale rappresentato dall’area chiusa dalla cinta.
Poiché il 99% degli strumenti di basalto provengono dalla superficie, non è stato possibile una sicura attribuzione culturale, ma l’ampia e chiara tipologia, che abbiamo confrontato con quella rilevata nel coevo insediamento di Balate a Francofonte, permette una indubbia preminente attribuzione all’elemento castellucciano.
Notare che il letto ed il greto del sottostante fiume Mulinello conservano numerosi ciottoli basaltici, che lo scorrere millenario delle acque ha levigato, costruendo talvolta forme sfruttate poi dall’uomo.
Altri strumenti litici Dai livelli neolitici:
17
- un frammento di pomice a forma di parallelepipedo, con tutti e sei i lati levigati. Gli angoli superiori sono stati leggermente smussati intenzionalmente. Misure: mm 34x33x12. - un disco di pietra da mola, con la faccia inferiore perfettamente levigata per l’uso, leggermente convessa. Misure: mm 54, ≠ 37.
Dai livelli castellucciani: - un pendaglio in pietra basaltica spezzato a metà, in origine forse
sub-circolare, il quale presenta un foro passante bi- troncoconico. Misure: mm 48, ≠ 15;
- alcune “fuseruole” di argilla, sia discoidali che ovoidali, tutte con foro passante.
- Due frammenti di “corni fittili”.
Industria su osso Dai livelli neolitici:
- n. 5 punte di osso, di cui solo una integra; delle altre quattro si sono recuperate le estremità distali. Tutti e cinque gli elementi non presentano segni decorativi.
Dai livelli castellucciani: - n. 2 “ossi a globuli”, di cui uno spezzato in due frammenti.
Altri materiali di interesse paleontologico Dai livelli neolitici:
- pochi frammenti di scafopode Dentalium (entalis?); - valve di Cardium edulis; - denti di Capra; - corno di Capreolus.
Dai livelli castellucciani: - denti di Equus.
In entrambe le culture, frammenti di ossa, anche combuste.
__9__
INDIZI ENEOLITICI
Provengono da una grotticella ad ampio portello d’ingresso, sita a mezza costa nella Timpa e al di sotto della cinta fortificata, adattata dall’ uomo forse a sepoltura, ma depredata già in antico e svuotata del suo contenuto, alcuni materiali che non esitiamo ad attribuire ad una fase iniziale dell’età del Rame, in ogni caso a cavallo tra il Neolitico a ceramiche impresse e
18
incise e l’età del Bronzo Antico, entrambe le culture presenti sul sovrastante pianoro; trattasi di diciotto frammenti fittili a motivi impressi e incisi, di due strumenti di selce e di un frammento di punta di osso lavorato. Se ne dà una sommaria descrizione:
- frammento distale di una punta, lunga 31 mm, realizzata su diafisi di osso lungo probabilmente di Capra;
- elemento laminare frammentario di selce, finemente e fittamente seghettato in un bordo, sì da potervi riconoscere un c.d. elemento di falce. Lu. mm 37, La. mm 23 ;
- frammento distale di una punta di selce, ritoccata su ambo i lati con ritocco profondo semierto e continuo. Lu. mm 32, La. mm 10;
I frammenti fittili, tra i quali si osservano elementi appartenenti ad un vaso carenato, sono tutti decorati con motivi incisi essenzialmente lineari, dritti o spezzati, a fasci o a coppie parallele; in tre frammenti si osservano anche coppie o fasci di linee a zig-zag, ed in due una serie lineare di punti impressi, in un caso adiacenti ad una linea incisa singola.
E’ presente in un frammento il motivo a denti di lupo tratteggiati a graticcio, mentre in un altro la decorazione incisa si esprime con un fascio di linee, orizzontali all’esterno e verticali all’interno, che campiscono una larga banda risparmiata ad angolo acuto.
Assente invece la decorazione eseguita con rotella e cordicella, o quella nota come decorazione cardiale.
Da un piccolo saggio ad est della cinta fortificata e all’esterno della stessa, provengono due frammenti di bordi di vasi, entrambi carenati e decorati con due linee sub-parallele orizzontali profondamente incise. La forma ed i motivi, come pure l’impasto dell’argilla, sono in effetti estranei alle culture che sul Petraro sono fortemente radicate, quella neolitica a ceramiche impresse ed incise, e quella castellucciana nella sua facies sud-orientale.
A circa un chilometro a sud-ovest del Petraro, in località Mandre è stata rilevata la presenza di una piccola necropoli attribuibile all’Età del Rame; l’eneolitico è testimoniato anche da frammenti fittili di colore grigio-scuro, buccheroide, con sobri motivi incisi, probabilmente realizzati a stecca, che si rinvengono nei pressi e al di sotto delle tombe, anch’ esse svuotate in antico, ed anche esse ad ampia apertura d’ingresso realizzata ad arco. La presenza di agrumeti, ed oggi la massiccia presenza antropica, impediscono una indagine più estesa dell’ area interessata da tali indizi, i quali sono pochi e quindi insufficienti per una più esaustiva chiarificazione archeologica della località. Nei pressi si nota una sorgente d’acqua che scaturisce dalla roccia, forse la stessa segnalata dall’Orsi nella sua Periegesi e da lui connessa al c.d. acquedotto greco.
19
__10__
MICROLITISMO GEOMETRICO
Nelle fasi preistoriche post-glaciali del territorio a nord di Siracusa, si osserva la presenza di un particolare strumentario microlitico geometrico, in cui ricorrono le seguenti forme:
- triangolo - segmento di cerchio, o semilunato - trapezio, o tranciante trasversale - segmento trapezoidale. Il triangolo è presente nel Vallone Maccaudo, unico sito mesolitico del
territorio provinciale che ha fornito un consistente numero di esemplari, sia scaleni ed isosceli che rettangoli. Associato al triangolo, e ad esso numericamente superiore, è, sempre all’ interno del Maccaudo, il segmento di cerchio, il quale si conserva anche nella successiva fase neolitica a ceramiche impresse e incise. Negli strati neolitici del Maccaudo il triangolo scompare, ma, numericamente poco rappresentativo, compare il trapezio.
E’ nel Neolitico di Punta Bonìco in Gisira, in quello di Cozzo Telegrafo, di Punta Tonnara e di Campolato sud che il tranciante trasversale si presenta in un apprezzabile numero di esemplari, talvolta dalle dimensioni notevolmente ridotte; in Gisira e sul Cozzo Telegrafo lo strumento è associato ad un altro microlito, il microbulino, che è lo scarto della lavorazione della selce per la produzione di microliti geometrici.
Tale varietà di microlitismo geometrico è assente nel villaggio di Vallone Amara nord, dove tuttavia si osserva la presenza di rari triangoli. Altro microlito geometrico, il segmento trapezoidale, sembra essere peculiare di alcuni insediamenti castellucciani del territorio provinciale, talvolta associato al segmento di cerchio in una forma prevalentemente semilunata.
Peculiari dell’insediamento castellucciano del Petraro sono i segmenti di cerchio ed i segmenti trapezoidali, i quali sono stati rinvenuti in apprezzabile quantità sia in superficie che nei saggi stratigrafici. I livelli neolitici hanno invece restituito segmenti di cerchio associati a trapezi, nella tipica forma detta a tranciante trasversale.
All’esterno della cinta fortificata, in un saggio che ha restituito materiali attribuibili all’età del Rame, associato ad elementi semilunati è presente il trapezio, sia isoscele che scaleno. Significativa è, in tale strato, la presenza di una piccola punta a dorso abbattuto, elemento questo tipico delle culture del paleolitico superiore ed in quelle di tradizione paleolitica.
Il segmento trapezoidale si rinviene a Castelluccio di Noto, insediamento eponimo della cultura, e, a nord di Siracusa, nella contrada Piana della Catena a Lentini, in Arcile di Augusta, in contrada Balate, territorio di Francofonte, dove è associato al semilunato, e al Petraro di Villasmundo, anche qui associato al semilunato. In contrada Piana della Catena è
20
fortemente rappresentata la cuspide di freccia bifacciale, sessile, elemento questo scarsamente rappresentato al Petraro, dove viene sostituito da rozze punte, ritoccate o non, adatte comunque ad essere immanicate in una asticciola di legno. Del Petraro si conoscono appena tre cuspidi di freccia nella forma canonica foliata, mono e bifacciale
L’uso di alcuni microliti geometrici è tuttora controverso, in ogni caso di difficile interpretazione. Se l’utilizzo del tranciante trasversale, o trapezio, si ritiene ovvio in quanto ritenuto una cuspide che sostituisce la canonica punta sub-triangolare con o senza codolo (in Egitto alcune raffigurazioni parietali evidenziano l’uso di frecce armate di trancianti trasversali, utilizzate nella caccia al leone), non altrettanto ovvio è l’uso dei segmenti trapezoidali, dei segmenti di cerchio e dei triangoli, talvolta visti come elementi accessori sostitutivi delle alette laterali in una freccia armata di una cuspide litica, sia essa a tranciante che a punta.
__11__
GLI “OSSI A GLOBULI” Da: L.Bernabò Brea, LA SICILIA
PRIMA DEI GRECI, 1966. “...Il più importante fra questi (elementi che permettono di stabilire collegamenti con culture fiorite contemporaneamente in altre regioni), è costituito da alcuni singolari oggetti di osso di forma allungata, decorati con una successione di globuli a rilievo e con finissime incisioni sia su di essi che nel campo all’intorno, che D.J. Evans ha recentemente identificato come idoletti estremamente schematizzati. Essi ricorrono con una notevole frequenza nelle tombe di questa civiltà (Età del Bronzo antico – n.d.A.). La sola necropoli di Castelluccio ne ha dato sette, alcuni dei quali per la loro finezza e per la perfetta conservazione sono i migliori esemplari della serie; ma altri esemplari, interi o frammentari, provengono da Cava Lazzaro, dalle Sante Croci, da monte Casale, dalla grotta Masella di Buscemi.
Il grandissimo interesse di questi idoletti, oltre alla estrema finezza della loro lavorazione, che li pone fra le creazioni più perfette dell’artigianato preistorico siciliano, sta nel fatto che altri esemplari quasi identici sono stati trovati anche fuori della Sicilia.
Uno di essi proviene da Malta. Un secondo è stato trovato recentemente a Lerna nel Peloponneso, in strati
degli inizi del Medio Elladico. Altri due, simili, anche se meno accuratamente decorati, sono fra i materiali di Troia II-III.
21
Questi ossi a globuli costituiscono quindi un importante elemento di raccordo cronologico fra la Sicilia, Malta e l’Egeo”.
___________________
La definizione di ossi a globuli, data a quella categoria di caratteristici oggetti di osso che si rinvengono nei livelli del Bronzo antico nell’area centro-orientale mediterranea, si limita ad illustrarne la forma, ma non ne definisce la funzione, la quale ad oggi è dubbia, anzi sconosciuta. Ancora nel 1995 tali prodotti vengono definiti di prestigio. Di destinazione oscura secondo l’Orsi (il quale non escludeva il loro uso per fini pratici della vita domestica, o nei riti funerari), sono sempre stati ritenuti un prodotto di importazione dall’Asia, il che confermerebbe l’esistenza di una corrente commerciale agente dalle coste asiatiche fino sulle sicule (Orsi, 1893).
Alla data del 1996 la letteratura ne elencava 27, provenienti da: - Castelluccio di Noto ............................................... 8 - Area tra Lentini e Carlentini................................ 1 - Grotta S. Lazzaro ................................................... 1 - Canticaglione ......................................................... 1 - Castiglione............................................................. 1 - Serra Paradiso........................................................ 1 - Baravitalla.............................................................. 1 - Sante Croci............................................................. 2 - La Muculufa........................................................... 1 - Monte Casale.......................................................... 1 - Altamura (Puglia) ................................................... 1 - Malta...................................................................... 1 - Lerna (Peloponneso)............................................... 1 - Hissarlik –Troia- (Turchia)..................................... 4 - Petraro di Villasmundo........................................... 2 I due ossi a globuli che rinvenimmo sul Petraro, oggi esposti presso il
Museo Regionale Paolo Orsi di Siracusa, provengono entrambi dal livello castellucciano del saggio n. 1.
In uno, lungo mm 64, a sezione piano-convessa, i globuli, in numero di 9, si presentano rettangolari, l’altro, la cui sezione è concavo - convessa, lungo 69 mm, ne evidenzia 7, circolari. Quest’ ultimo fu rinvenuto spezzato in due frammenti. Entrambi gli ossi non presentano traccia di decorazione, incisa o graffita.
Idoletti fortemente schematizzati li ha definiti J. D. Evans; da altri (O. ADAMO- L’ANTICA ETÀ DEL BRONZO IN ITALIA, 1996) sono stati inclusi tra i pendagli e gli amuleti.
Come per tutte le cose di cui si sconosce l’uso, la fantasia ha soverchiato la ragione e si è arrivati a considerarli placchette per ornare manici di pugnali. Naturalmente non si è tenuto conto che nel periodo castellucciano in Sicilia i pugnali furono in larga misura rozzamente ricavati dalla pietra
22
dura e probabilmente immanicati in supporti di legno e, forse di osso; e che comunque, la grandezza di alcuni ossi a globuli, fortemente ornati, sconsiglia un simile uso in strumenti le cui dimensioni erano per lo più molto limitate.
__12__
LE NECROPOLI Numerose tombe a grotticella artificiale sono sparse in modo disordinato su tutta l’area del Petraro, a gruppi o isolate, aperte sia sul pianoro dove l’esistenza di piccole falesie ne ha permesso la realizzazione, sia lungo la timpa e a varie altezze, alcune facilmente accessibili, altre meno. Ad oggi ne sono state contate, certamente per difetto, una cinquantina, ma un censimento di tutte le tombe che si trovano ai margini della cinta muraria o nelle sue immediate vicinanze, tali da essere connesse al villaggio preistorico, non è stato possibile, per la impraticabilità di larghi tratti della timpa, e considerando che un gruppo, ancora non censito, si trova sui margini settentrionali della strada Augusta-Villasmundo; altre, aperte in un contesto calcarenitico ad est della “cinta fortificata”, sono state distrutte o rese di difficile interpretazione dai crolli che interessano quel tratto di timpa. E ancora, un numero imprecisato di tombe è stato distrutto dalle cave di pietra, sia ad ovest che ad est della cinta muraria.
Sulla fronte ovest di un cocuzzolo calcareo esistente tra il Petraro e contrada Mandre, sono state contate ancora una decina di tombe a grotticella artificiale in un contesto che vede anche la presenza di altrettante tombe a fossa, a sezione trapezoidale, aperte nella platea calcarea. Sul pavimento di una delle tombe a grotticella artificiale è stata scavata una tomba a fossa. Un paio di tombe a fossa si trovano ancora in un piccolo ipogeo polisomo esistente sempre nella falesia occidentale del cocuzzolo.
La pianta delle tombe a grotticella artificiale è normalmente quella circolare, con tetto piatto o leggermente incurvato; solo in una si riconosce una thòlos sul tipo di altre thòloi identificate in ambiente castellucciano nell’area provinciale. Sulla volta della thòlos è stato scalpellato, come in altre thòloi sia castellucciane che più tarde, uno scodellino rovesciato.
Si evidenziano tre diversi tipi di portello d’ingresso: -un tipo, aperto in un piccolo padiglione quadrangolare scavato nella
roccia, è anch’esso di forma quadrangolare, talvolta perfettamente quadrata; da qui si accede ad una anticella ( ), quando presente e normalmente ellittica, o direttamente alla cella funeraria (naòs);
23
-altro tipo è rappresentato da un’apertura ovalizzata, talvolta quasi ellittica, con l’asse maggiore normale al piano di calpestio, aperta anch’essa in un piccolo padiglione quadrangolare leggermente curvilineo;
-il terzo tipo non è in effetti un portello, ma un’ampia apertura quasi sempre semicircolare, larga quanto la maggiore ampiezza della grotticella e variamente alta. Dall’imboccatura il tetto si incurva gradatamente fino a congiungersi col pavimento, che è normalmente sub-circolare. In tale tipo di grotticelle artificiali manca il padiglione di ingresso che a mo’ di caratterizza gli altri tipi. Quest’ultimo tipo può essere attribuito anche ad una fase culturale precedente a quella castellucciana.
Diverso è il portello della thòlos, incorniciato da una serie di tre modanature decrescenti, il quale è perfettamente rettangolare e più ampio di quello delle altre tombe.
Su una tomba a prospetto trilitico, non usuale nell’area castellucciana del Petraro e del più vasto ambito provinciale, se ne riferisce più avanti al § 13.
Il tempo ha alterato o addirittura distrutto alcuni prospetti, ma ad una attenta analisi è stato possibile ricavarne la tipologia, che infine si richiama con larga approssimazione sia ai tipi definiti nella regione castellucciana della Sicilia sud-orientale che alla tipologia sufficientemente nota da più antichi contesti dell’età del Rame nella stessa area. Quest’ultima cultura, presente al di fuori della cinta muraria, si è manifestata, come si è detto più sopra, per pochi ma chiari indizi anche in una tomba a grotticella artificiale, purtroppo violata in epoca imprecisata.
Tutte le tombe dell’area archeologica del Petraro di Villasmundo sono
state manomesse da scavi clandestini già ab antiquo, ma anche in tempi relativamente recenti, almeno quelle poche sfuggite una prima volta alla attività devastatrice degli antichi razziatori di corredi tombali. Su alcuni materiali rinvenuti all’interno e all’esterno di tombe già devastate, dove erano stati dimenticati o abbandonati, se ne riferisce più avanti.
24
__13__ TOMBA CON RILIEVO TRILITICO
Da: G. Cacciaguerra, CNR: TOMBA CON RILIEVO TRILITICO
IN CONTRADA PETRARO (MELILLI, SR), Sicilia Archeologica, a. XXXIII 2000, f. 98.
“Nel 1996 è stata casualmente rinvenuta in Contrada Petraro una tomba a grotticella artificiale, attribuibile al Bronzo Antico, che presenta alcuni elementi architettonici non direttamente confrontabili con le coeve evidenze di architettura funeraria siciliana. Verrà, quindi, presentata una larga serie di confronti per meglio inserirla nel contesto dell’ ipogeismo funerario siciliano e del Mediterraneo centrale.
La tomba è posta in linea d’aria a circa 600 m. a Est dalla cinta fortificata del Bronzo Antico indagata negli anni ’60 (Voza 1968), in un’area caratterizzata da banchi rocciosi digradanti in ripide terrazze verso il fiume Mulinello. La tomba fu scavata sulla parete verticale di una delle balze più basse, oggi parzialmente coperta dalla vegetazione. Essa fu scavata nella roccia calcarea che nella zona si presenta estremamente compatta ma piuttosto fratturata. Ciò ha permesso la conservazione di alcuni particolari architettonici che non si sono potuti conservare in altri contesti a causa del supporto roccioso meno consistente. La tomba al momento della scoperta si presentava con un sottilissimo strato di terra all ’interno della cella. In seguito essa è stata quasi del tutto ripulita del suo contenuto da ignoti, permettendo tuttavia di evidenziare sul pavimento il lettuccio...
... Al di là dei confronti con regioni extra isolane è importante evidenziare il ruolo che tombe monumentali come quella del Petraro hanno rivestito in seno alle società del Bronzo Antico siciliano. In passato è stato più volte ricordato che esse sono la testimonianza del ruolo preminente di alcuni gruppi sociali che utilizzavano l’architettura funeraria per mettere in evidenza il loro status. In quest’ambito assumono importanza alcuni elementi architettonici di origine alloctona utilizzati per questo scopo. Inoltre “(...) la tomba monumentale avrebbe avuto la funzione di marcatrice del territorio (...) Il controllo del territorio era alla base del prestigio sociale di queste élites, ma sembra giocare un ruolo importante anche la capacità di mantenere rapporti con gruppi sociali esterni (...)” (Procelli 1997, pag. 347)...
...Per ciò che riguarda l’inquadramento cronologico della tomba, vi sono notevoli difficoltà, relativamente alle problematiche sopra descritte; tuttavia, è stato notato che nelle fasi tarde del Bronzo Antico l’apporto architettonico maltese diventa un puro elemento decorativo ripetuto in
25
modo schematico e forse inconsapevolmente (Maniscalco 1996, pag. 512). In base a ciò ritengo che sia possibile attribuire la tomba ad una fase iniziale del Bronzo Antico siciliano vista la notevole aderenza al “modello” maltese, e quindi ipotizzare che la sua costruzione sia avvenuta in una fase in cui i contatti con Malta megalitica potevano essere ancora in corso o comunque cronologicamente non molto lontani...
__________________________________________________________________ Ci piace a questo punto riproporre quello che aveva scritto l’Orsi circa il gruppo di tombe che annovera quella a prospetto trilitico descritta dal Cacciaguerra.
“Salendo a ritroso la valle del Molinello, a tratti incassata fra rupi serrate, a tratti un po' aperta per depressione dei ciglioni laterali, ed oltrepassato il Cozzo Ddiero, si arriva ad un gruppetto di tombe sicule, aperte sull’alta fiancata sinistra del fiume, che nulla presentano di speciale, né invitano allo scavo”.
__14__
MATERIALI DALLE TOMBE 16 E 17 Le tombe 16 e 17, aperte sulla fronte di una piccola e bassa falesia esposta a sud, non potute rilevare o fotografare perché invase da una fitta vegetazione, si trovano al di fuori del contesto dell’ area recintata; si presentano accostate, divise da un sottile diaframma e si aprono al livello del piano di campagna. Sono le ultime due tombe, ad est della cinta fortificata, che senza alcun dubbio si possono connettere alla serie di tombe, numerate da 1 a 15, che si aprono ai piedi e nei pressi dell’area centrale del villaggio quale può considerarsi quella recintata.
Le tombe, come tutte le altre, furono trovate vuote, ma i materiali in esse contenuti, una quantità imprecisata di vasi (comunque non meno di una cinquantina e tutti frammentari), furono scaricati all’esterno e lì abbandonati in caotica mistione, coperti nel tempo da un leggero strato di humus. Recuperati fortunosamente, furono depositati presso la Soprintendenza Archeologica di Siracusa.
Gli “scavatori”, certamente in cerca di tesori, omisero di rimaneggiare una piccola “isola” di terra, che trovammo decisamente in posto sul fondo della tomba n. 16 e la cui rimozione portò alla luce due vasetti fittili, uno dei quali intero e l’altro frammentario; qui se ne dà una sommaria descrizione:
26
(a): Tazza - attingitoio monoansata, carenata, collo a profilo concavo, orlo estroflesso, molto assottigliato; ansa a nastro, ad orecchio, impostata e sopraelevata sull’orlo e quindi raccordata alla vasca all’altezza della carena. Decorazione indecifrabile molto evanescente, molto parziale sul collo, apparentemente a sviluppo in linee verticali. Fondo piatto. Diametro dell’orlo: cm 6,4; altezza all’orlo: cm 6.
(b): Brocchetta monoansata, corpo globulare, alto collo tronco -conico rovesciato a profilo rettilineo, orlo molto assottigliato. Ansa indefinibile, probabilmente a nastro e ad orecchio, che si parte dal bordo e, forse, sopraelevata sullo stesso, fino a raccordarsi a metà del corpo. Fondo piatto. Non presenta decorazione alcuna, forse perché eliminata dal tempo. Diametro del bordo, cm 8; altezza all’orlo, cm 10 ca.
All’interno del vaso (a) si trovavano: - una lama di selce chiara, fratturata in due frammenti,
leggermente incurvata verso l’estremità distale; sul margine sinistro si notano numerosi irregolari incavi. Il tallone, liscio, è integro. La sezione è trapezoidale. Lu. mm 102, La. 19, Sp. 4;
- una robusta lama di selce grigio-chiara, dritta, integra, con un bordo corticato. Il tallone, liscio, è integro. La sezione è triangolare. La estremità distale, piatta, è stata assottigliata con l’asportazione in senso longitudinale di una lamella. Lu. mm 88, La. 30, Sp. 10.
Tra i frammenti ceramici provenienti dall’esterno, in uno con frammenti di piccole lame di selce, si sono riconosciute le seguenti forme:
- fruttiera su basso piede. Bacino tronco-conico a profilo rettilineo, su piede tronco-conico a profilo leggermente concavo, cavo all’ interno. Orlo con bordo semipiatto orizzontale. Sul bacino, tre bugne ellittiche impostate verticalmente e simmetricamente. Manca, o a vista non è rilevabile per una forte incrostazione di humus, la eventuale decorazione. orlo cm 29,2; h. orlo cm 14,2; orlo piede cm 15; h. piede cm 5;
- fruttiera su alto piede cavo all’interno. Non disponiamo delle misure del bacino, la cui larghezza all’orlo non doveva essere inferiore a cm 30. Tre anse a nastro, disposte simmetricamente, impostate sul piede e sul bacino. Altezza del piede cm 31, nel punto di impostazione al bacino cm 6,7; orlo piede cm 21. Il profilo è sinuoso: tubolare (cm 9,5 di diametro) nella parte mediale, tende a rastremarsi in quella distale. In basso il profilo è leggermente concavo;
- altra forma riconoscibile è una pignatta, con diametro all’orlo di circa 25 cm, h. ca. 15 cm .
Sconosciamo se la tomba adiacente 17, anch’essa invasa da una fitta vegetazione, mostri ancora spazi che conservino materiali residui abbandonati dagli scavatori nelle passate età, quando la ricerca di tesori nelle antiche necropoli era un hobby esteso a tutte le classi sociali.
27
__15__
ELEMENTI DI CULTO Dell’autore: SU ALCUNI ALTARI PREISTORICI DI PIETRA
LOCALIZZATI NELLA REGIONE CASTELLUCCIANA DELLA SICILIA SUD ORIENTALE,
Archivio Storico Siracusano, III,XIII (1999).
“...Avendo voluto cercare tra le pieghe del tempo e dello spazio archeologico preistorico altri indizi di rituali nei quali si possono confrontare le funzioni che noi abbiamo attribuito ai manufatti di cui discorriamo, abbiamo fermato la nostra attenzione anche sul Petraro del Mulinello, dove la ricerca, per la presenza, non usuale in zona, di una cinta fortificata a torri circolari castellucciana, sovrapposta a strutture pertinenti ad un villaggio neolitico a ceramiche impresse e incise, è particolarmente attiva da alcuni decenni. Lì, ad oggi, non sono emerse strutture come quelle di Gisira ed Interrata. L’unico elemento che sembra attestare un culto, confrontabile con quello praticato nei luoghi predetti, è un tratto di roccia, naturalmente ed irregolarmente piatto così come affiora nello strato di humus, delle dimensioni di circa mt 3x3, in cui sono state scavate quattro buche.
Come il disegno evidenzia, trattasi di buche ellissoidali, variamente grandi e profonde, ma decisamente regolari, le cui dimensioni sono desumibili, in quanto ridotte in scala, dallo stesso disegno, ma che comunque non superano i 75 cm. di lunghezza e i 30 cm. di profondità.
Il tratto roccioso scelto per la loro realizzazione si trova all’ esterno della cinta fortificata, una decina di metri a nord della torre di ovest, comunque scorporato dai sistemi di buche esistenti all’interno ed all’esterno dell’area recintata e pertinenti a capanne neolitiche e castellucciane. E ancora, la loro dislocazione nella platea rocciosa, non sembra aver seguito un disegno, nel senso che non vi si riconoscono intenzionalità per fini a noi sconosciuti; due (A e C) hanno direzione est-ovest, una (D) ha direzione nord-sud e la quarta (B) è inclinata nella direzione nord-est/sud-ovest. Non vi dubbio, comunque, che al Petraro le buche sostituiscano i solchi che in Gisira ed Interrata circoscrivono le “tavole”.
La piattaforma calcarea del Petraro presenta un tratto scalpellato, sagomato a mo’ di gradino, come ad indicare una via d’ accesso al “luogo sacro”. La scalpellatura, corrosa dal tempo, non lascia comunque spazio ad interpretazioni univoche, tanto più che non conosciamo in loco altri esempi da portare a confronto.
Quindi, al Petraro del Mulinello, l’altare, la struttura che noi abbiamo identificato come altare, non possiede le caratteristiche che abbiamo visto in Gisira ed Interrata; l’assenza di tali caratteristiche tuttavia non ci sorprende, ma più ci convince che tale realtà, quella inerente al culto, è più
28
complessa di quanto si possa credere ad un primo e superficiale approccio con il problema. In effetti, una “tavola” o altro elemento previsto da un rituale, non è necessariamente un elemento complesso; si può assumere che un altare, sul quale si sacrifichi, è sostanzialmente il luogo in cui ogni elemento di culto, funzionale al rito, ha un suo posto riconosciuto dalla collettività, simbolico, il luogo dove ogni cosa è osservata e conservata in funzione di una norma trascendente; un gesto, una parola o una frase, ma anche un canto, che sappiano attingere alla lingua del mito arcaico della religione primigenia, rivelata o non, necessitano di poco spazio per sopravvivere nei culti e nei riti, ed anche quando l’altare, il luogo di culto, si amplia e diventa ziqqurat, moschea o cattedrale, il vero altare, il sancta sanctorum, potrà essere una semplice pietra o una tavola....”. ____________
Le strutture di Gisira di Brucoli ed Interrata di Lentini, più sopra richiamate, sono in effetti delle piattaforme risparmiate nella roccia e circoscritte da un solco, sub circolari le due di Gisira e circolare quella di Interrata. In tali strutture, che trovano riscontro per larghi margini nel Medioriente pre cristiano, è possibile vedere degli altari sacrificali, o tavole delle offerte, su cui si sacrificavano gli animali. I solchi in Gisira ed Interrata, e le buche ellissoidali al Petraro (a) di Villasmundo, servivano probabilmente a raccogliere il sangue delle vittime. (a)- Riteniamo di non poter escludere che le buche ellissoidali del Petraro debbano essere considerate pertinenza del villaggio neolitico. In altra occasione, considerato il contesto e la struttura, cercheremo di allegare elementi a confronto.
__16__
“CORNI VOTIVI” DI ARGILLA
Il Petraro di Villasmundo ha restituito tre frammenti fittili che la letteratura archeologica riconosce, per la loro forma, con il nome di “corni votivi”. Si tratta di:
- estremità distale di “corno”, lunga ca. 7 cm, leggermente incurvata e relativamente piatta; - frammento prossimale di “corno”, lungo 10 cm, a sezione circolare, ca. mm 53 alla base, 32 in punta. Da labili indizi, è possibile ipotizzare che il frammento fosse in origine munito di una base probabilmente rotonda, della quale si sconosce comunque la forma esatta.
29
- frammento prossimale di “corno”, lungo 11 cm. ca., sezione circolare in prossimità della base, ellittica nella parte anteriore. Anche in questo frammento, si ipotizza una base rotonda.
I tre frammenti non presentano alcuna decorazione, sia dipinta che incisa o graffita.
Relazionando sugli scavi eseguiti negli scarichi del villaggio di Castelluccio di Noto, Paolo Orsi (Scarichi del villaggio siculo di Castelluccio, B.P.I. a XIX, 1893), così scrive: “Né meno oscure (sono) certe corna fittili (tra interi e rotti sono sette esemplari) ad estremità curva, impostate su di una basetta circolare; l’ esemplare maggiore misura cm 16 in lunghezza, ed un altro mostra una serie di intaccature sull’orlo. Di codeste corna, non nuove negli strati archeologici siculi dell’isola, la destinazione è molto dubbia, ma io propendo a crederle simboli profilattici, niente affatto dissimili dalle grandi corna fittili delle palafitte elvetiche e dalle corna bovine, ancor tanto in uso, con tale significazione, nell’ Italia di mezzo e meridionale”.
Noi non condividiamo tale interpretazione dell’Orsi. I corni che, ancora oggi, sono in uso nell’Italia di mezzo e meridionale come tiene a precisare il grande archeologo, sono vere corna di bue, e le varianti in pietra o in legno ricalcano esattamente la forma delle corna di bue, ovvero il bucranio.
All’opposto, gli oggetti rinvenuti a cominciare dall’età del Rame e per tutto il Bronzo antico negli scarichi dei villaggi, possono essere definite “corna” per approssimazione, non ricalcando affatto la forma delle vere corna bovine anche a riconoscervi una forte stilizzazione.
Riferendoci ad alcune strutture castellucciane nelle quali è possibile identificare degli altari sacrificali preistorici, e delle quali abbiamo fatto cenno più sopra, ma anche a quella del Petraro sebbene diversificata nella forma, così abbiamo scritto nel 1999 con la nota richiamata al § 15:
“Rivolgendo la nostra attenzione alla Bibbia, notiamo come Dio detti norme sul modo di approntare l’altare, sia esso l’altare per gli olocausti (Esodo, XXVII,2) che quello dei profumi (ibid. XXX,2). La norma impone tra l’altro che ai quattro angoli gli altari abbiano dei corni, i c.d. corni di consacrazione. Tali attributi hanno gli altari di tipo cananeo, anche quando i corni, come a Petra in altari tardi, siano due, posti ai lati. Creta conosce l’altare a corni.
Ora, a voler superare il carattere etnico della , in quanto imposta da Dio agli Israeliti per la costruzione degli altari a corni, una connessione è possibile vedere con etnici diversi, se oggi la presenza di altari muniti di corni è attestata per lungo tempo dall’ Irak alla Siria, a Creta, alla Palestina, all’ Egitto.
Che i “corni” siano da connettere proprio ad una religione etnica, quindi all’origine non universale, può, a nostro parere, essere un assunto suscettibile di essere dimostrato; naturalmente con difficoltà mancando esempi eclatanti a sostegno, ed avendo come unico supporto elementi sparsi, di difficile ma non impossibile aggregazione: tra questi, le “tavole di
30
pietra” di cui discorriamo, ma anche i “corni”, che in Sicilia si sono mostrati agli archeologi già nel secolo scorso.
“Corni fittili”, a cominciare dall’età del Rame, sono presenti in Sicilia, ma la loro interpretazione si è mossa sempre nel limbo delle cose di cui “si sa poco”. In assenza di una precisa identificazione chiamati genericamente “corni votivi”, il loro rapporto con elementi di culto derivato da una ben precisa norma religiosa, così come sarebbe pervenuta in Occidente nel III millennio dal Vicino Oriente per varie vie e vicissitudini, sembra che non sia stato preso in considerazione, anche se si sarebbe sempre intuita una stretta correlazione tra i “corni” -o le “corna” come furono dette dall’Orsi, -ed un generico rapporto con la divinità dai corni mediato; questi essendo stati visti, in tal caso, come intenzione di “voto” e non come parte di un tutto (l’altare) prevista da un rituale. E questo anche perché la storia della ricerca archeologica preistorica in Sicilia non ha visto, come si osserva in Ciaceri, rituali preellenici connessi ad una ben identificata “religione”, che non sia quella, spesso naturistica, intravista in alcuni culti siculi, talora fatta propria e snaturata dalla colonizzazione greca; né offre particolari elementi, a valenza metastorica, per i quali si possa risalire al “reperto”, allo strumento per mezzo del quale l’uomo è in grado di far intervenire nella sua esistenza il “dio”.
In verità, lo “strumento” sacro può annidarsi in ogni angolo e, oggi, non essere riconosciuto come tale; né potremmo in effetti riconoscerlo quale parte materiale residua di un rituale complesso, in assenza di elementi, anche minimi, che permettano confronti, o, in ogni caso, ipotesi le quali, come ha scritto il Pais, in archeologia, come le integrazioni, sono necessarie.
I “corni fittili” non sono in effetti dei “prodotti” difficili da interpretare, come lo sono, per esempio, i c.d. ossi a globuli, che si rinvengono un po' dovunque nel Mediterraneo centro-orientale, e sono stati visti una volta come “idoletti fittili”, altra volta come “prodotti di prestigio”. Nessuna connessione certa con la “religione”, con un rito religioso, è stata ipotizzata; la generica definizione di “idoletti fittili” si esaurisce nella convinzione di trovarci , tutto sommato, davanti ad un prodotto di cui “si sa poco”, ma ritenuto, come d’uso, un prodotto della “più evoluta” civiltà mediorientale”. Quindi, ornamenti religiosi imposti da una norma divina, arredi previsti da un culto, semplicemente funzionali ad un rito religioso così come oggi è possibile vedere in ogni religione la quale, attraverso manifestazioni esteriori, ritiene di poter stabilire un contatto con la divinità, e non strumenti profilattici per allontanare il malocchio. Se una sola volta il grande Paolo Orsi avesse dimenticato di considerare i Siculi gente barbara ed inferiore, forse sarebbe pervenuto alla conclusione che anche loro avevano, come i “più evoluti greci”, capacità espressive degne di attenzione, anche in relazione alla loro religione.
31
__17__
LA THÒLOS
Thòlos (θόλος), come noto, è un edificio a cupola o a volta, e si riferisce a quelle strutture le quali, come la celebre tomba da cui proviene il c.d. Tesoro di Atreo a Micene, sono state realizzate con pietre a filari aggettanti. Per estensione, sono considerate thòloi i nuraghe sardi ed i sesi di Pantelleria. Quest’ultime strutture sono state inserite dalla letteratura archeologica tra quelle che caratterizzano il c.d. Megalitismo ridotto mediterraneo.
Thòloi sono considerate in archeologia preistorica tutte quelle tombe a grotticella artificiale e a pianta circolare, la cui camera, scavata nella roccia, si presenta a mo’ di cupola aggettante.
Nella Sicilia preistorica la tomba a thòlos è peculiare dell’età del Bronzo Medio (ved. necropoli di Thàpsos nella penisola di Magnisi, Necropoli del Mulinello, Coste di Gigia in territorio di Melilli, Necropoli di Monte Tauro in contrada Pezza Grande di Augusta, ecc.). La thòlos talvolta è preceduta da un corridoio, o dròmos (, quindi da una anticella; quasi sempre all’interno si trovano una o più nicchie laterali, mentre spesso al centro della cupola è possibile notare un piattino talvolta incassato, talaltra risparmiato nella roccia, come a voler simboleggiare in maniera schematica il foro d’uscita del fumo nel tetto delle capanne che molto probabilmente era a cupola.
Sebbene la tomba a thòlos nella cuspide sud-orientale della Sicilia caratterizzi tutto il Bronzo Medio, è possibile notarla anche in alcune necropoli castellucciane del Bronzo Antico; si tratta, per quanto ci risulta fino ad oggi, di una sola thòlos per ogni insediamento, ma in alcuni insediamenti se ne trovano più di una. Ne è stata notata una a Piana della Catena in territorio di Lentini, un’altra a Roccarazzo, territorio di Francofonte, dove la camera è preceduta da un lungo corridoio, e ancora più di una a Roccadia ad est di Carlentini, una ancora nella spalla sud-occidentale di Gisira di Brucoli (qui il portello d’ingresso presenta una complessa modanatura a tre cornici decrescenti), ancora una, di pregevole fattura, nel Vallone della Neve. Del Petraro si conosce una sola thòlos, aperta nella falesia ai piedi della cinta muraria; il portello d‘ingresso si presenta ornato da una modanatura a tre cornici decrescenti, e come altre thòloi, ha all’interno una nicchia laterale.
Essendo la thòlos una struttura che già può essere definita monumentale, distinguendosi dalle comuni tombe castellucciane per il portello d’ingresso il quale, anche se non modanato, ha forma più regolare di quello delle comuni tombe a grotticella artificiale, spesso per l’ampiezza della stessa camera e per la presenza di almeno una nicchia laterale, e ancora per la
32
presenza della decorazione rappresentata dal piattino (o anello) presente talvolta alla sommità della cupola, e ancora per trovarsi, talvolta, relativamente lontana dalle altre tombe che compongono la necropoli, non può essere escluso che tale tipologia tombale, diversa per i motivi suddetti da quella canonica del Bronzo Antico, voglia indicare uno status sociale e/o politico eminente della famiglia o clan che in quella tomba, e solo in quella, seppelliva i propri morti.
Essendoci ignota la reale organizzazione politica del villaggio del Petraro, ogni ipotesi, anche se proponibile, non è certamente da assumere per vera; ma non si può fare a meno di notare che già l’area recintata dal poderoso muro, all’interno del quale non può essere necessariamente vista tutta la complessità del villaggio, ma solo una piccola parte di esso, propone l’esistenza di una organizzazione sociale che ammetteva strutturalmente il predominio di una casta dirigente, munita di poteri che probabilmente esercitava da una residenza fortificata quale può vedersi nell’ area protetta dalla cinta. In tal caso, solo chi esercitava il potere poteva disporre anche di una tomba diversa, unica, che si distinguesse da tutte le altre. Ma questa è solo una ipotesi.
Non si ritiene superfluo ricordare che la civiltà castellucciana fu coeva a quella che costruì i c.d. “grandi palazzi” dell’Egeo (Cnossòs, Fàistos, Mallia, Gournià), fiorita a Creta, in età minoica, nella prima metà del secondo millennio a.C. Qui il potere veniva esercitato dal Palazzo, il quale sovrastava, per la sua imponenza architettonica e per la sua complessità, il resto del “villaggio”, le cui strutture povere, sparse ai piedi della rocca, confermavano la magnificenza del Palazzo stesso.
Non è neppure superfluo ricordare come dalla seconda metà del secondo millennio a.C. alla civiltà minoica si sostituisca anche a Creta, culla di civiltà nel Mediterraneo orientale, quella micenea la cui capitale, Micene, che sovrasta la pianura di Argo nel Peloponneso, nulla ebbe da invidiare a Cnossòs per magnificenza e ricchezza.
E’ utile infine sottolineare il ritrovamento da parte di scavatori clandestini, in una imprecisata tomba del Petraro, di un pugnale di bronzo, lungo ca. 32 cm., la cui tipologia si richiama in maniera indiscussa ad analoga produzione micenea, per cui se ne può ammettere la provenienza da tale area culturale.
__18__
L’ECONOMIA
Un pugnale di bronzo miceneo all’interno di una tomba castellucciana del Petraro di Villasmundo non dovrebbe sorprendere più di tanto, alla luce
33
della letteratura archeologica che segnala i molti contatti tra oriente e occidente già dal secondo millennio a.C., se non fosse che la sua presenza in un luogo tanto lontano dal suo luogo di produzione induce comunque a porsi delle domande.
Non vi è dubbio che il trasferimento di prodotti dall’Egeo alla Sicilia doveva seguire la logica del commercio, per cui se un pugnale miceneo arrivava per una antica forma di baratto al Petraro di Villasmundo, da qui altri prodotti dovevano essere trasferiti altrove; in altre parole, il Petraro produceva qualcosa di suo che vendeva a persone che risiedevano sull’altra sponda del Mediterraneo, da dove importava qualcosa che il Petraro non produceva in proprio: il bronzo appunto, una lega di rame e stagno della quale la Sicilia non disponeva.
Ma non può essere escluso che il Petraro importasse prodotti esteri per il tramite di altre comunità “castellucciane” isolane.
Cosa si produceva al Petraro? Si è ipotizzato il commercio di strumenti di basalto, prodotti appunto a Villasmundo per la vendita. Ma, per quanto a nostra conoscenza, gli studi non hanno ancora dimostrato che il basalto del Petraro sia stato mai trasferito anche in Grecia.
Né lo strumentario litico recuperato al Petraro ha mai evidenziato la presenza di “elementi di falce”, sì da far ritenere che fosse proprio il grano, od altro cereale, la contropartita per l’importazione di prodotti di bronzo. Al Petraro non sono emersi indizi che inducano a ritenervi florida la coltivazione di cereali. Gli elementi di falce, fortemente rappresentati a Mégara Hyblaea e sull’isolotto di Ognina (qui sia nei livelli neolitici che in quelli del Bronzo Antico), al Petraro sembrano assenti, sia nell’area castellucciana che in quella neolitica.
All’opposto, la presenza di denti di caprovini e di equini tra i rifiuti dei pasti, lascia ritenere che sul Petraro tali animali domestici venissero allevati già dal Neolitico, il che permette di supporre che prodotti dello allevamento venissero venduti a terzi (lana, formaggi, pelli ecc.).
Più complesso si pone il problema quando si voglia affrontare quello relativo ai c.d. “ossi a globuli”. Orsi, abbiamo detto, li ritiene prodotti di importazione dalla Grecia; noi ribaltiamo il problema e affermiamo che tali prodotti “di prestigio” abbiano invece potuto seguire il percorso inverso; si spiegherebbe così l’insufficiente e poco specializzato numero di ossi rinvenuti in Grecia, rispetto ai molti e artisticamente ornati rinvenuti in Sicilia.
Comunque, a parte il pugnale di Bronzo (che proviene da scavi incontrollati, quindi inaffidabili), nient’altro è emerso al Petraro che possa far pensare, nel Bronzo Antico, ad un intenso scambio commerciale con altri paesi: la ceramica, per tettonica e decorazione, è quella vista nella cuspide sud-orientale della Sicilia, discostandosi notevolmente dalla facies etnea e da quella della Sicilia occidentale. Disponendo il villaggio e i territori circonvicini di molti giacimenti di argilla, una produzione per la esportazione verso “città” vicine non può essere comunque esclusa, allo
34
stesso modo di quella di strumenti basaltici per l’estesa presenza di lave basaltiche plio - pleistoceniche ad ovest del villaggio; come non può essere escluso, anzi si ritiene provato, il commercio della selce con l’interno ibleo.
E’ utile precisare che i livelli castellucciani in tutti e tre i saggi di scavo non hanno restituito prodotti del mare, differentemente dai livelli neolitici i quali hanno restituito, come si è detto più sopra, Cardium edule.
Quindi, economia agricola basata sull’allevamento e sulla caccia (attività quest’ultima suggerita dal ritrovamento, in posti relativamente lontani dal villaggio, di elementi litici - cuspidi e microliti geometrici- facenti parte di aste di freccia, e, nei livelli neolitici, di corna di cervide), tenuto conto che la vallata del Mulinello, ma anche dei corsi d’acqua dell’area a nord e a sud del Petraro, dovevano rappresentare dei bacini particolarmente ricchi di selvaggina, sia stanziale che migratoria.
__19__
ALCUNE CONSIDERAZIONI
Il problema nato dalla impossibilità di registrare in poche pagine decine di migliaia di informazioni date dal Petraro di Villasmundo, sia quelle provenienti dai saggi di scavo, sia quelle emerse da una capillare ricognizione effettuata in trent’anni su una vastissima superficie almeno lì dove i vincoli proprietari e le condizioni del territorio, accerchiato e frantumato giorno dopo giorno da cave di pietra, lo hanno permesso, ed il conseguente problema posto dalla impossibilità di presentare e descrivere oggi in maniera esaustiva la realtà archeologica del Petraro nella sua complessità e interezza, si sono posti già dal primo momento in cui se ne è decisa la pubblicazione. Poiché la ricerca si è accentrata in maggior misura all’interno dell’area recintata, e marginalmente al di fuori di essa, trattandosi comunque di piccoli interventi diretti a definire una leggibile stratigrafia, ad oggi l’unico intervento scientificamente valido ed esaustivo è da ritenersi quello è quello, diretto dalla Soprintendenza ai beni archeologici di Siracusa, che ha permesso di mettere in luce, nella sua attuale interezza, la cinta fortificata. Ma si tratta in effetti di una goccia tratta fuori dal vasto oceano della realtà archeologica, di straordinaria complessità ed importanza, che contraddistingue il sinus megaricus ed il suo hinterland.
Per la posizione strategica del villaggio del Petraro, per la sua vastità, per la complessità ed importanza dei dati di cui ormai si dispone, sarebbe stato
35
opportuno continuare nella ricerca allargandone di molto i confini, sia ad est che ad ovest della cinta, ma anche a nord, per diradare la nebbia che ancora avvolge il Petraro, rivelatosi uno dei più straordinari insediamenti dell’Età del Bronzo Antico che costellano la cuspide sud orientale dell’Isola.
Non a caso l’elemento megarese, che nella seconda metà dell’ottavo secolo a.C. colonizzò la frangia di est del regno di Iblone, diresse le sue vele proprio su queste coste: dovevano certamente esistere condizioni, sia sulla costa che nell’ hinterland, che invogliavano a stabilirvisi. Numerosi corsi d’acqua (S. Cusumano, Cantera, Marcellino, Mulinello, Porcaria, S. Leonardo) bagnano il territorio, estesi ed importanti insediamenti indigeni vi si sono succeduti fino all’alba della “colonizzazione”, e tra questi ultimi, il più importante in zona, il popolo che aprì nelle pareti della valle del Marcellino centinaia di tombe.
Ma è tra il terzo ed il secondo millennio, quando ad est fioriva la civiltà micenea, che l’area la quale guarda verso il sinus megaricus si presenta sovraffollata. Ad oggi sono già noti una ventina di insediamenti che vanno dall’Età del Rame al Bronzo Medio, di cui ben 15 sono da attribuire alla presenza castellucciana: tra questi il Petraro, con la sua particolare problematica connessa alla cinta ed alla presenza degli ossi a globuli i quali, essendo di rozza fattura, forse incompleti, si oppongono alla ipotesi dell’Orsi che vedeva negli ossi dei prodotti importati da oriente.
Già la cinta fortificata pone problemi. A differenza della cinta fortificata di Thàpsos, la quale, visto il notevole
sviluppo lineare del tratto messo in luce dal Voza (circa 200 metri), fu certamente costruita per proteggere una vasta area, quella del Petraro, come si è detto più sopra, lunga circa 140 metri se vi si comprendono le due bretelle di est e di ovest (quest’ultime, che probabilmente raggiungevano lo strapiombo, lunghe complessivamente ca. 60 metri), è posta in effetti al di fuori dell’area occupata dalle abitazioni e dalle necropoli. Le buche per pali di capanne che abbiamo esplorato all’interno del muro, dove la stratigrafia non aveva subìto alterazioni, contenevano solo materiali neolitici, quindi è da presumere che all’interno della cinta non esistessero capanne castellucciane nella forma canonica che noi vi conosciamo, realizzate cioè con una struttura portante composta da pali di legno infissi nella roccia, di forma rotonda o in ogni caso ovoidale; è da presumere invece che l’elemento castellucciano avesse recintato quell’area con un poderoso muro rinforzato da torri (da presumere nel complesso più robusto di quello di Magnisi), per scopi che nulla avevano a che vedere con la difesa delle comuni e povere abitazioni, le quali certamente non si trovavano all’interno della cinta, ma erano sparse su una più vasta area.
Abbiamo ipotizzato che: - l’area era stata munita perché vi si potessero conservare le scorte
del villaggio;
36
- il signore del villaggio, l’Anaktor o Basileus ( o ), comunque lo si voglia considerare, e con esso la casta dominante, vi avevano eretto il proprio “palazzo”;
- in caso di aggressione, l’area recintata accoglieva tutta la popolazione non chiamata a combattere. La maggior quantità di “armi” di tipo castellucciano (asce e mazze da combattimento, di basalto, quasi sempre rotte, e cuspidi di freccia) sono state rinvenute in superficie, all’esterno della cinta e per una vastissima area.
L’ipotesi di un più esteso villaggio, non recintato in origine da mura fortificate, contrattosi nel tempo fino a essere contenuto in un’area di 2.500 mq. circa, non è suffragata da prove, quindi deve essere accantonata.
Quindi, allo stato attuale, soltanto uno scavo che interessi tutta l’area recintata dalla fortificazione e parte dell’area circostante, potrebbe dare, anche se in maniera parziale, abbastanza informazioni sull’ organizzazione urbana del Petraro.
E sempre che le cave di pietra e le discariche più o meno inquinanti non completino in pochi anni quell’opera millenaria di demolizione di norma riservata alla natura e al tempo.
37
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE a)- Una prima ricognizione di superficie sul Petraro fu fatta da chi scrive,
da P. Gianino e da G. Bonaccorsi, nella primavera del 1959, a seguito della localizzazione di una vasta area interessata dalla presenza, in superficie, di una consistente quantità di elementi litici su selce, ossidiana e basalto, dei quali non si faceva cenno nella letteratura. ______________________________________________________________________
BERNABO’ BREA L., 1966- LA SICILIA PRIMA DEI GRECI.
BORDONARO S., DI GRANDE A., RAIMONDO W., 1984- LINEAMENTI
GEOMORFOSTRATIGRAFICI PLEISTOCENICI TRA MELILLI, AUGUSTA E LENTINI (SIRACUSA), Boll. Acc. Gioenia Sci. Nat., vol. 17, n. 323.
CACCIAGUERRA G., 2000- TOMBA CON RILIEVO TRILITICO IN CONTRADA
PETRARO (MELILLI, SR), Sicilia Archeologica, a. XXXIII, f. 98.
HOLM A., 1896-1901- STORIA DELLA SICILIA NELL’ANTICHITÀ
HOUEL J., 1782- VOYAGE PITTORESQUE DES ILES DE SICILE, DE MALTE ET DE LIPARI.
ORSI P., 1893- Scarichi del villaggio siculo di Castelluccio, B.P.I. a. XIX,
n. 5 e 6. ORSI P., 1902- MOLINELLO PRESSO AUGUSTA, III. Periegesi archeologica,
estratto dalle Notizie degli Scavi.
RUSSO I., 1999- SU ALCUNI ALTARI PREISTORICI DI PIETRA LOCALIZZATI NELLA REGIONE CASTELLUCCIANA DELLA SICILIA SUD ORIENTALE, Archivio Storico Siracusano III,XIII.
RUSSO I., 1987- L’ETÀ DELLA PIETRA NEL TERRITORIO DI AUGUSTA,
Notiziario Storico di Augusta, 15. RUSSO I., ARCHEOLOGIA DEL BASSO CORSO DEL PORCARIA: PREISTORIA DI
GISIRA DI BRUCOLI, Arch. Stor. Sir. s.III,IX.
RUSSO I., GIANINO P., LANTERI R., 1996- AUGUSTA E TERRITORI LIMITROFI – I – PREISTORIA, supplemento n. 5 all’Archivio Storico Siracusano
38
SPIGO U., 1984-85. RICERCHE IN CONTRADA GISIRA, Atti del VI Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia Antica.
STRAZZULLA V., 1899- STORIA E ARCHEOLOGIA DI TROTILON, XIPHONIA
ED ALTRI SITI PRESSO AUGUSTA DI SICILIA. VOZA G., 1967- VILLAGGIO FORTIFICATO DELL’ETÀ DEL BRONZO IN
CONTRADA PETRARO DI MELILLI (SIRACUSA), Atti della XI e XII Riunione Scientifica dell’Ist. Ital. di Preist. e Protostoria.
39
INDICE
La Timpa Ddieri…………………………………………………………… 1 I luoghi……………………………………………………………………… 6 La cinta fortificata………………………………………………………… 8 Le prime ricerche sul Petraro…………………………………………… 9 I saggi di scavo…………………………………………………………….. 10 Buche per pali e abitazioni………………………………………………. 12 I materiali………………………………………………………………….. 13 Indizi eneolitici……………………………………………………………. 18 Microlitismo geometrico………………………………………………….. 19 Gli “ossi a globuli”…………………………………………………………. 20 Le necropoli………………………………………………………………… 22 Tomba con rilievo trilitico………………………………………………... 24 Materiali dalle tombe 16 e 17……………………………………………. 25 Elementi di culto………………………………………………………….. 27 “Corni votivi” di argilla…………………………………………………… 20 La tomba a thòlos…………………………………………………………. 31 L’economia…………………………………………………………………. 32 Alcune considerazioni……………………………………………………. 34 Bibliografia essenziale…………………………………………………… 37 Indice……………………………………………………………………….. 39 Figure………………………………………………………………………. 40
51
Petraro. Tavola delle offerte neolitica. A dx: tavola a coppelle: da s. Maria navarrese (Sardegna)