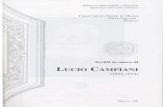Il Varmo di Ippolito Nievo
Transcript of Il Varmo di Ippolito Nievo
FONDAZIONE GIORGIO eINI
«Leggiadre donne ...» Novella e racconto breve
in Italia a cura di Francesco Bruni
Marsilio to 01)
'If!:. ,
FABIO FINOTTI
«IL V ARMO» DI IPPOLITO NIEVO
1. A meta dell'Ottocento la cultura italiana si volge con crescente interesse verso il mondo ruraIe. Destinatario di pubblicazioni come I'Almanacco del Vesta-Verde del Correnti e l'Amico del contadino del Cantoni, oggetto di studi economico-sociali come quelli dello Jacini, il popela delle campagne diviene soggetto di tJarrativa col Ravizza, col Carcano, con la Percoto, con Ia Codemo l
• E it Carcano, dopo 10 straordinario successo deIl'Angiola Maria (1839), a consacrare il genere della «Ietteratura campagnola» con Ie novelle di argomento rusticale degli anni 1840-50 (La vecchia della Mezzegra, 1843; Rachele, 1845; L'Ameda, 1851; Selmo e Fiorenza, 1853). E non esolo un tema, rna un tone nuovo, uno stile dell' oralita ad affacciarsi dalle pagine dedicate ad un mondo contadino che preme per parlare con la sqa voce:
questa storia [. .. ] vorrei poteda raccontare alIa buona, COS1 come l'intesi, in una bella serata d'autunno, da un vecchio COjllpare del paese, it quale vi aveva avuto la sua parte [. .. P.
Gia prima del NovelHere campagnuolo e delle Con/essioni d'un Italiano del Nievo, nel Carcano si affacciano narratori «popoIari» ai quali I'autore delega per brani pill 0 meno lunghi il compito di raccon tare Ia storia, come nella Vecchia delta Mezzegra. Cosl, dalla realta contadina, tra permanenti tentazioni lacrimose e sentimentali, balena una luce pill netta, tagliente, che incrina la fiducia manzoniana nella provvidenza, e fa della campagna il Iuogo in cui una miseria senza riscatto s'incarna in nuove figure non pill di «umili», rna di «vinti»:
103
FABIO FINOTTI
quando un vecchio pescatore, nel breve tragino della punta di Ghiffa ad Intra Iii. sulla curva e maestosa riva del Verbano, mi fece, piegandosi sui remi, il malinconico racconto, 10 andava fra me pensando che l'ignota fanciulla dena montagna fu essa pure una delle tante vittime mietute da codesta nostra civilta cOSI orgogliosa di se e COS1 stolta; la quale vuole tuno sagrificare, non diro a1 genio, rna al demone dell'industriallsmo, a quel tirannieo problema della proJuzione e della consumazione, che pur troppo fino ad ora altra verita non ci ha fatto vedere se non questa che i pochi s'impinguano, che i molti muoiono di fame e di patimento - poveri fiori del campo, recisi al principio del mattino dana falee dell'indifferente mietitoreP
A sollecitare la narrativa campagnola il Correnti dedica al Carcano it saggio-manifesto Della letteratura rusticale nel 1846, l'anno in cui la Sand comincia a pubblicare i quattro romanzi di argomento contadino (La mare au diable, Franryois Ie Champi, La petite Fadette, Les mattres sonneurs) destinati ad essere raccolti sotto il tholo complessivo di Les veillis du Chanvreur. Certo, con la sua ambigua fusione di saintsimonismo e romanticismo, la Sand bene illustra Ie ambiguita di quel nuovo genere, osciIlante tra la realistica rappresentazione delle miserie economiche e morali del popolo, e un idealismo che 10 trasforma in modello e tende alla sua sublimazione.
Sara questa equivoco insieme morale e stilistico che spingera H Nievo a marcare Ie distanze dal Carcano - cui pure tanto devono it Novelliere campagnuolo (1856) e H Conte pecoraio (1857) - negando in una lettera al Fusinato l'appartenenza al suo «genere contadineSCO»4. Gia nel Nievo che due anni prima del Novelliere campagnuo10 scrive gli Studi sulla poena papalare e civile massimamente in Itaiza (1854) c'e uno slancio realistico e attivistico assente nel Carcano, e vicino piuttosto aIle posizioni del Tenca. Uno spirito libero, «primitivo» costituisce il vero insegnamento morale del popolo, al di la delle virtu domestiche e religiose cantate dalla scuola manzoniana: nel mondo popolare il Nievo valorizza insomma una vitalita capace di risoIlevare I'Italia dallo sconforto prodotto dai fallimenti del '4849. La critica al sentimentalismo populist a e COS1 una critica alIa debolezza morale e civile che ne deriva:
nella loro fede morale il dolore si traduce in accasciamento, la speranza in inerte aspettazione, I'idea in sogno, l'amore in mistica stravaganza [. .. ] ne avevano indovinato nel popela che Ii circondava quella fibra elastica e robusta che non si spezza al primo urto, rna che risponde invece alia percossa con una pronta reazione e si acuisce percio nella lotta anziche ottundersi' .
104
«IL VARMO» DI IPPOLITO NIEVO
Ma, intrecciata con questa vitalismo e volontarismo, rimane nel NovelHere campagnualo del Nievo un'acquisizione essenziale della narrativa rusticale precedente. Proprio reagendo al «demone dell'industrialismo» il Carcano faceva della campagna it luogo di un racconto «antistorico», nel quale il mondo rusticale diveniva luogo della memoria, terreno di resistenza all'ideologia del progresso e di perenne infanzia e rinascita dell' animo:
E quante volte io ritotno a respirare quell'aria, a contemplare quei monti, quell'acque, quel delo, la dove albergano gia tant'altre memorie del mio cuore, mi par come di sen tire, nel bello sempJice e maestoso della natura, nell'armonia solenne delle linee alpine, mana a mana digradanti fino all'ampia e ubertosa pianura, una voce misteriosa di speranza e di pace, un amore piu vero della vita e del bene. Gli anni miei /andulleschi corsero per fa maggior parte nella serena e aperta campagna,' e ora, negli anni delle deluse aspettazioni e della ferrea necessita umana che ride e trionfa, ranima mia ritoma a quell' asilo dimenticato [. ..]6. '
Non stupisce dunque che l'anno successivo, negli Studi sulla POeSta popolare e dvile del Nievo la natura e il popela delle campagne divengano vichianamente i luoghi di una poesia, fusa con la primitiva infanzia dell'uomo e della civilta, che scorre carsicamente nel presente e si svela a chi sa indagare 10 strato piu profondo della storia e della coscienza: «uno strato sotterraneo che non apparisce distintamente alla superficie, rna che si ribella perc ad una commistione completa cogH strati superiori, e che da segni di sua presenza per poco che si scandagli H terreno»7. La poesia e. forma di un' antropologia a piu livelli, che richiede una capacita regressiva nell' ordine delle eta umane (dallamaturita all'infanzia), sociali (dalla borghesia al popolo), storiche (dalla dvilta industriale a quella primitiva e «naturale» delle campagne):
Intanto ad ogni passo che 10 spirito umana muove nella sua lunga carriera egJi ama volgersi addietro L .. ] e questa ripiegarsi su do che fu [...] riceve nell' orcline letterario la sua piu splendida applicazione, nella poesiaB,
Cosi, all'inizio del Varma9 Ia poesia sara identificata proprio con gli spazi piu nascosti della «natura»: «Ogni disposizione di natura [,',] spira [...] una sua singolar poesia dalla quale ci si rivelano bellezze tanto piu delicate e pellegrine quanto meno aperte e comprese» (VA, p. 719). E proprio Ia traduzione nievana del sentimentalismo del Carcano nei termini di un'antropologia e di una poetica del
105
FABIO FINOTTI
primitivo e Ia radice di quella dialettica tra storia, memoria e natura che percorrera non solo il Novelliere campagnuolo - e in particolare 1l Varmo - rna Ie Con/essioni d'un italiano: un mito insieme rusticano e infantile all'inizio del romanzo cattura la VOce narrante in un passato quasi senza tempo, riaffiorante in una senilitii che va liberandosi pur essa dalle ansie della storia, «senza timori e senza speranze che non siano eterne»lO.
Nella novella campagnola si apre cosi il gioco modernissimo tra coscienza e innocenza, e - da un pun to di vista narrativo - tra racconto e descrizione/evocazione. Per questa il Nievo risolvera II Varmo, in una serie di «quadri», con una traccia narrativa ridotta al minimo. La novella lunga si frantuma, e al suo interno lascia spazio alIa genesi di una nuova, modern a novella breve: luogo non piu di condensazione, rna di rallentamento del tempo narrativo, nel ritmo sospeso dell'evocazione, della regressione e della contemplazione memoriale.
2.
Le immagini apprese all'anima in un'ora di pace e di bonta, moltiplicate dal sentimento, popolano di vaghi fantasmi il sacrario del cuore. Questo racconto pertanto inspirato dalle memorie d'una passeggiata assieme go. dutaci, fra noi due diversissimi d'opere e di studi resti, pegno d'amicizia e di morale concordia. (VA, p. 719)
Giii nella dedica all'amico Francesco Verzegnassi, il Nievo indica la qualita del «realismo» praticato dal Varmo: la verita e ricreata (<<moltiplicata») dal <<sentimento», rivissuta dalla «memoria», nel clima di libera divagazione di una «passeggiata» riscaldata dalla vibrazione intima dell'«amicizia», «in un'ora di pace e di bonta».
Questo slancio memoriale e affettivo individua subito il suo polo d'attrazione in un'etii infantile dell'uomo, sicch<! protagonisti del racconto divengono dei bambini: 10 Sgricciolo (Pierino), la Favitta (Tina), il Giorgetto. E ogni rischio di populismo eevitato giacche la voce narrante riconquista anch'essa una levitii fanciullesca, quasi dissolvendo l'elemento economico in una contemplazione magica delle cose. II narratore ritrova 10 sguardo con cui il mondo primitivo e fantastico dell'infanzia si vede e si giudica, uno sguardo arioso che sa trasfigurare dall'interno persino la miseria:
cotali regioni sono misera stanza di sterilita e di fatica; contorte e scapigliate Ie arb9rature, umili e cadenti Ie case, disadorne vi appaiono Ie chiese,
106
«IL VARMO» DI IPPOLITO NIEVO
meschini e quasi aceozzaglie del easo i villaggi; ma sopra tanta apparente deformita si spande invisibile, e attragge l'animo sen1.a passare pegli occhi, una cert'aria di pace serena che non abita Ie campagne piiJ ubertose e fiorenti. (VA, p. 720)
E la stessa pace di cui quel mondo si compiace, quando si rispecchia in se stesso, riflettendosi nell'animo limpido e infantile del Varmo:
II villaggetto c.,.J ha preso il partito di mostrarsi tal qual fortuna l'ha fatto [ ...J un miglio lontano sui radi filari delle vigne si cominciano a scernere Ie tettoie di paglia, e i fumaioli disfatti e il<campaniletto mezzo sconqua~sato [..,J Ma a rabbelIire tanta miseria s'e accinto valorosamente quel earo fiumicelIo del Varmo; e vi giuro che al veder capovolte Ie casette di Glaunico nel suo specchio argentino e tremolante, dove i caldi colori del fondo si mescono col riverbero del/a prospettiva, I'animo si sol/eva d'ogni triste1.1.a (VA, p. 722)
II miracolo dun que ela dove la poesia modern a 10 cerchefll: non nel grande e nel nobile rna nel piccolo e nel comune, riscattato da una contemplazione «argentina» e vibrante di luce come Ie acque del Varmo. II sottotitolo del Varmo, «Novella paesana» rinvia proprio a una poesia dell'umile, del domestico, del quotidiano formulata con chiarezza negli Studi sulla poesia popolare e civile, la dove il Nievo indica Ie doti del buon poeta in vernacolo:
Le precipue doti del buon poeta in verna colo sono: spirito spontaneo e prettamente paesano, linguaggio che appaja meglio parlato che seritto [. ..] Nee di codeste doti eprodiga a molti la natura [ ... ] Forse sarei per dire ehe ingegno profondamente poetico abbisogni piu che ad ogni al~ro al poeta in verna colo, imperoche mold sarannocommossi alI'aspetto d'un tramonto suI Mediterraneo, 0 d'una nevicata sulle Alpi, 0 d'un uragano sull'Oceano, e in eopia troveranno Ie frasi e Ie rime per dipingere Ie 10ro impressioni, ma pochi assai all'incontro sapranno earpire in una scena di famiglia, in un semplice caso campagnuolo quelia pudica poesia ehe per esser salva dalle oeehiate dei profani si rifugia nell'intima essenza delle cose II ,
E non c'e dubbio che il descrittivismo del Varmo - tutto orientato verso il piccolo paradiso nascosto sulle rive di un fiumicello friulano - divenga il miglior manifesto di questa poesia in vernaco10, sostituendo definitivamente con una «semplicita primitiva» ill paesaggio e di colori il «pittoresco» rom antico, con i suoi artifici e la sua «tavolozza ingegnosa»:
107
FABIO FINOITI
Un tal che, partitosi dalle folte campagne del Trivigiano col mal del quattrino nel fegato, di qua del ponte della Delizia devii verso Camino per quella magra pianura che costeggia il Tagliamento, subito cor desiderio ritoma aIle negre arature di Oderzo e ai colli pampinosi di Conegliano, abbandon an do alla rabbia della bora e delle montane quei deserti di ghiaia. Ma il pittore L..] sarebbe indotto da quei primi aspetti a tirare innanzi; ed ecco che di na poco il piede gli sosterebbe quasi involontario; benche per quella volta indamo, trovandosi impotente ogni tavolozza meglio ingegnosa a ritrarre quella semplicita primitiva che non ha parentela con qual un que arti/iciale trovato. (VA, p. 719)
Un valore simbolico avranno allora nel racconto il paesaggio naturale e la rappresentazione dell'infanzia che in esso si muove: forme - la natura e l'infanzia - di un'innocenza ritrovata anche nello stile, fondendo realismo e lirismo, e anticipando con una sorta di poesia in prosa una poetica del «fanciullo» che trionferii a fine secolo.
3. Ma quest'innocenza non va solo ritrovata. Essa va riconquistata con un percorso interiore, con un movimento dal «qui» della nostra maturita e della nostra storia, al «Ia» di una memoria incarnata dal mondo appartato, arretrato, vibrante di sacralita e d'infinito del paesaggio friulano:
Son quelli infatti i paesi ove la natura si dimostra pii:t spoglia e maestosa, piu muta e sublime, pii:t chi usa ed infinita; somigliante nella mia opinione aIla-greca Diana, che per mutarsi daIl'Olimpo nei recessi di una fonte, non s' appalesa meno altera e divina. Nessuna cosa pii:t mirabile al mondo di quellucido orizzonte che jugge all'occhio per mille tinte diverse sulle sponde del Tagliamento, quando il sole imporporando il proprio letto cambia in tremulo argenta i molti fill d'acqua scorrente come rete per Ie vaste ghiaie del torrente; ed ogni sassolino ed ogni crespolo d'onda manda una luce tutta sua, come ogni stella ripete un nuovo chiarore nell'azzurro della notte; e Ie praterie s'allargano d'ognintorno come il cielo si sprofonda nell' alto; e lunge lunge si schierano illuminate dal tramonto Ie torri dei radi paeselli donde si parte un suono di cam pane COS! affiocato per la vastita e la distanza, da sembrare un cora di voci ne celesti ne terrene, nel quale preghiere degli uomini si sposino arcanamente Ie benedizioni degli angeli. COS! quel calmo sole vassi morendo, e la lontana cerchia dell' AJpi ne rinvergina l'ultimo bacio sulle vette nevose [...]. (VA, pp. 719-720)
deittici (<<quelli», «quel») creane una prospettiva interna, aprono 10 spazio di un «altrove» che si spalanca verso !'infinito,
108
«IL VARMO» OJ IPPOLITO NIEVO
dando un nuovo respir~ alla sintassi. II ritmo del periodo, con Ie sue frasi paratattiche, evoca Ie successive dilatazioni della memoria che unisce ricordo a ricordo in una continuita liquid a di trapassi dalla terra al cielo, dal giorno alla notte, tutti dominati da un'irradiazione di luce che fa vivere ogni sasso del torrente, ogni torre di paese, e culmina nell'estremo riflesso del sole sulle lontane vette dei monti. Non una reaita oggettiva, rna I'evocazione della realta, con il suo tempo fluido e lento - anche formalmente liberato dal flusso precipitoso della storia - con la sua interna vibrazione, con Ie sue impennate liriche (segnalate da impennate linguistiche: (<vassi morendo») regola 10 stile del Varmo:
La pertanto dalla nitida ghiaia sprizzano ad ogni passo Ie limpide e perenni fontane, e di sotto aIla siepe sforacchiata dal vento effondesi un profumo di viole piu delizioso che mai, e per l' aria salubre e trasparente piove da mane a sera il canto giocondo delle allodoIe; la pascotano armenti di brevi membra e soniti che morrebbero mugolando innanzi aIle colme mangiatoie della bassa; la vivono genti robuste, semplici tranquille, abbarbicate da tenerissimo affetto a un suolo duro e ingrato; ta fra soleo e soleo Cresce l'olmo nodoso e stentato, suI quale la vite lentamente s'arrampica [ ...] ld infine, a dispetto di tutto, getta profonde radici la ricca pianta del gelso L..J. (VA, p. 720)
«La...»: i deittici tornano a evocare un «altrove». E di nuovo la lontananza diviene slancio poetico nell' anafora (La ... 18... .. la...) che da respir~ e commozione all'unieo, pausato, lunge periodo. Anche l'uso dei singolari (la siepe, l'olmo, la vite)di ascendenza dassica, evocando la specie net suo singolo esemplare, contribuisce a presentare ogni elemento naturale in una dimensione assoluta e sirnbolica, introducendo il lett ore nella temperie di una solennita arcaica (Omero e Virgilio saranno presto evocati)~ corne se proprio gazie al paesaggio si compisse un viaggio a rhroso entro una memoria collettiva 12.
4. Miracolo del Varmo ela tematizzazione di questa «realismo della memoria» in una fanciullezza rusticana che 10 traduce in milO vivente. II mondolet priiii1~Varmo verra cosl guardato con gli .D.r'~ occhi altrettanto primitivi e in antili dei protagonisti e delloro fratello d'acque, il fiume, che simboleggia l'energia carsica e sorgiva della natura, libera dal mondo adulto dell'economia, della produzione, dellavoro:
109
I
FABIO FINOTII
Nel mezzo di questa territorio da parecchie sorgenti, che forse pigliano vita per sotterranei meati dal vicino Tagliamento. sgorga una vaga riviera la quale chiamano il Varmo, ed e cosl cara e allegra cosa a vedersi. come silvestre verginetta che non abbia ne sdenza, ne cura della propria leggiadria. Sulle sue rive non s'alternano gli adornamenti ai ripari come nell'acque serventi all'agricoftura, ne ella ogni trarto s'accieca sotto f'arco d'un ponte 0 nei canaletti d'un'o/ficina. ma libera divaga per campi e per prati, partendosi ora in pib rami, ed ora circuendo graziosamente se stessa, e cOSt prepara bagni e pelaghetti ai beccaccini ed agH anitrocchi L.J. (VA, p. 720)
II Vanno e irresponsabile ed errabondo. Nel suo capnCClOSO corso l'ideaIistico fiume della storia perde la propria linearita, si dirama in infiniti recommencements, pare contraddire se stesso, diviene emblema di un'infanzia senza vincoli, e insieme di una poesia senza piiI doved pedagogico-risorgimentali. Ai «laberinti di ruscelIi», ai «Iucidi laghetti», aIle «fondure cavernose» del Varmo, aIle sue «grotte [ ... J colorate e fantastiche» (VA, p. 721), come per una intima fratellanza, sono continuamente richiamati i protagonisti, che ugualmente alternano corse all'impazzata, cammini it rebours, arresti improvvisi:
Di sguazzar nel rio immolandosi fino aIle midolIe, [ .. ,J sedere chiacchierando e spassandosi sopra sponde tutte corrose dall'acqua, saltare da sasso a sasso come ranocchi nel bel mezzo della fiumana 0 valicarla camminando a ritroso dove il guado era men dolce, tali erano i loro diletti (VA, p. 732)
Luogo di un destino affrancato dal pericolo e dal dovere (<<colI'imminente pericolo d'affogare ad ogni istante L.J non visti da nessuno continuavano nei loro piaceri, tanto piiI lieti e saporiti quanto pt'u pedgUost' e vt'etatt'»: VA, p. 732), il Varmo nei suoi meandri, nelle sue caverne, nei suoi anfratti, nell'irrazionalita giocosa delle sue corse e dei suoi ristagni raffigura i percorsi fantastici, favolosi e misteriosi della coscienza infantile. Si capisce che I' operosita dei «pontefid» - di coloro che nella natura tracciano Ie strade dritte e razionali del progresso - venga arrestata e travolta dalla sua onda irridente:
Soltanto da pochi anni due strade comunali hanno stirato sulla cheta acqua del Varmo i loro cinque metd di carraia; rna l'ingiuria fu poca e la cheta acqua se n'e vendicata, cred'io, burlescamente quando non son molti autunni costrinse que' due ponti a piegar Ie schiene per farle reverenza [ .. .]. (VA, p. 721)
110
«IL VARMO» DI IPPOLITO NIEVO
E dunque la scelta del mulino come secondo polo dell' ambiente, non rispetta solo una consolidata topografia letteraria J}. n<<mulino» rappresenta it terdtorio di confine in cui l'energia sorgiva della natura eincanalata e piegata allavoro, e la liquida poesia dell'infanzia e posta al servizio di un'economia tutta prosastica e terrena. n mulino eitluogo per 10 Sgricciolo del dovere, delle umiliazioni e di una carita che per voce della Polonia viene continuamente rinfacciatao L'infanzia ritrova la sua felicita solo quando si specchia in se stessa, e infrange Ie regole: nell' amicizia crescente tra 10 Sgricdolo e Favitta, neltoro disobbedire a Polonia, e - appunto - nelle corse al Varmo, capace di trasformare anche la fatlca in ditetto:
e se [il Varmo] intoppa talvolta nella mota d'un mulino, sembra anco godere di questa varianza, e volgerla attorno gaiamente, e balzellar via qua e l?t in goccioline iridate e in pioggia di diamanti. (VA, p. 721)
Dove - confermando la struttura di rispecchiamenti e di inv~stimenti simbolici che genera it racconto - il fiume obbedisce alla medesima «psicologia» infantile che pennette alIa F avitta e allo Sgricdolo di trasfigurare ludicamente la vita operosa e faticosa del mulino in gioco, proprio sulle sue rive:
Illoro gioco era alle volte di graffiar nel sabbione alcuni rigagni L..] E talora, diviso con sassi un piccolo filo della corrente ove la era meno lenta, vi costruivano alla spiccia un moHnello di canne; e la sabbia tenendo Ie veci di grano e di farina, sovente contendevano in riguardo all'asino che doyea recar quello e riportarne questa; rna a cotale ufficio, pur troppo non molto lusinghiero, si adattava alla fine con doloroso eroismo di galanteria il povero Sgricciolo; mentre la Favitta, cambia~a di mugnaio in avventore, parava innanzi il somarello percotendoIo scherzosamente con una vermena. (VA, p. 736)
E sara anche il narratore a partecipare a questa focalizzazione infantile, con l'iniziale descrizione del mulino ormai sottratto dal tempo ad una funzione operativa, e ricondotto dalla natura ad un ritmo di danza e gioco:
Ne un mulino che e Ii presso toglie per nulla di vaghezza a quella sempIke scena [...] anzi esso stesso a quella campestre solitudine presta conforme il movimento e, sarei per dire, Ia parola C.'] poiche l'e tanto antico, a mio giudizio, che la capricciosa natura l'ha gi?t rioccupato parte a parte per diritto di prescrizione; e Ie muraglie son cosl sconnesse e fiorite, e il tetto e cosl ineguale e muscoso ch'esso ti d?t sembianza d'una fattura del
111
FABIO FINOTTI
caso; ed anche ad ogni voltata si stupisce di non veder la mota volare in frantumi; rna questa, COS1 marcia e sdentata com'e, pur segue a danzare, e incamiciata aIla bella prima di licheni e di muschi va ora inghirlandandosi di cento fioretti acquaioli; immagine a parer mio del vecchio Anacreonte che coronato di rose cantava brindisi alla morte. (VA, p. 722)
5. Non sara dun que un caso che il «rito di passaggio» dall'infanzia alla giovinezza, dal tempo del piacere al tempo del dovere per 10 Sgricciolo e la Favitta sia proprio nella partecipazione piena all'attivita del mulino. A partita chiusa, a maturazione compiuta, il mulino cedera il posto ad una dimensione dell'esistenza ancora pili solida, ormai tutta legata alla terra:
un gran cambiamento avvenne nei gusti dello Sgricciolo; ne certo il cielo l'avea destinato al mestiero del mugnaio, poiche appena ebbe accolto un piccolo capitaletto, penso a comperare un buon pezzo di terra; e COSt a poco a poco il mulino rimase negletto, ed ora invece dietro di esso si stende una campagnetta cos1 piana, regolare eben piantata, che a colpo d'occhio s'indovina Ia predilezione del mugnaio per l'agricoltura. (VA, p.
E si potrebbero seguire Ie tappe di questa conversione che segue un percorso a spirale, sempre pili lontano dallo spirito libero, disinteressato del gioco. Dalla prima incrinatura dell'armonia nella guerra col Giorgetto, che gia trasforma il gioco in qualcosa di pili serio, alla frattura tra 10 Sgricciolo e la Favitta, al primo viaggio della fanciulla verso un altro mulino, dove per la prima volta la si vede partecipare aIle faccende domestiche, e con la voce del nonno entra l'elemento storico e sodale.
Certo - fino a questa punto - !'influenza del Varmo, e del suo flusso infantile di sogni e ancora vittoriosa. Basterebbe pensare a come il nonno di Giorgetto traduca i1 suo vangelo «sodalista» in termini fiabeschi sulle rive del fiume: «gironzava sulle sponde del Varmo facendo i conti sulle dita dei campi che gli sarebbero toccati, e di quanto avrebbe speso per accomodarli a modo suo tutti a viti e a pergolati» (VA, p. 743). °alIa cucciolata di gattini, «pulcinetti» e «puttini» contemplata dalIa Favitta nella cucina del mulino. 0, infine, all'intonazione magico-arcaica che ispira subito dopo la deserizione di un focolare nel quale si prepara queUo di Fratta (VA, p. 748).
Ma gia da quel primo viaggio la Favitta torna con una pili matura consapevolezza del discrimine tra dovere e gioco. E di Ii il racconto sembrll: seguire la progressiva dissoluzione dell'infanzia nelle
112
<<IL VARMO» DI IPPOLITO NIEVO
maldicenze che s'interpongono tra 10 Sgricciolo e la Favitta, nel triste matrimonio della Favitta col Giorgetto, nel successivo matrimonio di Favitta con 10 Sgricdolo, che segue per l'una il fallimento delIa prima unione, per l'altro l'alienazione in una fatica incapace di colmare it vuoto del cuore. E l'infanzia sembra davvero tramontare in questa sposalizio tardivo e reso pili mesto dalla duplice disillusione che l'ha preparato, compiendosi in fine nell'abbandono del mulino, quando 10 Sgricciolo di un tempo volge definitivamente Ie spalle al fiume.
Eppure questa maturazione ebruciata dal Nievo in un fuoco di successive smentite. Proprio nel momento del dolore il Varmo acquista per 10 Sgricciolo una dimensione simbolica non solo orizzontale Ouogo di immediata liberta e innocenza) rna vertic ale (luogo di memoria e di regressione):
Congedato dalla Favitta con una voltata di spalle, e con una schemevole riverenza dalla Polonia, s' avvio egli lunge il Varmo dal quale non sa~ peva scostarsi; e camminando per Ie sue rive sempre pladde e belle sentiva bollirsi nel seno pill tempestosa che mai l'angoscia di quella separazione [. .. ] Per se riserbava l'unico sollievo di sedere alla sera di ogni domenica in qualche solitario renaio del Varmo; e in que' soli momenti viveva per se stessa I'anima sua, rna pill non viveva che di memorie [. . .]. (VA, pp. 758759)
Ed eproprio questo mote regressivo che nella condusione del racconto fonde - ancora una volta - tema e struttura narrativa. Chi racconta, infatti, la vicenda della Favitta e dello Sgricciolo, se non una nuova Favitta, un nuovo Sgricc;iolo, emblemi di un'infanzia che torna a rifiorire dalle sue ceneri? E il narratore a rivelarlo, con un improvviso rovesciamento di prospettive, nell'ultima pagina del racconto che - ndove parrebbe concluso - torn a come il Varmo a ravvolgersi su se stesso:
onde seppimo in breve che que' due ragazzetti si chiamavano la Favitta e 10 Sgricciolo, e che in tal modo erano stati battezzati dai loro genitori. Doveva essere d'ingegno molto bizzarro chi si piaceva d'imporre simili nomi ai propri figliuoli! e non seppimo resistere aHa tentazione di conoscerli.
Dal conoscerli al farci contare Ia loro storia, e poi aIlo scriverla, Ia strada era tutta un pendio. 10 mi Iasciai andar gill per Ia china aIla trasandata, come que' birichini che godono di scendere rotoloni Ie rive erbose delle nostre coHine. (VA, p. 761)
113
FABIO FINOITI
Lungo il capriccioso corso del Varmo continuano dunque a giocare la Favitta e 10 Sgriccio10 e l' arte si sa1da circo1armente a1 10ro mondo: nella persona dell'autore, che torna sulle sponde del fiume e gioca con loro ai passerini (cioe a far rimba1zare sassolini suI fiume); nella voce del narratore che rievoca per iscritto, dopo quell'incontro, l'infanzia dei loro genitori, come se il suo racconto fosse esso stesso una sorta di gioco infantile (<<come que' birichini...»); e infine nella forma stessa del racconto che con una strategica analessi colloca l'occasione che 10 ha originato non all'inizio rna alIa fine, rappresentando 1a perenne vittoria dell'infanzia su una maturita che ad essa perennemente si rivolge, per riviverla e riscriverla.
II movimento del Varmo e cosl perfettamente circo1are, dall'infanzia all'infanzia: come quello della natura e della memoria il suo percorso torna a recuperare cio che sembrava perduto. E nella finale citazione giustiana - questa vitacda grulla e inconcludente - scorre una vena di pungente ironia verso Ie costruzioni ben architettate, lineari, progressive dei grandi sistemi. Tanto pili dubbio, contorto e invece per Nievo il cammino della vita:
Ahime temo assai, che vi sieno due vite; l'una piena di ragionl e di sognl che si pensa neUe biblioteche, l'altra ispida di contraddizioni e di verita, che si agita pazzamente nel mondo l4 •
6. Nel Varmo l'infanzia diviene dunque maestra di esp10razione umana e di scrittura: e proprio «passeggiando» per Ie rive del fiume, abbandonando Ie strade maestre della storia, che aHo scrittore e data la possibilita di conoscere e ricreare 1a vicenda della Favitta e 10 Sgricciolo. E tra gli acquisti di questa scelta andrii innanzitutto indicata proprio un'immagine pili ricca, profonda della fanciullezza, determinante anche per Ie Con/essioni d'un Italiano.
Basterebbe pensare ai turbamenti affettivi di cui anche l'infanzia si dimostra capace, nel precoce, inconscio amore dello Sgricciolo per 1a Favitta lj, che anticipa quello del piccolo Carlino per la Pisana. 0 ricordare la capacidi infantile di trapassare immediatamente dal riso al pian to, come se l'espansione del do10re trovasse la strada aperta dall'esplosione della gioia:
QueUa vedete fu una gran festa pel Pierino! e non piu si pose a mirada colla solita pace, ma ridendo e gridando e saltandole d'intorno dimostrava per mille mondi la sua allegrezza, come il cagnuolo al ritorno del padrone [. ..] Ma durante il desinare, mentre la Tina continuava con que! suo spiritino irrequieto e ridevole, il fanciuUo all'incontro si facea scuro scuro e pare
114
«IL VARMO» Dl IPPOLITO NIEVO
va quasi che il cucchiaio gli cadesse di mano; e alia fine poi lascio a mezza la minestra, e Ie lagrimone gli venivano giu a quattro a quattro. (VA, pp. 726-727)
COS! pure senza sentimentalismi, rna con piena aderenza all'ingenua egoismo dei bambini, viene evocata subito dopo la nostalgia per la madre, tanto che la commozione del fan ciullo nel rimpiangerla e ricompensata a suon di ceffoni:
No, no, papa! - rispose il Pierino, - non pian go per alcun male, sibbene perche mamma mia non eperanco tornata.
- Ma sl che l'e tornata: non la vedi qui la tua mamma? - rispose il mugnaio additando sua mogHe.
- Ah no che non I'e questa! - soggiunse fra i singhiozzi il fanciulletto. - Domando io di quella che mt faceva pregare vicino al suo leno, e mi par-lava con amore, e quando era sereno mi conduceva seco nei prati a guardare Ie oche.
- Oh queUa, vedi, - disse allora Simone tutto intenerito, - quella hon torned piu qui fra noi, poiche il Signore la tolse con se in paradiso [ .. .]
Ma il Pierino non parve consolarsi in questi ragionari, e seguitava a starsi muto e lagrimoso, finche tutto ad un tratto volgendosi ingenuamente al mugnaio:
- Oh perche, - gli domando, - il buon Signore non si etolta quest' altra mamma in paradiso, lasciando a me queUa di prima?
- Ah sciagurato, birbone, e insolente! - udo la Polonia, la quale mentre puHva la bocca e il mento della Tina ud. questa tirata del fanciullo. Ah tu vorresti inviarmi al paradiso... ? To'! to' frattanto!
E in queste parole Ie ceffate balenavano e scoppiavano a dritta e a sinistra ( ...J. (VA, pp. 728-729)
Anche 1a scrittura imita insomma it fanciullesco corso del Varmo con il suo «umorismo sentimentale», e. con la sua scomposizione del racconto in quadretti compiuti in se come giochi infantili, insistendo sino aHa fine suH'immedesimazione del narratore col mondo dei bambini:
10 mi son ito sempre innanzi, trastullandomi a veder piovere dalla penna frasicduole e capitoletti; come il/anciullo si spassa col so//iare da una cannuccia Ie bolle di sapone; ed ora all'improvviso m'accorgo che la novella efinita. (VA, pp. 754-755)
Cosi, rispetto al populismo di tanto romanticismo e di tanta narrativa campagnola, II Varmo, coniugando Rousseau e Sterne, deli
115
FABIO FINOTTI
nea una nuova poetica che trova la sua piena realizzazione nelle pagine centrali del racconto: in quell'inoltrarsi e attardarsi dei fanciulli nel segreto ombroso del «belluogo». E in particolare nella memorabile scena che adegua la scrittura al moto senza tempo della Favitta e dello Sgricciolo, colti a gambe penzoloni, sopra un mondo rovesciato:
Ne v'era guado che non conoscessero, ne fondo dove non avessero pescato coi piedi e colle mani, ne ceppaia ill vinco su cui non fossero saliti, ne spanna di riva suUa quale non si fossero seduti colle gambe penzolone, specchiandosi nellaghetto purissimo e raddoppiando di brio e di contentezza, come se per l'appunto quei due personaggi a capo all'ingiu fossero sopravvenuti a ravvivare Ia compagnia. (VA, p. 736)
Ela stessa ottica con la quale, sin dall'inizio, il narratore si accosta al Varmo, ricercando la vera anima del paesaggio di Glaunico nel suo rifles so capovolto, entro Ie acque del fiume (VA, p. 722). All'opposto i consigHeri comunali che progettano i ponti suI Varmo «non si erano mai specchiati in quelle [. ..J acquette» (VA, p. 721) dalle quali 10 Sgricciolo e la Favitta ci guardano col volto dell'autore fanciullo.
7. It Varmo diviene coslluogo di una esplorazione verticale della coscienza verso Ia sua infanzia segreta (oggi si direbbe «rimossa»)' inverando la poetica abbozzata negH Studi sulla poesia popo/are e ci-vile: .
Pure se illinguaggio ecOSI aperto, non 10 sono per nulla i segni di esso; anzi l'idea di quel vago spettacolo sgorga e si compone da si secrete odgini, che bisogna contemplarlo con sincera religione per esseme alcun poco chiariti; imperocche ben si potrebbe dire che in esso L..) fa vita etutta interna ed ombrata. (VA, p. 735)
Cio dunque che in una dimensione orizzontale e storica appare come deviazione, come gioco, e in una dimensione verticale e coscienziale scavo interiore. A questa alludono Ie pagine iniziali del Varmo, che rivelano un'accorta sapienza prospettica. Quasi riemergendo dal fondo della coscienza illuogo del racconto econquistato progressivamente e inavvertitamente. Lo sguardo va dall' «esterno», all'«interno», daIlo spazio che circonda Ia scena, al fulcro piu intimo di quei «paesi ove la natura si dimostra piu spoglia e maestosa, pi~ muta e sublime, piu chi usa e infinita». Cosl la novella si avvia evocando il distacco «dalle folte campagne del Trivigiano» verso il Ta
116
«IL VARMO» DI IPPOLITO NIEVO
gliamento, e dalle sue pianure si con centra poi sui miseri villaggi che Ie popolano, fino a mettere a fuoco il corso che sgorga «nel mezzo» del paesaggio.
E il Varmo, rna con un ulteriore restr~gimento di campo, di quel corso si coglie solo un tratto: quello che attraversa Glaunico, e di quel tratto infine, quasi incidentalmente (<<Ne un mulino che en presso togHe per nulla di vaghezza a quella semplice scena»), prende rilievo un punto. E il mulino di Mastro Simone: dal suo aspetto attuale, il racconto risale infine al passato, e ne attraversa Ie mura per scoprirne l'intimita.
La sapienza del Nievo sta nel dare a questa carrellata narrativa un respiro di lirica liberta: avvicinandosi al teatro della novella quasi per caso, come divagasse da particolare a particolare, da memoria a memoria e 10 sguardo non cercasse, rna trovasse Ie immagini. II racconto evoca cosl un pensiero che procede non per costruzioni, rna per assodazioni, e si conforma al passo del «pittore» che «tira innanzi» senza sapere dove va, infine arrestandosi, rap ito da uno spettacolo che pare imporsi fuori di ogni artifido narrativo: «ed ecco che di Ii a poco it piede gli sosterebbe quasi involontario» 16.
Si comprende allora la riluttanza a dare una conclusione aIla vicenda. In contrasto con un'infanzia ritrovata come perenne dimensione dell' anima, come tempo senza tempo, Ie strutture che regolano it genere del racconto e 10 obbligano ad una fine vengono richiamate ironicamente:
sarei II per II per appiccarvi Ia morale, e far su tu~to una croce; rna in questo secolo ecresciuta una certa genia di lettori viziati, la quale crederebbesi gabbata se non vedesse.morti e seppelliti 0 per 10 meno maritati i personaggi di un racconto [. ..) onde io tirer<) innanzi a far man bassa de' mid mugnai per solo conto dei lettori, consolandomi col pensiero che Ia natura, se nego agli uomini la coda, ne fomi pili 0 meno largamente i pecori, i giumenti e Ie scimmie, e puo ben permettersi un tantino anche alIa mia novella. (VA, p. 755)
E non e un caso che il punto di maggiore coincidenza tra it personaggio-narratore e la sua materia sia invece in un'apparente divagazione. Sistema metaforico e strategia narrativa si fondono nella celebre descrizione del «far passarini», che congiunge in un gioco comune l'infanzia dei protagonisti alIa maturita dell'io narrante (VA,
pp. 737-738). A lettura condusa ci si accorge che proprio quel gioco econdizione del racconto:
117
FABIO FINOTII
6 G. Carcano, Selmo e Fiorenza, in Id., La Nunziata, cit., pp. 153-154; corsivi mid. 7 I. Nievo, Studi sulla poesia popolare e civile, cit., p. 31. 8 Ibid., p. 30. 9 Si citedi da 1. Nievo, II Varmo. Novella paesana, in Id., Romanzi. Racconti e novelle, a
cura di F. Portinari, Milano, Mursia, 1967: per i rinvii si userilla sigla VA, seguita dal numero di pagina. Pubblicato nell' «Annotatore Friulano» di Udine (marzo-aprile 1856), If Varmo ebbe nel Novecento Ie sue prime edizioni in volume a cura di I. De Luca (Padova, APE, 1945) e di V. Branca (Firenze, Le Monnier, 1945) al quale la presente lettura eidealmente dedicata. La pili recente edizione ea cura di A. Romano, Roma, Salerno, 1990.
10 1. Nievo, Le con/essioni d'un Italiano, introduzione a cura di S. Romagnoli, Venezia, Manilio, 1992, p. 5.
II I. Nievo, Studi sulla poesia popolare e civile, cit., p. 56. 12 Cfr. VA, p. 722, dove il paesaggio riflesso dal Varmo prende: «tal colore di poesia da
ricordare Ie BucoJicbe e I'Odissea». B Cfr. J. Starobinski, La /abrique sur Ia riviere, in «Lettere Italiane», 46, 1994, pp. 369
394. 14 1. Nievo, Ii barone di Nicastro (1857-1860), a cura di P. Ruffilli, Pordenone, Studio
Tesi, 1987, p. 73. n VA, p. 32: «Ma quando perahro aveva cold tra Ie braccia la piccola Tina, ol'addestra
va ai primi passi, 0 Ie imboccava il cucchiaio della pappa, allora egli non Ie scappava piu; e davanti alle sue ginocchia 0 presso alIa tavola stavasi immergendo nelle nere pupillette della bambina una occhiata lunga amorosa e contenta che non pareva di ragazzo SI tenero. Allora tosto la Polonia sahava su a dargli dell'incantato, pestandogli anche a volte Ie mani, rna il Pierino per cio non si sbigottiva, e ritraendosi ora dietro una seggiola ed ora nel cantuccio del focolare seguitava a pur guardare la Tina, finche la riportavano nella sua cuna, e quindi scivolava fuori alI' aia aperta come se il chiuso gli desse un grave affanno».
16 Ibid., p. 719. 17 1. Nievo, Le con/essioni d'un Italiano, cit., p. 915. 18 I. Nievo, Le JuccioJe. Canzoniere: Pre/udio, vv. 22, in Id., Poesie, a cura di M. Gorra,
Milano, Mondadori, 1970, p. 261. 19 I. Nievo, Le con/essioni d'un Italiano, cit., p. 914. 20 1. Nievo, Leiuccio/e: A/Ie mie fig/ie, vv. 31-36, in Id., Poesie, cit., pp. 263-264.
120
MATTEO PALUMBO
ASCESA E MORTE DI UN «PARVENU»: «LA ROBA» DI GIOVANNI VERGA
1. La roba appartiene alla serie delle Novelle rustic~ne, pubblicate per la prima volta nel 1883 dall'editore Treves. Nella storia actistica di Verga si colloca tra I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo:'in altre parole, tra I'ideologia naturale del romanzo di Aci-Trezza, e la successiva descrizione dell'ascesa sodale e del fallimento patito dall'eroe del secondo romanzo. Per queste sole ragioni la novella potrebbe assumere un valore altamente rivelatore, come indice di un mutamento in atto. Si tratta di capire, infatti, che cosa accade quando Verga, nel progetto del «cicIo dei vinti», abbandona la rappresentazione delle cIassi pili umili, legate alla soglia minima della soprawivenza, e si rivolge all'osservazione di mondi sociali diversi, che comindano a identificarsi sempre di piiI con il possesso e con Ie ricchezze. La roba. non solo come novella, rna nel senso comune della parola, diventi;percio, nel cambiamento di prospettiva, una categoria fondamentale. La sua esplicita assunzione a titolo introduce in un nuovo contesto sodale e umano, in cui conta, in modo determinante, la proprieta. La rappresentazione estetica, secondo una legge mai tradita di corrispondenza tra temi e linguaggiol, si adatta inevitabilmente al cIima di questo scenario, in cui operano soggetti non pili miserabili come I Malavoglia, e non an cora aristocratici, come sarebbero probabilmente apparsi gli attori della Duchessa di Leyra. 0 dell'Onorevole Sdpioni, 0, infine, dell'Uomo di lusso. Essa ha bisogno, per questa passaggio, di criteri, sia interpretativi ~he stilistici, distinti da quelli adottati nel romanzo e nelle novelle precedenti. Non sara possibile complicita 0 simpatia con gli oggetti descritti, rna piuttosto si imporra, nella sua accecante evidenza, la spie
121
FABIO FINOTfI
Un mese fa, io passeggiava per quelle ban de con un mio amicissimo, il cui solo difetto edi odiare il canto delle allodole; rna 10 compensa poi rispetto a me, coll'essermi compagno in una passione veramente artistica pei passarini. [...] una garzonetta ed un fanciullo, all'aspetto contadini, pensarona di unirsi al nostro spasso; e pur troppo ci convenne confess are d'aver trovad due maestri! La comunita di piaceri ingenera simpatia; e la simpatia alla curiosita e la curiosita alle chiacchiere [ .. .]. (VA, pp. 760-761)
Ed equeI gioco innocente a fornire la chiave del sistema insieme metaforico e narrativo che regoIa It Varmo, fondato sulla convinzione che nell'infanzia si dispieghi non solo un momento rna Ia verita essenziale dell'esistenza umana. Cio che si disegna in quell'apparente passatempo einfatti il gioco stesso della vita, nel suo slancio iniziale, nei suoi trionfi e nelle sue cadute:
una di queUe alate piastreUe si slancia a grandi valichi, e poi si tuffa a capofiuo, e 10 spruzzo ne zampilla in alto come pennacchio cristallino; un'altra guizza via lievemente accompagnata da un fruscio quasi di seta gualcita, fmche la muore senza accorgersene; e una terza dopo una rischiosa sdruc. ciolata spicca un gran saito e si salva dal naufragio sulI'una delle rive, dove trascorre un poco picchierellando per allegria i fratelli sassolini; e un'altra ancora dopo corso buon tratto dritto come una freccia si torce voltolandosi leggiadramente, e pare proprio che la si affondi ballando la schiava [ ... ]. (VA, p. 737)
COS! i sassi fatti rimbalzare stille acque del fiume offrono I'immagine piu viva dell'indole e del destino dei due piccoli protagonisti del Varmo:
i passarini dello Sgricciolo lunghi, violenti, temerari, si disegnavano sull'acqua e per l'aria, a baleni, come il guizzo dellampo; quelli all'incontro della Favitta trottolavano via pettegoli, curveggianti, graziosetti; e la striscia, lucente di stille, prodotta dalloro scivolio, assomigliavasi a quella lasciata pel cielo dalle stelle cadenti. (VA, p. 738)
E non sara simile ai passerini della Favitta, I'intero corso dell' esistenza della Pisana?
0, primo ed unico amore della mia vita, 0 mia Pisana, tu pensi ancora, tu palpiti, tu respiri in me e d'intorno a me! 10 ti veggo quando tramonta il sole, vestita del tuo purpureo manto d'eroina, scomparir fra Ie fiamme delI' occidente, e una fo/gore di luce della tua fronte purificata lascia un fungo SOleD per l'aria, quasi a disegnarmi il cammino J7
•
118
«IL VARMO» OJ IPPOLITO NIEVO
Scintille di energia «Iucente e vagabonda»18 , Ie vite saranno percio simili aIle Iucciole nelle poesie del Nievo e nella condusione delle Confessioni: «0 Iuce eterna e divina io affido ai tuoi raggi imperituri la mia vita tremoIante e che sta per ispegnersi!... Tanto sembra spento illumicino al cospetto del sole, come la lucciola che si perde nella nebbia»19. Cosl neI Varmo, proprio la Ieggerezza e il brioso lirismo delle immagini e dello stile divengono la traccia piu profonda della fosforescenza «tremuIa», «guizzante e fuggitiva» con cui l'assoluto vive e si frammenta nel gioco lieve, «infantile» delle esistenze umane:
Lucciolette, aneo un momento, Ed il pugno ehe vi accoglie Vi dara libere al vento. Vinto han gia Ie vostre doglie n ritroso animo mio. Lueciolette, addio, addio! ... 20
I Sugli almanacchi popolari efr. c. Tenca, Gli almanacchi popolari [1850], in Id., Giorna/ismo e letteratura nell'Ouocento, a cura di G. Scalia, Bologna, Cappelli, 19712 [1959]. SulI'influsso deUo Jacini sui "Crepuscolo,," (dove pubblicano racconti campagnoli il Carcano e la Percoto) cfr. I. De Luca, Introduzione a I. Nievo, Novelliere campagnuolo e altri racconti, Torino, Einaudi, 1956. Recenti edizioni degli autori cirati: C. Ravizza, Un curato di campagna (1841), a cura di E. Fllvretti, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1990; G. Carcano, La Nunziata. Novelle campagnuole, a cura di F. Tancini, Milano, Serra & RivII, 1984; C. Percoto, Racconti (1858], a cura di M. Prisco, Novara, Club del Libro, 1972; L. Codemo, Scene di vita. Antologia di 11a"ativa, a cura di G. PuUini, Mirano (Vel, Eidos, 1996. Sul genere campagnolo efr. A. m Benedetto, Sulla let/eratura campagnola, in Id., Ippolito Nievo e allro Otlocento, Napoli, Liguori, 1996. Per il Carcano in particolare mi permetto di rimandare a F. Finotti, L'innocenza perduta: slruUure na"alive dal romanw storieo alia storia domestica, in «Lettere Italiane», 41,1989, pp. 554-587.
2 G. Carcano, Selmo e Fiorenza, in Id., La Nunziata, cit., p. 156. j G. Carcano, La Nunziata, cit., pp. 74-75. 4 Cfr.la lettera ad Amaldo Fusinato del 27 gennaio 1856 in I. Nievo, Lenere, a cura di
M. Gorra, Milano, Mondadori, 1981, pp. 370-371. Cfr. anche I. Nievo, Ciance letterarie [1858] in Id., Le Confessioni d'un italiano. Saiui vari, a cura di F. Portinari, Milano, Mursia, 1961, pp. 799-805. Dove sembra pero che i commentatori non abbiano colto it tone ambiguo, ironico del discorso del Nievo che mentre rimprovera amichevolmente aI Carcano it suo quietismo, non cessa di proporlo a modello contro 10 spregiudicato affarismo deUa letteratura contemporanea. Cfr. p. 801: «Giulio Carcano eun letterato a1lo stato fossile, rimasto ad attestare I'esisttnza di una generazione primitiva, quando credevasi bonariamente che il euore dovesse entrarci almanco per un buon terzo neUa composizione di un !ibro, quando si aveva la ridicola pretensione di parere ed essere scriuori onesti ed indipendenti, a rischio e pericolo deU'editore». Invece (ibid.); «Illetterato contemporaneo ha la coscienzlI della sua missione, e I'adempie L ..J materia/ista come un medico, positiro come un banchiere, rcalista come una l0rette, s'ispira aile succulenti emanazioni della cucina [ ... ] e baratta Ie nove Muse, beUe e vergini come sono, con una butirros3 braduola alia milanese».
, I. Nievo, Studi sulla poesia popolare e civile massimamente in Italia, a cura di M. Gor- . ra, Udine, Istituto Editoriale Veneto Friulano, 1994, p. 52.
119