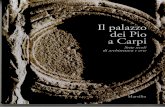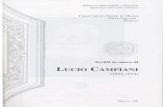Effetti dell’unificazione tra entusiasmo, disincanto, delusione (Cattaneo, d’Azeglio, Nievo,...
Transcript of Effetti dell’unificazione tra entusiasmo, disincanto, delusione (Cattaneo, d’Azeglio, Nievo,...
SALERNO EDITRICEROMA
PRE-SENTIMENTI DELL’UNITà D’ITALIA
NELLA TRADIzIONE CULTURALE DAL DUE ALL’OTTOCENTO
Atti del Convegno di Roma 24-27 ottobre 2011
a cura di
CLAUDIO GIGANTE e EMILIO RUSSO
ISBN 978-88-8402-768-9
Tutti i diritti riservati - All rights reserved
Copyright © 2012 by Salerno Editrice S.r.l., Roma. Sono rigorosamente vietati la ri produzione, la traduzione, l’adattamento, anche parziale o per estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effet tuati, senza la preventiva autorizzazione scritta della Sa lerno Editrice S.r.l. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.
Il volume è stato realizzato con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri
397
Claudio Gigante
effeTTI dell’UnIfIcaZIone Tra enTUsIasmo, dIsIncanTo, delUsIone (caTTaneo, d’aZeglIo, nIevo, Zola, carpI)
1. Cattaneo 1860
Vorrei iniziare il mio discorso – fondato su alcuni casi che mi sembra possano considerarsi esemplari – con Carlo Cattaneo, giun-to a Napoli il 21 settembre del 1860, due settimane dopo l’entrata di Garibaldi; vi resterà sino al 18 ottobre quando, deluso dall’andamen-to delle cose e senza essere riuscito a convincere il generale a cam-biare strada, partirà tre giorni prima della celebrazione dei plebisci-ti. Durante il soggiorno napoletano Cattaneo scrisse il saggio Ugo Foscolo e l’Italia, destinato ad apparire nei fascicoli lii-liii del nuovo « Politecnico » del bimestre ottobre-novembre 1860 e poi, qualche mese dopo, in edizione autonoma. Premeva a Cattaneo ricordare il ruolo che Foscolo aveva avuto quale precursore laico e antiaustria-co del « Risurgimento » italiano:
Foscolo fa parte di quella successione di generosi intelletti – scrive – che da Dante e Petrarca e Machiavello sino a’ dí nostri parlarono sí altamente o sí sdegnosamente dell’Italia agli Italiani, che avvampò alfine in essi tutti la brama di stringersi con un patto, e sott’una od altra forma mostrarsi al mondo giurati in lega indissolubile di fratelli.1
Dopo aver celebrato l’Ortis come il « potente libro » da cui le nuo-ve generazioni « attinsero la fiera passione che li condusse a disprez-zar per la patria la felicità e la vita », Cattaneo esprime i suoi dubbi nei confronti di un processo storico che sembra orientato soltanto dall’influsso letterario (p. 18):
1. C. Cattaneo, Ugo Foscolo e l’Italia, Milano, Editori del Politecnico, 1861, p. 8 (le pagine d’ora in poi direttamente a testo, fra parentesi). Sul topos del patto fondativo, che nei voti di Cattaneo doveva avere una valenza costituente, vd. A.M. Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, Torino, Ei-naudi, 20113, pp. 56-66.
claudio gigante
398
Noi non crediamo che tutto nel mondo possa operarsi a forza di poesia; crediamo anche alla potenza del calcolo, e pur troppo a quella dell’interes-se, ed eziandio dell’inerzia, e di tuttociò che nella dottrina di Helvetius si chiamava amor proprio. Ma non possiamo negare ciò che trionfalmente si compie sotto i nostri occhi. In fine, e appunto oggidí ne siamo testimonj, l’interesse non miete se non ciò che il disinteresse ha seminato.
Chiunque abbia attraversato le pagine di Cattaneo, solitamente lu-cide e disincantate, difficilmente portate all’entusiasmo, non può che restare colpito dal trionfo ch’egli dichiara di vedere sotto i suoi oc-chi, in quell’ottobre, a Napoli. Nel saggio foscoliano Cattaneo trova modo di ribadire, a scanso di equivoci (equivoci che, come ci inse-gna la nostra storia recente, si sono a lungo perpetuati), che il « patto federale » da lui auspicato per l’Italia altro non sarebbe che un « mo-do d’unità », l’unico, per lui, che garantirebbe durevolmente « con-cordia » e « libertà » (p. 33). Ma è nelle ultime righe che Cattaneo in-siste sul ruolo di caposcuola che Foscolo ebbe nella formazione di una coscienza nazionale non soltanto per pochi « eletti », come pen-sava, ma per le « moltitudini » (p. 50):
Ma le speranze, a cui Foscolo sembrò farsi volontariamente cieco, si rive-larono ad altri, i quali erano nutriti di quelle eloquenti pagine ch’egli scri-veva gemendo. E questi versarono prodigamente alle moltitudini ciò che Foscolo riputava gelosamente serbato agli eletti del gregge umano. L’Italia trapassò in mano ai profeti della speranza; in mano a quelli che riputarono vittoria perfino i disastri, purché si combattesse; a quelli che si applaudiro-no talvolta anche d’aver dato ansa al nemico di farsi piú terribile, purché si facesse aborrire.
E codesti nuovi scrittori, pei quali ciò che Foscolo aveva chiamato in sé stesso amore e furore di patria, si propagò a tutta Italia, portarono talmente l’impronta del suo stile e dell’anima sua, che noi, dopo aver letto con amo-re i dieci volumi delle Opere di Foscolo, pensando a ciò di cui fummo te-stimonj, dal principio del secolo, fino ai prodigii che avvengono qui sotto i nostri occhi, sentiamo di dover congiungere in perpetuo nella mente no-stra, Ugo Foscolo e l’Italia.
Di nuovo ricorre, con riferimento alla sua presenza a Napoli, l’e-spressione sotto i nostri occhi, mentre l’avverbio qui è in corsivo; Cat-
effetti dell’unificazione
399
taneo consegna al primo numero del « Politecnico » dell’Italia unita un messaggio di entusiasmo (non si potrebbe dire diversamente di fronte al sostantivo prodigii), segnato dalla sensazione che l’impresa garibaldina concluda nella maniera piú impensata una stagione di lotte lunga un secolo. È difficile credere che, rispetto al suo proget-to di un’Italia federale, Cattaneo, che a Napoli giocava in questo senso la sua ultima partita, si facesse molte illusioni dopo avere assi-stito nei mesi precedenti alle annessioni al Piemonte degli stati dell’Italia centrale; il suo entusiasmo sembra quindi, per una volta, svincolato da una precisa prospettiva politica, tanto piú che nelle stesse pagine Cattaneo riconosce che per i piú, « oggidí », un asset-to « federale » sarebbe « inintelligibile » (p. 33). È la storia di un’idea che Cattaneo celebra, con un’enfasi che non tornerà mai piú nel-le sue pagine: ed è finanche inutile produrre citazioni, tanto sareb-bero numerosi gli attestati di sfiducia e di disprezzo nei confronti del-l’ordinamento successivo dello stato, che ai suoi occhi ha privato di dignità le realtà urbane che dell’Italia sono il fondamento (su Na-poli dirà che « spogliata di ogni lustro paventa il re vecchio, bestem-mia il re nuovo, non crede alla repubblica e dispera della monar-chia »).2
Il conflitto fra l’idea, frutto di una formazione patriottico-lettera-ria, e la realtà è il filo rosso che accomuna il destino di numerose personalità del Risorgimento. Altre considerazioni ricorrenti sono la profonda, quasi incredula, impressione per l’improvvisa rapidità del processo unitario e la discussione intorno al “carattere” del po-polo italiano,3 individuato come un insieme di qualità morali, an-cora da acquisire, che solo potrà consentire di mantenere anche in futuro l’Unità raggiunta.
2. C. Cattaneo, Epistolario, a cura di R. Caddeo, Firenze, Barbèra, vol. iv 1956, p. 73. Quanto alle realtà urbane, alludo naturalmente al saggio La città considerata come principio ideale delle istorie italiane (1858; vd. l’ed. a cura di G. Armani, Milano, Garzanti, 1979).
3. Su cui vd. le pagine ormai classiche di G. Bollati, L’Italiano. Il carattere nazio-nale come storia e come invenzione (1983), Torino, Einaudi, 2011 (in partic. le pp. 35-127), e il recente libro di S. Patriarca, Italianità. La costruzione del carattere nazionale, trad. it. Roma-Bari, Laterza, 2010.
claudio gigante
400
2. D’Azeglio 1860-1861
Fra coloro che non parteciparono alla proclamazione del Regno d’Italia vi fu il senatore Massimo d’Azeglio che trascorse lontano da Torino il periodo tra il dicembre 1860 e il maggio del 1861, soggior-nando per motivi, sembra, di salute a Genova, Pisa e Firenze.4 Nel gennaio del 1861, d’Azeglio iniziò a comporre l’opuscolo Questioni urgenti, che fu stampato dal Barbèra, a Firenze, due mesi dopo. Nel-la lettera dedicatoria indirizzata a Ciro d’Arco (alias Giuseppe To-relli), datata 4 marzo 1861, d’Azeglio esprime il proprio rammarico per trovarsi costretto a essere « lontano dal nuovo Parlamento […] in queste cosí splendide e felici circostanze ».5 Questioni urgenti, il pam-phlet nel quale d’Azeglio affronta la questione romana proponendo di stabilire, anche se non subito, la capitale a Firenze (giova ricorda-re che d’Azeglio è stato il primo a proporre questa soluzione, che ai suoi occhi doveva, però, avere carattere definitivo), vorrebbe segna-re, scrive, l’inizio di un dibattito pubblico dove anche le proposte
4. D’Azeglio risulta a Genova a partire da metà dicembre del 1860; il 16 scrive infatti a Carlo Stefanoni: « Sono venuto via da Torino, perché ci son stato male con una febbre di raffredore; e m’hanno detto di cercare clima migliore. Cosí sto a Genova per un mese, e poi anderò a Pisa, Firenze, ec. Presto presto pare che potrò andare anche a Roma, se seguita questa tramontana. Per passarvi l’inverno è pro-prio l’asso quel soggiorno. Non sono egualmente persuaso di farne una capitale… » (M. d’Azeglio, Scritti postumi, a cura di M. Ricci, Firenze, Barbèra, 1872, p. 428; i puntini finali sono nell’edizione di Matteo Ricci, che dell’autore era il genero, e indicano probabilmente una censura postuma per carità di patria). D’Azeglio s’in-trattiene a Genova, come si evince dal carteggio con Eugène Rendu, fino ai primi giorni del 1861 (cfr. L’Italie de 1847 à 1865. Correspondance politique de Massimo d’Aze-glio, Paris, Lib. académique Didier et Cie, 1867, p. 175); ma poco dopo è a Pisa, dove compone le Questioni urgenti (iniziate il 15 gennaio, come si legge in sede liminare); a marzo d’Azeglio è a Firenze, da dove data la dedica delle Questioni a Ciro d’Arco, il 4 marzo 1861. A Firenze scrive al fratello (Lettere al fratello Roberto, a cura di G. Briano, Milano, Lib. P. Carrara, 1872, p. 183) e piú volte, fino a maggio, al Rendu (Correspondance, cit., pp. 177-95); dopo un breve soggiorno a Genova (cfr. ivi, p. 195), d’Azeglio torna a fine maggio in Piemonte. Il ricorso a queste vecchie raccolte è necessario, perché l’edizione moderna dell’epistolario di d’Azeglio, condotta con encomiabile acribia da Georges Virlogeux per il Centro Studi Piemontesi, è giun-ta per ora sino al 1852.
5. Questioni urgenti. Pensieri di Massimo d’Azeglio, Firenze, Barbèra, 1861, p. 6 (le pagine d’ora in poi direttamente a testo, fra parentesi).
effetti dell’unificazione
401
impopolari, come la sua (abbandonare il progetto di Roma capita-le), possano essere espresse senza ricevere insulti (pp. 7-8):
Ma bisognerà pure che in Italia cominciamo ad avvezzarci gli uni a parla-re, e gli altri a lasciar parlare: gli uni a dir ragioni, e gli altri a risponderne, senza voler soffocar la voce di nessuno con filze d’aggettivi, o spauracchi d’impopolarità. Bisognerà pure ad ogni modo, dopo avere per tanti an-ni sudato onde liberarci dalle censure degli Ispettori di Polizia e de’ Mae-stri del Sacro Palazzo, ci risolviamo altresí a far testa alle censure delle sèt -te, delle sagrestie, degli interessi di vanità, d’influenza, di borsa. Bisognerà pure alla fine risolversi ad essere un popolo libero ed indipendente davve-ro, ed a prenderne gli usi, la lingua, il modo di trattare, e di vivere; ad assu-mere quella dignitosa indipendenza di carattere, che è la piú nobile pro-prietà d’un uomo: proprietà che nessun decreto può dare, nessun tribuna-le guarentire, se non sa ognuno possederla e difenderla per virtú propria […].
Quando i piú in Italia abbiano rivestito questo carattere, allora saremo veramente un popolo libero: allora saremo pienamente indipendenti, ci mostreremo una gran nazione, e sapremo vivere da gran nazione. Altri-menti (mi sia permesso citare un aneddoto) faremo come quel ciabattino che vinse al Lotto, eppure la mattina dopo nell’alzarsi si cinse come al so-lito il grembiule di cuoio, non avendo ancora imparato a fare il signore.
Che d’Azeglio sia stato sin dal principio scettico verso le modalità con cui si era giunti all’Unità è cosa nota, cosí come sono noti i suoi giudizi non proprio amichevoli nei confronti dei meridionali. D’A-zeglio temeva Garibaldi, temeva ancora piú i mazziniani, riteneva pura archeologia il mito di Roma, verso cui anche Cavour stava per cedere,6 Roma che era, ai suoi occhi, lontanissima, nello stato pre-sente, non soltanto dagli splendori del passato ma anche dalla cul-tura costituzionale necessaria per reggere uno stato moderno. Ciò
6. Nel famoso discorso del 25 marzo 1861: cfr. C. Cavour, Discorsi parlamentari, vol. xv (1859-1861), a cura di A. Saitta, Firenze, La Nuova Italia, 1973, pp. 479-501 (cfr. p. 480: « senza Roma capitale d’Italia, l’Italia non si può costituire »); vd. A. Viarengo, Cavour, Roma, Salerno Editrice, 2010, pp. 463-69. Il giudizio di d’Aze-glio, in proposito, fu perentorio: « Quant aux affirmations de Cavour, personne ne les prend au sérieux. Le cher homme en est arrivé à ce que, quand il parle, la seule chose qu’on croit impossible est précisément celle qu’il affirme » (Correspondance politique, cit., p. 189; lettera al Rendu del 6 aprile 1861).
claudio gigante
402
non toglie che – al di là della questione della capitale e al di là di qualche senile volgarità antimeridionale (dico cosí, perché in gio-vinezza d’Azeglio aveva avuto un atteggiamento diverso) – sia pos-sibile cogliere negli scritti del vecchio statista, tra la fine del 1860 e i primi mesi del 1861, un misto di stupore e di ammirazione, se non proprio (il che sarebbe troppo) di entusiasmo. Si è detto delle « splendide e felici circostanze », frase non ironica, con cui d’Azeglio definisce il nuovo contesto politico in principio delle sue Questio-ni urgenti. Ma, soprattutto, il tono del pamphlet, al di là della fermez-za anti-mazziniana (perché d’Azeglio è convinto che solo la pro-paganda repubblicana avrebbe da guadagnarci nella conquista del Campidoglio) e dei fieri accenti anticlericali, è un’esortazione a tro-vare una soluzione per il bene comune. Di recente mi sono soffer-mato sulla figura di d’Azeglio, sulle sue contraddizioni, sui suoi me-riti, malgrado tutto, nella vicenda unitaria:7 se per decenni d’Aze-glio è stato considerato uno dei personaggi simbolo della stagione dell’indipendenza e dell’Unità (addirittura annoverato durante il Ventennio tra i cosiddetti “prefascisti”),8 ora di lui si ricordano piú volentieri, al contrario, le perplessità del 1860 e la sua opposizione sia alla spedizione garibaldina sia all’annessione del Mezzogiorno, da lui giudicata prematura.9 Sintomaticamente, oggi, lo troviamo citato nei discorsi di alcuni politici della Lega Nord quale lun gi-
7. Vd. C. Gigante, La costruzione di un’identità storica. Massimo d’Azeglio dall’ ‘Ettore Fieramosca’ al ‘Niccolò de’ Lapi’, in Il romanzo del Risorgimento, a cura di C. Gigante e D. Vanden Berghe, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2011, pp. 85-107; Id., « Fatta l’Italia, facciamo gli Italiani ». Appunti su una massima da restituire a d’Azeglio, in « Incontri. Rivi-sta europea di studi italiani », 26 2011, 2 pp. 5-15. Ho proposto infine un’interpreta-zione dei suoi pamphlets politici nell’intervento La nazione necessaria: Massimo d’Aze-glio e il diritto di unirsi ovvero di dividersi presentato quale relazione introduttiva alla terza giornata del Convegno annuale dei comparatisti italiani: La letteratura davanti alla legge (Trieste, 15-17 dicembre 2011).
8. Vd., di chi scrive, Scrittori del Risorgimento “precursori del fascismo”? A proposito di un luogo comune della storiografia letteraria fascista, in « Intersezioni », xxxi 2011, pp. 349-68.
9. Cfr. N. Vaccalluzzo, Massimo d’Azeglio, Roma, Are, 1930, pp. 235-54, nonché W. Maturi, in Dizionario Biografico degli Italiani (d’ora in poi DBI ), Roma, Ist. della Enciclopedia Italiana, vol. iv 1962, pp. 746-52, in partic. pp. 750-51.
effetti dell’unificazione
403
mirante profeta del carattere fragile e artificioso dell’Unità rag-giunta.10
Ma, come ho cercato di dimostrare altrove, le cose stanno in real-tà in modo assai piú complesso; anche negli anni Sessanta, malgra-do indubbie diffidenze, d’Azeglio esprime la sua fiducia nella nuo-va Italia e nella possibilità che all’unificazione politica segua quella morale. In Questioni urgenti, composto sull’onda emotiva dell’Unità appena conseguita, d’Azeglio scrive che « liberar l’Italia, renderla forte, e perciò unificarla, è il pensiero di tutti », lui compreso, « ma non intendiamo che sotto la coperta dell’Italia ci vogliano invece far passare la Repubblica » (p. 13). Anticipando quello che sarà il senti-re di Crispi, d’Azeglio aggiunge che i mazziniani e i repubblicani in ge nere rischiano « di dividere la nazione, e distruggere l’unità di quel l’impulso potente che ci spinge verso l’indipendenza » (p. 18);11 poco piú sotto, reiterando il timore di una divisione fra forze rivo-luzionarie del meridione e forze “costituzionali” del nord, d’Aze-glio sottolinea come chi fomenta i sentimenti repubblicani sia de-stinato a prendersi la responsabilità di dividere l’Italia in due fazioni, l’Italia « la cui salute stava tutta nell’unione » (p. 23). Questo parti-colare stato d’animo spinge d’Azeglio, a proposito della spedizione dei Mille, a riconoscerne il valore irresistibilmente epico: « La poe-sia dello sbarco a Marsala e della conquista dell’Isola, che ricondu-ceva le immaginazioni ai figli di Tancredi d’Hauteville ed a Roberto Guiscardo, elettrizzava l’Europa: mai simil fascino aveva, e con ra-
10. Vd., quale esempio significativo, il discorso tenuto da Dario Bianchi al Con-siglio regionale della Lombardia, il 22 febbraio 2011: quel che qui interessa è che gli scritti di d’Azeglio, e la frase « Fatta l’Italia, ecc. » (che gli è senz’altro attribuita), siano utilizzati come argomenti contro le celebrazioni del centocinquantenario (il discorso è leggibile in rete, sul sito personale del consigliere lombardo).
11. Quanto a Crispi, la consonanza con d’Azeglio non è, ovviamente, sul piano degli schieramenti nel 1861, ma su quello della linea politica postunitaria: l’ex gari-baldino – che era andato su tutte le furie a Milano, nell’aprile del 1860, quando il governatore provvisorio d’Azeglio aveva messo sotto sequestro i fucili destinati a Garibaldi – finí per compiere proprio l’itinerario politico auspicato da d’Azeglio, rinunziando, in nome dell’Unità, agli ideali repubblicani (« la monarchia ci unisce e la repubblica ci dividerebbe »): cfr. Ch. Duggan, Creare la nazione. Vita di F. Crispi, trad. it. Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 285-320.
claudio gigante
404
gione, esaltate tanto le menti » (p. 30); Garibaldi è definito « Valen-tuomo »: « è impossibile non provare simpatia per lui; io lo stimo, perché non ha mai pensato a sé, perché egli dice sempre chiaro quel che vuole e quel che pensa » (p. 26); i Mille, almeno per « la maggior parte », sono « bravi ed arditi giovani » (p. 31). Insomma la distanza profondissima da Garibaldi, denunziata in ogni pagina del pamphlet con toni peraltro molto meno forti di quelli che d’Azeglio usa nella sua corrispondenza privata,12 è una distanza politica, che non an-nulla, tuttavia, di fronte al rapido volgersi degli eventi, il desiderio di costruire la nuova nazione. Due giorni dopo la dedicatoria delle Questioni urgenti, scrivendo a Eugène Rendu, destinatario della piú importante sezione dell’epistolario politico di d’Azeglio (dal 1847 al 1865, proprio gli anni che mancano nei Ricordi), egli riconosce che, quanto all’Italia, « è stata fatta come mai niente del genere è stato fatto al mondo »; malgrado ciò, resterà e dopo magari molti conflit-ti interni riuscirà a trovare il suo equilibrio:
Quant à l’Italie, je reconnais qu’elle s’est faite comme jamais rien de ce genre n’a été fait au monde; mais je pense qu’elle restera, et qu’après Dieu sait combien de tiraillements intérieurs, elle prendra son assiette. Dans la précipitation de cette œuvre il faut voir, non pas le fait isolé, mais l’ensem-ble; et, dans cet ensemble, la preuve que tout le travail existait et était achevé depuis long-temps [sic]. Je suis convaincu que là est la vérité.13
La rapidità del processo di unificazione, tra il 1859 e il ’60, non de -ve insomma fare dimenticare il lavoro compiuto dalle generazioni precedenti; occorre guardare agli eventi recenti senza separarli dal-l’insieme delle battaglie per l’indipendenza (« il faut voir, non pas le fait isolé, mais l’ensemble »). Sono affermazioni importanti per co-
12. Malgrado la dimostrazione di « simpatia », d’Azeglio in Questioni urgenti con-sidera Garibaldi politicamente inaffidabile, perché incapace di sottrarsi dal condi-zionamento dei piú radicali: tanto piú dopo le onoranze e l’assegno di sostenta-mento concesso ai familiari di Agesilao Milano, che aveva attentato senza successo alla vita di Ferdinando II nel 1856 (fu giustiziato a Piazza Mercato). Ma negli stessi mesi, nella corrispondenza privata, si trovano epiteti di tenore ben piú forte: « une nullité absolue comme intelligence » è definito Garibaldi in una lettera al Rendu del 4 gennaio 1861 (Correspondance politique, cit., p. 177).
13. Ivi, p. 178.
effetti dell’unificazione
405
gliere, al di là degli umori, il pensiero di d’Azeglio: perché qui, co-me altrove, egli rivendica il ruolo da lui svolto negli anni dell’attivi-tà politica, dal 1848 al ’52 soprattutto, legando idealmente e storica-mente le circostanze presenti alle azioni intraprese dalla sua gene-razione un quindicennio prima (d’Azeglio portava ancora su di sé i segni della ferita riportata nella battaglia di Monte Berico, nel giu-gno del ’48, combattendo contro gli Austriaci).
Il discorso generazionale ha una sua importanza, in questo con-testo, e lo avrà si può dire sino a I vecchi e i giovani di Pirandello. D’A-zeglio si sente ormai fuori tempo massimo per partecipare alla vita politica, sembra in molte occasioni aver perduto quella capacità di intuire e precorrere che era stata la sua fortuna di politico “dilettan-te”. Pure, nelle sue lettere e nei suoi scritti pubblici, finanche nel suo testamento,14 per non parlare del proemio dei Ricordi, ricorre in-cessantemente l’esortazione alle nuove generazioni a raccogliere l’o-pera già realizzata dai padri superando gli egoismi di parte; ancora nei primi mesi del 1861, scrivendo il 14 maggio a Carlo Stefanoni – un aristocratico romano, esule dopo i casi del ’49, il quale, tornato in Italia nel ’59, si era arruolato a Bologna con l’esercito regolare –, d’Azeglio esclamava fiducioso: « Ora viene il buono! Ora l’Italia è imbastita; bisogna cucirla, e cucirla bene! Da bravi dunque. Lavora-te ognuno nella sua sfera, fatevi onore, ed io, come tutti gli spetta-tori, batteremo le mani ».15 Un mese dopo, scrivendo a Carlo Mat-teucci, d’Azeglio insisteva sulla sua idea che il problema, ormai, era essenzialmente morale: « Per formare solidamente l’Italia, certo ci voglion soldati, amministratori, finanzieri, ecc., ma prima di tutto bisogna creare uomini, e gli uomini si fanno con un’educazione
14. Nel 1857, vergando una delle minute del suo testamento, d’Azeglio aveva raccomandato agli Italiani di superare le « passioni municipali », che facilitavano la dominazione straniera, e di ritrovare la concordia e la forza: « Ricordo però agl’Ita-liani che l’indipendenza d’un popolo è conseguenza dell’indipendenza dei caratte-ri ». Questa minuta è stata pubblicata in molte occasioni; cito da F. Bonola, I patrio-ti italiani: storie e biografie, Milano, Messaggi, 1869, vol. iii p. 57.
15. D’Azeglio, Scritti postumi, cit., p. 429. Con meno ottimismo confessava qual-che anno dopo: « credo che in Italia due o tre generazioni dovranno essere ite a far letame prima che vediamo un bel grano! » (ivi, p. 496, a I. Gabardi, 14.2.1865).
claudio gigante
406
forte e severa ».16 È un pensiero, come già si accennava, che attraver-sa tutta l’opera di d’Azeglio: dagli anni Trenta, quando si giustifica con Manzoni della propria scelta di scrivere un romanzo storico, che sarà l’Ettore Fieramosca, in nome dell’insegnamento morale che il pubblico potrà trarne,17 sino all’ultimo opuscolo Agli elettori, pub-blicato nel giugno del 1865, in cui si rammarica che i caratteri degli Italiani ancora « tentennino ».18
Per inciso, nello stesso scritto del ’65, d’Azeglio invita gli elettori a votare per quei politici che dimostrino di avere « carattere » e, pri-ma di tutto, « per chi vuol far l’Italia assolutamente »: intendendo per far l’Italia, essendo l’Unità politica già avvenuta, il creare un po-polo di persone integre, votate al bene comune, capaci di superare i rispettivi particolarismi (« il nostro vecchio peccato sta sempre in noi, ed è tutt’altro che vinto. Sí tutti abbiamo in un cantuccio del cuore un po’ di guerra civile »); siamo insomma nei paraggi della celebre massima « Fatta l’Italia, facciamo gli Italiani » che frettolosa-mente è stata disattribuita a d’Azeglio, a partire da un volume cura-to da Simonetta Soldani e Gabriele Turi del 1993,19 e che invece può essere riattribuita a chi nei propri Ricordi, ripercorrendo le ragioni che lo avevano spinto a scrivere in giovinezza un romanzo come l’Ettore Fieramosca, aveva scritto:
16. Pubblicata da N. Bianchi, Carlo Matteucci e l’Italia del suo tempo, Torino, Boc-ca, 1874, p. 511; quindi, con correzioni, da A.M. Ghisalberti, Massimo d’Azeglio, un moderato realizzatore, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1953, p. 39.
17. Cfr. M. d’Azeglio, Epistolario (1819-1866), a cura di G. Virlogeux, Torino, Centro Studi Piemontesi, vol. i (1819-1840), 1987, lett. 56 (ad A. Manzoni, 12.7.1831), pp. 82-84, alle pp. 82-83: « Credo che in teoria le vostre ragioni contro il romanzo storico non si possano confutare; da me poi no sicuramente. Ma credo ancora dub-bio se verrà mai il tempo in cui questo vostro giudizio sia adottato dalle masse, ed intanto mi pare che si potrebbe far servir questo mezzo benché imperfetto al bene universale; supposto che vi siano uomini a servirsene, che abbiano talenti e massi-me tali da potersi erigere a maestri del pubblico ».
18. Cfr. M. d’Azeglio, Agli elettori, in Id., I miei ricordi. Scritti politici e lettere, a cura di N. Vaccalluzzo, Milano, Hoepli, 1921, pp. 437-53, a p. 452 (le due citaz. che se-guono sono alle pp. 439 e 450).
19. Fare gli italiani. Scuola e cultura nell’Italia contemporanea, a cura di S. Soldani e G. Turi, vol. i. La nascita dello Stato nazionale, Bologna, Il Mulino, 1993 (vd. l’Introduzio-ne dei curatori, pp. 9-33, a p. 17).
effetti dell’unificazione
407
Io pensavo […] che del carattere nazionale bisogna occuparsi, che bisogna far gli Italiani se si vuol avere l’Italia; e che, una volta fatti, davvero allora l’Italia farà da sé. M’ero in conseguenza formato un piano d’agire sugli animi per mezzo d’una letteratura nazionale, ed il Fieramosca era il primo passo mos-so in questa direzione.20
Che poi questo pensiero sia sovente intercalato, soprattutto nella dimensione privata del suo epistolario, da dichiarazioni di scora-mento nei riguardi del meridione e da dubbi insistiti sulla sua assi-milabilità al resto del Paese è questione diversa e complementare su cui non è necessario insistere in questa sede.21 Semmai, sarebbe uti-le cogliere nelle parole di d’Azeglio un salutare desiderio di farsi da parte – cose di altri tempi, come sappiamo – a beneficio delle gio-vani generazioni.
3. Ippolito e Carlo Nievo 1860-1861
Il marchese Stefanoni, a cui d’Azeglio indirizzava la lettera che citavo piú sopra, conobbe probabilmente a Bologna, dov’era di guarnigione, il tenente di artiglieria Carlo Nievo, uno dei fratelli di Ippolito. Carlo e Ippolito rappresentano in fondo, in seno alla stes-sa famiglia, i due volti delle battaglie tra il 1859 e il 1860: l’uno uffi-ciale dell’esercito regolare, l’altro garibaldino; il terzo fratello, Ales-sandro, significativamente oscilla, negli stessi mesi, tra i due poli
20. M. d’Azeglio, I miei ricordi, a cura di A.M. Ghisalberti, Torino, Einaudi, 1971 (19491), p. 368. Ma per tutta la questione vd. Gigante, « Fatta l’Italia, facciamo gli Italiani », cit.
21. L’episodio piú noto è quello della lettera a Matteucci del 2 agosto 1861, nella quale d’Azeglio s’interroga sul senso della politica repressiva del nuovo stato uni-tario contro il brigantaggio dell’Italia meridionale: nello spirito della lettera, come piú esplicitamente in altre dichiarazioni di quest’epoca, c’è un manifesto scettici-smo nei confronti della possibilità di unire parti tanto diverse dell’Italia. Eppure, col senno di poi, bisogna riconoscere a d’Azeglio di avere intuito molto prima di altri il significato anche politico degli atti di brigantaggio. Cfr. D. Mack Smith, Il Risorgimento italiano. Storia e testi (1968), Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 530-31; si veda anche sull’argomento la lettera alla figlia Alessandrina, in d’Azeglio, Scritti postumi, cit., pp. 380-81, e, soprattutto, le lettere a Eugène Rendu dallo stesso divulgate in Correspondance politique, cit., pp. 203-8.
claudio gigante
408
(Ippolito gli aveva nascosto la sua partenza con Garibaldi perché, come spiega un mese dopo alla madre, « la era impresa cosí pazza ed assurda da non sembrar conveniente l’immischiarvi un fratello »).22 Non è soltanto cronaca familiare: Carlo, l’ufficiale “regolare”, men-tre Ippolito è in Sicilia, partecipa il 18 settembre alla battaglia di Ca-stelfidardo e, qualche settimana dopo, è a Gaeta « assediante » (come lo definisce Ippolito)23 fra gli altri l’ultima resistenza dell’esercito di Franceschiello. Lo scambio epistolare tra i due fratelli rivela insof-ferenza per come le cose si sono messe e delusione per la disformi-tà degli abitanti del Mezzogiorno rispetto alle loro attese. Carlo, addirittura, farebbe « abbruciare vivi » tutti gli abitanti dal Tronto a Gaeta (« che razza di briganti! »): « ho bisogno di fermarmi ed in una città che ne meriti un poco il nome, poiché fin ora – scrive nella nota terribile lettera del 29 ottobre 1860 – sul Napoletano non vidi che paesi da far vomito al solo entrarvi, altro che annessioni e voti popolari! ».24
Poco piú di un mese dopo, Ippolito, nella lettera abbozzata, ma non compiuta, diretta all’amico bresciano Andrea Cassa, branco - la – quanto ai Siciliani – in pensieri dello stesso tenore, anche se espressi in maniera civile:25 poiché si tratta di una lettera mai con-clusa e dunque non spedita è forse lecito dedurre, con le parole della Gorra, « che il Nievo, dopo essersi abbandonato a uno sfogo – comprensibile conseguenza di tanta fatica e tanta tensione – in una piú pacata riflessione lo abbia trovato quanto meno eccessi-
22. I. Nievo, Lettere, a cura di M. Gorra, Milano, Mondadori, 1981, p. 646 (ad Adele Nievo Marin, 24.6.1860, da Palermo). Le citazioni da questa edizione, quan-do presenti nel corpo del testo, sono indicate con l’abbreviazione Lett., seguita dal -le pagine.
23. Cfr. ivi, p. 706: « mi dispiacerebbe di partir ancora senza dar un bacio al po-vero assediante » (a Bice Gobio Melzi, 2.2.1861, da Napoli).
24. In I. Nievo, Lettere garibaldine, a cura di A. Ciceri, Torino, Einaudi, 1961, p. 89.
25. Nievo, Lettere, cit., p. 699: « Che gente, Andrea, che gente! […] Sarà forse colpa del Borbone o del diavolo ma non si può campare un giorno in Sicilia senza mandar a quel paese la razza umana e chi le somiglia! Miracolo e fortuna che tanto senno rimase loro da grattarsi la rogna peggiore e ajutar noi che venivamo a gua-rirla! » (scritta a Palermo, il 5 dicembre 1860).
effetti dell’unificazione
409
vo »;26 anche se l’insofferenza verso la società siciliana, e poi piú ge-neralmente verso i meridionali, affiora in svariati altri passi del-l’epistolario. In ogni modo, Ippolito risponde al fratello Carlo sol-tanto il 9 febbraio del ’61, da Napoli, tre settimane prima di morire (Lett., p. 710):
abbiamo bisogno di grandi scosse per mescolarci bene e costituire l’unità – e tu hai un po’ torto quando giudichi di tutte le Provincie Napoletane da quei pochi contadini-briganti che hai veduto – Intelligenza ve n’ha – so-brietà non manca. Manca il lavoro e questo si insegnerà coll’assicurarne il profitto e coll’attivare l’industria – Rinnova le condizioni di questo paese dal lato comunicazioni e sicurezza e vedrai i miracoli – Del resto ti giuro ch’io ci sto come in una galera, fuori il clima che è insuperabile.
Colpisce la parola miracoli, la stessa che in piú occasioni egli adopera per definire le insperate vittorie garibaldine contro l’esercito napo-letano. Ippolito Nievo è angustiato: non soltanto per i rendiconti finanziari dell’amministrazione siciliana, di cui è il principale re-sponsabile, in qualità di Vice Intendente, dal luglio del 1860,27 ma per un fastidio piú sottile che lui stesso fatica a definire. Un fasti-dio che ritroviamo costantemente – dal Risorgimento alla Grande Guerra – negli sfoghi dei patrioti delusi (ci sono alcune analogie sorprendenti, per esempio, tra Nievo e il Gadda diarista di guerra):28 un fastidio che nasce dal contrasto quotidiano tra la sacralità dell’Idea – la « coscienza d’un gran fine » evocata nelle pagine proemiali delle
26. Nel commento alle Lettere, cit., p. 1129. Sulla stessa lunghezza d’onda è la let-tura di E. Chaarani Lesourd, Ippolito Nievo. Uno scrittore politico, Venezia, Marsilio, 2011, pp. 160-61.
27. Quando l’intendente Giovanni Acerbi parte per la Calabria (cfr. Chaarani Lesourd, Ippolito Nievo, cit., p. 156). Testimonianza insostituibile di questa attività è nell’appendice dell’ed. Gorra dell’epistolario.
28. Vd., ad es., quel che Gadda scriveva il 13 luglio 1916: « Povera Italia! Ci vuole la mia dose di idealismo, di pazienza, di speranza, di fede inalterabile, per tirare avanti fra tante delusioni e amarezze » (C.E. Gadda, Giornale di guerra e di prigionia, in Id., Opere, ed. diretta da D. Isella, Milano, Garzanti, vol. iv 20083, pp. 431-867, a p. 567). Cfr., di chi scrive, « Vogliamo Magenta e Solferino ». Sull’eredità risorgimentale nel giovane Gadda, in « I Quaderni dell’Ingegnere. Testi e studi gaddiani », n.s., xii 2012, n. 3 pp. 137-56.
claudio gigante
410
Confessioni –29 e la realtà delle cose. Sin dal suo approdo a Marsala, Nievo è rimasto colpito dall’aspetto « saraceno » della Sicilia: « Aspet-to africano di quella parte di Sicilia. Donne velate come le sarace-ne »; « aspetto strano di questi semi-selvaggi [sarebbero i pastori] vestiti di pelli di capra »; Salemi è « una vera città, anzi una topaia, saracena »; « Parallelo fra il bournous dei saraceni e lo scapolare dei si-ciliani, non troppo a vantaggio di questi ultimi. Incontriamo i primi frati; ci accorgiamo di essere in pieno medioevo »;30 o ancora: « Mar-cia per Partenico. In questo paese i cani sono ancora occupati a mangiare i Napolitani abbrustoliti [cioè i soldati borbonici, mala-mente giustiziati dalla folla] – non è un sintomo di civiltà ». Finan-che le squadre di volontari siciliani gli appaiono, oltre che molto piú poche rispetto alle previsioni, come bande di « semi briganti » (Lett., p. 641, a Bice Gobio, 28 maggio 1860). Ma è soprattutto, a Palermo, il carattere dei Siciliani di città che lo lascia interdetto: « Qui si vive – scrive alla madre il 24 giugno 1860 – in pieno seicento, col barro-chismo, le raffinatezze e l’ignoranza di allora » (Lett., p. 646); e anco-ra alla madre, una settimana dopo: « I Siciliani son tutti femmine […]; Guaj se fosse toccato a loro liberarci da Maniscalco [capo della polizia borbonica di Palermo], e dagli sbirri »; le squadre di volonta-ri, inizialmente alleate dell’esercito garibaldino, sono soltanto « bri-ganti emeriti che fanno la guerra al governo per poterla fare ai pro-prietari »: ora che i garibaldini sono al governo, devono fare da « ca-rabinieri » contro di loro (Lett., p. 654). E si potrebbe continuare con le osservazioni, divertite ma mai simpatetiche, sulla “buona” socie-tà palermitana.
Quel che consente a Nievo di perseverare nel suo delicato inca-rico è non soltanto il senso del dovere, che lui stesso chiama in causa, ma la preponderanza che l’Idea di nazione e di Unità ha sul-la stessa realtà che si spiega davanti ai suoi occhi. Di fronte alla Sici-
29. I. Nievo, Le Confessioni d’un Italiano, a cura di S. Casini, Parma, Guanda, 1999, vol. i p. 71 (le citazioni dal romanzo sono indicate d’ora in poi direttamente a testo, con l’abbreviazione Conf. ).
30. I. Nievo, Diario della spedizione dal 5 al 28 maggio, in Id., Opere, a cura di S. Romagnoli, Milano-Napoli, Ricciardi, 1952, pp. 1053-60, a p. 1056 (la citaz. che segue è a p. 1059).
effetti dell’unificazione
411
lia reale, balena allora, quale estremo soccorso, quella libresca; an-cora a Bice Melzi scrive da Palermo, il 2 novembre 1860: « ho la nostalgia dei paesi ideali – chi sa che non mi ristori sulle rovine di Segeste e di Selinunte, o sulla vetta nevosa e fumante dell’Etna! » (Lett., p. 685).31 Anche qui è possibile cogliere un’analogia con il si-stema mentale di Gadda: qualche giorno prima di essere catturato nei pressi di Caporetto, descrivendo i sentieri intorno al villaggio di Sverinaz (nell’attuale provincia di Udine), Gadda annotava: « Il pae-saggio autunnale, nebbioso, con dei boschi: come le ideazioni de’ miei poemi: ma ci manca l’anima degli uomini che io immagino; il cap. Beretta e il tenente brontolano per la pioggia »:32 dove è fortis-simo lo stacco tra la maestà “ideale” del paesaggio, degno di una rievocazione letteraria che in una certa misura avrà luogo in segui-to, e l’umano, fatale, brontolare di fronte alle intemperie. Cosí in Nievo di fronte alla Sicilia reale – causa di una drammatica ineludi-bile delusione (sociale, antropologica, ideale) –, balena nelle sue let-tere dell’autunno del 1860, quale estremo soccorso non solo retori-co, la Sicilia libresca, fonte inesauribile di idealità patriottica.
Una geografia e un’antropologia ideali, non solo una storia idea-le, percorrono del resto il capolavoro delle Confessioni: penso natu-ralmente al cap. xvii, quello dell’Epopea napoletana del 1799, in cui Carlino, giunto in Puglia, esalta l’uniformità delle popolazioni ita-liane (« e dal sommo all’imo di questa povera Italia non siamo per tanto diversi gli uni dagli altri come vorrebbero darci a credere ») e in particolare quella delle donne (« Le donne poi, oh le donne si somigliano tutte dall’Alpi al Lilibeo! »: Conf., ii pp. 1057-58),33 fra -si che non è indolore accostare, quasi con impietosa antifrasi, alle
31. E conclude: « Però non saranno altro che ripieghi al bisogno irresistibile di aria lombarda che mi affatica i polmoni ».
32. Gadda, Giornale di guerra e di prigionia, cit., p. 661.33. Nievo non poteva saperlo, ma Manzoni, scrivendo a Lamartine il 6 aprile
del 1848, aveva esclamato: « il n’y a plus de différence entre l’homme des Alpes et celui de Palerme, qu’entre l’homme des bordes du Rhin et celui des Pyrénées » (Lettere, a cura di C. Arieti, Milano, Adelphi, 1986, to. ii p. 435); nelle Confessioni (ii p. 1254) vi è un cenno ai versi infelici del couplet xiii de Le Dernier chant du pèlerinage d’Harold. Colgo l’occasione per emendare un curioso errore – insinuatosi nella tradizione esegetica del romanzo nieviano – ripetuto nei principali commenti in
claudio gigante
412
istintive osservazioni, ricordate poco fa, che Nievo compie sui pri-mi Siciliani in cui s’imbatte e ai giudizi sulle donne formulati in se-guito.34 Sintomatico di questa diffidenza ostile è il riferimento a un quoziente di (in)civiltà saracena che affiora costantemente negli scrit-ti siciliani di Nievo; il lettore delle Confessioni, che non sia guidato da schemi preconcetti tesi all’agiografia dell’autore, sa che nei con-fronti dei Turchi assediatori di Molfetta Carlino Altoviti abbando-na la tonalità media e anti-eroica, che solitamente gli si attribuisce, per divenire un temibile sterminatore (Conf., ii p. 1062):
Io imprecai furiosamente alla barbarie di coloro che davano sí bella parte d’Italia in preda a quei mostri, e mi avventai con Martelli e coi compagni a una tremenda vendetta. Quanti ne incontrammo tanti furono tagliati a pezzi dalle nostre spade, calpestati dai cavalli, e fatti a brani dalla folla di-sperata che ci si ingrossava alle spalle. Sulla piazza ove si era già ritratto il maggior numero per riguadagnare le lancie e buttarsi in mare, la carnefi-cina fu piú lunga e piú terribile. Fu quella l’unica volta ch’io godetti barba-ramente di veder il sangue dei miei simili spillar dalle vene, e i loro corpi sanguinosi ammucchiarsi boccheggianti e ferirsi l’un l’altro nelle convul-sioni dell’agonia.
Altrove, il medesimo Carlino, parlando del ruolo di Venezia, la de-finisce il baluardo « che aveva difeso per tanti secoli tutta la Cristia-nità dalla barbarie Mussulmana » (Conf., i p. 815); in termini analo-ghi Nievo si esprimerà, dopo Villafranca, in Venezia e la libertà d’Ita-lia.35 In questo quadro si svolge nel romanzo l’epopea della lotta per
circolazione (Romagnoli, Gorra, Casini): non Guglielmo, ma Gabriele Pepe sfidò e ferí a duello Lamartine il 19 febbraio 1826.
34. Penso in particolare a un passo di una delle lettere inviate a uno dei Mille, Romeo Bozzetti: « Di questo Palermo io odio oggimai fino le pietre! – Non parlia-mo delle donne che sono stupide, brutte, pretenziose, antipatiche, pettegole, spor-che, ineducate, di cattivo gusto, scimunite; insomma tali quali diventerei io se mi fermassi qui a lungo » (22.11.1860, in A. Nozzoli, Nievo 1860: sulle lettere a R. Bozzet-ti, nel vol. Ippolito Nievo tra letteratura e storia. Atti della Giornata di Studi in memoria di Sergio Romagnoli, Firenze, 14 novembre 2002, a cura di S. Casini, E. Ghidetti, R. Turchi, pref. di P.V. Mengaldo, Roma, Bulzoni, 2004, pp. 59-74, a p. 72).
35. La « secolare e meravigliosa repressione dell’usurpazione Ottomana » fu « la naturale continuazione dell’antica politica Italiana appetto all’Europa, e nella qua-le Venezia durò sola e instancabile; ultima crociata per la difesa della civiltà cristia-
effetti dell’unificazione
413
l’indipendenza della Grecia che, se è trasparente figura del destino gemello che il Nievo del 1858 auspica per l’Italia, è anche interpre-tata come una battaglia di civiltà.
Nel tentativo di percorrere i tratti essenziali dei dialetti italiani, Nievo aveva descritto, qualche anno prima, la Sicilia come la terra dove « per le aperte campagne odi i contadini improvvisare egloghe ed idillii che ricordano i bei tempi di Teocrito »:36 il giovane scritto-re aveva vagheggiato una terra che recasse ancora in sé le tracce vive (non solo le rovine) del suo passato di incunabolo, in Italia, della civiltà classica; il costante riferimento nelle lettere siciliane al quo-ziente “arabo” del paesaggio, anche umano, unite al tiepido e op-portunistico patriottismo delle popolazioni locali, suona come un atto di triste disincanto. Nel Resoconto amministrativo della prima spe-dizione in Sicilia, datato 16 luglio 1860 e apparso una settimana dopo su « La Perseveranza » – firmato dall’intendente Acerbi e comune-mente attribuito a Nievo –,37 si descrivono come « ancora saraceni » i « sentieri » di « questa bellissima parte d’Italia »; nella stessa pagina l’approdo in Sicilia dei Mille è evocato con enfasi quasi epica (« Ma poiché toccammo il sacro suolo dei Vespri […] »): 38 anche fra que-ste righe, destinate a presentare al pubblico la gestione economica della spedizione, trapela uno scarto tra il richiamo alla sacralità del-l’impresa di Garibaldi (« l’angelo della Liberazione » accorso « sul le ali dei venti a liberar la Sicilia »), tributaria di una visione letteraria, quando non retorica, della Storia (con il richiamo immancabile ai Vespri), e il territorio dissestato dell’isola, che della Storia parrebbe recare un’altra versione.
In Sicilia Nievo intravede degli elementi di resistenza non mate-
na che non valse a salvarla dall’immensa ingratitudine Europea » (I. Nievo, Vene-zia e la libertà d’Italia, in Id., Rivoluzione politica e rivoluzione nazionale, a cura di M. Gorra, Udine, Ist. editoriale veneto friulano, 1994, pp. 133-51, a p. 134).
36. I. Nievo, Studi sulla poesia popolare e civile (1854), a cura di M. Gorra, Udine, Ist. editoriale veneto friulano, 1994, p. 61.
37. Dubbi tuttavia sono espressi da Patrizia zambon in margine all’ed., a sua cura, di I. Nievo, Scritti giornalistici alle lettrici, Lanciano, Carabba, 2008, pp. 52-53.
38. I. Nievo, Resoconto amministrativo della prima spedizione in Sicilia, in Id., Opere, cit., pp. 1061-70, a p. 1066 (la citaz. che segue è a p. 1061).
claudio gigante
414
riale – l’esercito borbonico si scioglie come neve al sole – ma mora-le; se il popolo è in fondo in sintonia con il giudizio sulle « plebi » meridionali che lo stesso Carlino aveva dato nelle Confessioni (si ri-cordino le considerazioni sul Regno di Napoli dove la « massima civiltà » sarebbe patrimonio di « pochissimi uomini per lo piú di no-bili o egregi casati », mentre l’abiezione e l’ignoranza sarebbero il fon-do comune del popolo: Conf., ii p. 1060), quel che sembra mancare nella realtà è il contraltare di paladini come Ettore Carafa, dei nobi-li eroi che nel romanzo, da soli, hanno la capacità di riscattare e tra-scinare un popolo altrimenti barbaro. Nella lettera al fratello Carlo, dove, come abbiamo visto, la speranza per il futuro è affidata alla diffusione della cultura del lavoro e dell’industria nel Mezzogiorno, Nievo, dopo aver osservato che è difficile capire « cosa pensi » il « po-polaccio Pulcinella », scrive che per « costituire l’unità » sono neces-sarie « grandi scosse », bisogna « mescolarsi bene » e giungere rapida-mente a Venezia e a Roma (Lett., p. 710): come avverrà anche in altre stagioni – dalle prime spedizioni coloniali sino alla Grande Guerra – la campagna militare per restituire alla nazione ciò che idealmente le spetta è intravista come l’occasione necessaria per temprare i ca-ratteri e formare quell’unità morale senza la quale un popolo non è degno di esistere. Ma soprattutto, ancora una volta, di fronte al-la realtà Nievo innalza la battaglia ideale: Venezia e Roma, i luoghi simbolo di un’intera generazione. Roma, « il nodo gordiano dei no-stri destini », come da sentenza di Carlino Altoviti (Conf., ii p. 1007).
4. Zola 1894-1896
Sul luogo simbolo di due generazioni di scrittori patrioti si è scritto molto: del resto è nell’idea di Roma che confluiscono perso-naggi diversi e fra loro rivali come Mazzini, Garibaldi e da ultimo Cavour, la celebrata trimurti dei manuali di storia patria d’antan. Il controcanto sarà offerto piú tardi da tanta letteratura “indignata” (si direbbe oggi), tra l’Imperio di De Roberto e I vecchi e i giovani di Pi-randello: ma il discorso è piú vasto e piú complesso, quantunque, per le linee generali, soprattutto per il versante “parlamentare”, ab-bastanza noto.
effetti dell’unificazione
415
Su Roma vorrei proporre brevemente un angolo di visuale di-verso: la prospettiva offerta da Rome di zola, romanzo fluviale, pub-blicato nel 1896 in contemporanea in Francia e in Italia, dove appar-ve a puntate su « La Tribuna » prima di uscire in volume.39 zola la-vorò alla stesura del romanzo tra il 1894 (quando effettuò anche un soggiorno di due mesi nella capitale) e la primavera del 1896. La vicenda si situa nell’autunno del 1894, al tempo del secondo gover-no Crispi: una stagione di crisi non soltanto per le conseguenze degli scandali finanziari legati alla Banca Romana e per le infuoca-te tensioni sociali esistenti in diverse aree del Paese, a cominciare dalla Sicilia, ma anche per i dubbi sulla tenuta della stessa Unità.40 zola non sembra compiere sforzi particolari per distinguersi dai luoghi comuni sugli Italiani che si colgono nella stampa coeva d’Ol-tralpe (in particolare gli articoli di René Bazin e Alfred Berl),41 con-dizionati da diffidenze politiche e anche, presumibilmente, dai nu-merosi corollari della cosiddetta “guerra doganale”. Ciò detto, zo-la coglie due temi fondativi della crisi dell’Italia post-unitaria: in primo luogo, lo scarto drammatico tra il mito a lungo vagheggiato della capitale – che per la sola forza del suo passato remoto avrebbe dovuto dare linfa al glorioso futuro della nuova Italia – e l’impasto di corruzione politica e finanziaria che nella realtà si era formato; in secondo luogo, il paradosso di uno stato che costruisce la propria capitale sul principio di un’idea: Roma non è la città che ha guidato il processo unitario né il suo prestigio nasce da una riconosciuta superiorità politica. Il primato di Roma è il frutto allo stesso tempo
39. Rome, par E. Zola, Paris, Charpentier, 1896; Roma, trad. di G. Palma, Roma, Stab. tip. della Tribuna, 1896. Le tappe della composizione (con l’inevitabile dossier di documenti, come da regola per zola e dintorni) sono tracciate da Jacques Noi-ray nella Préface e nella Notice che corredano la sua recente edizione del romanzo (Paris, Gallimard, 1999). Rome è il secondo romanzo della trilogia Les trois villes, che comprende Lourdes e Paris.
40. Cfr. Duggan, Vita di Francesco Crispi, cit., pp. 760-64; F. Cammarano, Storia dell’Italia liberale, Roma-Bari, Laterza, 2011, p. 168.
41. Cfr. R. Bazin, Les Italiens d’aujourd’hui, in « Revue des deux mondes », lxiii 1893, vol. cxviii pp. 47-94 e 524-71; A. Berl, Les deux Rome en 1894, in « La revue de Paris », i 1894, to. v pp. 541-74. Si tratta di articoli che sono stati da tempo segnalati dalla critica zoliana (cfr. Rome, ed. Noiray cit., Notice, pp. 903-5).
claudio gigante
416
di una visione archeologica, non moderna, della Storia e di una co-struzione ideologica: quando questa non sarà piú condivisa, anche il primato verrà meno.
zola immagina che un giovane prete francese, Pierre Froment, protagonista già di Lourdes,42 accorra nel 1894 a Roma per difendere un proprio libro – nel quale ha vagheggiato una profonda riforma della Chiesa – che rischia di essere condannato all’Indice; dopo una lunghissima tortuosa serie di incontri con personaggi di ogni risma, ma in particolare dell’aristocrazia romana, Froment riesce a ottene-re un’udienza da Leone XIII senza per altro riuscire a impedire che il libro sia condannato. Il prete comprende tardivamente di avere coltivato un’illusione impossibile: la Chiesa non potrà mai essere riformata, perché una sua riforma, una sua reale rinunzia alle pre-rogative temporali, significherebbe la fine della stessa istituzione, che ha ragione di esistere soltanto nella sua granitica “romanità”. Lo sguardo del prete si estende quindi sulla capitale del nuovo stato, travolta dallo scandalo finanziario legato alla speculazione edilizia (zola trae informazioni minuziose, al riguardo, dall’articolo di Ba-zin: ma sappiamo dai suoi diari ch’egli stesso, a Roma, volle visitare nell’autunno del ’94 l’immenso cantiere fatiscente nato a ridosso del quartiere Prati); la classe dirigente dell’Italia non sembra neppure lontanamente all’altezza dei voti delle generazioni precedenti che avevano versato il sangue per l’indipendenza e l’Unità. Ne nasce – pur all’interno di episodi invero troppo caricati, simili alle tinte go-tiche di altre generazioni (su tutti l’obbrobriosa storia di amore e morte di Dario e Benedetta, un miscuglio indigesto di clichés lette-rari davvero non all’altezza dello scrittore) – un complesso ragiona-mento sui vecchi e sui giovani, sulle illusioni patriottiche di una generazione tradite dalla malattia affaristica di un’altra, che a mio giudizio (ma mi occuperò di questo in un altro intervento che ho in preparazione) contribuí a ispirare il romanzo pirandelliano, se non altro in forma di reazione: perché ritengo che Pirandello intendesse riproporre nelle sue pagine, in tutta la sua drammaticità, il divario
42. Paris, Charpentier, 1894; trad. di G. Palma, Roma, Stab. tip. della Tribuna, 1895.
effetti dell’unificazione
417
etico-politico fra vecchi e giovani per suggerire, rispetto a zola, tutt’altra chiave di lettura.
Centrale in questa prospettiva – ma non per la trama di Rome, ove occupa un ruolo marginale – è la figura di un vecchio patriota, Orlando Prada, personaggio nel quale zola ha inteso sintetizzare un intero secolo di lotte; dunque, un altro ottuagenario, un milane-se che ha un passato di carbonaro, poi di mazziniano, infine di gari-baldino nel 1848-’49 (partecipa sia alla difesa di Roma che a quella di Venezia); quindi l’esilio a Torino, nel decennio di preparazione, e la conversione alla causa sabauda; la partecipazione alla battaglia di Magenta, nel ’59; un anno dopo Orlando è fra i Mille che sbarca-no a Marsala; ancora, come non bastasse, si trova con Garibaldi in Aspromonte, nel ’62; a Custoza nel ’66; a Mentana nel ’67, ed è, neanche a dirlo, dopo essere in fretta rientrato fra le armate regola-ri, fra i primi bersaglieri che varcano la breccia di Porta Pia: piú che un percorso « classico » – come l’ha definito Sophie Guermès, che ha avuto il merito di richiamare di recente l’attenzione, in chiave risorgimentale, su questo romanzo –43 si tratta di un percorso “idea-le”; Orlando è un vero e proprio maratoneta delle battaglie per l’Unità; la sua biografia di patriota onnipresente – dalla Carboneria a Porta Pia – non ha corrispondenze precise con nessuno dei prota-gonisti del tempo.44
Orlando Prada, piú volte ferito in giovinezza, è vissuto nel mito dell’Unità e nel culto di Roma; colpito adesso da paralisi, costretto all’immobilità – ma non afasico, a differenza del dumasiano Noir-tier de Villefort che forse gli ha prestato qualche tratto (come sug-gerisce Tilli Bertoni nel suo saggio nel presente volume) –, vive al
43. Cfr. S. Guermès, Fiction et diction du Risorgimento dans la littérature de langue française, de Charles Didier à Émile Zola, nel vol. Il romanzo del Risorgimento, cit., pp. 211-27, partic. pp. 217-18. Al romanzo, da altre prospettive, sono dedicati quattro contributi del vol. Il terzo Zola. Émile Zola dopo i ‘Rougon-Macquart’, a cura di G.C. Menichelli, Napoli, Ist. Universitario Orientale, 1990, pp. 141-213.
44. Secondo Noiray, nelle note di commento dell’ed. cit., zola avrebbe tratto spunto per Prada dalla vita di Garibaldi: ma è francamente difficile seguirlo in questa direzione. Quanto all’aspetto fisico, invece, zola s’ispirò a Enrico Cernu-schi, che aveva avuto modo di conoscere durante il lungo esilio di questi in Francia (ed. cit., p. 948).
claudio gigante
418
piano alto di un edificio, ironia della sorte, di via XX settembre, dal quale si dispiega uno dei piú suggestivi panorami di Roma. Il vec-chio Orlando vive di questo panorama, che simboleggia tutto quel-lo che ha desiderato nella sua vita; si abbevera di questa visione quasi a volere cercare un sostegno capace di conferirgli un nuovo orizzonte ideale, di fronte alla devastazione morale del presente: che non è soltanto dovuta alla corruzione del mondo politico, che pure ha un suo peso, ma alla scoperta che l’Unità è ancora da farsi (non manca il richiamo a d’Azeglio),45 perché i cittadini del nord e del sud hanno alle spalle secoli di culture differenti e continuano a restare moralmente distanti. È la solita visione di maniera, secondo cui da un lato ci sarebbe « le Nord travailleur et économe, politique avisé, savant, tout aux grandes idées modernes », dall’altro « le Midi ignorant et paresseux, tout à la joie immédiate de vivre, dans un désordre enfantin des actes, dans un éclat vide des belles paroles so-nores » (p. 211), politicamente formato da individui scaltri e traffi-chini che concepiscono la costruzione della nuova capitale soltanto come un colossale affare, senza alcuna prospettiva di grandezza ideale. Fonte di queste asserzioni – fastidiosamente fondate su pre-giudizi in senso lato “razzisti” – è l’articolo di Berl che, oltre a de-scrivere i caratteri dei meridionali e dei settentrionali in termini che zola riprende alla lettera,46 propone la medesima visione della nuo-va capitale e del nuovo stato militarmente conquistati dalle forze del nord, ma politicamente preda dell’ “avido” attivismo meridio-nale.
Ma non è solo un problema nord-sud: c’è anche, vivissima, come accennavo piú sopra, la questione generazionale. Luigi, il figlio di
45. Cfr. Zola, Rome, ed. Noiray cit., p. 223 (le pagine d’ora in poi direttamente a testo, fra parentesi).
46. Cfr. Berl, art. cit., p. 551: « L’Italien du nord, calme, brave, industrieux, robu-ste, instruit, économe et intègre, apporte dans la vie publique ces qualités solides et foncières. Le Méridional est tout autre d’esprit, de caractère, de tempérament. Impressionnable et mou, facile et spirituel, prompt d’esprit et d’imagination, mo-queur et pétulant, il est aussi d’une ignorance profonde, d’un individualisme ef-fréné, incapable d’effort […] et surtout, en matière politique, sans scrupules et sans moralité ». E vd. anche Bazin, Les Italiens d’aujourd’hui, cit., pp. 86-87.
effetti dell’unificazione
419
Orlando, allevato dal padre nel mito della costruzione nazionale, è divenuto uno dei piú intriganti affaristi della nuova capitale; avido e senza scrupoli, ammira il padre ma non riesce a farsi contagiare dalla sua passione né dai suoi ideali. I “vecchi” muoiono e non c’è un “giovane” che ne prenda il testimone ideale, grida Orlando (p. 208):
Oui, oui! lança-t-il dans un dernier cri, on donnait tout, son cœur et sa tête, son existence entière, tant qu’il s’est agi de faire la patrie une et in-dépendante. Mais, aujourd’hui que la patrie est faite, allez donc vous en-thousiasmer pour réorganiser ses finances! Ce n’est pas un idéal, cela! Et c’est pourquoi, pendant que les vieux meurent, pas un homme nouveau ne se lève parmi les jeunes.
L’ardore dei “vecchi” per la conquista dell’Unità e di Roma, deside-rata come e piú di una donna, anche la piú amata (« Moi, je l’ai aimée et voulue plus qu’aucune femme », p. 204), si è trasformato nei “gio-vani” non soltanto in sete di affari, ma anche in una sorta di abulia di ideali, quasi un tragico contrappasso delle passioni dei “vecchi”. Se il vecchio Orlando ancora spera nella grandezza di Roma e nell’Uni-tà dell’Italia, la sua speranza è rappresentata come una lontana futu-ra utopia, che non ha alcun rapporto con il presente, ma è soltanto nutrita da un’incrollabile fede nell’Idea di nazione (« L’Italie renaî-tra dans sa glorie ancienne, dès que le grand peuple de demain aura poussé de terre! », p. 847); mentre nei pochi “giovani” dove sono an-cora vivi i semi dell’ideale inizia a serpeggiare un desiderio di anar-chia e distruzione: è il caso del giovane Mascara, tipica figura di an-gelico Gutmensch, che sogna di radere Roma al suolo per poterla ri-costruire daccapo. Il suo aspetto efebico – in linea con una tradizio-ne di angeli potenzialmente sterminatori che si ritrova anche, da noi, in De Roberto, Pirandello e Borgese – è in voluta contraddizio-ne con i propositi esplosivi: Mascara è il nipote ventenne di uno dei Mille, morto in Sicilia mentre combatteva insieme a Orlando Pra-da. È un anarchico che non ha piú fiducia nelle parole dei “vecchi” e non crede al mito della terza Roma: insegue, con i suoi compagni, il mito della quarta Roma, che rinascerà dalle ceneri di quella che i patrioti dell’altra generazione si erano illusi di edificare.
claudio gigante
420
5. Carpi 1878
Concludo ricordando un libro per molti versi straordinario, oggi quasi dimenticato, L’Italia vivente di Leone Carpi,47 « il primo tenta-tivo di costruire un quadro sociologico d’insieme della società ita-liana »,48 che apparve nel 1878. Fondandosi su un nutrito numero di informazioni raccolte attraverso le prefetture del Regno49 e altre fonti confidenziali,50 Carpi, unitarista convinto per fede (poteva fra l’altro vantare la partecipazione alla Costituente della Repubblica romana, nel ’49) ma desolato di fronte allo spettacolo che l’Italia gli offre, cerca di tracciare un profilo morale delle classi agiate del Pae-se. Del primo corpo sociale analizzato, l’aristocrazia, Carpi ritiene fedele ai Savoia la piemontese, la ligure e la sarda (insomma il nu-cleo fondativo del Regno) e considera affidabile l’aristocrazia lom-barda, che aveva a suo tempo osteggiato l’Austria; inerti, ma sostan-zialmente fedeli, sono invece i nobili di Veneto e Toscana, mentre gli risulta ostile al « nuovo ordine di cose instaurato in Italia » gran parte dell’aristocrazia « degli spenti ducati di Modena e Parma » (p. 71). Quanto alla « aristocrazia napoletana », scrive (p. 72): « a che gio-va dissimularlo? », soltanto
Una piccola minoranza propugna con nobile ardimento i principj liberali, e si è legata con affetto alla Dinastia sotto la di cui bandiera incontaminata ricompose l’Italia le sue membra lacerate, a dignità di nazione. La grande
47. L. Carpi, L’Italia vivente. Aristocrazia di nascita e del denaro. Borghesia - Clero - Bu-rocrazia. Studi sociali, Milano, Vallardi, 1878 (su Carpi vd. R. Romanelli, in DBI, vol. xx 1977, pp. 599-604).
48. Bollati, L’italiano, cit., p. 150. Non mi sembra peraltro corrispondere allo spirito del libro di Carpi il giudizio di Bollati secondo cui l’autore non dedichereb-be alle classi popolari « trattazioni specifiche, essendo sottinteso che non interessa-no come classi, ma soltanto come problema » (ibid.).
49. Il tramite delle prefetture era già stato utilizzato dal Carpi per le sue indagi-ni sulla emigrazione degli italiani (Dell’emigrazione italiana all’estero nei suoi rapporti coll’agricoltura, coll’industria e col commercio, Firenze, Civelli, 1871).
50. Cioè, « quanti uomini fra i piú insigni abbia in ogni angolo l’Italia, per cultu-ra, ingegno, rettitudine e fine discernimento, senza distinzione di partiti politici » (Carpi, L’Italia vivente, cit., p. 14: le pagine d’ora in poi direttamente a testo, fra pa-rentesi).
effetti dell’unificazione
421
maggioranza di essa è [invece] borbonica, e tiene bordone a quella parte del clero, che non è piccola, nemica dell’indipendenza e dell’unità d’Italia […].
Tuttavia, « Molle per costumi », l’aristocrazia napoletana non è pe-ricolosa, come non lo è quella di Sicilia, che secondo Carpi è avver-sa tanto ai Borboni quanto all’Unità e ai Savoia. Un giudizio affine è riservato all’aristocrazia romana che, se « per tradizioni nobiliari e per ricchezza è forse collettivamente la piú potente », nondime-no, « nella sua grande maggioranza » essa sarebbe « nemica dell’unità d’I talia, fieramente e disdegnosamente avversa alle istituzioni libera-li e costituzionali » (p. 73). Insomma, sia pure a grandi linee e pur commettendo, quanto al Mezzogiorno, il comune errore ottocen-tesco di identificarlo con il Napoletano e la Sicilia, Carpi ritiene omo genea e affidabile solo l’aristocrazia del centro-nord, eccezio-ne fatta per i piccoli ex ducati.
Passando alla condizione morale, lo sguardo di Carpi appare de-solato: nell’aristocrazia si scorgono avarizia, « pregiudizi di casta », « bigottismo » e « superstizione » (pp. 104-5). Bisognerebbe riuscire, attraverso un’azione politica mirata, a responsabilizzarla per ren-der la uno « dei propugnacoli piú efficaci della libertà, del progresso, del la potenza e dell’estimazione dell’Italia redenta », sfruttando ma-gari la sola dote che sembra sopravvivere negli antichi lignaggi: il senso dell’onore (p. 119). Carpi si avventura quindi in vaghe e utopi-stiche proposte di riforma dello status nobiliare (per esempio l’idea di espellere chi se ne dimostri a vario titolo indegno) che sembrano avere la sola funzione di tenere in piedi il disegno ideale, di costru-zione unitaria e nel contempo di conservazione sociale, che egli nutre. Il problema, anche per lui, nasce in primo luogo dalla man-canza di « carattere » del popolo italiano (p. 229):
Questa diagnosi, che io faccio della società italiana, rende pur troppo evi-dente il fino buon senso di quell’illustre uomo di Stato, che fu Massimo d’Azeglio. Egli aveva ragione quando diceva « L’Italia è fatta, gli Italiani sono da farsi »;51 ed è perciò che manca ancora a noi il carattere tipico nazionale,
51. Sia detto en passant, questa citazione è una delle prove che la massima era attribuita a d’Azeglio già negli anni Settanta (secondo Soldani-Turi, Fare gli italia-
claudio gigante
422
e quel fiero ed alto sentimento collettivo della dignità nazionale, che ren-de potenti i popoli. Uomini d’onore e di forte tempra vi furono sempre, presso tutte le nazioni, ma rari sono per avventura i popoli di carattere. Avvegnaché, per formare un popolo di carattere, occorra che per lunga stagione sia di carattere la grande maggioranza dei cittadini […].
Non bastano, insomma, le azioni individuali « d’insigne patriotti-smo » o di personale abnegazione: in Italia « non appena furono ces-sati lo stimolo e l’effervescenza momentanea » delle battaglie unita-rie, « si fece manifesto, ora per l’atonia che ci colse, ed ora per in-composte manifestazioni di basse gelosie, e per ambiziose pretese », come mancassero « ancora gli elementi di coesione, e le qualità mo-rali che rendono veramente una nazione di carattere ». Carpi indi-vidua lucidamente i due punti di debolezza della rivoluzione italia-na: le poche « menti elette » che l’hanno voluta di fronte alla « gran massa delle attonite popolazioni », che l’hanno soltanto subita; e, d’altro canto, l’esito « rapido e fortunato » che ha impedito un reale processo di educazione patriottica del popolo. « Mal si compresero le grandi difficoltà che offre, ed offriva, il riunire in breve lasso di tempo ad un pensiero e ad un’azione comune » gli antichi stati ita-liani; « quindi si alimentò il vezzo di demolire, di sprezzare, e spesso di oltraggiare le piú intemerate individualità, solo perché non pos-sedevano la verga miracolosa del taumaturgo legislatore ». Il quadro generale, nel 1878, pare a Carpi disastroso: nelle città italiane vi è un « pubblico inerte e non curante », senza fiducia in sé, senza alcun sentire, apatico: « Generazione infingarda, che deve rinsavire, o ri-cadere nell’oblio meritato » (pp. 236-38).
Straordinariamente attuale è il cap. viii, La moralità in Italia, per le sue pagine sull’evasione fiscale che è attribuita in larga parte all’« in-consulto procedere » dei vari governi pur di « raggiungere il pareg-gio »; una politica di bilancio puramente contabile che non tiene conto della miseria dei lavoratori; una politica economica che inse-gue un equilibrio astratto « senza por mente ai rudimenti della giu-
ni, cit., vol. i p. 17, essa invece « venne formulata solo molto piú tardi, nel 1896, nel pieno della crisi di identificazione del paese creata dalla sconfitta di Adua, dall’ex ministro della Pubblica istruzione Ferdinando Martini »).
effetti dell’unificazione
423
stizia distributiva ». Le misure fiscali, vissute dal contribuente come esose e vessatorie, gli fanno sembrare oneste le astuzie per « frodare il tesoro nazionale » (pp. 267-68). Notevoli sono anche le pagine de-dicate al « favoritismo »: « Tutto, o quasi tutto », scrive Carpi, si ottie-ne in Italia « mercè delle sollecitazioni, delle raccomandazioni, de-gli impegni d’alti personaggi, se non piú dall’alcova come in altri tem-pi piú molesti » (p. 268); « è invalsa per tutta Italia », commenta scon-solato, « la degradante convinzione che nulla possa ottenersi anche di giusto e di onesto dalle pubbliche amministrazioni senza pre-ghiere, senza sollecitazioni e senza potenti influenze » (p. 269). Pre-gnanti sono infine le pagine sulla « Maffia » in Sicilia e la « Camorra » a Napoli: pur condannando quanti attribuiscono a tutti i meridio-nali un’indole o un’appartenenza mafiosa, Carpi s’inquieta nel con-statare la collusione con la malavita persino di parte delle classi col-te e civili (pp. 270-72).
Il ritratto sociale dell’Italia che Carpi realizza, pur fondato su un modo dubbio di raccogliere i dati, appare – fatte salve le ovvie dif-ferenze – in drammatica sintonia con il nostro tempo: segno che i problemi da lui lucidamente individuati non sono stati se non in minima parte risolti. Ma dalla sua, quale estremo retaggio dell’espe-rienza risorgimentale, vissuta in proprio sia nella stagione cospira-tiva, sia in quella dell’effimera Repubblica romana e del successivo esilio politico, Carpi poteva vantare un’incrollabile fiducia nel futu-ro destino dell’Italia: ancora per lui la forza dell’Idea si sovrappone-va allo squallore del presente; gli errori, molti, troppi, gli appaiono, in fondo, come dolorosi incidenti che nulla tolgono alla grandezza del disegno unitario e che sono naturali ostacoli da superare per con-seguire, come scrive, una « redenzione » compiuta.
Ed è forse di qui che occorrerebbe ripartire.