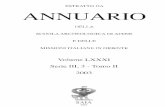S. Ippolito, Caltagirone: nuovi dati sull’abitato dagli scavi Orsi
Transcript of S. Ippolito, Caltagirone: nuovi dati sull’abitato dagli scavi Orsi
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA
RIVISTA DI SCIENZEPREISTORICHE
fondata da Paolo Graziosi
LXIV - 2014 - Firenze
RIV
ISTA D
I SCIE
NZ
E PR
EIST
OR
ICH
EL
XIV
- 2014 - Firenze
RIVISTA DI SCIENZE PREISTORICHEdell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria
redazione e amministrazioneVia S. Egidio 21 - 50122 Firenze
Tel. 055 2340765; fax: 055 5354821; e-mail: [email protected]
Direttore responsabileRaffaele C. de Marinis
Comitato di letturaClarissa Belardelli, Maria Bernabò Brea, Daniela Cocchi Genick, Isabella Damiani, Raffaele C. de Marinis, Giovanni Leonardi, Franco Marzatico, Monica Miari, Lucia Sarti
Prezzo per l’Italia e per l’estero € 95,00Per i volumi precedenti prezzi vari a seconda della disponibilità
(sul sito www.iipp.it)
ISSN 0035-6514
Jean Vaquer, Les pratiques funéraires au Néolithique moyen dans le Midi de la France .........
Maria Maffi, Il Neolitico Recente Emiliano (NRE): proposta di definizione ..........................
Günther Kaufmann, L’ascia dell’Uomo venuto dal ghiaccio .................................................
Nuccia Negroni Catacchio, Elsa Pacciani, Erika Albertini, Matteo Aspesi, Jacopo Moggi-Cecchi, Nuovi dati su alcune necropoli rinaldoniane. Revisione di vecchi scavi, nuove datazioni e recenti analisi dei resti scheletrici ..............................................................................
Anita Crispino, S. Ippolito, Caltagirone: nuovi dati sull’abitato dagli scavi Orsi ....................
Maria Clara Martinelli, Francesca Cannizzaro, Milena Gusmano, Considerazioni sulla facies di Malpasso nella cuspide orientale della Sicilia e nelle isole Eolie .........................
Davide Tanasi, Rappresentazioni naturalistiche nella ceramica del Bronzo Antico Siciliano: il caso di Grotte di Marineo (Licodia Eubea, Catania) ...................................................................
Carlo Veca, Contenitori “per i vivi” e contenitori “per i morti” a Thapsos (Siracusa): un approccio tecnologico a un problema interpretativo ....................................................................
Biancamaria Aranguren, Maria Rosaria Cinquegrana, Alberto De Bonis, Vincenza Guarino, Vincenzo Morra, Marco Pacciarelli, Le strutture e lo scarico di olle del Puntone Nuovo di Scarlino (GR) e i siti costieri specializzati della protostoria mediotirrenica ........................
Gianni Santuari, Umberto Tecchiati, Due ganci di cintura in bronzo di cui uno traforato tipo Castaneda (età antico La Tène) da Collalbo-Bolzano
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA. Attività degli anni 2013 e 2014
Norme per gli autori ...............................................................................................................
5
25
57
83
115
151
193
203
227
259
281
297
Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria
Rivista di ScienzePreistoriche
fondata da Paolo Graziosi
LXIV - 2014 - Firenze
Introduzione
Il sito di S. Ippolito o del Bersaglio, ubica-to 4 km a Nord - Est di Caltagirone (Catania), rappresenta uno tra i più importanti complessi di età pre e protostorica nella Sicilia centro - me-ridionale.
Sebbene l’area sia stata frequentata ininterrot-tamente a partire dalle fasi più antiche della prei-storia, essa è nota soprattutto per la caratteristica classe ceramica che prende il nome dal sito, cro-nologicamente collocata da Luigi Bernabò Brea alla fine dell’Eneolitico e in relazione, almeno per alcune forme ceramiche, con facies culturali di origine cipriota e cretese (Bernabo Brea 1988, pp. 493-506).
L’interesse recente su questo insediamento (Procelli 2001, Alberghina e Gullì 2011, Alber-ghina 2012, Martinelli e Procelli 2012) e sulle problematiche relative alla collocazione crono-
logica dello stile ceramico eponimo, quale fase autonoma ed alla base della formazione del Bron-zo antico siciliano o strettamente legata a quella Malpasso, non ha tuttavia mai preso in conside-razione l’intero sviluppo cronologico del sito, accennando appena alla continuità di frequenta-zione dell’abitato, che, dall’esame della cerami-ca recuperata da Paolo Orsi, nasce nel Neolitico medio1.
La presente ricerca, che segue un breve reso-conto preliminare (Crispino 2012), vuole invece, attraverso l’analisi dei reperti ceramici recuperati grazie alle indagini di Paolo Orsi- le uniche ad oggi edite-, spostare l’attenzione dallo studio del-la singola fase ceramica (Cocchi Genick 2005) ad
1 La presenza più antica testimoniata sul colle S. Ippolito si data al Neolitico medio (Stentinello) a cui appartengono alcuni frammenti caratterizzati dalla tipica decorazione ad impressioni; limitate ma sufficienti a dimostrare la continuità di vita dell’insediamento, sono le testimonianze relative alle fasi successive, attestate dalla ceramica tipo Serra d’Alto, documentata da una presa a cartoccio semplice e da un fram-mento di scodella carenata di impasto simile. Ben rappresen-tata la fase Diana da prese a rocchetto allungato.
SUMMARY - S. Ippolito, Caltagirone: new data on the settlement from excavations by P. Orsi - The paper aims to investigate the mostly unpublished archaeological record, brought to light in the S. Ip-polito hill, Caltagirone (Catania), during the explorative campaigns carried out by Paolo Orsi since 1906. The archaeological collection, stored in the Museo Archeologico Regionale of Syracuse, includes mainly pottery dating to Copper Age, with a long-term sequence, until the late phase corresponding to the homonymous fa-cies. However, the absence of information on stratigraphic data, suggests to illustrate the pottery according to typological criteria, as well as the the most recurrent shapes and decorative patterns. The presentation of the material is enriched with useful information from the unpublished Orsi’s notebooks.
Parole chiave: Eneolitico, ceramica, abitato, inquadramento crono-tipologico, Sicilia, Paolo OrsiKey words: Copper Age, pottery, settlement, chrono-typological classification, Sicily, Paolo Orsi
S. Ippolito, Caltagirone: nuovi dati sull’abitato dagli scavi Orsi
Anita Crispino (1)
Rivista di Scienze Preistoriche - LXIV - 2014, 115-149
(1) Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali Piazza Duo-mo 14, 96100 Siracusa tel. 0931 4508242: e-mail: [email protected]
116 Anita Crispino
una valutazione complessiva, volta a meglio in-dagare l’origine e l’evoluzione della fase stessa. La lettura, inoltre, dei taccuini di scavo redatti al momento delle indagini da Orsi e dal disegnatore Rosario Carta ha permesso l’acquisizione di dati sull’abitato finora inediti.
Storia delle indagini archeologiche
Il colle, di formazione gessosa, si erge per un’altezza di 429 m. s.l.m., isolato da ogni parte, alle sorgenti del fiume Caltagirone, dominando il passaggio tra la piana dei Margi e quella del Signore: “... Una piccola fortezza naturale che aveva il vantaggio di potersi approvvigionare dell’acqua fluviale oggi scarsissima, allora ab-bondante e defluente alle sue radici”.
Così scriveva Paolo Orsi nel 1928 in una nota che costituisce l’unica relazione sugli scavi con-dotti sul colle (Orsi 1928, p. 83). Lamentando la distruzione di parte del terrazzamento a causa dell’apertura di cave di gesso, egli individuava due stanziamenti di cui il primo, il più antico, con materiale archeologico riferibile al Primo Periodo Siculo della sua classificazione2, insieme a debo-lissime tracce di “industria stentinellese con ca-panne e focolari”; un altro abitato, di epoca più recente, era ubicato sulla cima del colle dove ven-nero alla luce altri resti di capanne. Una piccola necropoli di 20 tombe del tipo a forno scavate nel calcare fu rintracciata a circa 350 m. dal villaggio inferiore.
Grazie alla consultazione degli inventari del Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, alla lettura dei taccuini dello studioso roveretano e dei rapporti scritti a seguito di vari sopralluoghi dal custode Domenico Inglieri, si è potuto ricostru-ire la successione delle varie visite e delle brevi campagne di scavo effettuate fin dal 1906 nel sito, di cui l’ultima, dell’agosto 1928, portò alla nota pubblicazione nel Bullettino di Paletnologia3.
Nel giugno 1907 Paolo Orsi scrive (Taccuino n. 66): “A mezzogiorno del Colle, davanti la cava
2 Per Siculo I Orsi intendeva la ceramica dipinta a motivi geometrici simile a quella recuperata nella necropoli del pri-mo Bronzo di Castelluccio.3 Il sito viene segnalato a Paolo Orsi nel giugno 1905 dallo studente liceale Salvatore Bazzano.
e la piccola fornace del gesso, si stende un piano messo a frumento ed olivi proprietà del Cav. Fran-cesco Beninato di Caltagirone. Questo piano era tutto occupato da capanne, il suolo è pieno di cocci ed ossa a testimoniare la potenza e la lunga durata del villaggio ed ho esaminato il margine limitrofo che costeggia il piccolo rigagnolo, scendente da Sud e che con secolare lavorio ha roso il fianco della terrazza. Quivi sul fianco sud roso dal riga-gnolo si vedono i banchi a filari neri di carboni pieni di detriti di industria umana; nella scarpa sottostante si notano centinaia e centinaia di ossa di animali e di cocci di tutte le epoche. Il materiale stratificato ed i fondi di capanne si avvertono da 2 sino a 8 – 10 mt ed io non riesco dalla visita di oggi a capire se si tratti di un colossale scarico per secoli e secoli buttato sul margine del burrone ovvero di vere e proprie capanne stratificate. Pare anzi che le più profonde fossero le più antiche, cioè quelle del I periodo. Certo è che in questa fiancata rotta dal fiume vi è un materiale enorme, dove in un’ora ho raccolto parecchi giarroni. Enorme è il numero delle ossa di mammiferi, anche grandi da cui si potrebbe magnificamente ricostruire la fau-na di questo popolo di cacciatori e di mandriani“.
Il materiale recuperato, subito inventariato, comprende industria litica e ceramica databile dalla fase iniziale alla finale dell’Eneolitico.
Nel 1919 il custode Domenico Inglieri4 scrive: “Dal giorno 10 al 16 (Ottobre) si sono eseguiti saggi di scavo alle falde del Poggio per la ricerca di tombe e del villaggio siculo di cui si riteneva l’esistenza e pel recupero del materiale archeolo-gico colà esistente e si sono rinvenuti moltissimi frammenti di terrecotte sicule del I periodo, fram-menti di coltelli di selce e ossidiana e qualche cu-neo logorato dal tempo.
Dal giorno 17 al 20 si è lavorato nella parte più alta del Poggio e propriamente dove il terreno è letteralmente coperto di frammenti di terrecotte. Si sono scavate 10 trincee, ma quasi senza risul-tati, solo in due trincee si rinvenne una grandis-sima quantità di pietrame arenario squadrato ad arte ma bruciato dal fuoco e sotto a questo una grande quantità di frammenti di cocci decorati a figure geometriche del 4 periodo e cioè del perio-do greco – siculo, anche queste bruciate; inoltre
4 Rapporto 417 del Novembre 1919 – Archivio Storico So-printendenza di Siracusa.
117S. Ippolito, Caltagirone: nuovi dati sull’abitato dagli scavi Orsi
fra la cenere si rinvennero ossa di animali in parte bruciate e carbone vegetale. Di prima vista tutto quel pietrame accatastato mi aveva fatto nascere la speranza che ivi fossero delle capanne ma col progredire del lavoro però mi son formata piena convinzione che fossero delle abitazioni a forma di casette ma completamente devastate, al punto tale da non poterne rilevare una piantina; solo qual-che gruppo di pietre si trovava a posto e formava qualche frammento di muro, a questa devastazione ha contribuito anche la natura del terreno molto scosceso, la poca terra e anche i ripetuti saccheggi praticatovi dalle diverse generazioni, come pure le grandi piogge che coll’andare dei secoli hanno quasi denudato l’intero poggio di natura roccioso.
Dal 21 al 24 si è ritornato a lavorare alle fal-de del Poggio per completare minuziosamente l’esplorazione di quel tratto di terreno. Si sono scavate 7 grandi trincee che variano da 2 a 4 me-tri di profondità e da 3 a 4 in lunghezza; si sono rinvenuti pochi frammenti di terrecotte e di col-telli ed una grande quantità di ossa di animali e tre corna di cervo in frammenti; inoltre ho fatto scavare superficialmente in lungo e in largo tutto il rimanente terreno per circa 700 metri quadri e propriamente dove erano tracce di terrecotte e si sono rinvenuti n. 3 ascioline ben conservate, n. 8 cunei, coltelli di selce e di ossidiana dei quali 3 interi e moltissimi in frammenti, n. 6 fra pun-teruoli e stecche di ossa di animali, n. 5 cuspidi pienamente lavorate e ben conservate.
Tutto il terreno scavato alle falde è un miscu-glio di ossame, frammenti di terrecotte e di selce e perciò si può stabilire con sicurezza che è un terreno di riporto”.
La maggior parte dei frammenti di datazione più tarda, di cronologia compresa tra il XIII e il VII sec. a. C., risultano infatti inventariati dopo questa campagna di scavo.
Ancora Inglieri5: “... sebbene abbia trovato il terreno dove è lo scarico delle capanne sicule in parte coltivato a fave e in parte preparato per la semina del grano, ciò nondimeno con un solo ope-raio mi sono messo all’opera e ho rinvenuto tre frecce di selce intere ben conservate e ben lavorate ed una con le alette spezzate, una grossa cuspide pure di selce, frammenti di coltelli di selce e di os-
5 Rapporto 623 del 18 Dicembre 1920.
sidiana, un grosso nucleo di ossidiana, poche ossa di cervo, una punta di pugnale in rame, una stecca di osso e frammenti di terrecotte”.
Il più cospicuo lotto di materiale proviene dall’ultimo scavo effettuato da Orsi nell’agosto 1928; scarne le annotazioni sul taccuino, il n. 140: “Mi preme ricordare la presenza di vasella-me scarso ma vicino alla ceramica Stentinello - Matrensa; dunque il Bersaglio è l’unica stazione della Sicilia nella quale sia rappresentato il proto - presiculo e il I, II e III periodo …”.
Più interessante il resoconto, effettuato da Ro-sario Carta, che scrive nel taccuino n. 138 (set-tembre 1928): “Il fianco di sud e di sud-ovest (…) scende ripido e inaccessibile fino al piano (un centinaio di metri di altezza), ivi si trova un ter-reno piano e leggermente declinante verso NO. In un piccolo tratto di questa spianata (…) si erano annidati in epoca neolitica dei siculi, formando un villaggetto verso il margine del torrentello che scende da quel lato del monte intaccando forte-mente il suolo cretaceo e gessoso (…) (fig. 1).
Fig. 1 - Sezione stratigrafica. Taccuino n. 138 di Paolo Orsi redatto da Rosario Carta. Siracusa Museo Archeolo-gico Regionale “Paolo Orsi”.
Section. Paolo Orsi Notebook n. 138 written by Rosario Carta. Syracuse, Regional Archaeological Museum “Pa-olo Orsi”.
118 Anita Crispino
Gli scavi che ora si fanno, di fatti sono esegui-ti rivoltando man mano tutto il terreno, e così si deve fare per non lasciare tanti piccoli oggetti che sono cosparsi qua e là nei diversi strati. È un banco di terra che procedendo verso il torrentello si va approfondendo come si vede nella sez. A - B (fig. 2) sicché abbiamo delle piccole profond. con delle grandi che arrivano a superare i tre metri.
Scavando man mano tutto il terreno si è venuto a trovare un cumulo di pietrame grosso e piccolo. Con un lavoro accurato di selezione si è venuto a delineare un rudere che ha tutto l’aspetto di una piccola capanna sicula. La piantina disegnata accuratamente (fig. 3) da’ un’idea della struttura di essa. Pare che sia stato un sol vano di forma rettangolare. Dal lato di sud - est non esiste avan-zo di muro, ma solo delle piccole pietre messe a coltello come si vede dalla sez. A - B.
Internamente si trovarono avanzi di vasella-me, lisciatoi in pietra vulcanica ceneri ecc. Solo in un angolo si trovarono tracce sicure del foco-lare con carboni e ceneri. Il pietrame adoperato non è in gesso come il materiale che lì si trova, ma è calcare ordinario.
Le pietre che serviron a macinatori sono gene-ralmente di tagli non grandi e di forma irregolari. Essi sono fatti o di lava o di un’altra pietra ros-sastra assai dura.
Procedendo lo scavo, a poca distanza dalla piccola capanna dal lato di NE si trovarono quel-le magnifiche selci, amigdaloidi, al fondo della trincea e vicino si raccolsero alcuni vasi che col
Fig. 2 - Sezione dell’area di sca-vo. Taccuino n. 138 di Paolo Orsi redatto da Rosario Carta. Siracusa Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”.
Section of the excavated area. Pa-olo Orsi Notebook n. 138 written by Rosario Carta. Syracuse, Re-gional Archaeological Museum “Paolo Orsi”.
Fig. 3 - Pianta di una capanna. Taccuino n. 138 di Paolo Orsi redatto da Rosario Carta. Siracusa Museo Archeolo-gico Regionale “Paolo Orsi”.
Plan of an hut. Paolo Orsi Notebook n. 138 written by Ro-sario Carta. Syracuse, Regional Archaeological Museum “Paolo Orsi”.
119S. Ippolito, Caltagirone: nuovi dati sull’abitato dagli scavi Orsi
restauro son venuti quasi interi, fra i quali l’inte-ressante vaso a zucchetta.6
A N. O. della capanna, quasi addossati al muro di questo, si trovarono diversi framm. di vasi a stralucido di tipo Matrensa ecc.
In questi scavi sono abbondanti le ossa, avan-zi di pasti, di quadrupedi piccoli e grossi. Si vedo-no anche corna di un animale che non è la vacca, forse è il bufalo, e corna di cervi.
Abbondano anche le selci e di meno le ossi-diane. (…) È interessante assistere allo scavo di questo villaggio: a mano a mano che si taglia il bancone di terra si vanno trovando strati di ceneri e ceneri frammiste a carboni. Sono avanzi di foco-lari che spesso si trovano sopra uno strato di creta malamente cotta. Sotto a questi focolari altri e sot-to ancora avanzi di detriti organici o combusti o disfatti. Frammisto a tutto ciò qualche frammento di selce, frammento di vasellame che serviva per il bisogno quotidiano. Ogni tanto si trovano dei framm. di vasi buoni. Sotto i miei occhi nella par-te più bassa di una trincea si è trovato un vaso a clepsidra con molta cenere di dentro. E così si van-no trovando le ossa avanzi dei pasti e quelle lavo-rate a punteruoli. È degna di nota la mancanza di pietrame. Solo qua e là si trova qualche sasso, ciò indica che le capanne erano poche o che furono tutte travolte verso il torrentello.
Lo strato archeologico non è sempre uguale: di tratto in tratto si affievolisce e poi riprende”.
Dal 1928 l’area dell’insediamento eneolitico non è stata più oggetto di indagini archeologiche.
Analisi dei materiali7
Il periodo più antico dell’Eneolitico è rappresen-tato a S. Ippolito da frammenti appartenenti a dif-ferenti classi ceramiche, che sulla base delle prin-cipali caratteristiche morfo - tecniche e dei sistemi decorativi, possiamo ricondurre ai seguenti gruppi: - Ceramica decorata con incisioni riferibile alla
facies di S. Cono - Piano Notaro;
6 Carta si riferisce alla brocchetta a bocca obliqua e fondo concavo inv. 48459 (cfr. infra n. 174 in catalogo).7 Per la nomenclatura delle forme ceramiche si è fatto rife-rimento a McConnell 1999, per la ceramica dell’Eneolitico iniziale, e alle edizioni dei siti più importanti per le fasi se-riori.
- Ceramica con incisioni a pettine, ricollegabile alla classe di Calafarina;
- Ceramica con decorazione a bande rosse su fondo grigio (Calafarina);
- Ceramica con motivi dipinti in bruno - rossic-cio su fondo chiaro (stile del Conzo).
Ceramiche dello stile S. Cono - Piano Notaro:1: tratto di orlo di scodella a corpo carenato a
superficie di colore grigio scuro. Motivo de-corativo esterno inciso: linee spezzate curvili-nee affiancate da punti. Impasto grigio. H 5.9, Largh. 5.5, Spess. 0.8. (fig. 4A)
2: tratto di orlo con parete di olla. Motivo deco-rativo esterno inciso: linee parallele campite da reticolo. Impasto grigio. H 8.2, Largh. 8.7, Spess. 0.4 - 0.6. (inv. 48964) (fig. 4B)
3: tratto di orlo di vaso a fiasco (?); orlo piatto, ingobbio rosa interno. All’esterno motivo de-corativo inciso a linee zig-zaganti riempito da pasta bianca. Impasto grigiastro al nucleo con inclusi calcarei e grigiastri. H 7.5, Largh. 6, Spess. 0.7. (fig. 4C; fig. 5B)
4: tratto di orlo estroflesso (bicchiere globula-re?) ricoperto da ingobbio rosa con motivo decorativo a linee incise e due punti impressi sull’orlo esterno. Impasto rosa con inclusi la-vici. H 3.5, Largh. 5.2, Spess. 0.7. (fig. 4D)
5: tratto di orlo estroflesso. Superficie ricoperta da ingobbio crema con chiazze grigiastre; all’esterno tre linee verticali incise. Impasto rosaceo con inclusi calcarei. H 4.3, Largh. 7.2, Spess. 0.4 - 1.1. (inv. 48968) (fig. 4E)
Pareti:6: frammento di parete di vaso di forma chiusa
a superficie esterna lucidata a stecca in colo-re grigio con motivo decorativo inciso: linee curvilinee e verticali affiancate da punti riem-pite da pasta bianca. Impasto grigio. H 6.3, Largh. 8.3, Spess. 1. (fig. 4F)
7: piccolo frammento di parete di vaso di forma chiusa. Superficie esterna di colore grigio lu-cidata a stecca con coppia di linee incise, di cui una fiancheggiata da punti. Impasto gri-gio. H 4, Largh. 5.8, Spess. 1. (fig. 4G)
8: frammento di parete di vaso di forma aperta a profilo curvilineo. Superficie grigia lucidata a stecca con all’esterno linee curvilinee incise riempite da pasta bianca. Impasto grigio. H 7.5, Largh. 7.6, Spess. 1. (fig. 4H).
120 Anita Crispino
9: frammento di parete di vaso di forma aperta a superficie grigia lucidata a stecca. All’ester-no coppia di linee incise parallele, di cui una affiancata da punti, riempite da pasta bianca. All’interno tracce di ocra rossa; impasto gri-gio. H 6, Largh. 5.3, Spess. 1. (fig. 4I)
10: piccolo frammento di parete di vaso di forma chiusa a superficie esterna grigia lucida con coppia di linee incise affiancata da punti. Im-pasto grigio. H 4.5, Largh. 5.3, Spess. 0.9.
11: frammento di parete di vaso di forma chiusa con all’esterno coppia di linee curvilinee inci-se. Impasto grigio. H 6.7, Largh. 4.6, Spess. 1.
12: frammento di parete di vaso a profilo retti-lineo di forma chiusa decorato all’esterno con zig - zag orizzontale e una linea incisa affiancata da coppia di punti riempiti da pasta bianca. Impasto grigio molto compatto. H 7, Largh. 5.5, Spess. 1. (fig. 5C)
13: frammento di parete di vaso di forma chiusa decorato all’esterno con una linea verticale incisa e banda in rosso. Impasto grigio. H 5.2, Largh. 5.3, Spess. 0.8. (fig. 5H)
14: piccolo frammento di parete con parte esterna lucidata a stecca e motivo decorativo a linee curvilinee incise affiancate da punti. Impasto rosa, grigio al nucleo con inclusi calcarei. H 3.7, Largh. 2.2, Spess. 0.4. (inv. 42172) (fig. 4L)
15: piccolo frammento di parete di vaso proba-bilmente di forma chiusa a superficie esterna lucidata a stecca e coppia di linee ondulate in-cise. Impasto grigio. H 4.5, Largh. 3.2, Spess. 0.7. (fig. 4M)
16: frammento di parete di vaso a profilo curvili-neo. Su ingobbio rosa, all’esterno linee inci-se curvilinee fiancheggiate da punti impressi. Impasto rosa con inclusi calcarei. H 8, Largh. 7.4, Spess. 0.8. (inv. 48968) (fig. 4N)
17: frammento di spalla di vaso di forma chiusa a superficie grigiastra decorato all’esterno con serie orizzontali di punti impressi e due linee verticali incise verticali. Impasto grigio. H 5, Largh. 7.7, Spess. 1 - 1.4. (inv. 48965) (fig. 4O)
18: piccolo frammento di parete di vaso di forma chiusa. Su ingobbio crema all’esterno coppia di linee incise affiancate da punti. Impasto giallastro con inclusi calcarei. H 3.7, Largh. 4, Spess.0.9 - 1.1. (inv. 40516) (fig. 5D)
19: frammento di parete. Su ingobbio crema una linea incisa curvilinea affiancata da punti. Im-
pasto grigio chiaro. H 5.2, Largh. 6.2, Spess. 0.8. (inv. 48965) (fig. 5E)
20: simile probabilmente di forma aperta. In-gobbio crema con all’esterno linee incise curvilinee fiancheggiate da punti impressi. Impasto rosa, grigio al nucleo con inclusi calcarei. H 5, Largh. 3.7, Spess. 0.6. (inv. 48965) (fig. 5F)
21: frammento di parete probabilmente di vaso di forma chiusa a superficie grigia con all’ester-no elemento angolare inciso. Impasto grigio. H 9, Largh. 6.5, Spess. 1.2. (inv. 48966) (fig. 5G)
22: frammento di parete a profilo carenato. Ban-de curvilinee campite da reticolo ad incisioni all’esterno. Impasto grigio. Ricomposto da due frammenti. H 5.3, Largh. 9.7, Spess. 0.6 - 1.1. (inv. 48966)
23: piccolo frammento di parete di vaso probabil-mente di forma aperta a superficie grigio scu-ro con all’esterno motivo decorativo inciso a linee orizzontali, parallele ad un rettangolo campito da reticolo. Impasto grigio. H 3.2, Largh. 3.5, Spess. 0.5. (inv. 42172)
24: frammento simile ma a superficie più chiara decorato con tre linee incise che formano un angolo retto. Impasto grigio. H 3, Largh. 4.2, Spess. 0.6.
25: piccolo frammento di parete a superficie gri-gio chiaro decorato con banda verticale in co-lore rosso, linea orizzontale incisa affiancata da punti. Impasto grigio. H 4.6, Largh. 6.2, Spess. 1. (inv. 48963)
26: piccolo frammento di parete. Su ingobbio crema coppia di linee curvilinee tagliate da orizzontali incise. Impasto rosa con inclusi calcarei. H 5.4, Largh. 4, Spess. 1.
27: frammento di parete con attacco di ansa a na-stro, parete a profilo curvilineo. All’esterno motivo a doppia onda e tremoli verticali entro linee spezzate e punti impressi. Impasto rosa con inclusi calcarei. Ricomposto da fram-menti con integrazioni in gesso. H 20, Largh. 26, Spess. 1. Ansa: Lungh. 5.7. (inv. 48941) (fig. 6A)
28: tratto di orlo con parete di scodella troncoco-nica, chiazze grigiastre all’esterno. All’ester-no, ad incisione, triangoli con vertice verso il basso campiti da tratti verticali. Impasto gial-lastro farinoso con inclusi calcarei. Ricompo-sto da quattro frammenti. H 11.1, Largh. 15,
121S. Ippolito, Caltagirone: nuovi dati sull’abitato dagli scavi Orsi
Spess. 1.5, Diam. 38 (ricostruito) (inv. 48970) (fig. 6B)
29: frammento di parete di piccolo vaso con mo-tivo decorativo esterno inciso a triangoli con-trapposti, campiti da tratti verticali. Impasto giallastro farinoso con inclusi calcarei. H 4.7, Largh.5.4, Spess. 0.7. (inv. 48971)
30: frammento di parete di grande vaso di forma aperta con all’esterno, ad incisione, triango-li con vertice verso il basso campiti da tratti verticali e serie di brevi tacche impresse entro due linee verticali. Impasto giallastro farinoso con inclusi calcarei e rossicci. H 11, Largh. 13.5, Spess. 1 - 1.5. (inv. 48971) (fig. 6C)
Tra i frammenti tipo S. Cono - Piano Notaro è possibile distinguere due classi ceramiche: una, a cui appartiene la maggior parte degli esemplari raccolti, caratterizzata da un impasto grigio scuro talvolta con inclusi, superficie esterna lucidata a stecca e decorata con incisioni; l’altra ad impasto rosa e superficie ad ingobbio chiaro e decorazione sempre incisa.
Per questa fase poche sono le forme ricostrui-bili: scodelle a corpo carenato, un’olla globulare, probabilmente piccoli bicchieri globulari ed un vaso a fiasco.
Gli schemi decorativi ad incisione risultano semplici, costituiti da una coppia di linee paralle-le rette o ondulate riempite spesso di pasta bian-ca e affiancate da punti. Talvolta all’incisione si accompagna la dipintura, rappresentata da una banda in rosso.
Confronti generici possono trovarsi nei reperti recuperati a S. Cono (Cafici 1899), a Piano No-taro (Orsi 1908), Rocchicella (Maniscalco 2008 p. 76, fig. 73), nelle grotte del Siracusano (Tinè 1960 p. 142 tav. II; 1965) ma anche nella Grotta del Vecchiuzzo (Bovio Marconi 1979 tav. VII, X), e nel territorio di Milena (Cl)8.
Più complesso il motivo a bande campite da reti-colo e a sottile incisione che si confronta con il ma-teriale della Grotta Zubbia (Tinè 1960, tav. III, 6).
È da rilevare come tracce di ocra rossa siano presenti nelle pareti interne di alcuni pezzi, con-fermando l’ipotesi di utilizzo di alcuni vasi come contenitori della stessa (Maniscalco 1989).
8 Grotta Fontanazza I e c.da Fontanazza, Maniscalco 1994 p. 336 fig. 2; 2007 pp. 172 - 173, figg. 2 - 3.
Alcuni frammenti (nn. 28-30), pur decorati con schemi propri della ceramica incisa dell’E-neolitico iniziale (triangoli semplici o contrap-posti campiti da tratti verticali a sottile inci-sione), si distinguono dagli altri per la qualità dell’impasto che risulta di colore giallo, farinoso e con inclusi calcarei o di colore rossiccio mol-to piccoli. Alla luce di queste caratteristiche, già notate da Orsi9, si è preferito isolarli, anche se rimane aperto il problema, in assenza di indagini archeometriche, di una eventuale importazione. Interessante, inoltre, il fatto che i frammenti, a quanto scritto dallo scavatore, siano stati recu-perati in una capanna. Le uniche forme vascolari identificate sono la scodella troncoconica e quel-la a carena morbida.
2. CeramiChe dello stile di Calafarina:31: tratto di orlo di scodella a superficie grigia con
tracce di colore rosso intorno ad una bugna a rilievo. Impasto rosa con inclusi calcarei. H 8, Largh. 6.4, Spess. 0.8. Bugna: Largh. 2.7.
Pareti:32: frammento di parete di scodella carenata con
ansetta. All’esterno linea incisa orizzontale; impasto grigio. H 4.6, Largh. 8.5, Spess. 1. Ansa Largh. 2.3. (inv. 48967)
33: frammento di parete di vaso fortemente ca-renato (scodella?) decorato all’esterno con sottili linee orizzontali incise disordinata-mente entro due solchi più profondi. Impasto grigio. H 10, Largh. 10, Spess. 1 - 1.4. (inv. 48949)
34: simile con uguale decorazione. Impasto gri-gio; ricomposto da due frammenti. H 7, Lar-gh. 8.8, Spess. 0.7-1.4. (inv. 48949) (fig. 6D)
35: piccolo frammento probabilmente di forma chiusa decorato con sottili linee incise a petti-ne delimitate da un solco orizzontale. Impasto grigio. H 6.3, Largh. 5.5, Spess. 1.3.
Pochi frammenti attestano la presenza della varietà Calafarina (Orsi 1907 A fig. F tav. IV,4) a S. Ippolito; le forme, ad eccezione di una scodel-la a parete fortemente carenata, non ricostruibili, sono di tipo aperto.
9 Inventario Museo Archeologico di Siracusa Vol. XV.
122 Anita Crispino
Fig. 4 - Ceramica di tipo S. Cono - Piano Notaro (dis. A. Crispino).
S. Cono - Piano Notaro incised pottery (drawing by A. Crispino).
123S. Ippolito, Caltagirone: nuovi dati sull’abitato dagli scavi Orsi
3. CeramiCa dello stile del Conzo:Olla a corpo globulare con accenno di collo:
36: tratto di orlo con parete, breve accenno di collo. Su ingobbio crema bande verticali con serie di triangoli campiti da tratti obliqui in violaceo. Impasto grigio con inclusi calcarei. H 6, Largh. 4.3, Spess. 1 (inv. 48980) (fig. 6F)
37: simile. Su ingobbio crema, bande verticali con serie di triangoli campiti da tratti obliqui fian-cheggiato da motivo a pettine. Impasto rosa con inclusi calcarei. H 5, Largh. 5.8, Spess. 0.7 (inv. 48960) (fig. 6G)
Colli:38: frammento di collo di vaso (fiasco?) decorato
all’interno con fascia in colore rosso, all’ester-no con fascia orizzontale in rosso marginata in nero. Impasto rosa con inclusi calcarei. H 3.8, Largh. 4.7, Spess. 0.5. (inv. 42174) (fig. 5I)
Pareti:39: frammento di parete di vaso a profilo rettili-
neo ricoperto da ingobbio rosa con all’esterno bande verticali con serie di triangoli campiti da tratti obliqui in colore violaceo. Impasto rosa con inclusi calcarei; ricomposto da due frammenti. H 5.5, Largh. 8, Spess. 1.1. (inv. 40498) (fig. 5L)
40: frammento di parete di vaso di forma chiu-sa ad ingobbio crema con all’esterno banda rossa e motivo decorativo costituito da serie di triangoli campiti da tratti obliqui in bruno. Impasto grigio al nucleo con inclusi calcarei. H 3.2, Largh. 4.2, Spess. 1. (inv. 48960) (fig. 6E)
41: frammento di parete simile. Su fondo crema, banda orizzontale in rosso e triangolo cam-pito da tratti obliqui e brevi tratti verticali su uno dei lati. Impasto rosa, grigio al nucleo con inclusi lavici. H 5, Largh. 4.6, Spess. 0.8. (inv. 48980) (fig. 5 M)
42: piccolo frammento di vaso di forma aperta. Su ingobbio crema all’esterno bande con serie di triangoli campiti da tratti obliqui e linee spez-zate in bruno. Impasto rosa, grigio al nucleo. H 4.7, Largh. 3.2, Spess. 0.7. (inv. 48980)
43: simile probabilmente di forma chiusa. Su in-gobbio crema, banda con triangoli campiti da tratti obliqui. Impasto grigio. H 6, Largh. 7, Spess. 1. (inv. 48980)
44: simile con uguale motivo decorativo. Impasto grigio. H 5, Largh. 7, Spess.1. (inv. 40494)
45: piccolo frammento di parete di vaso di forma aperta con tracce di triangolo campito da tratti obliqui e brevi tratti verticali. Impasto grigio. H 5, Largh. 4.5, Spess. 0.7. (inv. 40494)
Fig. 5 - Ceramica di tipo S. Cono - Piano No-taro (a - h) e Conzo (i - m).
S. Cono - Piano Notaro incised pottery (a - h) and Conzo painted pottery (i - m).
124 Anita Crispino
Fig. 6 - Ceramica di tipo S. Cono - Piano Notaro (a - c), Conzo (e - g) e Serraferlicchio (h - i) (dis. A. Crispino).
S. Cono - Piano Notaro incised pottery (a -c), Conzo (e - g) and Serraferlicchio painted pottery (h - i) (drawing by A.Crispino).
125S. Ippolito, Caltagirone: nuovi dati sull’abitato dagli scavi Orsi
Fig. 7 - Ceramica di tipo Serraferlicchio (dis. A. Crispino).
Serraferlicchio painted pottery (drawing by A.Crispino).
126 Anita Crispino
Poche considerazioni possono farsi sulla cerami-ca dipinta tipo Conzo -sempre associata alla incisa S. Cono - Piano Notaro – a cui si riconducono pochi frammenti appartenenti probabilmente a contenitori di dimensioni medio - grandi, ad eccezione di uno che potrebbe riferirsi al collo di un vaso a fiasco. Tipica la decorazione a triangoli in bruno su fon-do crema (Odetti 2012) talvolta marginati da banda rossa. Un frammento per la presenza nell’impasto di inclusi lavici potrebbe essere di importazione.
Simile, ma più ordinata, la decorazione con serie di triangoli campiti da bande oblique10 di al-cuni frammenti, tra cui due orli di olle, di cui uno con motivo a pettine che si confronta con uno si-mile all’interno di una tazza dello strato Malpasso della Chiusazza (Tìnè 1965 tav. XIX, 1).
4. CeramiCa dello stile di serraferliCChio:Particolarmente consistente appare il gruppo di
materiali riferibili ad un momento non certo inizia-le dell’Eneolitico. Il nucleo più rappresentativo è quello della ceramica dipinta riferibile allo stile di Serraferlicchio, che può essere suddiviso, in base al sistema decorativo, in tre gruppi principali:- Ceramica dipinta in bruno su fondo chiaro;- Ceramica dipinta in bruno su fondo rosso;- Ceramica dipinta in rosso con bande brune
marginate di bianco (o tricromica).
Ceramica a fondo chiaro:46: parte superiore di anfora, priva dell’orlo;
un’ansa a nastro verticale sul corpo e trac-ce dell’attacco di una seconda opposta alla prima. Su ingobbio rossastro con chiazze giallastre, serie di linee spezzate parallele e oblique; sull’ansa punti entro fasce in bruno. Impasto rosa con inclusi calcarei; ricomposto da frammenti con integrazioni in gesso. H 20, Largh. 30, Spess. 1. Ansa Largh. 3.5, Spess. 1.5. (inv.48930) (fig. 6I)
Pareti:47: frammento di vaso a profilo curvilineo di for-
ma chiusa. All’esterno su ingobbio rosa ban-de zig - zaganti in bruno. Impasto grigio al nucleo con inclusi. H 6.8, Largh. 10.4, Spess. 0.7. (inv. 40494) (fig. 6H)
10 Il motivo si ritrova in un frammento da Poggio Monaco, cfr. Catanzaro et alii 1975 - 1976 p. 22 fig. 5 n. 77.
48: frammento di parete di vaso di dimensioni medio - grandi. All’esterno, su ingobbio cre-ma, ampia fascia simile in bruno violaceo. Impasto grigio al nucleo con inclusi calcarei. H 6.3, Largh. 9.5, Spess. 1.2. (inv.48980) (fig. 8G)
Ceramica a fondo rosso:Coppa con prese semicircolari sull’orlo:49: tratto di orlo, arrotondato e leggermente estro-
flesso. Su ingobbio rosso motivo a zig - zag in bruno all’interno. Impasto giallastro, grigio al nucleo, con inclusi. H 9.5, Largh. 7, Spess. 0.6. (inv. 48959) (fig. 9H)
50: simile, bande parallele verticali in bruno all’e-sterno. Un foro circolare per restauro, attacco di ansa verticale all’esterno. Impasto rosa con inclusi calcarei. H 11, Largh. 13, Spess. 1. (inv. 48962) (fig. 9I).
51: frammento di orlo. All’esterno ingobbio rosa con chiazze rossastre; all’interno, su fondo rosso, triangoli campiti da reticolo in bruno tra fasce orizzontali. Impasto grigio al nucleo. H 5.6, Largh. 10.2, Spess. 0.9. (inv. 48959) (fig. 8E)
52: frammento di orlo con accenno di lobo, con decorazione a fasce oblique e orizzontali in bruno. Impasto rosa con inclusi. H 6.5, Largh. 5.5, Spess. 1.2. (inv. 42174) (fig. 7L)
53: tratto di orlo simile, leggermente distinto. In-gobbio rosso con chiazze grigiastre. Impasto rosa. H 7, Largh. 9.5, Spess. 1. (inv. 48974)
54: tratto di orlo, ingobbio rosso. Impasto rosa. H 5.5, Largh. 5, Spess. 0.8. (inv. 48974)
55: tratto di orlo, ingobbio rosso. Impasto rosa. H 3.8, Largh. 6, Spess. 0.8.
olla a corpo globulare con accenno di collo:56: tratto di orlo con parete ed ansetta. Ingobbio
rosso, all’esterno fascia orizzontale da cui si diparte serie verticale in bruno – violaceo; all’interno banda orizzontale lungo l’orlo. Impasto rosa, grigio al nucleo, con inclu-si calcarei. Ricomposto da 8 frammenti. H 11.3, Largh. 8.4, Spess. 0.6. Ansa: Largh. 1.1, Diam. 0.5. (inv. 48962) (fig. 7A)
Boccale:57: tratto di orlo con parete; ansa a nastro vertica-
le. Su ingobbio rossiccio, motivo decorativo a bande verticali ed oblique in bruno; fascia
127S. Ippolito, Caltagirone: nuovi dati sull’abitato dagli scavi Orsi
orizzontale in rosso, all’interno, lungo l’orlo. Impasto rosa con inclusi calcarei. H 5.5, Lar-gh. 6.5, Spess. 0.6. Ansa: Largh. 2, Spess. 0.8. (inv. 40486) (fig. 7B)
Vaso a fiasco:58: frammento di collo, su ingobbio rosso, motivo
decorativo a linee spezzate orizzontali e verticali in bruno. Impasto rosa con inclusi grigiastri. H. 12, Largh. 11, Spess. 1. (inv. 48979) (fig. 7C)
Orli:59: tratto di orlo estroflesso (boccale?). All’ester-
no, su colore rosso scuro, zig - zag in bruno; lungo l’orlo interno, fascia in rosso su fondo argilla. Impasto rosa con inclusi calcarei. H 3.5, Largh. 4.2, Spess. 0.5. (fig. 7D)
60: tratto di orlo simile. All’esterno su ingobbio rossastro linee spezzate delimitate da fasce orizzontali e oblique in bruno, una fascia oriz-zontale all’interno. Impasto rosa con inclusi calcarei e grigi. H 5.8, Largh. 4.4, Spess. 0.6. (inv. 41656) (fig. 7E)
61: tratto di orlo estroflesso, probabilmente di anfora, con attacco di ansa verticale. Su in-gobbio rosso serie orizzontale di triangoli con vertice verso il basso e bande orizzontali con serie di punti in bruno. Impasto rosa con in-clusi calcarei. H 7.6, Largh. 8.2, Spess. 1.2. (inv. 41656) (fig. 7F)
62: tratto di orlo di probabilmente di anfora ri-coperto da colore rosso con decorazione a fasce oblique e orizzontali in bruno sia all’in-terno che all’esterno. Impasto rosa, grigio al nucleo, con inclusi. H 5.2, Largh. 6.9, Spess. 1.2. (inv. 41656) (fig. 7I)
63: tratto di orlo di piccolo vaso. Su ingobbio ros-so linee spezzate parallele oblique delimitate da fasce orizzontali in bruno. Impasto gialla-stro con inclusi calcarei. H 3.5, Largh. 4.7, Spess. 0.5. (inv. 48980) (fig. 7H)
Colli:64: frammento di collo di vaso di forma chiusa
(vaso a fiasco?). Su ingobbio rosso fascia obliqua e tracce di triangolo campito da li-nee oblique in bruno. Impasto rosa con inclu-si calcarei. H 6.3, Largh. 5, Spess. 0.6. (inv. 41656) (fig. 7N)
65: frammento di collo e spalla di vaso di for-ma chiusa (vaso a fiasco?). Su ingobbio ros-
so tracce di triangoli a colore pieno e fascia orizzontale in colore bruno. Impasto grigio al nucleo con inclusi calcarei. H 8, Largh. 6.3, Spess. 0.7. (inv. 41656)
66: frammento di collo di piccolo vaso. All’ester-no, su ingobbio rosso chiaro, punti e fasci di linee disposte in varia direzione in bruno. Im-pasto rosa con inclusi calcarei. H 3.8, Largh. 5.5, Spess. 0.6. (inv. 48980) (fig. 8A)
Pareti:67: piccolo frammento di parete di vaso di forma
chiusa decorato con zig - zag in bruno su fon-do rosso. Impasto rosa con inclusi calcarei. H 2.3, Largh. 3.5, Spess. 1.
68: frammento di parete a profilo curvilineo (vaso a fiasco?). All’esterno su ingobbio rosso ban-de zig - zaganti in bruno. Impasto grigio al nucleo con inclusi. H 6.3, Largh. 5, Spess. 0.6. (inv. 42174) (fig. 7G)
69: frammento di parete di vaso a profilo curvili-neo di forma chiusa. Su ingobbio rosso, fasce oblique in bruno di vario spessore. Impasto rosa con inclusi. H 4.9, Largh. 5.5, Spess. 0.8 - 1. (inv. 41656) (fig. 8B)
70: frammento di parete a profilo curvilineo. Su ingobbio rosso, all’esterno, motivo decorativo a fasce verticali ed oblique in bruno. Impasto rosa con inclusi calcarei. H 5, Largh. 5, Spess. 0.6. (inv. 42174) (fig. 8C)
71: frammento di parete di vaso di forma chiusa. Su ingobbio rosso punti e fasci di linee dispo-ste in varia direzionein bruno. Impasto rosa, grigio al nucleo, con inclusi calcarei. H 9.3, Largh. 8.2, Spess. 0.8. (inv. 41656) (fig. 8D)
72: frammento di parete di vaso di forma aperta con, all’esterno, tracce di fascia verticale in bruno su fondo rosa, all’interno, su fondo ros-so, due fasce verticali in bruno. Impasto rosa con inclusi calcarei e grigi. H 5.2, Largh. 6.6, Spess. 1. (inv. 48959) (fig. 8F)
73: tratto di parete di vaso di forma chiusa. Su ingobbio rosso bande zig - zaganti in bruno. Impasto rosa con inclusi calcarei e grigi. H 8.2, Largh. 8.7, Spess. 1.5. (inv. 48980)
Anse:74: frammento di parete di vaso a profilo curvili-
neo con ansa verticale ed una bugnetta a rilie-vo ricoperta da colore bruno, all’attacco della stessa. Su ingobbio rosa scuro, sulla parete
128 Anita Crispino
esterna motivo decorativo a fasce oblique in nero. Impasto grigio. H 9, Largh. 7.2, Spess. 0.9 - 1.1. Ansa: Largh. 2.1, Spess.2. (inv. 48974) (fig. 7M)
Lobi:75: trapezoidale; su ingobbio rosso, all’interno,
triangolo campito da reticolo in bruno. Im-pasto rosa con inclusi calcarei. H 6.5, Largh. 5.3, Spess. 1.2. (inv. 42174) (fig. 8H)
76: simile con identico motivo decorativo. All’e-sterno tracce di fascia verticale. Impasto rosa con inclusi calcarei. H 8.3, Largh. 9.3, Spess. 1.2. (inv. 40494) (fig. 7O)
77: simile. Impasto rosa, grigio al nucleo con
inclusi calcarei e grigi. Ricomposto da due frammenti. H 7, Largh. 11, Spess. 1.3. (inv. 48958) (fig. 8I)
78: simile con tracce di decorazione interna e motivo a croce esterno. Impasto rosa con in-clusi calcarei. H 6, Largh. 10, Spess. 1. (inv. 48959) (fig. 8L)
79: simile, semicircolare, con tracce di decorazio-ne in bruno violaceo su fondo rosso. Impa-sto rosa con inclusi calcarei. H 5.7, Largh. 7, Spess. 0.8. (inv. 48958)
Presa a testa di elefante:80: frammento di parete con attacco del collo di
olla (?) con presa. Su ingobbio rosso fascia orizzontale da cui si diparte una serie vertica-
Fig. 8 - Ceramica di tipo Serraferlicchio
Serraferlicchio painted pottery.
Fig. 9 - Ceramica di tipo Serraferlicchio (h - i) e Malpasso - S. Ippolito (a - g).
Serraferlicchio (h - i) and Malpasso - S. Ippo-lito painted pottery (a - g).
129S. Ippolito, Caltagirone: nuovi dati sull’abitato dagli scavi Orsi
le in bruno. Impasto rosa con inclusi calcarei. H 5.5, Largh. 6.3, Spess. 0.7. Presa Largh. 1.2. (inv. 42174) (fig. 7P)
81: simile, ricoperto da colore rosso e, sulla presa, motivo a doppia croce entro due fasce verti-cali in bruno. Impasto rosa con inclusi. H 5.2, Largh. 5.1, Spess. 0.4. Presa: Largh. 0.9. (inv. 40488)
82: simile con presa molto allungata. Ingobbio rosso con bande parallele verticali in bruno. Impasto rosa con inclusi. H 6.1, Largh. 3.6, Spess. 0.5. Presa: Largh. 1.7. (inv. 40488)
83: frammento di parete di olla (?) con presa esterna. All’esterno, su ingobbio rosso, bande parallele verticali in bruno. Impasto rosa, gri-gio al nucleo, con inclusi grigi. H 8.3, Largh. 6.7, Spess. 1. (inv. 40488)
Ceramica tricromica:84: frammento di orlo di vaso di forma aperta con
ansa verticale a nastro. Su ingobbio rosso lu-cido, all’interno banda verticale in bruno mar-ginata in bianco; all’esterno tracce di motivo a triangolo negli stessi colori. Impasto rosa-giallastro con inclusi grigi. H 4.8, Largh. 4, Spess. 0.8. (inv. 48959)
85: piccolo frammento di parete. Su ingobbio ros-so bande brune e bianche. Impasto rosa con inclusi calcarei. H 2.7, Largh. 3.5, Spess. 1.
86: frammento di parete di vaso di forma aperta di grandi dimensioni. All’esterno su ingobbio rosso fascia orizzontale in bianco marginata in bruno. All’interno su fondo crema fascia orizzontale in rosso. Impasto rosa con inclusi calcarei. H 6.5, Largh. 5.5, Spess. 1.3 - 1.6. (inv. 41656)
87: frammento di parete di vaso di forma aperta. All’interno tracce di colore rosso, all’esterno, su fondo rosso, banda in bianco marginata in bruno e tre oblique nello stesso colore. Im-pasto rosa con inclusi calcarei. H 6.6, Largh. 11.5, Spess. 1.5. (inv. 41656)
88: frammento di parete probabilmente di scodel-la. Superficie esterna rosa con chiazze rossa-stre; all’interno, su fondo rosso, triangoli cam-piti da reticolo in bruno marginato in bianco. Impasto grigio al nucleo con inclusi calcarei. H 6, Largh. 8.3, Spess. 0.8. (inv. 48959)
89: frammento di parete di coppa (?). Su ingobbio rosso, tracce, all’esterno, di fascia in bruno e due parallele in bianco marginate in bruno.
Impasto rosa con inclusi calcarei. H 9, Largh. 8.3, Spess. 1.1. (inv. 48957)
90: frammento di parete di vaso di forma chiu-sa. Su ingobbio esterno rosso bande paralle-le verticali in bruno e bianco. Impasto grigio con inclusi calcarei. H 3.6, Largh. 4.4, Spess. 0.6. (inv. 42174)
91: frammento di parete di vaso di forma chiusa con tracce dell’attacco di presa a testa di ele-fante. All’esterno su ingobbio rosso due fasce verticali in bruno e bianco. Impasto grigio. H 3.5, Largh. 5.2, Spess. 0.8.
Al medesimo raggruppamento può essere as-segnato anche un isolato frammento pertinente ad una forma chiusa d’impasto grigio, a brunitura disegnativa:
Olla a corpo globulare con accenno di collo:92: Collo distinto, fondo piatto, due prese allun-
gate forate tra orlo e spalla. Decorata con striature prodotte da strumento brunitore. Im-pasto grigio con inclusi calcarei. Ricomposta da frammenti con integrazioni in gesso. H 15.5, Diam. bocca: 9.5, fondo: 5, Spess. 0.5. (inv. 48456) (fig. 10A)
La ceramica tipo Serraferlicchio identificata a S. Ippolito può essere suddivisa in quattro classi, anche se non sembra presente in nessun esempla-re il ricco e complesso repertorio decorativo del centro eponimo.
Della prima, a fondo chiaro con decorazione in bruno a zig - zag, fasce campite da reticolo e linee spezzate parallele ed oblique, fanno parte frammenti di vasi di forma chiusa, tra cui una grande anfora (cat. n. 46). L’impasto è ricco di inclusi grigiastri o calcarei.
Il secondo gruppo è costituito da ceramica a fondo rosso spesso lucido con decorazione in bru-no di tipo geometrico: triangoli, bande verticali o a reticolo accompagnate da punti, linee spezzate.
Varie sono le forme: la coppa quadrilobata con lobi sia trapezoidali che semicircolari anche solo accennati (Bovio Marconi 1979 tav. XXXII,1) che, secondo un recente studio (Adamo e Gullì 2008 p. 198), si colloca in una fase medio tarda dello stile, l’olla a corpo globulare, il boccale e il vaso a fiasco a collo cilindrico decorato con triangoli o linee spezzate. Quasi tutte le forme e i motivi decorativi si ritrovano nel centro eponimo
130 Anita Crispino
(Arias 1938, figg. 115, col. 128 - 129), grotta Van-gu del Lupo (Montallegro) (De Miro 1974, pp. 260 - 261, Adamo e Gullì 2012 p. 606, fig. 3), alla Chiusazza (Tinè 1965, tav. XII,1), Settefarine (Orsi 1910, tav. XII,3), Rocca Aquila e Fontanaz-za (Maniscalco 2007 p. 177, fig. 7), Poggio Mo-naco (Catanzaro et alii 1975 - 1976 fig. 6), Roc-chicella (Maniscalco 2008 p. 90, fig. 75).
La terza classe ceramica comprende frammen-ti a decorazione tricromica appartenenti anche a piccoli vasi.
La ceramica a brunitura disegnativa costitu-isce l’ultima classe. È rappresentata da un’u-nica forma, l’olla, già attestata nella cerami-ca dipinta in nero su fondo rosso ed in quella tricromica. Contrariamente a Serraferlicchio, mancano le scodelle troncoconiche tipiche di questa classe.
5. CeramiCa dello stile di malpasso:
Ceramica fine: Scodella troncoconica con prese plastiche sotto l’orlo:93: tratto di orlo ricoperto da ingobbio rossiccio
diluito. Sotto l’orlo, all’esterno, cuppella a ri-lievo. Impasto giallastro con inclusi calcarei. H 7.2, Largh. 6.2, Spess. 0.9 - 1.4. (fig. 10B)
94: tratto di orlo ricoperto da ingobbio rosso all’esterno. Sotto l’orlo falsa presa semilunata molto allungata. Impasto rosa chiaro con in-clusi grigiastri. H 8,5; Largh. 4,4, Spess. 0,9, presa Largh. 2,9. (fig. 15A)
95: tratto di orlo ricoperto da ingobbio rosso all’esterno. Sotto l’orlo falsa presa semiluna-ta. Impasto grigiastro friabile. H 8,5; Largh. 10,1, Spess. 1,1. (fig. 15B)
Pithoi:96: tratto di orlo con attacco di ansa verticale. Su
ingobbio rosso decorazione esterna con cor-done a rilievo orizzontale. Impasto rossiccio con inclusi calcarei. Ricomposto da fram-menti. H 12.2, Largh. 18, Spess. 1.5 - 2. (inv. 48978)
97: simile. Su ingobbio rosso decorazione simile al precedente. Impasto rossiccio con inclusi calcarei. Ricomposto da frammenti con inte-grazioni in gesso. H 13.5, Largh. 13.5, Spess. 1.5 - 1.8. (inv. 48978)
Situle:98: orlo arrotondato, parete curvilinea, ingobbio
rosso. Impasto rosa con inclusi calcarei. Ri-composto da frammenti con integrazioni in gesso. H 18, Diam. 23, Spess. 1. Piede Diam. 11, Ansa Largh. 10, Spess. 2. (inv. 48938) (fig. 10C)
Orci:99: frammento di orlo con parete. Ingobbio ros-
sastro esterno con all’interno tracce di fascia orizzontale in bruno lungo l’orlo. Impasto grigio al nucleo con inclusi calcarei. H 7, Lar-gh. 9.6, Spess. 0.7 - 1.00. (fig. 10D)
100: tratto di orlo. Ingobbio crema con tracce di colore rosso. Impasto grigio con inclusi cal-carei. H 4, Largh. 6.8, Spess. 0.7.
Bicchiere semiovoide con ansa a nastro sormon-tante:101: orlo arrotondato, fondo appuntito, tracce
sulla parte esterna dell’ansa di colore ros-so. Chiazze grigiastre in superficie. Impasto giallastro, grigio al nucleo con inclusi. H 9.5, Diam. 9, Spess. 0.6. Ansa Largh. 2.7, Spess. 1.2. (inv. 48457) (fig. 10E)
Bicchiere semiovoide su basso piede troncoconi-co, ansa a nastro:102: frammento di fondo con attacco di ansa a na-
stro. Ingobbio rosso opaco; impasto rosa con inclusi calcarei e di colore grigio. H 3.5, Lar-gh. 6.6, Spess. 0.6. Ansa Largh. 3.2, Spess. 1.7. (inv. 27711) (fig. 10G)
103: simile. Ingobbio rosso. Impasto grigiastro al nucleo. H 2.1/4.1, Spess.0.8, Ansa Largh. 3.5 (inv. 40487)
104: simile con fondo convesso. Ingobbio rosso lucido, impasto rosa con inclusi calcarei. H 3.9, Largh. 6.5, Spess. 0.5. Ansa Largh. 2.2, Spess.1.5. (inv. 48940) (fig. 10F)
Vaso a fiasco a collo cilindrico:105: frammento di collo e parte della spalla, trac-
ce di colore rosso. Impasto rosa, grigio al nucleo con inclusi calcarei. Ricomposto da frammenti. H 14, Diam. 10, Spess. 0.6. (inv. 48933) (fig. 10H)
Orli:106: tratto di orlo probabilmente di coppa su piede
131S. Ippolito, Caltagirone: nuovi dati sull’abitato dagli scavi Orsi
Fig. 10 - Ceramica di tipo Serraferlicchio a brunitura (a) e Malpasso (b - p) (dis. A. Crispino).
Serraferlicchio pottery: burnished ware (a) and Red Lustrous ware of Malpasso class (b - p) (drawing by A. Crispino).
132 Anita Crispino
con ansa a nastro verticale. Due cordoncini a rilievo verticale ai lati dell’ansa; ingobbio esterno chiaro, interno in colore rosso dilui-to. Due fori circolari sull’ansa. Impasto rosa, grigio al nucleo con inclusi calcarei; ricom-posto da frammenti. H 5, Diam. 19, Spess. 1.2 - 1.6. (inv. 48465) (fig. 10I)
107: tratto di orlo con collo ricoperto da colore rosso all’esterno e fascia in bruno lungo l’or-lo interno. Impasto rosa scuro. H 9.8, Largh. 9, Spess. 0.9 - 1.2.
108: tratto di orlo probabilmente di olla carenata con presa semilunata ricoperto all’esterno di colore rosso. Impasto giallastro con qualche incluso. H 7,1, Largh. 9,4, Spess. 0,7. Presa Lungh. 8,4. (fig. 15C)
109: tratto di orlo probabilmente di olla carenata con presa semilunata ricoperto all’esterno di colore rosso, decorata con tre bande verticali in bruno. Impasto giallastro con qualche in-cluso. H 5, Largh. 7, Spess. 0,7. (fig. 15D)
Pareti: 110: due frammenti di vaso di forma chiusa con
pareti a profilo curvilineo. Ingobbio rosso di-luito, impasto grigio chiaro con inclusi cal-carei. H 9, Largh. 12, Spess. 0.8 (inv. 27712)
Piedi:111: forma troncoconica, ingobbio rosso diluito,
base piatta. Impasto rosa con inclusi calcarei. H 12, Diam. 17, Spess. 1.1 - 2.
Anse:112: frammento di ansa a nastro sormontante in-
teramente ricoperto da ingobbio rosso. Impa-sto rosa con inclusi calcarei. Largh. 5, Spess. 1. (inv. 48974) (fig. 9G)
113: frammento di ansa a largo nastro ricoperto da ingobbio rosso. Impasto rosaceo con in-clusi calcarei. H 8.5, Largh. 2.8, Spess. 1.5. (inv. 40493)
114: simile, ingobbio rosso all’esterno. Impasto simile. H 6.6, Largh. 4.2, Spess. 1.6. (inv. 40493) (fig. 10M)
115: frammento di parete di vaso di forma chiusa a profilo curvilineo con ansa. Ingobbio cre-ma con chiazze rossastre. Impasto grigio con inclusi. H 6.4, Largh. 5.3, Spess. 0.7. Ansa Largh. 2.3, Spess. 1. (inv. 48974)
116: frammento, ingobbio rosso. Impasto rosa, gri-gio al nucleo. Largh. 2.5, Spess. 1.3. (fig. 9C)
117: frammento ricoperto da colore rosso. Impa-sto rosa con inclusi calcarei. H 11.5, Largh. 2, Spess. 1.3. (inv. 40489) (fig. 9E)
Piastra triangolare con ansa retroversa:118: frammento, con attacco di ansa verticale,
appartenente ad un bicchiere semiovoide. Ingobbio rosso lucido all’esterno, e parzial-mente all’interno. Impasto rosa, grigio al nu-cleo. Ricomposta da due frammenti. H 12.4, Largh. 6.3, Spess. 1. Ansa cilindrica Largh. 2. 8, Spess. 1.5. (inv. 48940)
119: simile. Impasto giallastro con inclusi calca-rei. H 10.8, Largh. 5.3, Spess. 1. Ansa cilin-drica Largh. 2.5, Spess. 1.5. (inv. 48940)
120: simile. Impasto grigio al nucleo con inclu-si lavici. H 8.7, Largh. 6.5, Spess. 0.8. Ansa verticale Largh. 2.8, Spess. 1.5. (inv. 48940)
Soprelevazione a piastra triangolare con appendi-ce asciforme:121: interamente ricoperta da colore rosso mal
distribuito. All’esterno l’attacco di un’altra ansa; impasto grigio con inclusi calcarei. Ri-composta da due frammenti. H 11.7, Largh. 5, Spess. 1.4. (inv. 48940)
122: interamente ricoperta da colore rosso con apici evidenziati. All’esterno l’attacco di un’altra ansa; impasto grigio con inclusi cal-carei. Ricomposta da due frammenti. H 7.2, Largh. 8.4, Spess. 2. (fig. 15F)
123: simile, parte terminale, interamente ricoperta da colore rosso con tracce all’esterno di co-lore bruno. Impasto grigio al nucleo. H 4.6, Largh. 3, Spess. 1. (inv. 48940) (fig. 10O)
124: simile ma con apici più evidenti. Su ingobbio rosso con chiazze grigiastre, tracce all’ester-no di decorazione in bruno. Impasto grigio con inclusi calcarei. H 4.5, Largh. 6, Spess. 1. (fig. 10N)
125: simile con tracce di colore rosso. Impasto grigio. H 5.3, Largh. 4.6, Spess. 1.5. (inv. 48940) (fig. 10P)
126: simile ad ingobbio rosso con all’esterno, ai margini, due fasce verticali in bruno. Impa-sto rosa con inclusi calcarei. Largh. 4, Spess. 1.5. (fig. 9A)
127: simile ad ingobbio rosso violaceo con pen-nellate più scure nei lati esterni. Impasto gri-gio con inclusi calcarei. H 8, Largh. 6.3/3.2, Spess. 1. (inv. 40496) (fig. 15E)
133S. Ippolito, Caltagirone: nuovi dati sull’abitato dagli scavi Orsi
Ansa a maniglia orizzontale:128: tracce di colore rosso in superficie. Impasto
rosa con inclusi calcarei. H 7.5, Largh. 10,2, Spess. 1.2. (inv. 48974) (fig. 12D)
129: su fondo rosso, tre bande orizzontali sulla parte interna, a colore pieno sull’esterna. Im-pasto grigio in frattura con qualche incluso. H 3.6, Largh. 7.5, Spess. 1.9. (fig. 15G)
130: ansa con frammento di parete. Ingobbio ros-so, impasto rosa, grigio al nucleo. Largh. 5.5, Spess. 1.7, Diam. 1.7. (inv. 48940) (fig. 9D)
Ceramica grossolana:Orcio:131: tratto di orlo con parete ed attacco di ansa
sulla spalla. Ingobbio chiaro con chiazze gri-giastre. Impasto rosa, grigio al nucleo con inclusi calcarei. Ricomposto da frammenti. H 11.5; Largh. 14; Spess. 1. Ansa Spess. 1.5 (inv. 48933)
Bicchiere semiovoide su basso piede troncoconico:132: miniaturistico, orlo arrotondato, parete a
profilo rettilineo mancante del fondo. Trac-ce di un’ansa sormontante. Impasto grigio con inclusi calcarei e di colore grigio. H 5.8, Diam. 5.5, Spess. 0.5. (inv. 26520) (fig. 12A)
Boccale a fondo concavo:133: chiazze grigiastre e rossastre in superficie;
fondo concavo, ansa tra orlo e ventre. Impa-sto rosa con inclusi calcarei; ricomposto da frammenti. H 11.5, Diam. 6, Spess. 0.6 - 0.9. Ansa Spess. 2. (inv. 48458) (fig. 10L)
134: pareti a profilo curvilineo, fondo concavo. Privo di parte dell’orlo, Impasto rosa con in-clusi calcarei. H 8.5, Diam. 5, Spess. 0.5 - 0.8. (inv. 48934)
135: simile, breve collo cilindrico. Ingobbio ro-saceo con chiazze grigiastre, ansa mancante. Impasto grigio al nucleo, molto friabile con inclusi calcarei. H 9,5, Diam. 5.2/3.7. Ansa Largh.3.5. (inv. 48925)
Vaso a fiasco:136: sulla spalla attacco di un’ansa a sezione cir-
colare. Ingobbio rosa con chiazze grigiastre. Impasto grigio. H 14, Largh. 17, Spess. 1 - 1.3 (inv. 26520) (fig. 12B)
Pentole:137: a corpo globulare, biansata, fondo concavo.
Ingobbio rosaceo; Impasto grigio al nucleo con inclusi. Ricomposto da frammenti con in-tegrazioni. Chiazze di bruciato in superficie. H 23.2, Diam 18.5/19. (inv. 48455) (fig. 11A)
Coppe su piede:138: frammento di fondo con parte del piede. All’in-
terno motivo a rilievo plastico. Impasto grigio in frattura con inclusi calcarei. Ricomposto da frammenti. H 5, Diam. interno 15.5, esterno 19, Spess. 1.2 - 1.6. (inv. 48461) (fig. 18F)
Ansa a nastro con appendice superiore:139: frammento di parete. Impasto rosa giallastro
con inclusi calcarei. H 13, Largh. 7.3, Spess. 1. Ansa Largh. 3. (inv. 48974)
Ansa a gomito:140: frammento. Impasto rosa, grigio al nucleo
con inclusi calcarei. H 5.5, Largh. 3.5, Spess. 0.9. (fig. 12C)
Ansa a maniglia impostata sul labbro:141: apici evidenziati. Ingobbio crema con chiaz-
Fig. 11 - Pentola di tipo Malpasso (a) e coppa su piede di tipo S. Ippolito (b).
Cooking pot (a) (Malpasso style) and pedestal vase (b) (S. Ippolito style).
134 Anita Crispino
ze grigiastre. Impasto grigio al nucleo con inclusi lavici. H 6.3, Largh. 9.5, Spess. 1.7. (inv. 48974) (fig. 12E)
Piastre:142: frammento di piastra quadrangolare con sca-
nalature a sezione semicircolare sulla super-ficie a vista. Ricoperta da colore rossiccio. H 13.8, Largh. 9.6, Spess. 1.8. (fig. 15O)
La facies Malpasso si contraddistingue a S. Ip-polito per due classi ceramiche: fine e grossolana. Della prima fanno parte molti frammenti di forme facilmente identificabili ricoperti da colore rosso perlopiù non lucido e di impasto ben cotto, rosato, ricco di inclusi calcarei; in alcuni frammenti sono presenti tracce di decorazione lineare in bruno. Si riconoscono vasi a fiasco, situle e coppe o olle con falsa presa semilunata11. Presente l’orcio, già attestato alla Chiusazza (Tinè 1965, tav. XXI, 2) nella necropoli di Malpasso (Albanese 1988 – 89, fig. 13,6), a Rocchicella (Vacirca 2008 p. 152 e p. 164, fig. 129), a Poggio dell’Aquila (Cavalier e Cultraro 2010 p. 59, fig. 12,8). Il bicchiere, forma distintiva di questo stile12, si ritrova in vari tipi tra cui uno con ansa sormontante e frammenti di ti-pici bicchieri semiovoidi a piastra sopraelevata su basso piede, talvolta convesso.
I frammenti di pithoi ad ingobbio rossiccio e cordone plastico esterno, trovano confronti con la grotta Infame Diavolo (De Miro 1961, fig. 8, 961).
È probabile che due boccali a corpo globulare con chiazze rossastre in superficie possano collo-carsi in questa fase, anche se la forma è presente nella ceramica dipinta della fase S. Ippolito.
Pochi i frammenti del tipo ad impasto grosso-lano che ho attribuito alla fase solo per le affinità tipologiche: una grande pentola a fondo conves-so13, un’olla, un bicchiere semiovoide, un vaso a fiasco, anse, il fondo di una coppa su piede con cordonature interne14 e piastre scanalate di diffi-
11 Simili a grotta Fontanazza II, cfr. Maniscalco 2007 p. 79, fig. 8,2; a Poggio dell’Aquila cfr. Cavalier e Cultraro 2010, fig. 17,1.12 Per la diffusione del tipo si veda Albanese 1988 – 89 pp. 191 - 193.13 Simile a Settefarine: Orsi 1910 p. 180, fig. 7.14 Cfr. Poggio dell’Aquila: Cavalier e Cultraro 2010 p. 60, fig. 13 e note 30 - 32 con i relativi confronti.
cile interpretazione (Maniscalco 2008 p. 80 e fig. 80, 81).
2.6 CeramiCa dello stile s. ippolito:
Coppe su piede:143: Orlo arrotondato, pareti a profilo rettilineo,
due anse a nastro verticale tra attacco del piede e vasca. Ingobbio rosso con chiazze nerastre, motivo a croce tra fasce verticali e orizzontali in bruno, all’esterno, illeggibi-le sulle anse. Impasto rosa, grigio al nucleo. Ricomposto da frammenti con integrazioni in gesso. H 23.2, Diam. 37, piede: Diam 19, H 7.5, Spess. 1.5 - 2. Ansa Spess. 1.5. (inv. 47776) (fig. 12F)
144: frammento di piede e parte della vasca. At-tacco di ansa a nastro verticale all’inizio del piede. Ingobbio rosso, fasce orizzontali e verticali delimitano motivo a scaletta vertica-le in bruno. Impasto rosa con inclusi calcarei; ricomposto da due frammenti. H 10, Diam. 11.2, Spess. 1.1 - 1.4. Ansa Largh. 2.1, Spess. 1.1 (inv. 48931) (fig. 12G)
Orli:145: tratto di orlo, probabilmente di coppa su pie-
de, ingobbio rosso. Tracce di triangoli con vertice verso il basso campiti da reticolo in bruno. Impasto grigio al nucleo con inclusi calcarei. H 6.3, Largh. 5.8, Spess. 1-1.4. (fig. 12H)
146: simile, ingobbio rosso, tracce di triangoli con vertice verso il basso campiti da reticolo in bruno. Impasto grigio al nucleo con inclusi calcarei. H 11.2, Largh. 7.6, Spess. 1.2
147: simile, ingobbio rosso, all’interno triangoli con vertice verso il basso in colore chiaro. All’esterno sottile linea incisa orizzontale in corrispondenza dell’orlo. Impasto rossiccio con inclusi calcarei. H 6, Largh. 6.7, Spess. 0.9.
148: simile, ingobbio rosso, fascia orizzontale da cui si dipartono verticali sia all’interno che all’esterno in bruno. Impasto rosa con inclusi calcarei. H 8.5, Largh. 8, Spess. 1. (fig. 13A)
149: simile, ingobbio rosso; all’esterno motivo decorativo in bruno, all’interno fascia oriz-zontale con bande verticali perpendicolari che racchiudono serie parallela di triango-
135S. Ippolito, Caltagirone: nuovi dati sull’abitato dagli scavi Orsi
Fig. 12 - Ceramica di tipo Malpasso (a - e) e S. Ippolito (f - l) (dis. A. Crispino).
Malpasso (a - e) and S. Ippolito (f - l) painted pottery (drawing by A. Crispino).
li. Impasto giallastro, grigio al nucleo con inclusi. H 9, Largh. 13.5, Spess. 1.1. (inv. 48961) (fig. 12L)
150: simile, leggermente estroflesso. Ingobbio
crema, all’interno triangoli con vertice verso il basso in bruno, all’esterno fascia orizzon-tale da cui si dipartono due verticali. Impasto rossiccio con inclusi calcarei. H 8.2, Largh.
136 Anita Crispino
Fig. 13 - Ceramica di tipo S. Ippolito (dis. A. Crispino) (l dis. R. Sequenzia).
S. Ippolito painted pottery (drawing by A. Crispino), (l drawing by R. Sequenzia).
8.7, Spess. 1.5, Diam. 30 (ricostruito). (inv. 48980)
151: simile. Ingobbio crema, all’interno triangolo tagliato da banda verticale in bruno. Impasto grigio al nucleo con inclusi calcarei. H 6.5, Largh. 6.3, Spess. 1.2. (inv. 41656) (fig. 13B)
152: simile. Ingobbio rosso con chiazze grigia-
stre, all’interno triangoli con vertice verso il basso campiti da reticolo in bruno. Impasto rosa con inclusi calcarei. H 12, Largh. 7.6, Spess. 1.7. (inv. 40494)
Pareti:153: frammento di parete di vaso di forma aperta
137S. Ippolito, Caltagirone: nuovi dati sull’abitato dagli scavi Orsi
(coppa su piede) con attacco di ansa vertica-le. Su ingobbio rosso all’esterno fasce ver-ticali in bruno, all’interno serie verticale di punti fiancheggiati da bande semplici. Impa-sto grigio in frattura con inclusi grigi. H 9.3, Largh. 12.7, Spess. 1.6. (inv. 40494)
Olla a corpo globulare, orlo distinto, fondo con-cavo:
154: frammentaria ad ingobbio rossastro. All’e-sterno motivo a croce entro fasce verticali e zig - zag superiore tra fasce orizzontali in bruno. Impasto grigio con inclusi lavici. H 11.5; Largh. 12, Spess. 0.6. (inv. 48928) (fig. 13C)
Olla a corpo globulare, orlo distinto, accenno di collo, fondo concavo:155: simile con collo cilindrico. Una presa a lin-
gua verticale impostata sulla spalla. Su in-gobbio rossiccio decorazione in bruno: due ampie linee spezzate verticali sul collo, una banda orizzontale sottolinea l’attacco del collo e la presa. Impasto grigiastro con in-clusi calcarei. Ricomposto da frammenti. H 19.3, Largh. max. 19.3, Spess. 0.6. (inv. 48956) (fig. 14)
156: tratto di orlo, breve collo distinto; tracce di ingobbio rosso, lungo l’orlo triangoli in co-lore pieno. Una banda orizzontale in rosso lungo l’orlo interno. Impasto rosa chiaro con inclusi lavici. H 7.1; Largh: 7; Spess. 0.7. (fig. 15L)
Boccali:157: globulare con collo cilindrico, fondo piat-
to, attacco di ansa sormontante. Su ingob-bio crema, in colore bruno, serie di triangoli allungati con vertice verso il basso a colore pieno lungo l’orlo; stesso motivo, ma con margini allungati, sul corpo. Impasto grigio con pochi inclusi. Ricomposto da frammenti. H 12.5, Diam. bocca: 7.7/6.9, Diam. fondo: 4.3, Spess.0.5. Ansa Lungh. 2.2. (inv. 48926) (fig. 17B)
158: simile a fondo concavo e bugnetta a rilie-vo contrapposta all’ansa. Su ingobbio rosa fasci di linee spezzate orizzontali con banda sottostante da cui si dipartono segmenti ver-ticali in bruno; sul corpo tracce di bruciato. Impasto giallastro con inclusi. H 16, Diam. 8, Spess. 0.5. Ansa Largh. 2.5, Spess. 1.6. (inv. 48927) (fig. 17C)
159: simile con ansa a nastro verticale leggermen-te caniculata. Su ingobbio rossiccio serie di bande parallele e perpendicolari campite da reticolo in bruno; due motivi a scaletta ver-ticale sulla parte esterna superiore dell’ansa. Impasto rosa con inclusi calcarei, ricomposto da frammenti. H 7.5, Diam. 5, Spess. 0.5 - 0.7. Ansa Spess. 0.7. (inv. 48925) (fig. 17A)
160: frammento di orlo con parete. Ansa a na-stro verticale; su ingobbio rosso all’attacco del collo fascia orizzontale da cui si diparte serie verticale in bruno sul ventre. Impasto rossiccio con inclusi grigiastri. H 8, Largh. 6, Spess. 0.4. (inv. 48980) (fig. 12I)
161: parte della parete con ansa. Su ingobbio rosso,all’esterno banda orizzontale all’attac-co del collo e oblique sul corpo; ansa a nastro verticale decorata con punto in colore pie-no. Impasto rossiccio con inclusi calcarei. H 8.7, Largh. 6.5, Spess. 0.8. Ansa Largh. 2.3, Spess. 1,3. (fig. 15H)
162: fondo umbelicato con attacco di ansa a na-stro verticale. Su ingobbio rosso, all’esterno bande e motivo a scaletta verticali. Impasto rosa. H 2.8, Diam. fondo: 3.5, Spess. 0.5. (inv. 26517) (fig. 15M)
163: simile. Su ingobbio violaceo bande verticali che si incrociano sul fondo in colore bruno. Impasto grigio in frattura con inclusi cal-carei. Ricomposto da due frammenti. H 2, Diam. fondo: 3.5, Spess. 0.7. (fig. 15N)
Fig. 14 - Olla di tipo S. Ippolito.
Wide-Mouthed Jar of S. Ippolito type.
138 Anita Crispino
Bicchiere:164: parte della parete con ansa. Su ingobbio
rosso all’esterno serie di triangoli tagliati da bande verticali, di cui uno con margini allun-gati in bruno; ansa a nastro verticale sul ven-tre. Impasto rosa con inclusi calcarei; ricom-posto da due frammenti. H 9.5, Largh. 7.7, Spess. 0.5. Ansa Largh. 2.2 alla base, Spess. 0.7. (inv. 48928) (fig. 13D)
Coppa con beccuccio di versamento:165: frammentaria con finta presa semilunata sot-
to l’orlo. Tracce di ingobbio rosso e decora-zione a fasce brune. Impasto grigio in frattu-ra con inclusi calcarei H 14, Diam. 16, Spess. 1.4. Beccuccio Diam. 3. (inv. 48932) (fig. 16)
Tazza attingitoio:166: tratto di orlo con parete con accenno di collo,
ansa a nastro sormontante impostata tra orlo e corpo. Su ingobbio rosa fascia orizzontale lungo l’orlo e all’attacco del ventre, da cui si dipartono verticali in bruno; serie di fasce orizzontali entro due verticali sull’ansa. Im-pasto rosa con inclusi calcarei. H 7, Largh. 7, Spess. 0.6. Ansa Largh. 2.5, Spess. 1.3. (inv. 40485) (fig. 13E)
Orli:167: tratto di orlo di anfora con attacco di ansa.
Orlo leggermente estroflesso, collo distinto, leggera cordonatura orizzontale all’attacco dell’ansa. Su ingobbio rosso, lungo l’orlo, triangoli in colore pieno entro bande oriz-zontali in bruno. Impasto grigio in frattura. H 6.6, Largh. 7.5, Spess. 1.5. Ansa Largh. 3.5. (inv. 40494) (fig. 13G)
168: simile ricoperto da ingobbio rosso. All’e-sterno fascia zig - zagante, all’interno tracce di triangoli in bruno. Impasto rosa. H. 6, Lar-gh. 6.4, Spess. 1.3. (fig. 13H)
169: simile, probabilmente di bicchiere. All’e-sterno motivo decorativo a triangoli e bande verticali in bruno. Impasto grigio in frattu-ra con inclusi calcarei. H 7, Largh. 6, Spess. 0.9. (inv. 41656) (fig. 13F)
170: tratto di orlo di vaso a fiasco. Orlo arro-tondato, collo cilindrico; su ingobbio rosso all’esterno, lungo l’orlo, triangoli in colore pieno con margini allungati; sul collo due bande orizzontali e tracce di una verticale all’attacco della spalla. Impasto rossiccio con inclusi. H 10,2, Largh. 9,8, Spess. 1. (fig. 15I)
Piedi:171: forma troncoconica, ingobbio rosso, moti-
vo decorativo in bruno: linee spezzate entro bande orizzontali e verticali. Quattro fori circolari. Impasto rosa con inclusi lavici. Ricomposto da tre frammenti. H 6.3, Diam. superiore 10.5, inferiore 15, Spess. 0.9. (inv. 48931) (fig. 13I)
Pareti:172: frammento di parete di vaso di forma aperta
ricoperto da ingobbio rosso con all’esterno motivo a croce in bruno. Impasto grigio in frattura con inclusi. H 6, Largh. 5, Spess. 1.2.
173: simile con uguale motivo decorativo esterno. All’interno fascia orizzontale in rosso. Impa-sto rosa con inclusi calcarei. H 4, Largh. 6.7, Spess. 0.6. (inv. 42174)
Fig. 17 - Boccali di tipo S. Ippolito.
One-handled Jug of S. Ippolito type.
139S. Ippolito, Caltagirone: nuovi dati sull’abitato dagli scavi Orsi
Brocchetta a collo cilindrico, corpo ovoide, fondo concavo:174: labbro obliquo, ansa a nastro verticale con
appendice superiore impostata tra collo e spalla. Una bugnetta opposta all’ansa; su in-gobbio rosso bande a colore pieno orizzonta-li e verticali di varia ampiezza con motivo a scaletta in bruno. Sull’ansa tracce di colore rosso. Impasto grigio con inclusi lavici; ri-composta da frammenti. H 27, Diam. bocca: 5, Spess. 0.7. Ansa Largh. 2, Spess 1.3. (inv. 48459) (fig. 13L)
Vaschetta ovoidale con ponticello solo su metà del vaso:175: ingobbio rossiccio, impasto grigio in frattu-
ra con inclusi calcarei. Ricomposta da fram-
menti. H. 10.3, Largh. 43, base 37. Recipien-te Diam. 13.5, Spess 1 - 1.5. Ponticello Lar-gh. 15.5, H. 8. (inv. 48939)
Vaschetta rettangolare con ponticello su tutta la lunghezza interna:
176: Frammento di orlo con parte del fondo. Su superficie grigiastra, quattro elementi triango-lari a lati concavi contrapposti, a pittura piena, affiancati da scalette e fasce verticali di varia ampiezza in colore violaceo. Tracce di fasce orizzontali in bruno all’interno. Impasto gri-gio in frattura con inclusi calcarei. H 9.5, Lar-gh. 5, Spess. 1 - 1.5. (inv. 48464) (fig. 13M)
177: frammento di orlo con parte del fondo. Colore rosso all’esterno; tracce all’interno dell’attacco del ponticello. Ricomposto da
Fig. 15 - Ceramica di tipo Malpasso (a - g) e S. Ippolito (h - n).
Malpasso (a - g) and S. Ippolito (h - n) painted pottery.
140 Anita Crispino
frammenti. H 8.6, Lungh. 20.2, Spess.1. (inv. 48463)
178: frammento di ponticello con incavo circola-re sulla parte superiore. Ingobbio rosso con tracce all’esterno di bande verticali in bruno. Impasto rosa. H 4.2, Largh. 7.3, Spess.2.3. (inv. 26517)
Anse:a nastro verticale:179: frammento. All’esterno su ingobbio rosso
motivo a doppia croce entro due fasce ver-ticali in bruno; all’interno su fondo crema banda obliqua in rosso marginato da fasce in bruno. Impasto grigio in frattura con inclusi calcarei. H 3.2, Largh. 2.8, Spess. 0.9. (inv. 40489) (fig. 18A)
180: simile. Su ingobbio rosso zig - zag entro fa-sce verticali in bruno. Impasto grigio in frat-tura. H 4.3, Largh. 3, Spess. 1. (inv. 40489) (fig. 18B)
181: simile, ricoperto da colore rosso. All’ester-no banda obliqua in bruno. Impasto grigio in frattura. H 4.5, Largh. 3, Spess. 1.7. (inv. 41656) (fig. 18C)
182: simile. All’esterno motivo a doppia croce tra bande verticali in nero, all’interno due fasce verticali e orizzontali in rosso. Im-pasto giallastro. H 4.5, Largh. 3. Spess. 1. (inv. 40489)
183: simile a sezione cilindrica ricoperta da colo-re rosso con chiazze esterne in bruno. Impa-sto grigio in frattura. H 7.2, Largh. 2, Spess. 1.5. (inv. 40489)
Soprelevazione a piastra triangolare con appendi-ce asciforme:
184: frammento; su ingobbio rosso serie di fasce orizzontali entro due verticali in bruno. Im-pasto rosa, grigio in frattura. H 8, Largh. 5.5, Spess. 1. (inv. 41656) (fig. 9F)
Soprelevazione a piastra sormontante:185: frammento. Su ingobbio rosso all’esterno
due motivi a scaletta verticali. Impasto grigio in frattura con inclusi calcarei. H 4, Largh. 5, Spess. 1. (inv. 41656) (fig. 18D)
186: simile con apici evidenziati. Ingobbio rosso. Impasto rosa con inclusi calcarei. H 4.7, Lar-gh. 5, Spess. 0.6 (inv. 40488)
Ceramica non decorataCoppe su piede:187: piede a profilo curvilineo su base piatta.
Ingobbio crema-rosaceo; due brevi prese a lingua orizzontali sopra l’attacco del piede. Ricomposta da frammenti con integrazioni. H 13.1, Diam. orlo 29, piede 14/11.5; prese Largh. 7.5 (inv. 48936) (fig. 11B)
188: simile con attacco di ansa a nastro verticale alla base della vasca. Ingobbio giallastro, im-pasto grigio in frattura con inclusi. Ricompo-sto da frammenti con integrazioni in gesso. H 16.5, Diam. 31. Piede: Diam. 14.5, Spess. 0.9. (inv. 48935) (fig. 18E)
189: ingobbio rosaceo; piede a profilo curvili-neo, due anse a nastro verticale frammentarie all’attacco del piede. Mancante della parte superiore; ingobbio rossastro con chiazze gialle. Impasto grigio in frattura con inclusi calcarei. Ricomposto da frammenti con inte-grazioni in gesso. H con ansa: 20, Diam. pie-de: 23, fondo: 25, Spess. 1.8. Ansa: Largh. 5, Spess. 2. (inv. 48973)
Vaschetta rettangolare con ponticello su tutta la lunghezza interna:
190: integra, acroma. Impasto grigio in frattu-ra con inclusi calcarei. H 8 - 11, Largh. 34, Spess. 1.5. Recipiente Diam. 14, ponticello Diam. 6, H 7. (inv. 47775) (fig. 18N)
191: frammento di ponticello con incavo circola-re sulla parte superiore e parte del pilastrino. Ingobbio chiaro. Impasto grossolano grigia-stro. H 7, Largh. 5, Spess. pilastrino: 3.4. (inv. 48948)
Anche per la ceramica tipo S. Ippolito è possibile distinguere le due classi. La forma va-scolare maggiormente rappresentata è la coppa su piede. Gli schemi decorativi, sempre su fondo rosso, ad eccezione di due frammenti nei quali è chiaro, sono semplici: bande verticali od orizzon-tali e, lungo l’orlo, triangoli a colore pieno o cam-piti da reticolo che si confrontano con i frammenti della Grotta Infame Diavolo (De Miro 1961, fig. 2 n. 1074), Muculufa villaggio (Maniscalco 1995 p. 41, p. 148, pl. 22), ma anche Grotta Pellegriti e grotta Marca (Ima Tartara p. 249, 9; p. 247, 6). Più complesso sembra lo schema del n. 149 e 153, il primo soprattutto, legato agli schemi dello stile di Serraferlicchio ma confrontabile con ceramica
141S. Ippolito, Caltagirone: nuovi dati sull’abitato dagli scavi Orsi
da Mezzebbi (Privitera 1994 p. 356, fig. 16; 1997 p. 88, fig. 12).
A parte va citato il n. 28 per essere decorato in bianco su fondo rosso; uguale schema ma su forma diversa si ritrova a Serraferlicchio (Arias 1938, fig. 77).
La brocca e l’olla, forma molto diffusa negli stili precedenti, ma nella variante a labbro estro-flesso, sono forme certe, tra cui un esemplare (cat. n. 154), importante anche per la presenza di inclu-si lavici nell’impasto, trova confronti nella grotta Infame Diavolo (De Miro 1961, fig. 9 n. 1030), il n 155 è simile ad un frammento da Grotta Fonta-nazza I (Maniscalco 2007 p. 180, fig. 8). Confron-ti anche a Grotta Palombara di Raffadali (Gullì 2000 pp. 143 - 147, tav. XLVI).
Il boccale è, insieme alla vaschetta e alla brocca a bocca obliqua, la forma tipo dello sti-le di S. Ippolito. I confronti più stringenti sono, per la forma, con Malpasso (Albanese 1988-89, fig. 13,4) ma anche con Villafrati (Bovio Marconi 1944, tav. XIII, 1), con il materiale della Grotta Petralia di Adrano (Cultraro 1997, fig. 1; Ima Tar-tara p. 276, nn. 69-70) e con quello dal Castello di Pietrarossa di Caltanissetta (Guzzone 2003 p. 5,b). Meno significativi con Muculufa villaggio (Maniscalco 1995 pp. 44-46, pl 27-28, pp. 153-154) e Tornambè (Giannitrapani e Iannì 2011 pp. 275-276, fig. 3), caratterizzati da decorazioni più complesse e dalla mancanza della bugna opposta all’ansa. Gli schemi decorativi si ritrovano simili in frammenti fittili da Serraferlicchio.
Per quel che riguarda gli impasti, in maggio-ranza sono di colore rosa a frattura grigia ed in-clusi calcarei o grigiastri, due frammenti conten-gono tritume lavico.
La coppa globulare con beccuccio di versa-mento ad ingobbio rosso e tracce di decorazione (cat. n. 165), si ritrova a Grotta Infame Diavolo (De Miro 1961, fig. 8, 989), a Mezzebbi (Privitera 1994 p. 356, fig. 17; 1997 p. 88 fig. 16), Mucu-lufa villaggio, ma con ricca decorazione dipinta (Maniscalco 1995 tav. 38 n. 122) nella grotta Pel-legriti di Adrano (Ima Tartara p. 249 n. 10) e al castello di Pietrarossa di Caltanissetta (Guzzone 2003 p. 5, a).
Esemplari inediti o poco conosciuti si possono confrontare con la brocchetta a bocca obliqua a fondo concavo (cat. n.174); vasi simili, sia pure di dimensioni minori sono stati trovati in c.da Poz-zillo presso Gela (Adamesteanu 1960; Tusa 1997, II p. 90), in c.da Durrueli presso Realmonte (Ag) (De Miro 1968 p. 120; Tusa e Pacci 1990, fig. 15), nella collezione Veneroso di Sciacca (Tusa 1997, II p. 91). Da porre in risalto, infine, la presenza nella brocca a bocca obliqua di inclusi lavici.
Due tipi sono individuabili per la vaschetta, forma che perdura nel Bronzo antico: a pianta ovoidale con ponticello solo su metà del vaso, e rettangolare su tutta la lunghezza interna, di cui il secondo anche nella classe non decorata. Il particolare motivo del frammento n. 176 si confronta con uno simile in un boccale facen-te parte della collezione Veneroso (Guilaine et alii 2009 p. 73, n. 54). Da ultimo, per la classe dipinta, sono da citare orli di anfore ed un piede traforato.
Le anse per la loro decorazione a doppia cro-ce o a bande verticali si possono paragonare alla ceramica di Serraferlicchio ma anche a quella ca-stellucciana. Tra i vasi ed i frammenti non deco-rati, diffuse le coppe su piede.
2.7. CeramiCa dipinta in bianCo su fondo grigio:
192: tratto di orlo con parete a superficie ester-na grigio scura lucidata a stecca. All’esterno bande parallele verticali in colore chiaro. Im-pasto grigio. H 8, Largh. 4.3, Spess. 0.5.
Tra questa classe ceramica propria dell’età del Rame e probabilmente contemporanea allo stile di Serraferlicchio, si colloca l’orlo di scodella a semplice decorazione lineare (Tiné 1965 p. 202; Bernabò Brea 1968 - 69 p. 28; Bovio Marconi 1979 tav. XII; Bernabò Brea 1988 p. 474).
Fig. 16 - Coppa con beccuccio di versamento di tipo S. Ippolito.
Spouted Bowl of S. Ippolito type.
142 Anita Crispino
2.8 CeramiCa dipinta in nero e rosso su fondo Chiaro:
193: tratto di orlo leggermente estroflesso. Su in-gobbio bianco esterno banda verticale in ros-so diluito marginata in nero. Impasto grigio. H 6.2, Largh. 4.1, Spess. 0.6 - 0.9. (fig. 18R)
2.9 CeramiCa assimilabili alla facies di piano quartara:
Presa a lingua prominente forata:194: frammento di parete di vaso a profilo curvi-
lineo con presa a due fori. All’esterno bande parallele verticali in bruno. Impasto grigio. H 4.5, Largh. 5.8, Spess. 0.5 - 0.7. Presa Largh. 3, Spess. 0.9. (inv. 48967) (fig. 18P)
195: simile acroma con un foro. Impasto grigio. Largh. 3, Spess. 0.8. (fig. 18S)
196: simile con tre fori. Impasto grigio. Largh. 3.9, Spess. 1. (fig. 18Q)
Alla facies eoliana si collegano i frammenti di piccoli vasi con prese a superficie grigia di cui il n. 194 con decorazione a sottili bande verticali dipinte (imitazione locale?) (Bernabò Brea e Ca-valier 1960 tav. XX, 5 - 8).
2.10 frammenti di inCerta ColloCazione CronologiCa:
Scodella a profilo curvilineo:197: tratto di orlo con parete. Superficie grigiastra
rozzamente modellata, cattiva cottura. Sotto l’orlo, all’esterno, presa cilindrica allungata con foro orizzontale. Impasto grigio. H 7.8, Largh. 6.2, Spess. 0.7 - 1. Presa: Largh. 2.
Scodella a pareti troncoconiche:198: tratto di orlo, leggermente distinto, rozza-
mente modellato, ingobbio rosa con chiazze grigiastre. Sotto l’orlo presa verticale a lin-gua. Impasto grigio in frattura. H 7, Largh. 13.5, Spess. 1.1. (inv. 48974)
Scodella a pareti troncoconiche con impressioni tali sotto l’orlo:199: tratto di orlo con serie di rozze impressioni
digitali all’esterno. Impasto giallastro, grigio in frattura. H 6.2, Largh. 5.4, Spess. 1.3.
200: tratto di orlo, leggermente estroflesso con
cordoncino esterno decorato ad impressioni. Impasto giallastro, grigio in frattura. H 3.6, Largh. 4.1, Spess. 1.1.
201: tratto di orlo con basso cordone decorato con impressioni digitali. Impasto grigio. H 3.8, Largh. 3.8, Spess. 0.8 - 1.1. (inv. 40516) (fig. 18I)
202: tratto di orlo, arrotondato, con serie di cup-pelle a rilievo. Impasto grigiastro con inclusi calcarei. H 5.8, Largh. 4.2, Spess. 0.8
Olla a corpo globulare:203: tratto di orlo con parete ed attacco di ansa
a maniglia sulla spalla. Ingobbio rosa con chiazze giallo - grigiastre. Impasto rosa, gri-gio in frattura con inclusi calcarei. Ricompo-sto da frammenti. H 11.5, Largh. 14, Spess. 1. Ansa: Spess. 1.5. (inv. 48933)
Olla a corpo globulare con impressioni digitali o bugnette lungo l’orlo:204: tratto di orlo, leggermente estroflesso con
impressioni digitali, acromo. Impasto grigio. H 3.8, Largh. 3.8, Spess. 0.8 - 1.1.
205: simile, acromo, con bugnette a rilievo lungo l’or-lo. Impasto grigio. H 4.6, Largh. 5.7, Spess. 0.8.
206: simile con impressioni digitali sull’orlo. Ingobbio rosa scuro. Impasto grigio. H 7.3, Largh. 10.8, Spess. 1.2. (fig. 18G)
207: simile con rozze impressioni digitali. Sulla superficie esterna chiazze grigiastre; impasto rossiccio, grigio in frattura. H 7.5, Largh. 9.3, Spess. 1.1.
Olla a corpo cilindrico con bugnette lungo l’orlo:208: tratto di orlo acromo con all’esterno due bu-
gnette a rilievo. Impasto grigio. H 4.8, Largh. 4.6, Spess. 0.7 - 1.2.
Bicchiere a corpo cilindrico e fondo piatto:209: miniaturistico a bocca irregolare, orlo arro-
tondato leggermente rientrante. Una piccola presa forata a lingua sul ventre; chiazze gri-giastre in superficie. Impasto grigio. H 5.5, Diam. 5, Spess. 0.8. (inv. 48918) (fig. 18H)
210: simile con attacco sull’orlo di un’ansa ver-ticale, ingobbio rosa con chiazze grigiastre. Impasto grigio. H 3.5, Diam. 3, Spess. 0.5. (inv. 48462) (fig. 18L)
211: simile a fondo concavo, bocca approssimati-vamente quadrata, rozzamente modellato. Im-
143S. Ippolito, Caltagirone: nuovi dati sull’abitato dagli scavi Orsi
Fig. 18 - Ceramica di tipo S. Ippolito (a - f, n), di incerta cronologia (g - m, o, r) e assimilabili allo stile di Piano Quartara (p, q, s) (dis. A. Crispino).
Pottery of S. Ippolito type (a - f, n), pottery of uncertain dating (g - m, o, r) and pottery correlating to Piano Quartara culture (p, q, s) (drawing by A. Crispino).
144 Anita Crispino
pasto rosa con inclusi calcarei. H 3.5, Largh. bocca 3.5, Spess. 0.5. (inv. 42171) (fig. 18M)
Imbuto (?):212: tratto di orlo con parete acroma. Attacco di
ansa sormontante sull’orlo; tracce di brucia-to all’interno. Impasto rosa, grigio al nucleo. H 13.5, Diam. 22, Spess. 1.6. Diam. foro 7. (inv. 48975) (fig. 18O)
Vasi a filtro:213: tratto di orlo, piatto, parete a profilo curvili-
neo. Impasto rosa grigiastro al nucleo. H 5.6, Largh. 5.3, Spess. 0.9. (inv. 48952)
214: tratto di orlo, piatto, parete a profilo curvi-lineo. Impasto grigiastro. H 4, Largh. 4.2, Spess. 1.4. (inv. 42173)
215: tratto di orlo, piatto, parete a profilo curvili-neo. Impasto rosa grigiastro al nucleo. H 3.8, Largh. 6.5, Spess. 1.3. (inv. 48952)
216: frammento di parete a profilo curvilineo. Im-pasto rosa grigiastro al nucleo. H 3, Largh. 4.2, Spess. 1. (inv. 42173)
Pithos ad orlo leggermente estroflesso:217: tratto di orlo con parete. Orlo arrotondato,
ansa a nastro verticale impostata tra collo e spalla. Superficie esterna grigiastra con chiazze giallastre all’interno. Impasto gial-lastro, grigio al nucleo. Ricomposto da due frammenti. H. 18, Diam. 6, Spess. 3. Ansa: Largh. 5, Spess. 3. (inv. 40496)
218: tratto di orlo con parete a profilo rettilineo, ansa a maniglia tra orlo e parete. Sulla su-perficie esterna, su ingobbio, cordone a leg-gero rilievo. Impasto rosa, grigio al nucleo. Ricomposto da tre frammenti con integrazio-ni in gesso. H 18, Largh. 33, Spess. 4. Ansa Largh. 6.5, Spess. 3.5. (inv. 48977)
219: tratto di orlo con parete a profilo rettilineo. Su ingobbio rosa, decorazione esterna plastica formata da un cordone orizzontale da cui di-partono verticali. Impasto rosa con inclusi cal-carei. H 14, Largh. 12, Spess. 3. (inv. 48976)
Bacino a profilo rettilineo, ansa orizzontale:220: tratto di orlo, arrotondato, con ansa. Sottile
linea incisa sotto l’orlo all’esterno. Impasto giallastro, grigio al nucleo. H 12, Largh. 15, Spess. 1.2 - 1.5. Ansa Largh. 11.5, Spess. 3.3. (inv. 40495)
Pareti:221: frammento di parete di pithos decorato all’e-
sterno con impressioni digitali; interno rosso. Impasto rosa, grigio al nucleo. H 13, Largh. 12.5, Spess. 3.5. (inv. 40501)
Soprelevazione a piastra rettangolare impostata sul labbro:
222: frammento a superficie grigia con chiazze più chiare. Nella parte interna una cuppella a rilievo. Impasto grigio. H 6.3, Largh. 9.5, Spess. 0.8.
223: simile, su ingobbio crema all’esterno piccola presa ed attacco di ansa. Tracce di bruciato all’esterno. Impasto rosa con inclusi calcarei. H 9.7, Largh. 16, Spess. 1.9. Presa Largh. 3.8, Spess. 1. (inv. 48974)
Presa semilunata:224: frammento di parete di vaso di forma aperta
(scodella?) con presa schiacciata esterna, in-gobbio crema. Impasto grigio. H. 5.5, Largh. 7.5, Spess. 0.6. (inv. 26517)
Genericamente nell’età del Rame si collocano i frammenti di scodelle e di olle decorati con im-pressioni digitali o con cordone a rilievo e quelli con bugnette a rilievo. Possono confrontarsi con reperti della medesima fase diffusi in tutta la Si-cilia e le Eolie.
Se difficile risulta l’inquadramento cronolo-gico dei pithoi (Procelli 1989 fig. 5, 18; Vacirca 2008 p. 153 figg. 127-128), manufatti simili ai vasetti miniaturistici sono stati messi in luce nella necropoli proto eneolitica di Piano Vento (Castel-lana 1995 p. 116).
Tra le scodelle, i n. 197 e n. 198 si ritrovano simili a Piano Quartara (Bernabò Brea e Cavalier 1968 tav. VII, 2), nella grotta Infame Diavolo e a Serraferlicchio; il n. 212, probabilmente un imbu-to, si confronta con uno simile dalla grotta Curci presso Catania (Orsi 1907B, fig. 28).
Tra le prese di difficile collocazione rimango-no il n. 224 e il 222.
Strumenti da lavoro ed altri oggetti fittili
Tra i materiali recuperati figura un cospicuo numero di fuseruole e di rocchetti fittili. Le prime, di forma biconvessa più o meno schiacciata sono
145S. Ippolito, Caltagirone: nuovi dati sull’abitato dagli scavi Orsi
di impasto grigiastro e di dimensioni comprese tra i cm. 2,5 e 4 di altezza e diametro tra i 3,7 e i 5,3; si confrontano con quelle recuperate nei livelli eneolitici della grotta della Chiusazza (Tinè 1965 p. 263 tav. XVII nn. 8 - 10, p. 272 tav. XXVI nn. 1-4, 7). I rocchetti, di altezza compresa tra 3 e 4 cm., erano impiegati probabilmente come pesi da telaio; sebbene frequenti negli abitati del Bronzo antico, sono attestati anche in complessi del Rame finale (Cavalier e Cultraro 2010 p. 63). Una ventina di esemplari di corni o phalloi fittili su base discoidale o cilindrica testimoniano infine attività di natura cultuale.
Considerazioni conclusive
L’esame del materiale riportato in catalogo, alla luce anche delle scarne ma preziose informa-zioni ricavabili dai taccuini di P. Orsi e R. Car-ta, consente di formulare alcune osservazioni di carattere generale sulla natura del sito e del suo ricco deposito.
Il primo dato di una certa rilevanza riguarda la possibilità, grazie alle informazioni ricavabili dai taccuini di scavo, di localizzare con una certa precisione il luogo di rinvenimento del sito più antico, ubicato sulle falde sud – occidentali del colle, in prossimità del torrente Caltagirone; la quantità e la ricchezza della produzione fittile e litica, descritta dagli scavatori al momento del-la scoperta, testimoniano la lunga durata di vita dell’insediamento che, sorto nel Neolitico me-dio15, ebbe il momento di massimo sviluppo nel corso dell’Eneolitico, ovvero, in base alle nuove datazioni radiometriche (Gullì et alii 2014), tra il IV e la fine del III millennio, senza alcuna apparente cesura.
Sebbene sia Orsi che Carta ricordino di aver individuato varie strutture in pietrame, di cui non viene disegnata la pianta né l’esatta ubicazione, sembra che, almeno nell’ultima campagna di scavo, sia stato intercettato lo scarico dell’inse-diamento. La sezione riportata nella figura 2 evi-denzia uno spesso strato di oltre m. 5 costituito da ceneri, carboni, frammenti fittili ed ossei senza alcuna traccia di strutture murarie corrisponden-
15 Si veda supra nota n. 2.
ti. Problematica l’attribuzione cronologica della capanna, l’unica di cui viene riportata documen-tazione grafica (fig. 3); con orientamento NO/SE, era di forma probabilmente rettangolare, con il lato minore di m. 3,10, il maggiore parzialmen-te conservato per una lunghezza di m. 2,60. Era delimitata da un perimetro murario formato da pietrame di varia dimensione dello spessore di almeno m. 0,80 e, probabilmente, una partizione interna nel lato Est divideva in due ambienti la struttura. Un focolare è rintracciato nella parte settentrionale e la presenza delle macine attesta l’attività di molitura dei cereali all’interno dello spazio domestico16.
La mancanza di descrizione del corredo va-scolare trovato all’interno della struttura ci im-pedisce di stabilire una cronologia certa dell’am-biente abitativo: alcuni dati, tuttavia, meritano di essere chiamati in causa ai fini della proposta di inquadramento della struttura. Carta annotava di avere trovato a NE della capanna la brocchetta a bocca obliqua eneolitica (fig. 13L) tipica dello stile di S. Ippolito, ma non sappiamo quale sia la relazione stratigrafico - spaziale tra il vaso e l’e-dificio. Che si possa trattare di una struttura abi-tativa riferibile all’Eneolitico sarebbe indicato dal rinvenimento di un gruppo di frammenti lungo la parete nord-occidentale, tra i quali Orsi aveva riconosciuto elementi della cultura neolitica di Matrensa e Stentinello. Appare assai verosimile, invece, che le ceramiche con incisioni ed impres-sioni menzionate dallo studioso non siano di epo-ca neolitica, ma siano attribuibili a quelle produ-zioni dell’Eneolitico iniziale note come ‘stile di Calafarina’. Se questa ricostruzione cogliesse nel segno, una datazione della capanna a pianta ret-tangolare nell’ambito dell’Eneolitico risulterebbe assai verosimile e coerente con gli elementi di tipo Calafarina identificati tra i materiali raccolti nel sito17.
16 Sull’architettura domestica nella Sicilia centro meridio-nale si veda McConnell 2003, Giannitrapani 2012, Gianni-trapani cds.17 La pianta è molto simile alla struttura scavata dallo stesso Orsi nel vicino colle di Settefarine (Orsi 1910 p. 183 fig. 8). Pochi gli esempi di architettura domestica datati al Rame finale: a pianta circolare nell’insediamento di Tornambè (En) (Giannitrapani e Iannì 2011), di incerta planimetria la capan-na di Biancavilla c. da Scalonazzo (Privitera, Turco, Alber-ghina 2012 pp. 710 - 714).
146 Anita Crispino
Un altro elemento che contraddistingue il sito in esame è la ricca documentazione connessa con la litotecnica, in particolare su pietra scheggiata e lisciata. La lavorazione della pietra avvenne certa-mente in loco perché furono recuperati strumenti di vario tipo e schegge di selce e di ossidiana18; inoltre, il riferimento di Carta al rinvenimento di “magnifiche selci”, immediatamente a NE della struttura sopra ricordata, potrebbe far ipotizzare un’area di lavoro per la produzione di industria litica.
Poco si può aggiungere sul frammento di lama di pugnale in rame19: il recupero effettuato insie-me a selci, ossa, un nucleo di ossidiana e a fram-menti vascolari privi di descrizione in occasione del sopralluogo di Inglieri nel dicembre 1920, rende incerta la pertinenza alla fase eneolitica dell’insediamento.
Altre informazioni di una certa rilevanza ri-guardano la presenza di una cospicua massa di re-sti ossei animali che, accuratamente descritti nei giornali di scavo, si riferiscono principalmente a bovini e ovicaprini, confermando la forte inciden-za della pratica dell’allevamento e, in misura mi-nore, della pesca20.
Ma il sito di certo dovette la sua ricchezza ad altri fattori; la sua posizione geografica, nel pun-to di incontro tra le valli del fiume Caltagirone e Gela, importanti vie di comunicazione, deve averne fatto un punto di controllo di queste stesse vie. Prodotti di scambio devono essere stati anche l’argilla, abbondante nelle aree limitrofe e forse il gesso21 e lo zolfo, il cui sfruttamento in epo-ca preistorica sembra essere avvenuto in età suc-cessiva (Castellana 1998). Questi stessi minerali sono presenti in tutta la zona meridionale della Sicilia, proprio la zona in cui è particolarmente diffuso il complesso di ceramiche dette di S. Ip-polito.
18 Nell’industria litica, il cui studio è affidato alla dott.ssa Virginia Forzisi, numerosa è la presenza delle punte foliate a base concava.19 H 4, largh. max. 2,5.20 Orsi e Carta menzionano più volte l’abbondanza di palchi di cervo, che si configura come un dato di un certo interesse a favore della forte incidenza della pratica della caccia. 21 Gusmano e Martinelli 2012. Il sito di Venetico presenta molte affinità con S. Ippolito, in particolare la presenza di grande quantità di pietrame bruciato che ha fatto ipotizzare la presenza di una cava per l’estrazione e la lavorazione del calcare e del gesso utilizzata durante la facies di Malpasso.
Non disponendo di più accurate informazioni sulla stratigrafia del deposito, il complesso di ce-ramiche può essere illustrato solo attraverso ampi raggruppamenti tipologici e stilistici. Tra i 224 frammenti riportati in catalogo, la percentuale maggiore è attribuibile alla fase Malpasso (26,5%) e a quella di S. Ippolito (25%)22. Queste percentua-li risultano fortemente attendibili perché si riferi-scono a due raggruppamenti ceramici che consen-tono una certa identificazione grazie alle spiccate peculiarità morfotecniche. Come si coglie bene nella stratigrafia messa in luce nell’insediamento sul Poggio dell’Aquila presso Adrano (Catania) (Cavalier e Cultraro 2009, p. 62, fig. 17), la classe dipinta in bruno su fondo rosso lustrato è recenzio-re rispetto a quella monocroma, pur condividendo in alcuni casi il medesimo repertorio vascolare. Se le percentuali risultano assai ponderate, anche la divisione interna dei due raggruppamenti presenta elementi di convergenza, a cominciare dall’eleva-to numero di fogge aperte, quali scodelle e coppe, a cui seguono boccali e bicchieri in più varianti. Meno rappresentate sono le fogge chiuse, ad ec-cezione delle olle, ad esempio brocche e fiaschi, attestate soprattutto nelle fasi iniziali del Rame ed in qualche esemplare con decorazione Serraferlic-chio (fig. 7C).
Alcuni tipi sembrano essere di lunga durata, come le coppe che, nella varietà a labbro quadri-lobato, sono attestate fino alla fase di Serrafer-licchio. Il tipo del bacino su piede (fig. 11B) si diffonde alla fine dell’età del Rame (facies Mal-passo-Chiusazza) per diventare la forma mag-giormente utilizzata nel Bronzo antico. Sembra tuttavia che sia presente anche a Serraferlicchio nello stile omonimo. (Arias 1928 coll. 733).
Un’altra forma particolarmente diffusa è l’olla che, nel deposito di S. Ippolito, è documentata fin dalla fase più antica dell’Eneolitico (fig. 4B); il tipo a labbro estroflesso (fig. 13C) è comune nelle fasi finali dell’epoca.
Se il bicchiere semiovoide, con o senza piede, è caratteristico esclusivamente del periodo Mal-passo - Chiusazza (Procelli 2001 p. 160; Cavalier e Cultraro 2009, p. 60, fig. 14.1-2), la tazza con ansa tra collo e ventre (fig. 7B), comparsa sicura-mente in fasi avanzate del Rame (Adamo e Gullì
22 Eneolitico iniziale (S. Cono – Piano Notaro, Calafarina e Conzo) 20%; Serraferlicchio 21%.
147S. Ippolito, Caltagirone: nuovi dati sull’abitato dagli scavi Orsi
2012 p. 604), è attestata anche nel repertorio dello stile dipinto di S. Ippolito; di poco più recente, il boccale a corpo globulare, si ritrova in contesti Malpasso (Albanese Procelli 1988-89 pp. 193-196). Esemplari a bocca più ampia saranno carat-teristici della fase castellucciana iniziale (Cultra-ro 2007, p. 65, fig. 3).
La coppa globulare con beccuccio di versa-mento (fig. 16), anche per la falsa presa semiluna-ta, sembra risalire a prototipi Malpasso.
Per quel che concerne i motivi decorativi, ca-ratteristici dell’intero corpus eneolitico di S. Ip-polito sono le fasce a zig-zag e soprattutto i trian-goli lungo l’orlo sia ad incisione che a dipintura. Diffuse anche le linee spezzate in ambedue le tecniche.
Nel particolare, quelli caratteristici dello stile c.d. S. Ippolito – i triangoli lungo l’orlo, il moti-vo a scaletta, le linee spezzate, il reticolo – sono presenti nei complessi del comprensorio agrigen-tino, come Serraferlicchio23, e nello strato 3 della grotta Vangu del Lupo, dove la decorazione di-pinta, organizzata in schemi sempre più regolari e geometrizzati, è in associazione con la ceramica monocroma del tipo Malpasso (Adamo e Gullì 2012 pp. 601-602).
Se le connessioni con lo stile di Serraferlic-chio si limitano agli schemi decorativi che, come è stato chiarito in precedenza, a S. Ippolito sono più regolari e rispondenti alla partizione tettonica del vaso, numerose appaiono le convergenze con il gruppo di Malpasso, dove alcune forme (boc-cali e coppe su piede) risulterebbero comuni ad entrambi i complessi tipologici.
Tali dati, pur in mancanza di una stratigra-fia certa, potrebbero far supporre la coesistenza,
23 Dalle stratigrafie note sembra che la ceramica Serraferlic-chio sia comparsa durante le fasi finali dell’Eneolitico antico essendo largamente attestata l’associazione con ceramica S. Cono - Piano Notaro, ma se nella Sicilia orientale non è più documentata nell’Eneolitico finale, nella Sicilia centro - me-ridionale si trova ben attestata fino alle soglie del Bronzo an-tico. Questo ha fatto ipotizzare una periodizzazione dell’E-neolitico non in tre fasi, ma in due, antica e finale (Leighton 1999, p. 91), senza alcuna soluzione di continuità e in cui Serraferlicchio, nel periodo di massimo sviluppo, partecipa di entrambe. La ceramica di Serraferlicchio non è più consi-derata una fase cronologica a sé stante, ma aspetto tipologico e stilistico associato sia con le fasi più antiche che con quelle più recenti dell’Eneolitico siciliano. Si veda anche Maniscal-co 1994 pp. 327 – 328; 2007 p. 179; Adamo e Gullì 2008 p. 195, 2012 p. 607 e Giannitrapani 2009 p. 230.
almeno parziale, nel Rame Finale di due classi ceramiche: una interamente dipinta in rosso, l’al-tra con schemi decorativi in colore bruno di tipo Serraferlicchio sicuramente evoluti, forse legate ad un diverso uso funzionale delle stesse. A sup-porto di tale tesi, suggerita in passato da E. Pro-celli (Procelli 2001; Martinelli e Procelli 2011) e confermata dal riesame delle stratigrafie delle grotte Palombara e Conzo (Odetti 2012), va l’at-testazione, in ambedue gli stili, di alcune fogge ben caratterizzate sul piano tipologico, quali i boccali monoansati, le coppe su piede, le anse a nastro con appendice superiore e la falsa presa ad archetto semilunato24.
Anche a S. Ippolito del resto sono state identi-ficate forme attribuibili all’orizzonte di Malpasso, interamente dipinte in rosso ma con fascia in bru-no lungo l’orlo (cat. n. 99, 123, 124, 126).
Questa interpretazione, tuttavia, nel sotto-lineare i legami diacronici interni, non vuole escludere l’eventuale ruolo esercitato da influssi extra – insulari (Cocchi Genick 2009, p. 149, fig. 7C) che potrebbero essere pervenuti, come giu-stamente ipotizzato, attraverso la circolazione di elementi simbolici in reti di scambio non dirette (Cazzella e Maniscalco 2012, pp. 97 - 99). Nel-la medesima prospettiva si inserisce la proble-matica sull’origine e diffusione della brocchetta a fondo concavo, per la quale mancano ancora oggi una accurata carta di distribuzione e soprat-tutto gli elementi di ancoraggio cronologico, dal momento che la maggior parte degli esemplari noti in letteratura risulta priva di contesto. Se le forti analogie nella forma e negli aspetti morfo-tecnici inducono a ricondurre la fabbricazione di questi vasi ad un ambito produttivo specializza-to, nel caso dell’esemplare da S. Ippolito (fig. 13L), pur in assenza di indagini archeometriche, la presenza di inclusi lavici nell’impasto ne fa-rebbe un prodotto di importazione probabilmen-te dalla zona etnea.
24 Recenti indagini archeometriche eseguite su campio-ni di varia epoca da Tornambè (En) hanno evidenziato una maggiore affinità petrografica degli impasti tra il vasellame acromo di facies S. Ippolito e quello monocromo Malpasso piuttosto che con gli esemplari dipinti della stessa fase. La presenza degli elementi decorativi avrebbe dettato l’esigenza di una tecnologia diversa e, di conseguenza, differenze nella composizione degli impasti (Fragnoli, Manin, Giannitrapani, Iannì, Levi 2013)
148 Anita Crispino
Rimane una questione aperta la problematica relativa ai rapporti tra lo stile S. Ippolito e la fa-cies successiva di Castelluccio. Quest’ultima nel sito è indiziata da pochi frammenti, di cui il più interessante è un attingitoio simile ai prodotti cd. proto – castellucciani (cat. n.166). Le vaschette con ponticello interno, invece, pur essendo tipiche di contesti del Bronzo antico, sono decorate con motivi caratteristici del Rame Finale (fig. 13M).
La mancanza di altre forme ceramiche, il bicchiere a clessidra per primo, e di schemi de-corativi più complessi tipici del Bronzo antico (Cultraro 2007, p. 65), induce a pensare che l’in-sediamento sia stato abbandonato o si attardasse in forme e schemi eneolitici, nel periodo in cui nella stessa zona calatina si diffondeva la facies castellucciana.
Se nel Neolitico e nell’età del Rame S. Ippo-lito non mostrava preoccupazioni difensive, ciò non avverrà nel Bronzo medio quando, dopo un probabile periodo di abbandono, il centro si svi-lupperà nella parte alta del colle.
Ringraziamenti - Si ringraziano le dott.sse Concetta Ciur-cina e Beatrice Basile, già direttori del Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” per aver permesso questa ricerca e per aver concesso la pubblicazione dei taccuini di scavo di Paolo Orsi e Rosario Carta. Un grazie per aver rivisto il testo all’amico Massimo Cultraro. I disegni sono della scrivente e di Roberto Sequenzia. Le fotografie di Germana Gallitto, laboratorio fotografico del Museo “Paolo Orsi” di Siracusa.
Riferimenti Bibliografici
Adamesteanu D. 1960, Scavi e ricerche nei dintorni di Gela, NSc, pp. 218-219.
Adamo O., Gullì D. 2008, Il tipo della coppa quadrilobata nell’ambito dell’Eneolitico siciliano, RSP LVIII, pp. 191-199.
Adamo O., Gullì D. 2012, La ceramica di Serraferlicchio da Serraferlicchio, AttiIIPP XLI, pp. 601-609.
Albanese R.M.1988 - 89, Calascibetta (Enna). Le necro-poli di Malpasso, Carcarella e valle del Coniglio, NSc, pp. 161-398.
Alberghina F. 2012, Considerazioni sulla definizione del-la facies di Malpasso - Sant’Ippolito in Sicilia, AttiIIPP XLI, pp. 663-671.
Alberghina F, Gullì D. 2011, L’età del rame finale in Si-cilia: considerazioni per una facies unitaria di Malpasso - Sant’Ippolito, AttiIIPP XLIII, pp. 129-134.
Arias P.E. 1938, La stazione preistorica di Serraferlicchio, MAL XXXVI, coll. 694-838.
Bernabò Brea L. 1968 - 69, Considerazioni sull’eneolitico e sulla prima età del bronzo della Sicilia e della Magna Grecia, Kokalos XIV - XV, pp. 20-58.
Bernabò Brea L. 1988, L’età del rame nell’Italia peninsu-
lare: la Sicilia e le Isole Eolie, RassA, 7, pp. 469-506.Bernabò Brea L., Cavalier M. 1960, Meligunìs Lipàra I,
Palermo.Bernabò Brea L., Cavalier M. 1968, Meligunìs Lipàra
III, Palermo.Cazzella A., Maniscalco L. 2012, L’età del rame in Sici-
lia, AttiIIPP XLI, pp. 81-104.Bovio Marconi J. 1944, La cultura tipo Conca d’ Oro della
Sicilia Occidentale, MAL XL, coll. 1-170.Bovio Marconi J. 1979, La grotta del Vecchiuzzo, Sikelikà 1.Cafici I. 1899, Sepolcro neolitico scoperto a S. Cono presso
Licodia Eubea (Catania), BPI XXV, pp. 4-6, 53-66.Castellana G. 1995, La necropoli proto eneolitica di Pia-
no Vento nel territorio di Palma di Montechiaro, Agri-gento.
Castellana G. 1998, Il santuario castellucciano di Monte Grande e l’approvvigionamento dello zolfo nel Mediter-raneo nell’età del Bronzo, Palermo.
Catanzaro G., Maniscalco L., Pappalardo G., Russo P., Vinciguerra D. 1975 - 1976, La stazione preistorica di Poggio Monaco nel territorio di Paternò, CronA 14/15 1975 – 1976, pp. 9-49.
Cazzella A., Maniscalco L. 2012, L’età del rame in Sici-lia, AttiIIPP XLI, pp. 81-104.
Cavalier M. – Cultraro M. 2010, Insediamento eneolitico sul Poggio dell’Aquila (Adrano): risultati preliminari, in Lamagna G. (a cura di), Tra Etna e Simeto. La ricerca archeologica ad Adrano e nel suo territorio, Catania, pp. 49-64.
Cocchi Genick D. 2005, Considerazioni sull’uso del termi-ne “facies” e sulla definizione delle facies archeologi-che, RSP LV, pp. 5-28.
Cocchi Genick D. 2009, Correlazioni tra l’Eneolitico sici-liano e peninsulare, Origini, XXI, n. s. IV, pp. 129-154.
Crispino A. 2012, Il complesso eneolitico di S. Ippolito, Caltagirone. Scavi Orsi. Nota preliminare, AttiIIPP XLI, pp. 653-662.
Cultraro M. 1997, La civiltà di Castelluccio nella zona etnea, in Tusa S.(a cura di), Prima Sicilia. Alle origini della società siciliana, Palermo pp. 353-357.
Cultraro M. 2007, La regione etnea tra Neolitico ed an-tica età del Bronzo: dinamiche culturali e sviluppo cro-no- tipologico, in La Rosa V., Privitera F. (a cura di), In Ima Tartara. Preistoria e leggenda delle grotte etnee, Palermo pp. 57-79.
De Miro E. 1961, Ricerche preistoriche a Nord dell’abitato di Palma di Montechiaro, RSP XVI, pp. 15-56.
De Miro E. 1974, Preistoria nell’ agrigentino. Recenti ri-cerche ed acquisizioni, AttiIIPP XII - XII, pp. 117-127.
De Miro E. 1974, Montallegro (Prov. di Agrigento), RSP XXIV, pp. 260-261.
Fragnoli P., Manin A. L., Giannitrapani E., Iannì F., Levi S.T. 2012, Indagine archeometrica sulla tecnologia produttiva e la composizione della ceramica preistori-ca e protostorica di Tornambè (EN) in Vezzalini G., Zannini P. (a cura di), Atti VI Congresso Nazionale di Archeometria, Modena, pp. 1-10.
Giannitrapani E. 2009, Nuove considerazioni sulla pre-senza in Sicilia del Bicchiere Campaniforme, RSP LVIII, pp. 219-242.
Giannitrapani E. 2012, Dalla capanna alla casa. L’archi-tettura domestica nella preistoria della Sicilia centrale, in Bonanno C., Valbruzzi F. (a cura di), Mito e Ar-
149S. Ippolito, Caltagirone: nuovi dati sull’abitato dagli scavi Orsi
cheologia degli Erei. Museo Diffuso Ennese: Itinerari Archeologici, Enna, pp. 69-75.
Giannitrapani E. cds, Complessità sociale e l’archeologia delle households negli Erei tra III e II mill. cal. a.C., in Crispino A., Cultraro M., Prima di Thapsos. La Sicilia centro-orientale tra Eneolitico Finale e l’età del Bronzo antico, Giornata di Studio (Siracusa 14 dicembre 2011).
Giannitrapani E., Iannì F. 2011, La tarda età del rame nella Sicilia centrale, Atti IIPP XLIII, pp. 271-278.
Guilaine J., Tusa S.,Veneroso P. 2009, La Sicile et l’Eu-rope campaniforme. La collection Veneroso à Sciacca, Toulouse.
Gullì D. 2000, Nuove indagini e nuove scoperte nella me-dia e bassa valle del Platani, Quaderni di Archeologia dell’Università di Messina 1,1, pp. 139-168.
Gullì D., Terrasi F., Tusa S., Giannitrapani E., Marti-nelli M.C., Maniscalco L., 2014, Nuovi dati di crono-logia assoluta nell’età del Rame, in Cocchi Genick D., (a cura di), Cronologia assoluta e relativa dell’età del Rame in Italia, Atti dell’Incontro di Studi. Università di Verona, 25 Giugno 2013, QuiEdit, pp. 173–195.
Gusmano M., Martinelli M.C. 2012, Una cava di calcare e gesso della facies di Malpasso a Venetico (Messina), AttiIIPP XLIII, pp. 679-684.
Guzzone C. 2003, Testimonianze preistoriche a Caltanis-setta e nel suo territorio, in Panvini R. (a cura di), Cal-tanissetta. Il Museo Archeologico Catalogo, Palermo pp. 3-17.
ima tartara, La Rosa V., Privitera F. (a cura di), In Ima Tartara. Preistoria e leggenda delle grotte etnee, Paler-mo 2007.
Leighton R. 1999, Sicily before history, London.Maniscalco L. 1989, Ocher Containers and Trade in the
Central Mediterranean Copper Age, AJA, 93, pp. 537-541.
Maniscalco L. 1994, Le ceramiche dell’età del rame nel territorio di Milena, in Tusa S. (a cura di), La preistoria del Basso Belice e della Sicilia Meridionale nel quadro della preistoria siciliana e mediterranea, Palermo pp. 323-338.
Maniscalco L. 1995, The Castelluccian Ceramics, in Mc-Connell B. (ed), La Muculufa II. Excavations and Survey 1988-1991. The Castelluccian Village and Other Areas, Louvain - La-Neuve, pp. 37–66.
Maniscalco L. 2007, Considerazioni sull’età del Rame nel-la media valle del Platani (Sicilia), RSP LVII, pp. 167-184.
Maniscalco L. 2008, Le fasi di vita attestate nell’area da-vanti la grotta, in Maniscalco L. (a cura di), Il santua-rio dei Palici. Un centro di culto nella valle dei Margi, Palermo pp. 76-95.
Martinelli M.C., Procelli E. 2011, L’età del Rame in Si-cilia: dalla facies ceramica alla facies archeologica, una strada difficile, AttiIIPP XLIII, pp. 113-120.
McConnell B. 1999, Il Primo Eneolitico in Sicilia, in Coc-chi Genick D. (a cura di), Criteri di nomenclatura e di terminologia inerente alla definizione delle forme vasco-lari del Neolitico/Eneolitico e del Bronzo/Ferro, Atti del Congresso di Lido di Camaiore 26-29 Marzo 1989, vol. I, Firenze pp. 233-240.
McConnell B. 2003. Insediamenti dell’altopiano Ibleo e l’architettura dell’età del Rame in Sicilia, AttiIIPP XXXV, pp. 225-238.
Odetti G. 2012, Le grotte del Conzo (SR) e della Palombara (SR) nel quadro dell’età del rame della Sicilia Orientale, AttiIIPP XLI, pp. 593-600.
Orsi P. 1907a, La grotta di Calafarina presso Pachino, abi-tazione e sepolcro, BPI XXXIII, pp. 7-22.
Orsi P. 1907b, Necropoli e stazioni sicule di transizione, BPI, XXXIII, pp. 4-99.
Orsi P. 1908, Sepolcri protosiculi di Gela, BPI XXXIV, pp. 155-168.
Orsi P. 1910, Due villaggi del primo periodo siculo, BPI XXXVI, pp. 159-193.
Orsi P. 1928, Stazione e necropoli al Bersaglio di Caltagiro-ne, BPI XLVIII, pp. 82-98.
Privitera F. 1994, La stazione di Mezzebbi nel contesto del Bronzo Antico del territorio di Milena, in Tusa S. (a cura di), La preistoria del Basso Belice e della Sicilia Meri-dionale nel quadro della preistoria siciliana e Mediter-ranea, Palermo pp. 339-356.
Privitera F. 1997, La stazione di Mezzebbi nel contesto del Bronzo Antico del territorio di Milena, in La RosaV. (a cura di), Dalle capanne alle Robbe. La storia lunga di Milocca - Milena, Caltanissetta, pp. 85-92.
Privitera F., Turco M., Alberghina F. 2012, Recenti in-dagini nel versante sud-occidentale dell’Etna: Belpasso e Biancavilla, AttiIIPP XLI, pp. 709-717.
Procelli E. 1989, La grotta dei Monaci. Stazione dell’età del rame presso Castelmola (Taormina), SicA, 71, pp. 41-50.
Procelli E. 2001, Continuità e cesura tra Tardo Rame e Antico Bronzo in Sicilia: qualche riflessione, in Marti-nelli M. C. Spigo U. (a cura di), Studi di Preistoria e Protostoria in onore di Luigi Bernabò Brea, Palermo pp. 157-174.
Tinè S. 1960, Giacimenti dell’età del rame in Sicilia e la “Cultura tipo Conca d’ Oro”, BPI LXIX – LXX, pp. 113-151.
Tinè S. 1965, Gli scavi della Grotta della Chiusazza, BPI LXXIV, pp. 123-286.
Tusa S. 1997 (a cura di), Prima Sicilia. Alle origini della società siciliana, Palermo.
Tusa S., Pacci M. 1990, La collezione dei vasi preistorici di Partanna e Naro, Palermo.
Vacirca I. 2008, Lo scavo del Saggio FA VII, in Maniscal-co L. (a cura di), Il santuario dei Palici. Un centro di culto nella valle dei Margi, Palermo pp. 150-167.
Jean Vaquer, Les pratiques funéraires au Néolithique moyen dans le Midi de la France .........
Maria Maffi, Il Neolitico Recente Emiliano (NRE): proposta di definizione ..........................
Günther Kaufmann, L’ascia dell’Uomo venuto dal ghiaccio .................................................
Nuccia Negroni Catacchio, Elsa Pacciani, Erika Albertini, Matteo Aspesi, Jacopo Moggi-Cecchi, Nuovi dati su alcune necropoli rinaldoniane. Revisione di vecchi scavi, nuove datazioni e recenti analisi dei resti scheletrici ..............................................................................
Anita Crispino, S. Ippolito, Caltagirone: nuovi dati sull’abitato dagli scavi Orsi ....................
Maria Clara Martinelli, Francesca Cannizzaro, Milena Gusmano, Considerazioni sulla facies di Malpasso nella cuspide orientale della Sicilia e nelle isole Eolie .........................
Davide Tanasi, Rappresentazioni naturalistiche nella ceramica del Bronzo Antico Siciliano: il caso di Grotte di Marineo (Licodia Eubea, Catania) ...................................................................
Carlo Veca, Contenitori “per i vivi” e contenitori “per i morti” a Thapsos (Siracusa): un approccio tecnologico a un problema interpretativo ....................................................................
Biancamaria Aranguren, Maria Rosaria Cinquegrana, Alberto De Bonis, Vincenza Guarino, Vincenzo Morra, Marco Pacciarelli, Le strutture e lo scarico di olle del Puntone Nuovo di Scarlino (GR) e i siti costieri specializzati della protostoria mediotirrenica ........................
Gianni Santuari, Umberto Tecchiati, Due ganci di cintura in bronzo di cui uno traforato tipo Castaneda (età antico La Tène) da Collalbo-Bolzano
ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA. Attività degli anni 2013 e 2014
NORME PER GLI AUTORI .......................................................................................................
RIVISTA DI SCIENZE PREISTORICHEVol. LXIV - 2014
INDICE
5
25
57
83
115
151
193
203
227
259
281
297