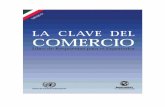Il comercio atlantico di schiavi
Transcript of Il comercio atlantico di schiavi
Le ci/re dell' esodo
II commercio atlantico di schiavi di Herbert S. Klein~'
Il commercio atlantico di schiavi rappresente il piu vasto flusso migratorio transoceanico della storia fino al XIX secolo, quando prese avvio dall'Europa l' emigrazione di massa della popolazione di razza bianca. Dopo le approfondite ricerche dell'ultimo quarto di secolo, condotte negli archivi africani, americani ed europei, lo schema essenziale e ormai noto. Si calcola che trail 1444 e il 1860 circa 11,7 milioni di Africani furono trasportati per mare, dalla costa dell' Africa, contro la loro volonta e in schiavitu; in America arrive un J::\Umero variabile stimato tra i 9,6 e i 10,8 milioni, cifra questa che dipende dalle stime sul-· la mortalita. Rifacendosi a una stima prudente, si assume che, fino al 1600, 239.000 Africani giunsero in America, 1,5 milioni nel XVII secolo, 5 ,2 milioni nel XVIII secolo - collocandosi la pun ta· massima del commercio nella seconda meta di questo secolo - e circa 2,8 milioni tra il 1811eil1860. Di questi schiavi africani che, stimati in numero di 9,8 milioni, arrivarono in America, il contingente piu ampio ande in Brasile (3,9 milioni); altri 3,8 milioni furono destinati alle Indie occidentali non ispaniche; 1,6 milioni approdarono sulle isole e sul continente ispano-~mericani; e meno di mezzo milione giunse negli Stati Uniti.
E ovvio che questo movimento di genti non continue ininterrottamente nel corso del tempo, dirigendosi verso tutte le regioni, ma varie considerevolmente in funzione dell' evoluzione economica di ciascuna delle aree di accoglienza. Fino ai primi decenni del XVII secolo, le principali regioni importatrici furono le colonie continentali ispano-americane e il Brasile. Questo accadeva perche esse disponevano di enormi
'' quantitativi di argento che serviva da mezzo di pagamento nella tratta degli schiavi africani e consentiva agli Spagnoli di utilizzarli come for-
* Traduzione di Benedetta Borello.
428 Stort'a dell' economz'a mondzale. 2. Daile scoperte geogra/iche alla crescita degli scambi
za-lavoro nella maggior parte delle citta coloniali. In tutte le regioni -specialmente in quelle costiere del Messico e del Peru - in cui la presenza degli Indios fu drasticamente ridotta dalle rnalattie epidemiche, questi furono spesso rimpiazzati dalla manodopera composta da schiavi africani, anche se i contadini Indios rimasero il principale elemento della forza-lavoro agricola.
Nel caso del Brasile dei primi due secoli, la mancanza di un consistente numero di agricoltori stanziali in villaggi contadini e la penuria di ogni tipo di metallo prezioso costrinsero la coro.na a fare affidamento sul lavoro schiavistico al fine di colonizzare e creare insediamenti su questa terra, considerata vitale da un punto di vista strategico. Incalzati dalle ricorrenti incursioni francesi e olandesi, i Portoghesi dedsero di dar vita, all'interno del Brasile, al sistema della piantagione di zucchero che si fondava tanto sul lavoro schiavile degli Indios, quanta su quello degli africani. Fu quindi il Brasile che creo il modello peril futuro utilizzo della manodopera schiavistica nelle piantagioni del continente americano. Anche se, sin dall'inizio, schiavi africani erano stati importati proprio dai mercanti portoghesi, nei primi anni del XVII secolo era la comunita costiera del ceppo linguistico Tupi-Guarani a costituire l' elem en to piu importante della forza-lavoro nella piantagione schiavistica. A lungo andare, pero, le malattie ne ridimensionarono l'importanza e sin dai primi anni del XVII secolo gli africani, insediatisi nelle regioni di Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, diyennero una presenza dominante nelle piantagioni di zucchero.
Dal 1630-1654, l'incursione nel Pernambuco degli Olandesi, colonizzatori e conquistatori, preparo la scena alla futura espansione dei mercati di schiavi in America; la caduta di Recife favorl, in quell' epoca, il trasferimento nelle Indie occidentali delle conoscenze tecniche del Portogallo e dei Paesi Bassi nonche dei capitali olandesi. Le Piccole Antille, abbandonate dagli Spagnoli, sopravvissero a stento, fino a quando nella seconda meta del XVII secolo lo zucchero ne divenne la produzione primaria. Dapprima introdotte su larga scala nelle Barbados e in Martinica con l'impiego di manodopera schiavistica, le piantagioni di zucchero vennero rapidamente assorbendo un consistente numero di schiavi africani e continueranno a farlo fino al XIX secolo. Nel periodo che abbraccia la fine del XVII e tutto il XVIII secolo, le isole francesi e britanniche divennero, insieme al Brasile, le principali importatrici di schiavi.
Nei primi decenni del XVIII secolo la Giamaica e Santo Domingo presero il posto di queste isole, fino ad assumere un ruolo guida; prima della fine degli anni ottanta, Santo Domingo importava il 39% degli 814.000 schiavi trasportati nel continente americano in quel decennio. Insieme alla Martinica e alla Guadalupa, le isole francesi assorbivano il
H.S. Klein I! commercio atlantico di schiavi 429
44 % del totale degli africani condotti nelle Americhe in questo periodo, il Brasile il 22 % e le In die ocddentali inglesi solo il 12 % .
La rivoluzione haitiana del 1791 distrusse il sistema della piantagione su base schiavistica di Santo Domingo, il piu efficiente nel suo genere in America, e coinvolse in esso terre in precedenza marginali. Cio a sua volta creo nuovi mercati di schiavi africani o dette impulso ai vecchi. Nei primi died anni del XIX secolo, il Brasile riceveva il 40% dei 609 .000 schiavi importati in quel periodo; gli Stati Uniti, negli ultimi anni in cui partedparono a questo tipo di commerdo, ne acquistarono un altro 26% e le isole-inglesi il 17%. Le piantagioni dell'isola di Cuba, da poco apparse sulla scena caraibica, dove avevano preso il posto di Santo Domingo come produttrici di spicco di zucchero e caffe, assorbivano ora il 12 % di tutti gli africani importati in America.
Nel 1808 la chiusura degli Stati Uniti all'importazione di schiavi africani e l''abolizione, un anno prima, della tratta atlantica degli schiavi da parte della Gran Bretagna, nonche i progressivi sforzi sostenuti da quest'ultima al fine di porre termine al commercio di tutte le altre nazioni, ebbero un importante impatto sul prezzo degli schiavi africani nel Nuovo Mondo e ne ridussero la domanda in molte regioni delle Americhe, ove la schiavitu era stata o continuava a essere importante. Nel 1834, l' abolizione della schiavitu nei domini britannid e nel 1848 nelle colonie francesi segno inoltre la fine di questo sistema di sfruttamento del lavoro in regioni che un tempo erano state importatrid di spicco. Il rifiuto britannico di accettare un commerdo intercoloniale di schiavi interruppe del resto lo sviluppo del sistema schiavisdco in queste colonie ben prima che la schiavitu fosse formalmente abolita.
Negli anni quaranta dell'Ottocento, questa chiusura della tratta degli schiavi nei domini francesi, olandesi, danesi e inglesi, rese il Brasile e Cuba i prindpali importatori, finche, negli anni dnquanta in Brasile e nei primi anni sessanta a Cuba, il commerdo fu abolito. Non solo cambio la direzione dei traffici, ma ne venne ridotto il volume. Malgrado il costante incremento del prezzo degli schiavi nelle principali economie schiavistiche di Stati Uniti, Cuba-Puerto Rico e Brasile, anche dopo la fine del commerdo transatlantico da parte di ciascuno di questi paesi, le pressioni inglesi mantennero ridotto il volume delle migrazioni forzate. Da una cifra che si aggirava sugli 800.000 arrivi negli anni cmanta e novanta del XVIII secolo, nel periodo compreso trail 1801 e il 1810, il flusso si ridusse a 609.000 africani ea solo 534.000 nei died anni successivi. La minacda di una definitiva abolizione del commercio a Cuba e in Brasile produsse, negli anni trenta dell'Ottocento, un temporaneo incremento delle importazioni, ma la dfra di 595.000 schiavi importati, esito di quella situazione, fu inferiore di un quarto al numero di quelli trasportati nel periodo di punta degli anni ottanta del Settecento. Da al-
430 Storz'a dell'economia mondzale. 2. Daile scoperte geogra/iche alla crescita degli scambi
lora in poi il commercio diminul rapidamente raggiungendo il livello di 433.000 schiavi negli anni quaranta e di 141.000 soltanto negli anni cinquanta del XIX secolo. Fu unicamente negli anni quaranta, pero, che l'immigrazione netta di liberi lavoratori provenienti dall'Europa risulto finalmente maggiore del flusso migratorio forzato di schiavi attraverso l' Atlantico.
Della maggior parte di questi schiavi e possibile determinare con certezza l' origine africana. I tre quarti provengono senza alcun dubbio dalla costa occidentale dell' Africa e solo un quarto dall'area sud-orientale del continente, poiche il Mozambico comincio a imbarcare schiavi soltanto negli ultimissimi anni del Settecento. Al culmine della tratta degli africani, negli anni compresi tra il 1700 e il 1807, quando i soli Inglesi caricavano circa 2,9 milioni di schiavi dalle sponde dell' Africa occidentale (cifra che ammontava al 42% della totalita degli schiavi trasportati dall' Africa in tale periodo), essi acquistavano 194. 000 schiavi dalla Senegambia, 484.000 dalla Sierra Leone, 408.000 dalla Costa d'Oro, 233.000 dalla Baia del Benin e 1.200.000 dalla Baia del Biafra; quest'ultima era la regione africana del periodo a vantare il maggior volume di traffici di schiavi. II Congo e l' Angola, conosciuta come Africa centrooccidentale, procuravano in questa fase 640.000 schiavi per i mercanti inglesi.
In questi stessi anni, gli Inglesi, che acquistarono 3, 1 milioni di schiavi, erano i principali trafficanti, seguiti dai Portoghesi che esportarono 1,9 di africani e dai Francesi che ne presero un milione. In questo secolo tra i commercianti di minore importanza c' erano gli Olandesi, che trasportarono in America 325.000 schiavi, i mercanii inglesi dell' America del Nord che ne procurarono 208.000 e i Danesi, che offrirono sul mercato 51.000 dei 6,7 milioni di africani importati in quel periodo. Per molti secoli, i traffici seguirono proprio questo modello, che consacrava quali nazioni leader l'Inghilterra e il Portogallo, le prime a praticare questo tipo di commercio, seguite dalla Francia e dai Paesi Bassi. Ma questi non furono gli unici paesi trafficanti di schiavi, poiche anche i mercanti che percorrevano la rotta che dalla lega anseatica e dalla Scandinavia giungeva fino a New Port nel Rhode Island e a Rio de Janeiro fornivano navi per questo ti po di commercio. Non c' era nazione o gruppo religioso che, attivo nel commercio atlantico, mancasse di prendere parte alla tratta degli schiavi.
Gli aspetti economici
Stabilire il volume, la direzione e la presenza dei vari gruppi nel commercio e, pero, solo l'inizio dell' analisi di questo assai complesso fe-
H.S. Klein Il commercio atlantico di schiavi 4.31
nomeno che e insieme forzata migrazione umana e commercio internazionale, e che fu all' origine di cosi vivaci dibattiti nel corso del XX secolo. Considerato come uno dei grandi crimini commessi dall'Europa occidentale nel corso della sua espansione nel resto del mondo, il commercio atlantico degli schiavi ha prodotto tan to un' ampia e acritica letteratura, quanta una moderna e sofisticata storiografia, la quale ha delineato i fondamentali aspetti economici demografici e persino culturali di questa migrazione umana di massa.
La letteratura non scientifica ha creato una «leggenda» che la storiografia attuale ha ricusato specialmente per quel che riguarda i costi del commercio, le modalita del trasporto attraverso l' Atlantico degli schiavi, i livelli di mortalita da loro patiti e i guadagni e i benefici che venivano agli europei dall' organizzazione di questi traffici. «Imballaggio ermetico», mortalita «astronomica», «schiavi a buon mercato», comprati in cambio di collanine senza valore e rum di poco prezzo, e il cosiddetto «commercio triangolare» si trasformarono in altrettanti «miti» accettati da tutti, dominando fino a tempi recenti la storiografia su questo fenomeno.
La realta fu molto piu complessa e piuttosto diversa da questo quadro stereotipato. Le questioni paste dalla recente storiografia possono essere raggruppate attorno a una serie di argomenti tra loro correlati, Questi interrogativi concernono i fondamenti economici del commercio, il suo impatto demografico e, in ultimo, le cause e le conseguenze della sua abolizione.
II primo problema da risolvere e quello di chi beneficio della tratta degli schiavi. In un primo tempo si e ritenuto che questo commercio costituisse un monopolio europeo dal quale gli africani ricavavano ben miseri compensi. I profitti erano astronomici- proseguiva il ragionamento - poiche gli schiavi potevano essere comprati in cambio di prodotti di scarto, di seconda mano o di cattiva qualita, provenienti dall'Europa, spesso per una frazione del loro reale valore. Tutti i dettagliati studi condotti sui beni impiegati dagli europei per I' acquisto degli schiavi africani, mostrano, tuttavia, che questi manufatti erano di buona qualita e molto spesso importati da paesi e continenti lontani. Questi prodotti erano la voce piu costosa nell'inventario di bordo, avendo un valore superiore alla somma del costo della nave, dei salari dell' equipaggio e delle forniture di cibo. Nel XVIII secolo, per esempio, i due terzi dei costi di equipaggiamento dei mercanti di schiavi francesi erano costituiti da beni utilizzati per l' acquisto della loro merce.
1 Quella dei consumatori africani era, d'altronde, un mercato raffinato. Era la loro domanda che determinava i beni esportati dagli europei nella regione sub-sahariana, e in cima a questa lista di prodotti si trovavano i filati di buona fattura tessuti nelle Indie orientali. II ruolo assun-
1, !
432 Storia dell'economia mondiale. 2. Dalle scoperte geogra/iche alla crescita degli scambi
to in questi traffici dai tessuti provenienti dall'Asia era tanto importante e costoso che gli europei, e in particolare gli Inglesi, tentarono disperatamente di sostituirli con imitazioni europee di minor valore; tutto questo con scarsi risultati, almeno prima del XIX secolo. Fu proprio la parte da loro avuta nel commercio con l' Asia che spiega perche, nel XVIII secolo, Liverpool e Nantes divennero i maggiori porti della tratta degli schiavi rispettivamente in Inghilterra e in Francia.
I tessuti, al primo posto per importanza economica, erano seguiti dalle barre di ferro di fabbricazione svedese, dagli attrezzi agricoli, dagli utensili domestici, dalle armi e dalla polvere da sparo, prodotti in Inghilterra e in altri paesi del continente europeo; c'erano poi il rum, confezionato nell'America settentrionale e meridionale, il brandy e altri liquori di provenienza europea, il tabacco lavorato brasiliano di Bahia, le conchiglie elicoidali dell'Oceano Indiana e una schiera di altri prodotti, relativamente costosi. Anche quando, per comprare schiavi, gli europei ricorrevano a prodotti africani, questi erano stati a loro volta acquistati in cambio di manufatti europei o asiatici. Tutti questi beni erano stati pagati dai mercanti con valuta pregiata. Inoltre, a differenza della maggior parte dei traffici europei con le colonie, il commercio africano richiedeva l' acquisto di una grande quantita di prodotti non nazionali, una vasta gamma che andava dal tabacco brasiliano, ai drappi delle Indie orientali al mobilio di fattura olandese. Sulla base di accurate statistiche commerciali si e dedotto che, nel corso del XVIII secolo e fino all'inizio del XIX le ragioni di scambio tra Africa ed Europa divennero favorevoli agli africani.
Insieme alle leggende sull'esiguo costo degli schiavi e sull'ignoranza dei consumatori africani, la letteratura tradizionale ha insistito sulla posizione subalterna mantenuta dai commercianti africani. Si e ritenuto che i prezzi degli schiavi fossero bassi e restassero invariati, mentre tutte le correnti di traffico dominate dagli europei rendevano gli africani inermi osservatori dell'intero processo. Tutti gli studi dimostrano, al contrario, che la combinazione dei beni che, in ciascuna regione, contribuivano a formare il prezzo, tendeva a cambiare nel corso del tempo, adattandosi alle variazioni della domanda e all' offerta. In questo modo i mercanti africani adeguavano la loro domanda di beni alle condizioni del mercato.
Gli africani dimostravano poi astuzia e ostinazione quando ostacolavano gli europei nei loro tentativi di creare condizioni di monopolio. Le piazzeforti europee in Africa occidentale e persino le citta portoghesi, sia quelle sulle coste, sia quelle all'interno dell' Africa del Sudovest, non furono in grado di impedire ai compratori concorrenti l'ingresso ai mercati locali. Le piazzeforti controllavano solo poche miglia di territorio nell' entroterra ed erano state concepite piu come mezzo
H.S. Klein Il commercio atlantico di schiavi 433
per tenere lontani i rivali che come arma per spaventare i fornitori. Per quel che riguarda i soli insediamenti portoghesi, essi non furono in grado di evitare che i F rancesi e gli Inglesi acquistassero un gran numero di schiavi in Congo e in Angola. Eppure si e ritenuto che questi ultimi fossero stati completamente monopolizzati dai Portoghesi.
Si deve sottolineare la complessita di questi traffici, che coinvolgevano ogni cosa dalle piazzeforti costiere permanenti, agli insediamenti portuali, fino ai battelli scoperti che solcavano i fiumi e gli specchi d' acqua della costa. Anche i commercianti africani lungo la costa presentavano una gran varieta; si andava dagli intermediari mulatti, ai monopoli commerciali di Stato; dai trafficanti privilegiati nobili fino a quelli regi. Alcuni Stati erano abbastanza forti da tassare pesantemente i commerci, mentre in altre zone vigeva il libero mercato. Erano ovunque gli africani, pero, che controllavano il volume degli schiavi e ne stabilivano il tipo da mettere in vendita. Ed erano sempre gli africani che decidevano i prezzi e i beni da utilizzare nella compravendita di questi schiavi.
I costi sociali della tratta
Se i commerci risultavano redditizi per gli individui, i gruppi, o le classi che li praticavano, rimane il problema dei costi sociali della tratta. Le incursioni operate dai mercanti di schiavi a danno degli agricoltori, il conseguente abbandono di terre con fiorenti colture, lo sforzo sostenuto in attivita di difesa o belliche, nonche il drenaggio di giovani adulti dalla forza-lavoro: tutto questo, nel lungo periodo, ebbe i suoi costi economici. Per coloro che erano coinvolti nei traffici e per la maggioranza degli africani, consumatori di beni asiatici ed europei d' importazione, tuttavia, il commercio era un'attivita redditizia, a prescindere dai suoi effetti di lungo periodo sullo sviluppo economico.
La letteratura tradizionale ha sostenuto che l' esiguo costo degli schiavi rendeva vantaggioso stiparne quanti piu la nave poteva contenerne senza affondare; il prezzo vantaggioso della merce rendeva di conseguenza accettabili alti livelli di mortalita, durante la traversata atlantica. Se ogni schiavo consegnato vivo rappresentava un puro guadagno, la morte anche di diverse centinaia aveva economicamente un senso. Ma se gli schiavi non erano un articolo conveniente che poteva essere comprato per pochi soldi, allora il relative argomento circa l' «imballaggio ermetico» non ha alcun senso. Un'elevata mortalita degli schiavi, durante la traversata, implicava infatti una perdita finanziaria per l'impresa.
Ancor piu convincente di questi argomenti teorici addotti contro la sconsiderata distruzione della vita umana e il fatto che nessuno studio
434 Storia dell' economia mondiale. 2. Daile scoperte geografiche alla crescita degli scambi
scientifico ha fino ad oggi dimostrato una sistematica e significativa correlazione tra il numero di schiavi trasportati e il livello di mortalita sperimentato in mare. Sono state recentemente analizzate migliaia di traversate sull' Atlantico e nessuna di esse ha evidenziato una significativa correlazione tra la stazza o lo spazio disponibile sulla nave e la mortalita.
Questa non significa che gli schiavi viaggiassero nel lusso. In effetti, avevano meno spazio a disposizione di quello destinato, a quel tempo, alle truppe o ai forzati trasportati per mare; do che si vuole dire e che dopo molta esperienza e dopo aver compreso le esigenze del commercio, i trafficanti di schiavi presero a caricare a bordo soltanto la merce che ritenevano di poter portare sana e salva oltre l' Altlantico. Da sporadiche allusioni alla questione sembra che nel periodo precedente al 1700 tanto gli approvvigionamenti di cibo, quanta l' organizzazione del trasporto fossero all'inizio insufficienti. Tutti gli studi sul commercio, relativi al periodo posteriore al 1700, dimostrano invece che i mercanti di schiavi caricavano il doppio di acqua e di viveri rispetto ai tempi richiesti dalla traversata; nella maggior parte dei tragitti, poi, trasportavano una quantita di schiavi leggermente inferiore a quella prevista dalla legge.
Questa crescente cura usata nel trasporto degli schiavi si rifletteva nei minori livelli di mortalita. Prima del 1700 il livello medio di mortalita della tratta, calcolato su numerose traversate, tendeva ad assestarsi attorno al 20%. Questa media, a sua volta, era il riflesso di variazioni piuttosto ampie; numerosi vascelli potevano vantare percentuali di mortalita molto basse, mentre molti altri sperimentavano livelli quasi doppi rispetto al valore medio della mortalita. Dopo l'inizio del Settecento, la percentuale media si ridusse drasticamente e le variazioni attorno a questa media diminuirono. Nella seconda meta del XVIII secolo, ii livello media di mortalita si era attestato al 12 % e, nei primi venticinque anni del XIX secolo tutte le correnti di commercio computate globalmente sperimentarono un livello media del 9% o persino inferiore. La dispersione intorno a questa media si ridusse e i due terzi dei vascelli ebbero una percentuale di mortalita molto vicina a quella media. Mentre nei primi due secoli della tratta degli schiavi il 33 % dei tragitti raggiunse una percentuale di mortalita pari al 20% o superiore, quest'ultima si abbasso fino al 10% nelle traversate degli anni 1800-1820.
Questa calo della mortalita era dovuto alla crescente standardizzazione dei commerci. Si costruirono imbarcazioni specifiche per la tratta degli schiavi, destinate a tutte le nazioni. A partire dalla seconda meta del XVIII secolo, i vascelli degli schiavi di tutti i mercanti europei avevano in media una stazza di 200 tonnellate. Quest'ultimo sembrava essere il tonnellaggio piu idoneo per un buon potenziale di carico nei traf-
H.S. Klein I! commercio atlantico di schiavi 435
fici. I mercanti di schiavifurono anche i primi a utilizzare nelle loro navi rivestimenti di rame, un nuovo e costoso metodo che assicurava ai loro vascelli vita piu lunga e maggiore velocita. Non va dimenticato che questi vascelli utilizzati per la tratta degli schiavi, erano molto piu piccoli rispetto alle imbarcazioni che gli europei impiegavano nei commerci con le Indie occidentali e orientali. Tutto questo a sua volta contribuisce in larga misura a spiegare perche il celebre schema del commercio triangolare (prodotti europei in Africa; schiavi per le Americhe; zucchero in Europa: tutto nel corso dello stesso viaggio) e ampiamente inventato. Gran parte dei raccolti americani raggiungeva i mercati europei a bordo di vascelli delle Indie occidentali, molto piu ampi e costruiti appositamente; queste imbarcazioni erano principalmente concepite per questo commercio di spola; la maggior parte dei mercanti di schiavi faceva ritorno con piccoli carichi o addirittura con niente. Persino nel piu cospicuo traffico di schiavi, quello brasiliano, nessun mercante di schiavi parti o arrivo mai in Europa.
I mercanti caricavano, in media, uno schiavo e mezzo per tonnellata e, anche se la dimensione e la percentuale dell' equipaggio erano soggette a variazioni, nelle navi per gli schiavi c' era normalmente il doppio dei marinai necessari a governare bastimenti di quella stazza. Questa elevatissima percentuale di personale veniva utilizzata per scopi di sicurezza connessi al controllo degli schiavi. Tutti i trafficanti europei utilizzavano lo stesso tipo di approvvigionamento, le stesse tecniche per il trasporto e adottavano anche i medesimi accorgimenti sanitari; costruivano delle tolde provvisorie per l' alloggio degli schiavi e li dividevano per sesso ed eta. Circa nello stesso periodo quasi tutti gli europei usarono il vaccino contra il vaiolo; tutti imbarcarono enormi provviste di cibo africano per il nutrimento degli schiavi e tutti adottarono gli stessi metodi per l'igiene quotidiana, l'esercizio fisico e la cura delle malattie. Questa uniformazione dei comportamenti spiega il generale calo del livello di mortalita sperimentato e contribuisce a respingere le tesi dei contemporanei secondo le quali un certo trafficante di schiavi era «migliore» o pill efficiente di tutti gli altri.
Le cause della mortalita
Se queste fondate statistiche sulla mortalita mettono sicuramente in crisi molte antiche teorie sulla mortalita «astronomica» e sull' «imballaggio ermetico», rimane da risolvere la questione del livello di mortalita; una percentuale del 9% in una popolazione di giovani adulti sani, nel corso di traversate che duravano dai 15 ai 3 0 giorni e da ritenersi alta o bassa? Se nel XVIII o all'inizio del XIX secolo si fosse verificato un
436 Storz'a dell' economia mondiale. 2. Dalle scoperte geografiche alla crescita degli scambi
simile livello di mortalita presso agricoltori francesi della stessa eta, sarebbe stato ritenuto una percentuale da epidemia. Ecco perche, anche se gli europei furono in grado di ridurre il livello a percentuali apparentemente basse, esse rappresentavano ancora un livello di mortalita straordinariamente alto in una popolazione di giovani adulti cosl selezionata. Allo stesso modo, mentre nel XVIII secolo le percentuali di mortalita delle truppe, degli immigrati e dei forzati si avvicinavano a quelle degli schiavi, nel XIX esse diminuirono a meno dell'l %, per le traversate atlantiche. Nel caso degli schiavi questa percentuale non scese mai al di sotto del 5 % , cifra questa comune a tutti i ti pi di bastimenti presi in esame. Sembra quindi che vi fosse una percentuale minima di mortalita che gli europei non furono mai capaci di abbattere; essa era legata alle particolari condizioni del trasporto degli schiavi e dipendeva dal numero degli schiavi imbarcati in rapporto al tonnellaggio e allo spazio disponibile.
La mortalita durante la traversata era dovuta a diverse cause. Le maggiori responsabili erano le gastroenteriti, spesso provocate dalla qualita del cibo e dell' acqua messi a disposizione degli schiavi nel corso del viaggio, nonche le febbri. Frequenti erano poi gli attacchi di dissenteria e la cosiddetta bloody flux, una forma particolarmente grave di enterite emorragica che poteva esplodere in prciporzioni epidemiche. Il fatto che gli schiavi fossero esposti alla dissenteria aumentava i rischi di contaminazione dei viveri e l'incidenza della mortalita. Era dunque la dissenteria la maggior causa di morte e la malattia piu frequentemente contratta durante le traversate. I livelli astronomici di mortalita, raggiunti in alcuni viaggi, erano dovuti a epidemie di vaiolo, di morbillo o di altre malattie molto contagiose, non direttamente connesse alle condizioni delle provviste di acqua o viveri o alle condizioni igieniche. Era questa imprevedibilita delle epidemie che impediva persino ai capitani piu esperti ed efficienti di eliminare i livelli molto elevati di mortalita che si potevano sfiorare in un dato viaggio.
Anche se, normalmente, il tempo della traversata non era da porsi in relazione con il tasso di mortalita, c' erano alcune rotte nelle quali il tempo costituiva una componente rilevante. Per il solo fatto che tali rotte erano di un terzo pill lunghe di tutte le altre, la tratta degli schiavi dell' Africa orientale sviluppatasi tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo si distinse per un livello complessivo di mortalita piu elevate di quello sperimentato nelle rotte dell' Africa occidentale, sebbene il livello registrato quotidianamente nel corso del viaggio per mare fosse lo stesso 0 perfino inferiore a quello di altre rotte piu brevi. n solo trasporto collettivo di schiavi, provenienti da tutte le varie zone epidemiologiche africane, assicurava inoltre la trasmissione di un consistente numero di malattie endemiche locali a tutti quelli che si trovavano a
H.S. Klein Il commercio atlantico di schiavi 4.37
bordo. Tutto questo a sua volta garantiva la diffusione nel continente americano delle piu gravi malattie africane. ,
Lo squilibrio fra i sess~ l' eta e la nazionalita
Gli studi condotti su tutti i commerci hanno evidenziato nel numero degli schiavi trasportati una ricorrente distorsione circa le donne e i bambini. Le donne rappresentavano, in media, un terzo o un quarto degli africani costretti a emigrare; i bambini ne costituivano mediamente il 10%. Sebbene si verificassero oscillazioni nel tempo e nello spazio, in generale, sembra risultare che queste cifre sono sorprendentemente incoerenti. Tanto gli scrittori contemporanei quanto gli studiosi posteriori ritennero che le distorsioni relative all' eta e al sesso fossero legate alle caratteristiche precipue della domanda delle Americhe. Negli scritti del XVIII e del XIX secolo in effetti si trova traccia di una questione piuttosto vasta al centro delle discussioni di quegli anni: essa riguardava la bonta o meno dei diversi gruppi etnici africani in termini di abitudini lavorative. Ma proprio come e stata respinta l'idea di una supremazia europea nella compravendita e nella determinazione del prezzo degli schiavi, cos! gli studi recenti hanno messo in dubbio il fatto che le caratteristiche della domanda americana avessero un'influenza determiqante nella selezione del tipo di schiavo da importare.
E chiaro che la scelta del momento stabilito per la migrazione di questi africani e dei luoghi verso i quali essi erano diretti era largamente condizionata dagli americani. Una regione americana, anche usufruendo del credito generalmente offerto dai mercanti di schiavi, non poteva essere inserita nelle correnti di traffico a meno che non producesse un raccolto commerciabile in Europa. Parallelamente, l'effettivo movimento di schiavi attraverso l'Atlantico era per sua natura stagionale; esso doveva infatti sfruttare i venti e le correnti, che avevano un gran peso sulla traversata, e utilizzare a proprio beneficio ladomanda americana, soggetta ad alternanze stagionali. Mentre la navigazione dall' Africa orientale, che passava peril Capo di Buona Speranza, era pill legata alle condizioni climatiche locali, le rotte dell' Africa occidentale sembravano rispondere alle esigenze di raccolto dei piantatori americani.
Se la stagionalita del trasporto degli schiavi era influenzata da fattori connessi alla domanda americana, la nazionalita, ii sesso e l' eta degli schiavi coinvolti nella tratta transatlantica erano determinati principalmente da condizioni imposte dall'Africa. Tutti gli studi dimostrano che, a eccezione dei Portoghesi in Angola e in Mozambico, gli europei non sapevano nulla delle societa con cui entravano in contatto. Nella maggior parte dei casi, gli africani venivano individuati con il nome del por-
438 Storia dell' economia mondiale. 2. Daile scoperte geografiche alla crescita degli scambi
to in cui erano stati imbarcati, e non in .base a un qualsiasi generico gruppo linguistico o rifacendosi a identita nazionali. Moltissimi commercianti non immaginavano che cosa succedesse poche miglia all'interno della costa; non ne erano a conoscenza neanche quegli europei che, dopo aver costruito fortificazioni einsediamenti stabili, intrecciavano relazioni con i governi locali. Anche se in Africa gli europei combatterono tra loro per preservare una particolare area della costa occidentale, i contrabbandieri appartenenti ad altri gruppi europei o africani si dettero da fare per ostacolare la nascita di qualunque tipo di monopolio. La monopolizzazione di traffici locali tentata da gruppi africani comportava spesso l' apertura di nuove rotte commerciali da parte dei loro concorrenti. Alcuni piantatori americani possono aver pensato che i «Congolesi» lavorassero sodo, mentre altri Ii ritenevano degli scansafatiche, in ogni caso quello che i piantatori desideravano aveva poca importanza. Essi accettavano qualsiasi gruppo etnico africano fosse stato loro venduto. Pochi erano i porti americani che, per lungo tempo, ebbero stretti contatti con una data regione africana; il caso piu celebre e quello di Salvador de Bahia, legato commercialmente alla Baia del Benin. Raramente, come nel caso della dissoluzione di un' estesa compagine statale o dopo una importante sconfitta militare, intere nazionalita, con gruppi etnici ben definiti e chiaramente individuabili, facevano ingresso nel mercato degli schiavi; solo in queste circostanze essi venivano conosciuti in America con i propri nomi. Questi casi costituivano, pero, piu l' eccezione che la regola.
Anche lo squilibrio tra i due sessi nel numero degli africani in partenza trovava la sua ragione piu nelle caratteristiche dell' off erta africana che in quelle della domanda americana. Sebbene in America vi fosse una differenza di prezzo tra uomini e donne, essa non bastava a fornire una spiegazione della bassa percentuale di donne coinvolte nella tratta degli schiavi. Nelle piantagioni americane le donne eseguivano quasi tutte le attivira manuali degli uomini e rappresentavano la maggioranza delle squadre di braccianti che coltivavano zucchero, caffe e cotone. Ne durante la traversata atlantica, esse erano soggette a livelli di mortalita piu elevati di quelli degli uomini, e dunque non fornivano alcun valido pretesto per non importarle dall' Africa. La risposta sembra essere semplicemente questa: gli africani offrivano sui mercati di schiavi della costa un numero di donne molto inferiore a quello degli uomini.
Le donne africane, libere o schiave che fossero, erano molto richieste in loco; e questa domanda locale spiega perche poche donne facessero ingresso nel commercio atlantico degli schiavi. In alcune societa africane le donne godevano di un' alta considerazione poiche costituivano il mezzo per acquisire uno status sociale, per ottenere una parentela e una famiglia. Uno dei tratti caratteristici delle societa dell' Africa
H.S. Klein I! commercio atlantico di schiavi 439
occidentale era l'enfasi da esse posta sui sistemi di parentela matrilineare e matrilocale. Dal momenta che le schiave potevano costituire importanti legami nelle relazioni di parentela, la loro importanza nel sistema sociale veniva aumentata. Le schiave, inoltre, erano vendute pill a buon mercato delle donne libere del luogo; ma, in una societa poligamica, il loro prezzo era naturalmente elevato. Persino piu importante era la prassi, largamente in uso in Africa occidentale, di utilizzare le donne come componente di rilievo della forza-lavoro agricola. Per tutte queste ragioni, nei mercati interni del continente africano le donne avevano un prezzo maggiore rispetto agli uomini.
Oltre all' alta incidenza di schiavi maschi, il commercio rivelava una presenza molto scarsa di bambini. Anche se essi, durante la traversata, non pativano livelli di mortalita piu elevati rispetto a quelli sperimentati da qualunque altro gruppo di schiavi, il prezzo di vendita, piu basso rispetto a quello degli adulti e il costo del trasporto, identico a quello di questi ultimi, non rendevano allettante, ai mercanti di schiavi, il loro acquisto. Sembra anche che, nei mercati interni, si pagasse per i bambini un prezzo piu elevato che per i maschi adulti, e percio potrebbero non essere comparsi in gran numero nei mercati costieri per considerazioni legate all' offerta locale.
La demografia degli schiavi africani
Tutti questi squilibri circa l'eta e il sesso degli africani chelasciavano il loro continente avevano un impatto diretto sulla crescita e sul declino della popolazione degli schiavi americani. La bassa percentuale di donne sulle navi in arrivo, il fatto che la maggior parte di queste schiave, trascorsi diversi anni della loro eta feconda in Africa, arrivassero gia in eta adulta, nonche l'esigua presenza di bambini tra gli schiavi condotti in America ebbero un'importanza fondamentale nella successiva storia della crescita della popolazione. Tutto questo implico che gli schiavi africani che giungevano in America non potevano riprodursi autonomamente. Le donne africanetrapiantate in America avevano perso alcuni anni potenzialmente riproduttivi e non erano quindi piu in grado di riprodurre il numero di maschi e femmine che componeva il gruppo originario degli immigrati; ancor meno esse avrebbero potuto dar vita a una generazione maggiore del numero complessivo degli africani giunti nelle Americhe. Persino le regioni americane che avevano assistito a un ~flusso di africani consistente e continua avrebbero, dunque, trovato difficile mantenere la loro popolazione di schiavi e ancor meno incrementarne l'ampiezza, se non avessero fatto ricorso a nuovi immigrati. Una volta che il flusso migratorio degli africani si arresto, per la
440 Storia dell'economia mondiale. 2. Daile scoperte geogra/iche'alla crescita degli scambi
popolazione di schiavi divenne possibile sperimentare tassi naturali di crescita (almeno fino a quando, negli anni dell'emancipazione, si regi-stro una consistente migrazione in senso contrario). .
L'incremento relativo della popolazione americana, causato dall'impatto che su di essa ebbe la tratta degli schiavi non fu tuttavia uguale in tutte le colonie o in tutte le repubbliche. Gli Stati Uniti sono un caso quasi unico, perche dall'inizio del XVIII secolo in poi la loro popolazione di schiavi sperimento inusuali tassi naturali di incremento. II ruolo marginale rivestito dalle esportazioni dell' America settentrionale sui mercati europei fornisce una spiegazione dell' afflusso, relativamente esiguo, di schiavi africani. L'enorme sviluppo della popolazione puo essere spiegato solo facendo ricorso a variabili demografiche pill complesse. Negli Stati Uniti, il tasso di crescita della popolazione di schiavi fu persino superiore a quello raggiunto nel XIX secolo da altre societa schiavistiche che alla fine si trovarono con una popolazione dominante creola o di schiavi autoctonL
Le teorie formulate,in altri tempi, dagli storici statunitensi a proposito di un miglior «trattamento» degli schiavi in America del Nord, sono state respinte dagli studiosi di demografia storica. E stato dimostrato che il periodo di potenziale fertilita fosse all'incirca lo stesso per tutte le schiave del continente americano. Dal momenta che la durata della fertilita (ottenuta considerando l'eta del menarca e quella della menopausa) e direttamente connessa alle diverse condizioni igieniche, alla quantita di cibo assunta e all'attivita lavorativa svolta, e poiche la durata di tale periodo non presenta grandi differenze nel continente americano, si e giunti appunto a respingere la tesi del miglior trattamento. Studi recenti hanno sostenuto che la fondamentale differenza nei tassi di crescita della popolazione va ricondotta a un periodo piu breve di allattamento. Mentre le schiave statunitensi, adeguandosi al modello nord-europeo, allattavano i propri figli per un solo anno, le schiave del resto delle Americhe mantennero in vita i tradizionali usi africani, consistenti nell'allattare i figli per due anni. L'allattamento ha effetti contraccettivi e questo fornisce una spiegazione della maggiore distanza di eta tra i figli delle schiave non statunitensi. Questa distanza inoltre spiega il numero relativamente maggiore di figli nati da schiave statunitensi in eta feconda.
L'argomento demografico non si esaurisce, pero, con la sola questione della crescita, poiche quello che si evince da tutte le tavole di mortalita costruite per gli schiavi del XIX secolo e che gli schiavi nord-americani vivevano piu a lungo dei loro colleghi del resto del conti11ente. La speranza di vita degli schiavi maschi era, in Brasile per esempio, in media superiore ai vent'anni e negli Stati Uniti si aggirava attorno ai trentacinque. Se si prescinde dagli alti livelli di mortalita infantile, la corri-
H.S. Klein I! commercio atlantico di schiavi 441
spondente speranza di vita di coloro che raggiungevano il quinto anno d' eta era, per gli schiavi brasiliani, attorno ai trentacinque, per quelli statunitensi di poco inferiore ai quaranta. A prima vista questo sembrerebbe avallare la tesi del «trattamento» migliore. Ma, la stessa differenza riscontrata a proposito degli schiavi sarebbe emersa, in effetti, in tutte le societa americane anche tra gli uomini liberi, bianchi e di colore. I brasiliani di razza bianca vivevano doe relativamentemeno dei bianchi dell' America del Nord. Erano quindi le differenze complessive delle condizioni di salute che spiegavano le diverse speranze di vita relative e non gli speciali trattamenti a cui erano sottoposti gli schiavi.
In nessun caso, tuttavia, gli schiavi americani di qualsiasi societa schiavistica sperimentarono il cosiddetto «livello medio dei sette anni» di vita, a cui si riferivano gli scritti contemporanei del XVIII e del XIX secolo. Questa leggenda sulla manodopera che aveva vita breve va pasta in relazione con la realta che si aveva sotto gli occhi: la popolazione degli schiavi era in calo, nonostante il consistente impatto dell'immigrazione africana. Gli osservatori non concepivano che gli squilibri legati all' eta e al sesso di questi africani fossero · un fattore causale della crescita demografica negativa della manodopera schiavistica. Essi al contrario consideravano questo decremento come un sintomo dell'altissima mortalita e della bassa speranza di vita. Tutti gli studi recenti, tuttavia, indicano in tutte le societa americane sia un livello positivo di crescita demografica tra gli schiavi nativi, sia una speranza di vita hen superiore al cosiddetto livello medio dei sette anni lavorativi.
Ibene/ici della tratta
Questa digressione sulla speranza di vita e sui livelli di crescita comparativi mette bene in luce le recenti ramificazioni della ricerca sulla tratta degli schiavi. Ugualmente vaste si sono dimostrate le discussioni sui benefici economici complessivi che il commercio schiavistico ha apportato agli stessi europei. Il dibattito si puo scindere in diverse questioni generali. Il commercio degli schiavi rappresento un'iniziativa economica proficua? Quale impatto ebbe sulla crescita economica europea? E, infine, quale fu l'incidenza della tratta degli schiavi e del lavoro schiavistico sullo sviluppo dell' economia americana?
Dai lavori degli studiosi europei di storia economica risulta evidente che, in base ai parametri europei di allora, i profitti ottenuti dal commercio degli schiavi non furono esorbitanti. Il livello medio del 10% che se ne ricavava era all' epoca considerato un buon livello di guadagno, ma non fuori dalla portata di altri investimenti. Se i profitti non erano «astronomici», resta tuttavia da chiedersi se il commercio fosse
442 Storza dell' economia mondzale. 2. Dalle scoperte geografiche alla crescita degli scambi
libero o fosse invece sottoposto a restrizioni tali da creare profitti oligopolistici; questi avrebbero potuto divenire in, un secondo tempo fonte di investimenti capitalistici per l' economia europea. Si e sostenuto che gli elevati costi d' entrata, sommati al lungo periodo necessario ad ammortizzare pienamente le spese con i profitti (piu di cinque anni per un normale viaggio schiavistico), facevano s! che soltanto societa con notevoli capitali potessero fare ingresso in questo commercio. La maggior parte dei commercianti dilazionavano le spese offrendo sul mercato titoli garantiti sui viaggi degli schiavi o tentando di assicurarsi altrimenti contra perdite catastrofiche, le quali potevano verificarsi in uno o piu viaggi falliti. I costi di ingresso in questo tipo di commercio, l' esperienza maturata con gli intermediari, nonche la natura internazionale dei complessi negoziati instaurati, fanno pensare che era limitato il numero dei mercanti che potevano fare ingresso nella tratta. Anche se, come sembra, alcuni si specializzarono (questo fu il caso di importanti case di commercio che operavano tanto in Francia quanta in Inghilterra) e impressionante il numero dei mercanti indipendenti che ogni anno prendevano parte ai traffici e la flotta delle navi equipaggiate per il commercio.
Questa dibattito sui relativi livelli di controllo e di partecipazione dei mercanti e stato lo spunto per una vivace letteratura di analisi. In questa discussione, tuttavia, nessuna corrente di storici e stata in grado di dimostrare che i profitti del commercio vennero direttamente investiti nelle prime imprese industriali che stavano nascendo in Gran Bretagna. Tutti gli studi sulle fonti del capitale industriale in Inghilterra ne indicano l' origine nell' agricoltura el o nel commercio europeo. Questa tesi della relazione esistente tra i profitti ottenuti dal commercio e dalle piantagioni coloniali, da un lato, e gli investimenti nell'industria europea, dall'altro, ha ottenuto pero un parziale supporto dalla questione dell' Africa come mercato per i manufatti europei, specialmente per quelli di base. Si e detto che l'industria degli armamenti francese, negli anni di pace sulcontinente europeo, dipendeva totalmente dal commercio africano, il quale era sowenzionato grazie alle esportazioni di schiavi. Per molte altre industrie, tanto sul continente europeo quanta in Inghilterra, si puo dimostrare I' esistenza di un rapporto di dipendenza che le legava al mercato africano. Dal momenta che una gran parte della prima attivita industriale consisteva nella produzione di beni grossolani e destinati a un consumo popolare, si potrebbe sostenere che il mercato africano rivestiva un ruolo essenziale nello sviluppo di alcune tra le neonate industrie europee. Questa tipo di commercio rirnane ancora da studiare approfonditamente ma ha gia condotto a una seria rivalutazione del ruolo delle esportazioni europee in Africa, nel cruciale periodo delle prima rivoluzione industriale.
H.S. Klein Il commercio atlantico di schiavi 443
Esiste un argomento marginale in questo dibattito sui profitti del commercio degli schiavi, a cui si e fatto soltanto cenno nella storiografia. Essa riguarda il ruolo dei profitti ottenuti dai mercanti americani che presero parte alla tratta: gli abitanti delle Indie occidentali, i nordamericani (soprattutto quelli del New England) e, in particolare, i brasiliani. Se si guarda al volume dei traffici e al capitale ottenuto; non c'e dubbio che poche regioni possano essere paragonate a Bahia, Rio de Janeiro e al Rhode Island. In questi porti, il numero dei velieri approvvigionati per l' Africa fa pensare a un importante incremento del capitale locale. Chi fossero questi mercanti e quale fosse il loro rapporto con l' economia delle piantagioni e con i primi stabilimenti industriali resta un argomento ancora da studiare.
J; abolizione de! commercio
Ultimo grande tema all' attenzione degli studiosi della tratta degli schiavi resta ancpra quello tradizionale delle cause e degli effetti della sua abolizione. E noto che la campagna intrapresa per abolire il commercio atlantico degli schiavi, iniziata nell'ultimo quarto· del XVIII secolo, viene considerata il primo movimento politico di massa di tipo pacifico, basato su una moderna propaganda politica, nella storia d'Inghilterra se non in quella d'Europa. La letteratura tradizionale giudico questa campagna una · crociata moralista, condotta a spese dei profitti economici e dei traffici commerciali. Una volta abolita la tratta nelle colonie britanniche, nel 1808, gli Inglesi tentarono di far desistere tutti gli altri grandi Stati europei dal praticare questo tipo di commercio. Questa campagna rappresento, a sua volta, un'operazione costosa in termini di riduzione dei traffici, allontanamento degli alleati tradizionali e delle ingenti spese sostenute per il blocco navale.
Sebbene, sin dagli inizi, i politici e gli scrittori britannici dipingessero il movimento di cui si facevano promotori come una campagna moralista, una nutrita letteratura contemporanea criticava i loro intenti. I Cubani, gli Spagnoli e i Brasiliani, oggetto della maggior parte degli strali lanciati dagli abolizionisti britannici dopa il 1808, giunsero alla conclusione che la campagna del XIX secolo era motivata dalla paura della concorrenza, in particolare dopa l' abolizione della schiavitu nel 1834, quando lo zucchero delle Indie occidentali britanniche venne prodotto con l'impiego di lavoro non schiavistico. L'America Latina sosteneva che il movimento abolizionista serviva a tenere fuori dal mercato europeo i beni schiavistici, prodotti in modo piu efficiente, rialzando i costi della manodopera. Tutto questo; a loro avviso, spiegava la campagna intrapresa contra la tratta degli schiavi. Piu tardi questo ar-
444 Stort'a dell' economz'a mondiale. 2. Daile scoperte geogra/iche alla crescita degli scambi
gomento venne ripreso dagli studiosi dell'economia delle Indie occidentali che a:sserirono che il sisterna della piantagione coloniale britannica era, dopo l' abolizione del commercio degli schiavi, inefficiente e ando incontro a seri problemi economici.
In antitesi a questo modello economico di tipo causale, gli storici pill recenti hanno argomentato che tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo l'economia delle Indie occidentali britanniche era florida. Persino dopo l' abolizione della tratta, sia isole piu vecchie, sia quelle di piu recente acquisizione erano competitive sui rnercati europei e fu solo l' abolizione della schiavitu a gettare lo scompiglio nell' econornia locale. Anche se la cainpagna abolizionista non viene piu considerata come una grande crociata moralista, la tesi del deterrninismo economico e ancora oggetto di aperto dibattito.
Conclusioni
Corne risulta evidente da quanto detto finora, la risposta ai molti quesiti sulla natura della tratta degli schiavi porta subito a dibattiti pill articolati, la maggior parte dei quali non si sono ancora placati. Diversi ambiti d'indagine che potrebbero fiorire dai nuovi filoni di ricerca rimangono ancora da studiare. Cos1 la questione delle origini culturali degli a:fro-arnericani, molto dibattuta, ma sempre dal punto di vista degli americani, deve essere abbondantemente integrata con le conclusioni che si sono tratte dallo studio del comrnercio degli schiavi. Ora si ha un'idea abbastanza chiara sui gruppi che furono coinvolti nel comrnercio e sulle regioni americane nelle quali essi si insediarono. Rimane, tuttavia, ancora da descrivere dettagliatamente l'importanza relativa di questi singoli gruppi nella creazione delle locali culture afro-america:ne.
Non bisognerebbe neanche dirnenticare che molte delle questioni presentate sono lungi dall' esser risolte. Ci sono continui aggiustamenti circa il numero degli schiavi imbarcati in ogni regione ed essi, spesso, correggono parzialmente le stirne correnti. Contemporaneamente gran parte delle nuove ricerche si sta occupando della salute e della trasrnissione delle malattie. Non si e ancora placata la discussione sulle cause della mortalita e infine resta in piedi il lungo dibattito circa l'impatto che la tratta degli schiavi ebbe sul continente africano. Simulazioni della crisi demografica, realizzate con l' ausilio dell'informatica, modelli di insediamenti regionali e di villaggi abbandonati e nuove stime sull'andamento generale della popolazione e sui livelli di crescita di lungo periodo hanno inaugurato un nuovo arnbito di ricerca negli studi di demografia africana precoloniale.
Ma, qualunque sia lo stato attuale del dibattito e il livello di conclu-
H.S. Klein I! commercio atlantico di schiavi 445
sivita di ogni singolo argomento, e evidente che il modo in cui noi oggi intendiamo la dimensione, l'importanza e !'influenza del commercio atlantico di schiavi sia stato profondamente modificato dagli sforzi di approfondita ricerca degli' ultimi venticinque anni.
Rzferimenti bibliografici
R. Anstey, The Atlantic Slave Trade and British Abolition, 1760-1810, Atlantic Highlands (N.J.) 1975.
R. Anstey, P.E.H. Hair (a cura di), Liverpool. The African Slalle Trade and Abolition, Liverpool 197 6.
A. Carreira, As Companhias Pombalinas de navegaqao, comercz'o e trdfico de escravos entre a costa africana e o nordeste brasileiro, Porto 1969.
J. Coughtry, The Notorious Triangle: Rhode Island and the African Slave Trade, Philadelphia 1981.
Ph.D. Curtin, The Atlantic Slave Trade: a Census, Madison 1969. S. Daget (a cura di), De la traite a l'escavage, Nantes 1988. D. Eltis, Economic Growth and the Ending of Transatlantic Slave Trade, New
York 1987. · D. Eltis, J. Walvin (a cura di), The Abolition of the Atlantic Slave Trade: Ori
gins and Effects in Europe, Africa and the Americas, Madison 1981. J.E. Inkori, S.L. Engerman (a cura di), The Atlantic Slave Trade: Effects on Eco
nomies, Societies and People in Africa, the Americas and Europe, Durham (N.C.) 1992.
H.S. Klein, The Middle Passage: Comparative Studies in the Atlantic Slave Trade, Princeton (N.J.) 1978.
G. Martin, I: ere des negriers (1714-1774): Nantes au XVIIIe siecle (2a ed.), Paris 1993.
J.C. Miller, Way of Death: Merchant, Capitalism and the Angolan Slave Trade, 1730-1780, Madison 1988.
R.L. Stein, The French Slave Trade in the Eighteenth Century: an Old Regime Business, Madison 1979.
E.F.S. de Studer, Le trata de negros en el Rio de la Plata durante el siglo XVIII (2" ed.), Buenos Aires 1984.
P. Verger, Flux et reflux de la traite des negres entre le Gol/e de Benin et Bahia de Todos os Santos, du dix-septieme au dix-neuvieme siecle, Paris 1968.