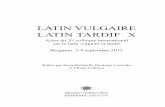STORIA DI MASSA MARITTIMA E DELLA MAREMMA - Elenco delle pubblicazioni fino al 2016
Fino alla fine del mondo. Stato e spazio politico nel recente dibattito sulla «forma-impero»
Transcript of Fino alla fine del mondo. Stato e spazio politico nel recente dibattito sulla «forma-impero»
217
«Teoria politica» XIX, nn. 2-3, 2003, pp. 217-250
FINO ALLA FINE DEL MONDO.STATO E SPAZIO POLITICO NEL RECENTE DIBATTITO
SULLA «FORMA-IMPERO»
di Damiano Palano
1. La Terra diminuita
— Dove volete che vada?
— Io non lo so […] ma, dopo tutto, la Terra è abbastanza vasta.
— Lo era una volta… […]
— Come, un tempo! Forse che la Terra è diminuita per caso?
— Senza dubbio […]. La Terra è diminuita, giacché la si percorre adesso dieci volte più presto di cento
anni fa. Ed è questo che, nel caso di cui ci occupiamo, renderà le ricerche più rapide1.
Se la conversazione improvvisata sui tavoli del Reform Club da alcuni gentiluominilondinesi costituiva poco più che il pretesto da cui prendeva avvio la carambola di avventuredel Giro del mondo in 80 giorni, la scoperta della «diminuzione» della Terra mostravaancora una volta la lungimiranza con cui Jules Verne riusciva a cogliere le implicazioni piùcontroverse delle conquiste tecnologiche. Interrogandosi sulla fuga di un ladro particolar-mente audace, i compagni di whist di Phileas Fogg arrivavano infatti a scoprire come laTerra — ormai cinta da un’ininterrotta catena di stabili linee di navigazione e strade ferrate— fosse di fatto «diminuita » grazie alla contrazione temporale degli spostamenti di mercie persone. Mentre il Viaggio al centro della terra poteva essere interpretato come un’esplo-razione dalle palesi allusioni metaforiche verso le più remote — e inconsce — profonditàdella psiche, anche la travolgente corsa attorno al mondo di Phileas Fogg e del suo dome-stico offriva così molto più che una concatenazione di avventure e colpi di scena perfetta-mente riuscita. Quella corsa contro il tempo, compiuta attraversando quattro continenti,governati da differenti regimi politici e abitati da popolazioni estremamente diverse percultura, religione e storia, era infatti anche una grande e incondizionata celebrazione dellaciviltà occidentale, capace di solcare gli oceani, innalzare ponti e costruire ferrovie, maanche — almeno agli occhi di Verne — di portare l’ordine e il progresso tra le brulicantifolle indiane e le riottose tribù dei nativi americani.
Più di un secolo dopo, in Bis ans Ende der Welt, l’entusiasmo che aveva permeato lepagine di Verne si trovava rovesciato in un cupo e irrimediabile pessimismo, trasformando
218
il viaggio che Wim Wenders faceva compiere ai due protagonisti, un viaggio pure per moltiaspetti simile a quello intrapreso da Phileas Fogg e dal suo fidato Passepartout, in una fugasenza scampo dalla catastrofe. Muovendosi quasi interamente nei non-luoghi delle cittàglobali e del turismo planetario, in stazioni della metropolitana, camere d’albergo, ristorantie uffici, la corsa di Wenders verso il limite estremo del mondo, alla ricerca di un orizzonteforse immune dal potere totalitario della tecnica, non poteva che tramutare la scoperta della«diminuzione » della Terra e l’intuizione ottocentesca della contrazione temporale dellospazio nell’incubo della « fine ». Alludendo alla colonizzazione di ogni più riposto spazio divita da parte della società della comunicazione, la fuga dei protagonisti da Venezia a Parigi,da Berlino a Londra, da Mosca a Pechino, da Tokyo a San Francisco, fino al continenteaustraliano, mirava infatti a mostrare non solo l’impossibilità del viaggio in un mondoormai completamente omologato, ma, in termini ancora più radicali, soprattutto la consape-volezza che la scomparsa dell’ultima e più remota «frontiera» aprisse le porte a una cata-strofe oscuramente presentita, tanto misteriosa quanto imminente.
Pur con connotazioni estremamente originali, la raffigurazione della globalizzazioneallestita da Wenders rivisitava un immaginario ampiamente consolidato, nel quale l’idea delcompimento della conquista umana della Terra risultava invariabilmente associata all’incu-bo della catastrofe. Sia che a provocare la scomparsa del genere umano fosse un conflittotermonucleare, sia che la l’ecatombe provenisse da qualche imprecisato disastro ecologico,lo spettro della « fine del mondo» ha fornito infatti lo scenario (e talvolta il pretesto) acentinaia di trame, centrate sull’esodo da un pianeta ormai inabitabile, su un nuovo «statodi natura » postbellico, e, persino, come nell’allegoria di Planet of the Apes, sul rovescia-mento della gerarchia antropocentrica. Al termine della Seconda guerra mondiale, lo stessoCarl Schmitt, nelle sue celebri riflessioni sull’Unità del mondo, non poteva evitare di evo-care un quadro per gran parte convergente con l’immaginario di un’apocalisse incombente.Diventando realistica soltanto con l’ascesa del « pensiero tecnico-industriale », l’idea del-l’«unità del mondo », a partire dalla metà dell’Ottocento, si era avvicinata rapidamente allasua potenziale realizzazione. Nell’arco di un secolo, a fronte dello sviluppo dei mezzi ditrasporto e degli strumenti di distruzione bellica, la terra, secondo Schmitt, si era « propor-zionalmente rimpicciolita», facendo apparire la «realizzazione dell’unità del mondo» comel’esito pressoché scontato della storia umana. Puntando a una ricomposizione della fratturaapertasi tra lo sviluppo tecnologico e la realtà morale, Schmitt non auspicava naturalmenteche la prospettiva dell’unificazione del pianeta si realizzasse effettivamente. Per quantocontestasse la fatalità di questo destino, però, non escludeva affatto che l’eventualità del-l’unificazione del mondo sotto un solo potere si potesse concretamente verificare e che,trasformando il genere umano in una sorta di «magnus homo», essa potesse raggiungere,con la « morte tecnica dell’umanità», il « punto culminante della Storia universale»2.
Cinquant’anni dopo la conferenza di Schmitt, il cupo scenario del conflitto atomico trale superpotenze, ha lasciato il posto a un immaginario in cui la catastrofe finale sarebbedeterminata da una sorta di lenta implosione della razionalità tecnica, in un quadro di pro-gressiva distruzione delle risorse ambientali e di logoramento delle condizioni della convi-venza sociale. Prefigurando il nuovo panorama molto più efficacemente della vecchia fan-tascienza degli anni Cinquanta, opere come Blade Runner di Ridley Scott o Neuromante diWilliam Gibson hanno fornito, già all’inizio degli anni Ottanta, l’oscura immagine di un
219
mondo interamente ricoperto dalle reti della società della comunicazione e dominato dacorporations pervasive e onnipotenti. Alle seducenti suggestioni offerte dalla science fic-tion non hanno voluto sottrarsi neppure le scienze sociali, e le riflessioni critiche sul proces-so di globalizzazione, sono così spesso risultate debitrici — a dispetto anche dell’originalitàe dell’estrema utilità delle analisi — dello stesso immaginario apocalittico al fondo dell’in-cubo della « fine del mondo». Già alla metà degli anni Ottanta, ad esempio, una ricercatriceattenta e rigorosa come Susan Strange, al termine di un suo importante lavoro, evocandoproprio l’immagine dell’ultima notte del XX secolo, dipingeva un panorama contrassegnatoda una crescente polarizzazione sociale, nel quale avrebbero potuto «alzare il bicchiere»per festeggiare l’ultimo capodanno del millennio «solo i partecipanti al gioco d’azzardodella finanza […] sopravvissuti nelle grandi torri per uffici dei centri finanziari del mondocapitalistico»3.
Invariabilmente al centro della letteratura cresciuta attorno all’idea del « nuovo medio-evo» globale, non poteva che trovarsi soprattutto il nodo della « scomparsa » dello Stato,descritto come letteralmente sopraffatto dalle grandi compagnie transnazionali e dall’in-controllabile fluire dei mercati finanziari internazionali. In questo senso, fornendo nel 1996una delle raffigurazioni più efficaci della globalizzazione dei mercati, la stessa Strangedelineava i contorni di un irreversibile « declino dell’autorità statale», nel quale, contempo-raneamente a una concentrazione delle risorse decisionali verso gli Stati « con capacitàglobale o regionale al di là delle proprie frontiere », si sarebbe assistito non solo all’emer-gere di «autorità non statali », ma anche alla «volatilizzazione» di una parte del potereprecedentemente esercitato dai governi nazionali4. A dispetto della convinta insistenzasull’idea di un declino tanto netto da sancire definitivamente la vittoria del «mercato» sulloStato, i primi anni del nuovo secolo hanno tracciato un quadro piuttosto differente, invitan-do anche a una revisione delle ipotesi formulate nel precedente decennio. In questo senso,come ha osservato recentemente Lorenzo Ornaghi, mentre è «certamente prematuro e conogni probabilità abbastanza ingenuo ritenere che la plurisecolare rete di corrispondenze ecoerenze da cui sono “ tenuti insieme” Stato e sistema politico (ed economico) internazio-nale sia ormai del tutto infranta», il compito che si pone all’indagine dei contestuali proces-si di globalizzazione e frammentazione non può che passare dallo studio delle modalità concui quelle stesse «corrispondenze » e « coerenze » si modificano e riarticolano all’internodel nuovo contesto5. Più che considerare perciò conclusa la vicenda della moderna statua-lità, risulta teoricamente molto più utile ricostruire le dinamiche con cui i differenti livelliistituzionali contribuiscono a ridefinire le geometrie dello spazio politico, configurandoarchitetture ed equilibri almeno parzialmente inediti. Ad essere posta in crisi dai processi dideterritorializzazione politica ed economica è infatti, come ha messo efficacemente in luceCarlo Galli, la specifica modalità con cui la modernità europea — dinanzi alla crisi dell’uni-versalismo medioevale, alle scoperte geografiche, alla fine della centralità europea e, so-prattutto, all’esaurimento di qualsiasi «spazialità immediatamente politica » — ha costruitouna geometria spaziale fondata sulla creazione di confini artificiali, costitutivamente insta-bili nel tempo e nella loro struttura. In altri termini, la sfida proveniente dalla globalizzazio-ne e la ridefinizione del ruolo delle unità statuali pongono in questione principalmente laconfigurazione dello spazio centrata sulla relazione istituita tra soggetto, Stato e società,finendo col determinare l’obsolescenza teorica delle categorie che innervavano la «moder-
220
na» geometria spaziale e soprattutto — insieme alle dicotomie di universale e particolare,pubblico e privato, e cosmopolitico e locale — la stessa distinzione tra interno ed esterno6.
Che tra gli effetti del superamento del confine tra inside e outside non stia soltanto lacaduta della moderna distinzione tra «nemico» e «criminale» (già messa a dura prova dalleguerre del Novecento), è stato peraltro mostrato nitidamente da Luigi Bonanate, il quale,riprendendo la formula habermasiana della « politica interna del mondo », ha messo in lucetutte le esitazioni con cui la riflessione politologica stenta a trarre le indispensabili conclu-sioni teoriche dalla registrazione di un processo di integrazione planetaria ormai ben più chedecennale7. La necessità di nuove categorie interpretative, indispensabili per dar conto diun processo che si muove al di fuori anche delle più consolidate distinzioni tra politica« interna » e « internazionale», risulta in effetti ancora oggi largamente insoddisfatta. Senozioni come quella di governance iniziano a mostrare la corda già dopo pochi anni di vita,i ritardi e l’urgenza degli sforzi appaiono ancora maggiori sul versante della riflessionesullo Stato e sulle sue funzioni. Mentre alla consapevolezza dell’esaurimento della sovra-nità non hanno fatto seguito riflessioni capaci di « relativizzare » la definizione ottocentescadello Stato, si è anche assistito, oltre che al revival del vecchio schema dell’imperialismo,all’inaspettato successo di un concetto dalle profonde radici storiche come « impero». Giàevocata negli anni Ottanta da Susan Strange per dar conto dell’assetto globale che stavaprendendo forma, la nozione di « impero » è stata infatti riproposta più di recente nel campodegli studi internazionali per illustrare il nuovo ruolo assunto dagli Stati Uniti e dalle lorotentazioni unilateraliste8. È stato comunque soprattutto nel dibattito giornalistico e nellacritica politica che l’idea di un «impero», ovviamente coincidente con gli Usa e il limitatonumero dei loro più fedeli alleati, ha conosciuto la maggiore fortuna, caricando spesso disuggestioni apocalittiche la requisitoria contro le potenze occidentali9. Proprio negli StatiUniti, però, l’inatteso revival del termine è stato favorito dal successo arriso nel 2000 aEmpire, il testo con cui Michael Hardt e Antonio Negri hanno tentato di definire i contornidel nuovo paradigma di esercizio della sovranità configuratosi informalmente negli ultimidecenni10. Per molti versi sorprendente, almeno in Italia, il successo del saggio — nel qualevanno ad innestarsi differenti matrici, dall’operaismo italiano degli anni Sessanta ai subal-tern studies, dal poststrutturalismo francese alla riflessione sull’impatto delle trasformazio-ni tecnologiche — è in realtà un segnale dell’interesse mostrato dalla teoria radicale norda-mericana per i differenti filoni del neomarxismo europeo, rivisitati in una chiave fortementeantideterminista alla luce dei dibattiti condotti nel quadro del decostruzionismo filosofico,del postcolonialismo, del postmodernismo e degli studi di genere11.
Esaminando le posizioni teoriche emerse nella recente riflessione sulla « forma-impe-ro», nelle prossime pagine verranno riconsiderati alcuni nodi al centro del vecchio dibattitomarxista sullo Stato, di cui verranno posti in luce tanto le ipotesi chiave quanto i limiti e leincongruenze. Prendendo le mosse dalla contrapposizione teorica tra concezioni «strumen-taliste» e « funzionaliste », e affrontando la questione dell’« autonomia» delle istituzionipolitiche, la ricostruzione delineerà successivamente i contorni principali della ricerca suirapporti tra Stato ed economia condotta negli anni Ottanta e Novanta. Riallacciandosi allevecchie formulazioni, ma soprattutto alle sollecitazioni maturate negli ultimi due decenni,uno degli obiettivi di Empire è infatti sciogliere il nodo problematico relativo al nesso traistituzioni politiche e ordine economico che l’ancora insufficiente sviluppo del capitalismo
221
avrebbe in precedenza reso insolubile. La tesi al cuore di queste pagine è che la riflessionesulla nuova « forma-impero» — pur proponendo una lettura efficace della crisi della spazia-lità modernità, intuizioni talvolta notevoli e una prospettiva capace di conferire una certaorganicità teorica al più recente dibattito radicale — non riesca interamente a superare ilimiti della vecchia tradizione marxista e finisca così con l’allestire, a dispetto delle dichia-razioni teoriche, un quadro fortemente determinista, per molti versi incapace di uscire dauna logica di lungo periodo e di orientare le analisi concrete.
2. Le geometrie dell’impero
Nel suo monumentale e ancora incompiuto studio sulle origini dell’economia-mondo,Immanuel Wallerstein ha insistito con forza sul ruolo svolto dagli Stati nazionali nell’affer-mazione e nell’estensione del modo di produzione capitalistico, soffermandosi inoltre sulnesso strettissimo esistente tra la nascita del « capitalismo storico» e il consolidamento delsistema interstatuale. Compiendo un percorso logico inverso a quello seguito da Marx nelCapitale, Wallerstein non si è posto come obiettivo l’individuazione di un modello astrattodel modo di produzione, ma ha piuttosto tentato di chiarire come la logica dell’accumula-zione si sia storicamente imposta, da quali soggetti sia stata perseguita e grazie a qualimodalità sia riuscita ad abbracciare un’area sempre più coincidente con quella del mondointero. Secondo questa lettura, i primi germi di quello che sarebbe in seguito divenuto ilworld-economy system erano già individuabili nell’Europa della fine del XV secolo. Già inquesta fase avrebbe infatti iniziato ad emergere un nuovo vero e proprio sistema «mondia-le », che, pur conservando alcune caratteristiche dei vecchi imperi, se ne sarebbe discostatoprofondamente, originando un assetto radicalmente innovativo:
Era un tipo di sistema sociale che il mondo non aveva ancora conosciuto, e che costituisce la caratte-
ristica particolare del moderno sistema-mondo. È un’entità economica ma non politica, diversa dagli
imperi, dalle città-Stato e dalle nazioni-Stato. Di fatto, essa comprende dentro i suoi confini (non si può
parlare di frontiere) imperi, città-Stato e le emergenti «nazioni-Stato». È un sistema mondiale non
perché comprenda il mondo intero, ma perché va al di là di qualsiasi unità politica definita giuridica-
mente. Ed è un’«economia-mondo» perché il legame fondamentale tra le parti del sistema è economi-
co, anche se veniva rinforzato in qualche misura da legami culturali e […] da accordi politici ed anche
da strutture confederali12.
Chiarendo la differenza tra le vecchie realtà imperiali e il nuovo sistema-mondo, Wal-lerstein riprendeva un punto cruciale degli studi dedicati da Fernand Braudel all’afferma-zione del capitalismo13. Mentre i vecchi imperi si erano fondati sull’estrazione di tributi eimposte resa possibile dal monopolio della forza e dall’esistenza di una struttura burocraticae repressiva rigidamente centralizzata, la novità del nuovo world system consisteva nellanatura prettamente economica della sua logica di dominio. Se questo mutamento non impli-cava la senescenza delle forme politiche di controllo e governo del territorio, imponeva peròagli Stati nascenti un ruolo che, a differenza delle vecchie sintesi imperiali, li avrebbe vistiimpegnati principalmente nel compito di assicurare la regolarità delle transazioni commer-ciali e un’azione di espansione non militare ma prevalentemente economica14.
222
Per quanto l’immagine al centro del libro di Hardt e Negri sembri contrastare la tesi diBraudel e Wallerstein, l’idea di « impero» proposta dai due autori per descrivere l’ordinepolitico della globalizzazione risulta solo in parte alternativa a quella dei teorici del-l’« economia-mondo ». Gli spunti critici indirizzati da Hardt e Negri a questo filone diindagine si concentrano infatti principalmente sull’adozione di una teoria «ciclica » dellosviluppo capitalistico da cui sarebbero del tutto espunti gli elementi conflittuali e il ruolodelle forze antagoniste alla dinamica della valorizzazione15, ma non implicano in alcunmodo una contestazione del carattere prevalentemente «economico» del world system inau-gurato dal capitalismo. Anche l’impero di cui Hardt e Negri intendono delineare i tratti nonè infatti una vera e propria forma di dominio politico, ma piuttosto uno sviluppo della logicadi dominio economico propria del «capitalismo storico ». Ciò che ai due autori preme sot-tolineare, nella definizione del nuovo «concetto di Impero», è piuttosto il « salto» di para-digma cui si assisterebbe con la compiuta realizzazione del mercato mondiale, un « salto »che non determinerebbe la senescenza dello Stato, ma, più semplicemente, ne ricolloche-rebbe la struttura e le funzioni all’interno di un nuovo ordine e di una mutata gerarchia.Nell’architettura allestita in Empire — un’architettura solo apparentemente lineare, ma inrealtà costituita da una complessa serie di cerchi concentrici e talvolta persino offuscatadall’avvicendarsi di immagini, suggestioni e rimandi letterari — la nuova forma della so-vranità non delineerebbe né una gerarchia di Stati dominati dagli Usa, né una sorta di veroe proprio governo politico mondiale di cui sarebbero espressione organismi internazionalicome il Wto, l’Imf o la World Bank. La formazione delle Nazioni Unite e l’immaginekelseniana di un ordine giuridico globale, cui sono dedicate le prime pagine del volume,sono infatti interpretate soltanto come tracce della « tendenza che conduce verso una rego-lazione unitaria e centralizzata del mercato mondiale e delle relazioni globali di potere»16.Determinando «mutamenti effettivi nella costituzione materiale del potere e dell’ordinemondiale », il nuovo paradigma di esercizio della sovranità si definirebbe invece come «unafabbrica di norme e una produzione di legittimità a lungo termine che ricoprono l’interospazio mondiale », oltre che come «una struttura sistemica, dinamica e flessibile, articolataorizzontalmente» e su un terreno « biopolitico», nella quale, come nella «società di control-lo» descritta da Foucault e Deleuze, « i meccanismi di comando divengono sempre piùimmanenti al sociale, e vengono distribuiti attraverso i cervelli e i corpi degli individui»17.
Che la svolta verso un nuovo paradigma non comporti la senescenza dello Stato è peral-tro chiarito con forza dai due autori, i quali stigmatizzano con una certa energia le letture chenegli ultimi dieci anni hanno posto la globalizzazione all’origine di una irreversibile crisidella sovranità statale. Per quanto sul piano interno l’autonomia dei singoli Stati nazionalirisulti effettivamente erosa, e benché le multinazionali siano realmente in grado di operareal di sopra dell’autorità costituzionale delle singole unità statuali, il nuovo quadro nonsarebbe affatto dominato da un incontrastato dominio degli attori « economici ». Le «fun-zioni costituzionali» svolte in precedenza dai singoli Stati sovrani, lungi dal venir meno,sarebbero piuttosto dislocate a un differente livello, e darebbero forma a quella nuova «co-stituzione dell’Impero» che Hardt e Negri descrivono — ricorrendo a un’immagine certosuggestiva, anche se non priva di ambiguità — come una «struttura piramidale, compostadi tre piani, ognuno dei quali comprende numerosi livelli »18. Al vertice supremo di questastruttura si troverebbero naturalmente gli Stati Uniti, mentre, subito sotto, il secondo e il
223
terzo livello del primo piano sarebbero occupati dal ristretto gruppo degli Stati nazionalidetentori dei principali strumenti monetari globali, oltre che da un complesso di associazio-ni dotate di « un potere culturale e biopolitico di portata globale». Al secondo livello stareb-bero invece le corporations transnazionali e, in una posizione subordinata, il complessodegli Stati-nazione minori, mentre l’ultimo gradino sarebbe presidiato dall’arcipelago delleOrganizzazioni Non Governative, intese come «organi rappresentativi di una società civileglobale ». Con un’operazione altrettanto gravida di suggestioni, Hardt e Negri istituisconoinoltre un’analogia — ovviamente soltanto metaforica — tra la struttura piramidale dellacostituzione globale e il modello della « costituzione mista» con cui Polibio spiegava lafortuna e la resistenza dell’Impero di Roma. Al di là delle differenze ovviamente abissali trai due assetti storici e politici, l’idea che regge l’analogia istituita da Hardt e Negri è chel’equilibrio della nuova costituzione imperiale sia riconducibile non tanto all’assetto trifun-zionale delle moderne costituzioni, fondate sul principio della divisione dei poteri, quantoproprio a un modello di costituzione mista, basato sulla presenza di differenti corpi tra lororelativamente indipendenti. In altri termini, la costituzione imperiale non sarebbe raffigu-rabile tanto come una sorta di super-Stato globale, quanto nei termini di un equilibrio insta-bile di corpi sociali operanti a vari livelli e con diverse specificità, secondo modalità para-gonabili — almeno a livello figurato — a quelle con cui monarchia, aristocrazia e democra-zia convivevano nel modello romano grazie alla contemporanea presenza dell’imperatore,del senato e del tribunato della plebe. I contorni di questa immagine si precisano ulterior-mente quando i due autori passano a descrivere la ripartizione delle prerogative di governodeterminata dal mutamento delle relazioni spaziali. Il primo asse di questa trasformazioneconsisterebbe infatti in una « ibridazione» delle stesse funzioni, nel senso che l’elementomonarchico della costituzione imperiale sarebbe chiamato a « controllare la dimensionecomplessiva del mercato » — e cioè a sorvegliare « la circolazione delle merci, della tecno-logia e della forza lavoro»19 — in un intreccio inestricabile con l’elemento aristocratico. Ilsecondo asse del mutamento costituzionale consisterebbe invece nel fatto che, in questafase, il « comando deve essere esercitato in misura sempre più sistematica sulle scansionitemporali della società e, soprattutto, sulla soggettività », e proprio in questo passaggiorisiederebbe il principale carattere della transizione dal paradigma disciplinare al paradig-ma del controllo:
Il potere viene esercitato direttamente sui movimenti delle soggettività produttive e sulla cooperazione;
le istituzioni vengono ininterrottamente formate e ridefinite in base ai ritmi di questi movimenti e la
topografia del potere non ha più esclusivamente a che fare con relazioni spaziali, ma con spostamenti
temporali delle soggettività. Troviamo così, ancora una volta, quel non-luogo […] rilevato nel corso
dell’analisi della sovranità. È dal non-luogo che vengono esercitate le ibride funzioni di controllo
dell’Impero20.
Al di là delle forti suggestioni, non prive di richiami all’immaginario della science-fiction21, la figura di un impero senza luogo e senza centro, ma tanto pervasivo da penetrarenella profondità delle coscienze, rischia naturalmente di sembrare solo un raffinata eserci-tazione intellettuale priva di qualsiasi riferimento alla realtà, come d’altronde la stessa ideadi una forma di dominio che si esercita su uno « spazio liscio », privo di qualsiasi divisione
224
o confine interno, pare definire soltanto l’ardita prefigurazione di un futuro presumibilmen-te remoto. Il discorso di Hardt e Negri — insieme ad alcune loro espressioni talvolta enig-matiche — risulta però chiaro se si comprende come dietro la nozione di « impero » sinasconda l’idea del mercato mondiale, vero cuore di tutte le loro argomentazioni e sostanzadella selva di immagini e metafore di cui Empire è affollato. Quello cui alludono i due autoriè ovviamente un mercato inteso non semplicemente come « immensa raccolta di merci»,ma, secondo l’originaria impostazione marxiana, come ambito di costruzione delle relazio-ni sociali capitalistiche. Quando i due autori scrivono che «nello spazio liscio dell’Imperonon c’è un luogo del potere» e che « il potere è, a un tempo, ovunque e in nessun luogo», essialludono dunque alla struttura del mercato, e cioè a una forma di organizzazione senzacentro, senza vertice e persino priva di stabili localizzazioni, eppure capace di imporre lapropria vigenza tendenzialmente in ogni ambito del globo. Parimenti, quando individuanocome elemento costitutivo del nuovo assetto imperiale l’esaurimento della moderna barrie-ra tra « dentro» e «fuori», oltre che tra « interno » ed «esterno », si riferiscono ancora unavolta proprio alla tendenza espansiva del mercato capitalistico, definito, in un passo deci-sivo del loro saggio, come il vero «diagramma del potere imperiale »:
Il mercato capitalistico è una macchina che ha sempre funzionato contro qualsivoglia divisione tra un
dentro e un fuori. È allergico alle barriere e alle esclusioni e si sforza sempre di includere ogni cosa nella
propria sfera di dominio. Il profitto è generato solo dal contatto, dal coinvolgimento, dall’interscambio
e dal commercio. Il mercato mondiale è il capolinea di questa tendenza. Nella sua forma ideale, il
mercato mondiale non conosce nessun fuori: il suo dominio è il mondo intero. La forma del mercato
mondiale è un modello per comprendere la sovranità imperiale. Come, per Foucault, il panopticon
rappresentava il diagramma del potere della modernità, il mercato mondiale rappresenta adeguatamen-
te […] il diagramma del potere imperiale22.
Proprio il riferimento al mercato mondiale chiarisce come l’« impero» descritto da Har-dt e Negri non sia un’entità politica analoga ai vecchi sistemi imperiali, ma un estremosviluppo della forma di dominio economico al centro delle ricerche di Arrighi e Wallersteine dei loro studi sulle trasformazioni del sistema mondiale dell’economia moderna. Ed è lastessa centralità del mercato mondiale a chiarire anche i principali snodi del discorso diHardt e Negri, a partire dall’attenzione posta sul superamento di quella distinzione modernatra «dentro» e «fuori» che costituisce uno dei nuclei centrali della loro riflessione, finoall’enfasi sul ruolo della costituzione statunitense, considerata, per le sue specifiche carat-teristiche genetiche, come la prefigurazione della successiva costituzione imperiale.
Intervenendo recentemente nel dibattito e ricostruendo con efficacia le radici storichedel concetto di « impero », Massimo Cacciari ha sostenuto che l’attuale revival del terminesarebbe per gran parte ingiustificato. L’idea di «civitas augescens », il riferimento alla«concordia» e la capacità di allargare il diritto di cittadinanza — elementi cruciali nellafondazione concettuale dell’imperium populi romani — risulterebbero infatti del tutto as-senti dallo scenario della globalizzazione, anche perché l’attuale «progressiva convergenzadei sistemi economici e politici » sembrerebbe riprodurre una dinamica assai più simile aquella del vecchio imperialismo23. Se Cacciari nega perciò al « governo politico» dellaglobalizzazione (e soprattutto alla politica statunitense) qualsiasi capacità inclusiva, Hardt
225
e Negri trovano invece proprio in questo punto uno degli elementi caratterizzanti del nuovoparadigma della sovranità, formatosi dallo sviluppo estremo della struttura costituzionalenordamericana. A differenza di quello europeo, lacerato da una crisi costitutiva e dallareintroduzione di schemi trascendentali, il modello americano di sovranità avrebbe infattiaffermato l’immanenza del potere costituente, celebrato come potenza produttiva della societàe proiettato verso una costante e (almeno inizialmente) illimitata espansione verso un « fuo-ri » destinato ad essere incluso nella rete costituzionale. Mentre il modello europeo di sovra-nità si sarebbe indirizzato a una conquista finalizzata all’esclusione, il modello repubblica-no americano, capace di includere la forza espansiva del potere costituente, si sarebbemosso verso una estensione inglobante, e, proprio percorrendo questa linea, avrebbe inizia-to a mostrare, seppur solo in nuce, i tratti della futura costituzione imperiale:
La sovranità, come potere che si espande in rete, si trova sulla cerniera che collega la repubblica
democratica all’Impero. L’Impero può essere rappresentato soltanto come una repubblica universale,
una rete di poteri e contropoteri strutturati da un’architettura inclusiva e illimitata. L’espansione im-
periale non ha nulla a che fare con l’imperialismo e neppure con l’iniziativa delle forme statuali votate
alla conquista, al saccheggio, al genocidio, alla colonizzazione e alla schiavitù. Contro questo imperia-
lismo, l’Impero estende e consolida il modello della rete dei poteri24.
Se la caratteristica fondante della sovranità imperiale americana era il riferimento a unospazio «sempre aperto», l’esaurimento di quella stessa dimensione spaziale — e cioè lachiusura della prospettiva della frontiera, decisiva nella prima fase della storia degli StatiUniti — avrebbe determinato un passaggio ulteriore, un’estensione della rete della sovra-nità imperiale al di fuori dei confini americani. Ripercorrendo le fasi principali della storiacostituzionale degli Usa, Hardt e Negri individuano così, verso la fine del XIX secolo, incoincidenza con la chiusura dello spazio imperiale, l’emergere di un imperialismo analogoa quello europeo, superato solo dopo la conclusione della guerra del Vietnam e del ciclo diprotesta degli Sessanta. Proprio al principio degli anni Settanta sarebbero così affiorate leprime tracce di quel progetto egemonico all’origine del contemporaneo impero postmoder-no, destinato a trasformare la « frontiera globale» nello « spazio aperto della sovranitàimperiale»25.
Coerentemente con l’impostazione marxiana cui intendono attenersi, Hardt e Negri nonconsiderano soltanto la «costituzione materiale» del nuovo impero postmoderno, ma —seguendo lo stesso percorso con cui Marx abbandonava la «sfera rumorosa del mercato»per entrare «negli antri nascosti della produzione» — puntano a mostrare come la rete delcontrollo biopolitico pianti le proprie radici nelle trasformazioni economiche intervenutenel corso del XX secolo. Anche in questo caso, è il modello di Welfare State emerso dal NewDeal roosveltiano ad essere letto come spia della tendenza verso l’«impero». Definito dallasintesi di taylorismo, fordismo e keynesismo, il New Deal viene descritto nelle pagine diEmpire come la forma più avanzata di «governamentalità disciplinare» e come un assettoin cui « l’intera società, in tutte le sue articolazioni produttive e riproduttive», oltre a essere« sussunta sotto il comando del capitale e dello stato», tendeva a essere governata «esclu-sivamente dalle norme della produzione capitalistica»26. Se, in questo senso, Hardt e Negrinon fanno che riformulare sinteticamente l’immagine della società-fabbrica già delineata
226
fin dalla fine degli anni Sessanta all’interno del paradigma teorico operaista, e in seguitoridefinita dalla scuola francese della regolazione, l’aspetto innovativo della loro discussio-ne è offerto dall’accento sugli effetti che il New Deal avrebbe avuto, nel lungo periodo,sull’assetto del mercato mondiale. La vittoria statunitense nella seconda guerra mondiale,sancendo l’epilogo del vecchio imperialismo europeo, avrebbe riarticolato il mercato mon-diale seguendo proprio le linee guida tracciate dal Welfare State roosveltiano. I tre princi-pali processi al centro di questa transizione — la decolonizzazione, il decentramento dellaproduzione e la diffusione delle forme disciplinari di governo — avrebbero tracciato icontorni di un ordine economico e politico mondiale, che, ben prima della caduta del bloccosovietico, alludendo alla graduale formazione dell’impero, avrebbe assegnato al mercatomondiale un ruolo di vera e propria « pietra angolare». Quello sancito dal New Deal globalesarebbe stato però solo un passaggio ancora parziale all’ordine imperiale, perché l’integra-zione del mercato mondiale garantita dal processo di disciplinamento avrebbe dovuto esse-re approfondita da un processo ben più radicale, che Hardt e Negri illustrano ricorrendoall’immagine marxiana del passaggio dalla «sussunzione formale» a quella «reale»27. Ten-tando di chiarire i termini del passaggio all’impero, Hardt e Negri definiscono infatti ilmutamento nell’organizzazione del mercato mondiale proprio come un salto verso una«sussunzione reale» che non avrebbe comportato soltanto un’intensificazione degli scambidi merci e dei flussi finanziari, ma soprattutto una «vasta trasformazione dei rapporti socialie produttivi», il superamento dell’architettura disciplinare del Welfare State e la ristruttu-razione informatica destinata a sancire la nuova centralità del « lavoro immateriale». Taliprocessi, al cuore del passaggio alla sussunzione reale, avrebbero formato le basi su cui lanuova costruzione imperiale, il « quasi-stato globale del regime disciplinare»28 — con lasua costituzione mista, l’ibridazione delle funzioni controllo e la logica di amministrazione— avrebbe iniziato a prendere corpo in modo compiuto.
Aprendo negli Stati Uniti un dibattito inaspettatamente ampio e vivace, l’affresco dipin-to in Empire non ha mancato di attirare critiche anche piuttosto severe, che, soprattutto nelcampo della teoria radicale, si sono concentrate sui limiti di una prospettiva fortementeeurocentrica e persino sulla valutazione dell’esperienza costituzionale americana, giudicatacome eccessivamente positiva. D’altra parte, la stessa idea secondo cui gli Usa, a dispettodella loro forza militare, non occuperebbero il « centro» dell’impero in via di costituzione,non ha potuto evitare di essere sottoposta a un fuoco di critiche piuttosto fitto, anche perchél’ordito complessivo di Empire — concepito negli anni Novanta, e dunque nel corso deldecennio della Pax Americana — è apparso rapidamente scalzato dagli eventi seguiti alsettembre 2001. Se però molti dei critici hanno messo in luce soprattutto i limiti connessi auna rivisitazione del marxismo eccessivamente disinvolta, è invece probabile che proprio iltentativo di abbandonare la vecchia teoria dell’imperialismo, insieme alle sue molteplicideclinazioni, costituisca il tratto più innovativo del volume e, forse, anche quello in gradodi sopravvivere più a lungo alla sua inattesa fortuna editoriale. Al di là della suggestionedelle immagini, delle forzature polemiche e delle formule altisonanti che hanno reso il testouna sorta di manifesto teorico, l’idea di un nuovo paradigma della sovranità, la metaforadella costituzione ibrida e, soprattutto, l’ipotesi di una nuova relazione tra lo Stato e ilmercato mondiale, hanno offerto infatti uno stimolo importante a una ripresa delle riflessio-ni sulle conseguenze «politiche » della globalizzazione29. A dispetto di questi meriti, al
227
cuore delle tesi di Hardt e Negri esiste però un limite passato sovente inosservato tanto aicritici più severi quanto ai più convinti sostenitori, ma dalle implicazioni talmente rilevantida rischiare di invalidare persino le intuizioni più acute. Si tratta di un limite per alcuniaspetti analogo a quello con cui Wenders rappresentava la « fine del mondo», nel senso cheanche gli autori di Empire finiscono col rappresentare l’esaurimento della conquista delglobo da parte del capitale negli stessi termini catastrofici con cui, in Bis ans Ende der Welt,veniva raffigurata la colonizzazione tecnologica di ogni più remoto angolo della terra. Seb-bene Hardt e Negri, a differenza di Wenders, accolgano con entusiasmo l’annuncio del« collasso» dell’impero, entrambe le prospettive risultano però dominate dall’imminenzadella catastrofe e di un crollo pressoché inevitabile. Non del tutto paradossalmente, infatti,secondo Hardt e Negri, proprio quando l’impero emerge nitidamente dal crepuscolo dellamodernità e dal tramonto degli Stati nazionali, le sue basi iniziano a sprofondare, mostrandouna fragilità inaspettata e la radice di una congenita lacerazione. L’idea di un impero deca-dente e alimentato dalla sua stessa corruzione non è infatti soltanto un espediente retoricoo il velo con cui occultare la compattezza del nuovo ordine globale e delle sue radici produt-tive, ma la base più profonda dell’architettura teorica allestita da Hardt e Negri. A benvedere, infatti, tutte le carte gettate sul tappeto nel corso della loro esposizione — dalla crisidella modernità europea al modello di sovranità della costituzione americana, dalla contrad-dizione tra capitale e sovranità statale alla «dialettica » della sovranità coloniale, dalla crisidell’imperialismo fino alla sussunzione reale e alla realizzazione del mercato mondiale —sono finalizzate proprio a preparare la logica conclusione del declino della forma imperiale.La stessa contraddizione che avrebbe contrapposto le esigenze dell’accumulazione capita-listica ai confini degli Stati nazionali giungerebbe a esplodere con la realizzazione delmercato mondiale, mentre la tendenza costitutiva del capitale a oltrepassare ogni limitespaziale e temporale non potrebbe che scontrarsi contro l’ultimo limite possibile, impostodall’assenza di qualsiasi ulteriore sbocco esterno.
È molto probabile che le prime analisi sull’imperialismo formulate dai teorici marxistiall’inizio del Novecento derivassero gran parte della loro forza dalla capacità di rappresen-tare l’assetto politico ed economico di una specifica stagione storica come l’annuncio dellafine del capitalismo. Prevedendo l’inasprirsi dei conflitti e la fatale comparsa della guerra,quelle ipotesi coglievano certo un elemento importante e indiscutibile di quella stagione edel nuovo ruolo assunto dagli Stati nazionali, ma, ipostatizzando un assetto congiunturalenella teoria dello Zusammenbruch o nell’immagine della « fase senescente del capitali-smo», esse finivano con l’approdare a un versante determinista destinato a indirizzare laricerca su un binario morto. Quando Hardt e Negri si confrontano con la tradizionale teoriadell’imperialismo mettono in luce proprio come gli esponenti di questo filone avesserorinunciato a rivedere le basi delle loro ipotesi, travisando completamente il significato delNew Deal e limitandosi a forzare i dati della realtà per adeguarli allo schema deterministadello « stadio supremo del capitalismo ». A dispetto di questa critica, in gran parte condivi-sibile, Empire soffre di un limite per molti versi analogo, perché nello schema teorico chelo sostiene il «miraggio» della compiuta realizzazione del mercato mondiale svolge lastessa funzione cui adempivano l’idea della completa spartizione del mondo nella teorialeniniana dell’imperialismo, o l’idea della caduta del saggio di profitto nell’ipotesi delloZusammenbruch. Ciò non comporta soltanto la surrettizia reintroduzione dello schema de-
228
terminista criticato sul piano programmatico dai due autori, ma — con conseguenze ben piùrilevanti e radicali — finisce con lo squalificare l’intero complesso della loro costruzioneteorica. Come verrà mostrato nelle prossime pagine, ciò risulta evidente soprattutto nel casodella teoria dello Stato, perché, a dispetto di intuizioni che rinnovano sensibilmente il vec-chio dibattito marxista sul funzionamento delle istituzioni politiche, lo spettro della realiz-zazione del mercato mondiale finisce col rinchiudere in un quadro predeterminato ognianalisi concreta.
3. Lo Stato come « strumento » e come « funzione »
Riflettendo sull’epilogo fallimentare dell’esperimento rivoluzionario bolscevico, nel1993 Otto Kallscheuer tornò a interrogarsi sulla carenza della teoria marxista dello Stato, unnodo problematico che durante gli anni Settanta aveva innescato un fitto e spesso asprodibattito intellettuale. Se nel 1978, replicando insieme a Elmar Altvater ad alcune osserva-zioni di Louis Althusser, aveva di fatto difeso la possibilità di rintracciare nel Capitaleindicazioni metodologiche decisive per comprendere le funzioni dello Stato30, quindicianni dopo Kallscheuer metteva in luce l’esistenza, al cuore della stessa concezione marxia-na, di una contraddizione di fondo. Kallscheuer non negava che dalle pagine di Marx potes-sero essere effettivamente ricavati elementi utili alla comprensione del funzionamento delleistituzioni politiche nelle società capitalistiche, ma riteneva piuttosto che, accanto alla con-cezione dello Stato come « strumento» nelle mani del capitale, convivesse contraddittoria-mente l’idea — presente soprattutto negli scritti giovanili ma mai di fatto abbandonata —secondo cui lo Stato rivoluzionario avrebbe dovuto essere « espressione» della comunitàdei suoi membri. In altre parole, alla concezione realistica dello Stato come « strumento » sisarebbe affiancata l’idea della politica come realizzazione di una comunità potenziale, un’ideache sarebbe rimasta al fondo anche dei lavori marxiani della maturità e al centro, ad esem-pio, della celebrazione della « libera associazione » edificata dai comunardi parigini31.
Se certo la lettura di Kallscheuer proponeva elementi di riflessione particolarmenterilevanti (soprattutto nel quadro di un dibattito sull’eredità di Marx dopo l’Ottantanove), lacontraddizione che segnalava non era certo l’unico nodo problematico, perché in effetti laconcezione marxiana conteneva al proprio interno anche ulteriori ambiguità, nascoste pro-prio al cuore di quella visione dello Stato come «strumento» che Norberto Bobbio hacollocato con forza all’interno delle teorie realistiche della politica32. Per quanto sia pres-soché indiscutibile il fatto che Marx considerasse lo Stato come un « mezzo», con cui leclassi dominanti assicuravano e rafforzavano le basi del loro potere, non è però troppodifficile scorgere all’interno delle sue pagine illustrazioni anche molto diverse delle moda-lità con cui lo Stato avrebbe garantito l’interesse del capitale e delle frazioni sociali domi-nanti. Quando, verso la fine degli anni Sessanta, iniziò a prendere corpo la cosiddetta «ri-scoperta » dello Stato, l’esistenza negli scritti di Marx di raffigurazioni del livello « politi-co» tra loro molto diverse, divenne quasi un luogo comune, oltreché il nodo al centro dicomplesse e non sempre fruttuose indagini filologiche. Persino tralasciando gli scritti «gio-vanili», nei lavori marxiani possono essere infatti rinvenute le tracce di almeno tre imma-gini ben distinte, anche se non necessariamente contraddittorie: la prima incentrata sull’idea
229
dello Stato come semplice e flessibile « strumento » nelle mani della borghesia, la secondacostruita sull’idea della «relativa» autonomia di uno Stato oggetto delle contrapposizioniinterne tra le varie frazioni sociali capitalistiche, e la terza diretta a raffigurare lo Stato comegarante neutrale dell’accumulazione capitalistica. In questo senso, un primo gruppo di scrit-ti può ad esempio sostenere l’immagine del puro «strumento», e cioè l’idea che lo Stato siaun’organizzazione priva di sostanziale autonomia, creata dalla borghesia nel corso della suaascesa, nel passaggio dall’età feudale alla società capitalistica: nell’Ideologia tedesca silegge ad esempio che lo Stato è « la forma di organizzazione che i borghesi si danno pernecessità […] al fine di garantire reciprocamente le loro proprietà e i loro interessi»33,mentre una celebre frase del Manifesto, precisando con maggiore nettezza questo punto,definisce lo Stato come « una giunta amministrativa degli affari comuni di tutta la classeborghese»34. La tesi della «relativa autonomia » dello Stato dalla classe capitalistica, oquantomeno da alcune delle sue frazioni, risulta invece avvalorata da un’altra serie di pas-saggi e, in particolare, dalle analisi svolte da Marx sulla Francia del 1848, in cui la repub-blica viene raffigurata come la « forma politica » sede delle fratture e delle alleanze interneal blocco borghese. In alcune pagine del Terzo libro del Capitale, quando Marx passa aconsiderare l’evoluzione del capitalismo verso le società per azioni, si può infine individua-re anche un salto nella lettura della funzione dello Stato, inteso sempre più come garante nondegli interessi della classe borghese, ma della permanenza del processo di accumulazionedel capitale. Illustrando la tendenza verso il monopolio determinata dalla socializzazionedel capitale, Marx riteneva ad esempio pressoché inevitabile « l’intervento dello Stato»nella gestione dell’economia35, e, proprio richiamandosi a questa ipotesi di fondo, nell’An-ti-Düring Engels delineò con nettezza i tratti della figura dello Stato « capitalista collettivoideale », destinato ad assumere direttamente la direzione della produzione sociale36.
I tre principali filoni che alla fine degli anni Sessanta tentarono di avviare una riflessionemarxista sullo Stato poterono ricorrere — con uguale legittimità teorica — alle differentiimmagini che Marx ed Engels avevano delineato, seppure in modo soltanto frammentario,nei loro scritti37. Riprendendo i risultati della celebre indagine condotta da Charles WrightMills sull’élite statunitense, Ralph Miliband poteva ad esempio declinare l’idea dello Statocome «giunta amministrativa» della classe dominante insistendo sull’estrazione sociale eculturale del personale collocato al vertice delle strutture politiche, burocratiche e militari38,mentre Nicos Poulantzas, richiamandosi soprattutto agli scritti storici di Marx, poteva soste-nere la tesi della « relativa autonomia» del livello politico39. Innescando una contrapposizio-ne piuttosto vivace, Poulantzas rimproverava a Miliband di concepire il legame tra Stato ecapitale solo nei termini di una filiazione « sociologica» delle élite politiche dalle élite eco-nomiche, dimenticando come le classi dirigenti fossero soltanto semplici « amministratrici»dell’accumulazione capitalistica40. Al di là delle divergenze e delle contrapposizioni, tantol’approccio strumentalista di Miliband, quanto quello strutturalista di Poulantzas, tendevanoperò a fornire un’immagine dello Stato in gran parte convergente, che in sostanza giungevaa raffigurare lo Stato proprio nei termini di uno « strumento » nelle mani delle classi domi-nanti. Sia nel caso in cui il livello istituzionale risultasse privo di qualsiasi autonomia, sia nelcaso in cui l’autonomia dalle frazioni sociali dominanti fosse «relativa», il punto comuneconsisteva nella relazione di dipendenza dello Stato dagli strati sociali capitalistici, e nondall’assetto delle relazioni sociali e dalla logica complessiva dell’accumulazione.
230
Muovendosi in una direzione per molti versi differente, il dibattito sulla teoria marxistadello Stato condotto nella Rft partì invece dalla rappresentazione del processo complessivodella riproduzione delineata nelle pagine del Capitale. Per quanto assumesse spesso i con-torni di un dibattito sulla « deduzione» dello Stato, la riflessione giunse a un notevole livellodi elaborazione, sia sotto il profilo teorico, sia dal punto di vista delle interpretazioni delletendenze politiche ed economiche contemporanee. Sul versante della definizione teorica, ilcontributo di Claus Offe fornì ad esempio una griglia concettuale capace di orientare unaserie considerevole di indagini specifiche, dedicate alle strutture educative, alla politicasociale e soprattutto alla «crisi fiscale » dello Stato41. Coniugando l’impostazione marxistaereditata dalla Teoria critica con l’analisi sistemica sviluppata dalla scienza politica norda-mericana, Offe delineò un’immagine secondo cui lo Stato risultava essere proprio una sortadi « funzione », e cioè un insieme di istituzioni la cui attività era volta principalmente agarantire il processo di accumulazione. In questo senso, lo Stato non era più inteso come unmezzo, più o meno autonomo, governato dalla classe dominante, ma risultava essere unattore, del tutto neutrale rispetto alle varie frazioni sociali, il cui scopo era di garantire lapermanenza dello sviluppo economico e la regolarità dell’accumulazione di capitale. Pro-prio polemizzando con l’impostazione «strumentalista », in un contributo steso con VolkerRonge, Offe scrisse perciò che lo Stato, lungi dall’essere « il “ servitore ” o lo “ strumento ”d’una classe contrapposta a un’altra », non era altro che il difensore « degli interessi comunidi tutti i membri di una società di classe capitalistica»42.
Ben più delle contemporanee riflessioni di Miliband e Poulantzas, il principale obiet-tivo polemico del dibattito sulla « deduzione» era costituito dalla vecchia teoria dello Sta-to del capitale monopolistico, avviata dalle ricerche sul capitale finanziario di Rudolf Hi-lferling, «canonizzata» dal saggio di Lenin sull’imperialismo e in seguito ripresa e ride-finita secondo differenti prospettive. Facendo derivare la funzione delle istituzioni politi-che dei paesi capitalistici dai caratteri generali dell’imperialismo individuati da Lenin,anche questa impostazione — non sempre coerente e spesso distorta dalle finalità dellacontrapposizione politica — avvalorava una concezione «strumentalista» dello Stato,perché, certo in modo assai meno raffinato di quanto avveniva nelle riflessioni di Milibande Poulantzas, riteneva che l’azione dello Stato fosse linearmente determinata dagli interes-si del capitale finanziario. Nella sua opera più nota, agli inizi del Novecento, Hilferlingaveva già indicato i termini essenziali di questa lettura, secondo cui la formazione delmonopolio sul mercato interno necessitava di un legame sempre più stretto con lo Stato,sia per garantire una politica doganale protezionista, sia per far valere all’estero i propriinteressi finanziari e conquistare nuove zone di influenza. A proposito della svolta antili-berista compiuta dai paesi europei verso la fine dell’Ottocento, il teorico marxista, adesempio, aveva scritto:
È […] necessario uno stato forte, capace di far valere i suoi interessi finanziari all’estero e di servirsi
della propria potenza per estorcere agli stati meno potenti vantaggiosi trattati di fornitura e favorevoli
transazioni commerciali; uno stato che possa spingersi in ogni parte del globo per fare del mondo intero
una zona di investimento del proprio capitale finanziario; uno stato, infine, sufficientemente forte per
condurre una politica espansionistica e incorporare nuove colonie43.
231
Non diversamente da Hilferling, ma in termini ancora più espliciti, Bucharin nell’Eco-nomia mondiale e il capitalismo aveva sostenuto che ogni sistema economico sviluppato siera già tramutato in «un trust “ nazionale” statale sui generis», spingendosi inoltre a defi-nire gli Stati moderni come l’«espressione precisa degli interessi del capitale finanzia-rio»44. A chiarire con ancora maggiore nettezza questa posizione (e a fornirne la sintesisicuramente più fortunata), fu però il «saggio popolare » di Lenin sull’Imperialismo, nelquale le tesi di Hilferling venivano coniugate con i risultati delle ricerche di John A. Hobsonsulla politica estera delle potenze europee. Apparentemente lineare, il discorso di Leninprocedeva dal riconoscimento della formazione dei monopoli e dell’egemonia del capitalefinanziario su tutti i differenti rami della produzione sociale, per poi giungere alla conclu-sione della inevitabilità delle politiche imperialiste e, soprattutto, dello scontro militare frale potenze occidentali per la spartizione del mondo. Anche in questo caso, lo Stato eraraffigurato come uno strumento, del tutto privo di autonomia, nelle mani dei monopoli e delcapitale finanziario: con l’avvento della fase imperialista, scriveva ad esempio Lenin, « imonopoli capitalistici hanno preso il primo posto nell’economia e nella politica », provo-cando l’acuirsi della « lotta di un piccolo numero di potenze imperialistiche per la parteci-pazione al monopolio»45. Se in Stato e rivoluzione elaborò una riflessione in parte piùarticolata sulle funzioni (oltre che sull’inevitabile «estinzione ») delle istituzioni politiche,nel saggio sull’imperialismo Lenin si soffermava esclusivamente sul ruolo dello Stato comeagente dell’espansione esterna e come « strumento » per estendere il monopolio; in questoquadro, andava a collocarsi anche la celebre immagine dello «Stato rentier», lo « Stato delcapitalismo parassitario in putrefazione»46, sostenuto non soltanto dal capitale finanziario,ma anche dall’« aristocrazia operaia » privilegiata dalle politiche monopolistiche.
Oltre a essere permeate da una serie di palesi contraddizioni logiche, le tesi di Leninfornivano evidentemente un’immagine estremamente stilizzata e quantomeno semplificatanon solo della logica di funzionamento delle istituzioni politiche nelle società capitalistiche,ma anche dei legami tra gruppi economici e potere politico. A dispetto di questi limiti, lateoria dello Stato del capitale monopolistico continuò a detenere una posizione privilegiatanelle riflessioni dei marxisti almeno fino al termine degli anni Sessanta, pur in presenza di uncontesto storico e politico abissalmente differente rispetto a quello in cui l’originaria teoriadell’imperialismo aveva preso le mosse. Spesso associata a una rappresentazione del merca-to internazionale che riproponeva ritualmente le formule dei primi del Novecento, la stilizza-ta immagine dello Stato, «strumento» di espansione militare saldamente collocato nellemani del capitale finanziario, fornì lo sfondo anche a indagini di una certa complessità.Rivisitando la teoria di Lenin e rafforzandone i presupposti « sottoconsumisti», Paul Baran ePaul Sweezy, nella loro celebre indagine sul Capitale monopolistico, individuarono ad esempiol’esistenza di un legame piuttosto lineare tra le «società per azioni gigante », resesi addirittu-ra indipendenti dal capitale finanziario, e le istituzioni di governo, e, pur ammettendo chepotessero maturare «contrasti tra impresa e stato», scrivevano che questi dovevavano essereintesi semplicemente come «riflessi di contrasti all’interno della classe dominante»47.
Per quanto nelle loro tesi «per una metodologia materialistica della politologia» Offe eRonge avessero buon gioco nel denunciare i forti limiti della teoria dello «Stato del capitalemonopolistico» e di tutte le concezioni «strumentaliste », era piuttosto evidente come nellaloro proposta rimanesse una lacuna, solo apparentemente marginale, relativa alla relazione
232
tra lo Stato e la dimensione internazionale. Mentre la connessione con la dottrina leninistadell’imperialismo — pur rivista alla luce della teoria sottoconsumista del «surplus» —consentiva ad esempio a Baran e Sweezy di individuare le funzioni svolte dallo Stato siaall’interno dell’economia statunitense, sia al suo esterno, Offe e Ronge — come d’altrondegran parte degli autori protagonisti del dibattito tedesco — non contemplavano neppure ilproblema. Quello che miravano ad elaborare era infatti un quadro teorico astratto, così comeastratte erano state le leggi di movimento individuate da Marx nel Capitale, e perciò silimitavano a raffigurare lo Stato come una forma istituzionale deputata alla garanzia delprocesso di accumulazione, destinataria da un lato di input dalla società e, dall’altro, eroga-trice di output, che in alcuni casi (per tipologia e quantità) potevano anche finire col porrein crisi la stabilità del sistema. Anche per il fatto di ereditare l’impostazione sistemicaelaborata da Easton, Offe aveva costruito la propria teoria dello Stato assumendo l’ipotesi«astratta» di un sistema economico e politico chiuso, dal quale era di fatto espunto il pro-blema della dimensione esterna. Non diversamente, anche autori tedeschi meno influenzatidall’approccio sistemico delinearono schemi interpretativi centrati sulla dimensione nazio-nale, trascurando non solo il ruolo dello Stato come agente internazionale, ma anche, talvol-ta, la stessa relazione tra il sistema politico-amministrativo e la dimensione mondiale delmercato. Se il nesso con l’arena internazionale rimaneva la lacuna principale del dibattitosulle « funzioni » dello Stato capitalistico, questo stesso problema era invece in gran parteassente per tutte le concezioni « strumentaliste», tanto per quelle che — come nel modellodi Lenin — ipotizzavano un legame diretto tra élite economiche e livello politico, quantoper quelle che riconoscevano alla politica una «relativa autonomia»48.
L’ipotesi « astratta » di un sistema chiuso, o « relativamente autonomo» dall’esterno —ipotesi comune alla gran parte delle teorie marxiste che si discostavano dalle versioni stru-mentaliste e dalla riproposizione rituale dello schema leninista dello Stato del capitale mo-nopolistico — poteva apparire, nella golden age delle economie occidentali, come una«semplificazione » teorica del tutto irrilevante ai fini della validità dell’analisi. Quella stes-sa semplificazione testimoniava però tutte le carenze di una teoria dello Stato che, purincentrandosi sulla relazione tra Stato e dimensione economica, considerava prioritaria-mente — e come unico terreno rilevante — lo «spazio chiuso» della dimensione nazionale.In breve, non solo veniva così del tutto sottovalutata la questione della eventuale gerarchiaesistente tra i diversi Stati, ma, soprattutto, venivano programmaticamente espunti dall’ana-lisi quei fenomeni di internazionalizzazione della produzione e degli scambi che nei decen-ni seguenti avrebbero costituito il presupposto di qualsiasi analisi sulla «crisi» della sovra-nità statale.
Secondo quanto sostengono oggi gli autori di Empire, l’insufficienza della teoria marxi-sta dello Stato non sarebbe stata semplicemente il frutto di una distorsione ideologica o diuna carenza di sforzi intellettuali, ma avrebbe costituito invece l’esito inevitabile di unancora insufficiente sviluppo del modo di produzione capitalistico. Per quanto nel pianooriginario del Capitale avesse previsto un volume sullo Stato, anche lo stesso Marx nonavrebbe mai messo realmente mano a quella sezione del suo lavoro, non tanto per le tormen-tate circostanze della sua riflessione, quanto per la consapevolezza che qualsiasi analisirealistica sul ruolo e le funzioni dello Stato avrebbe potuto essere condotta soltanto dopo larealizzazione del mercato mondiale, e cioè nel momento in cui il capitale avesse effettiva-
233
mente superato tutti i confini nazionali. Al tempo in cui Marx scriveva — secondo Hardt eNegri — « i lineamenti costituzionali di ogni singolo stato-nazione […] erano determinatidai saggi di profitto e dai differenti regimi dello sfruttamento corrispondenti alle diverseeconomie nazionali »: in questo senso, la teoria e la pratica dello Stato nazionale — inquanto «specifica organizzazione del limite» — risultavano strutturalmente in contraddi-zione con la realtà del modo di produzione capitalistico e con la sua tendenza a superarequalsiasi ostacolo alla propria estensione. Questa contraddizione strutturale tra Stato e ca-pitale, secondo gli autori di Empire, può essere risolta solo oggi, grazie alla realizzazionedel mercato mondiale e all’abbattimento di qualsiasi barriera alla valorizzazione, consen-tendo finalmente — come scrivono — il compimento della riflessione marxiana sullo Stato:
Una teoria marxiana dello stato può essere elaborata a condizione che confini e barriere siano superati
nella conclusiva coincidenza tra stato e capitale. In altri termini il declino dello stato-nazione, nel suo
significato più profondo, sancisce la maturazione delle relazioni tra stato e capitale […]. Oggi è forse
finalmente possibile definire (sempre che ve ne sia ancora il bisogno) i lineamenti dei due volumi
perduti di Marx49.
Ponendosi come sviluppo della ricerca marxiana, l’immagine dell’impero elaborata daHardt e Negri si propone così, al tempo stesso, come la soluzione e il superamento dellaquestione dello Stato che Marx non affrontò mai direttamente. Ma soprattutto — continuan-do a rifiutare non solo l’idea di un’autonomia del livello politico, ma anche qualsiasi versio-ne «strumentalista» — intende colmare la lacuna più grave al fondo della riflessione sulloStato come «funzione» dello sviluppo capitalistico, incapace di uscire dalla gabbia teoricadel sistema « chiuso». L’interrogativo principale è però se l’operazione di Hardt e Negririesca realmente e se la soluzione da loro proposta non rischi di riaprire una lacuna altret-tanto insidiosa.
4. La « forma-Stato» e il mercato mondiale
Pur percorrendo binari spesso deviati (e distorti) dalle vicende politiche nazionali, anchein Italia prese corpo negli anni Settanta un filone di indagine, che, rifacendosi in parte allostesso Poulantzas, oltre che ai gramsciani Quaderni del carcere, si mosse sostanzialmentesul versante « strumentalista». Alcuni allievi di Galvano della Volpe, come soprattuttoUmberto Cerroni, avviarono inoltre una ricerca che intendeva porre le basi per una vera epropria « scienza politica marxista», capace di sviluppare quelle intuizioni frammentarieche Marx non aveva approfondito, ma che si potevano ritrovare, oltre che in alcune paginesparse delle opere mature, soprattutto nella giovanile Critica della filosofia hegeliana deldiritto pubblico50. A differenza di quanto avveniva nei lavori di Poulantzas, gran parte delleindagini degli autori italiani si risolse però in una discussione sul metodo di Marx del tutto« preliminare» alle ricerche sul concreto funzionamento dello Stato contemporaneo51, ecosì — almeno se riferita alla riflessione italiana — non risultava affatto pretestuosa l’os-servazione di Norberto Bobbio, secondo cui gran parte dei protagonisti del dibattito mostra-va una marcata tendenza ad abusare del «principio d’autorità», sopperendo con «dotte e
234
sottili esegesi di testi marxiani o marxisti» all’assenza di un vero « studio delle istituzionipolitiche»52.
All’origine di una cruciale discussione intorno all’esistenza di una teoria marxista delloStato, la critica di Bobbio era rivolta solo parzialmente all’aspetto «realistico » della rifles-sione dell’autore del Capitale, e intendeva piuttosto sottolineare l’assenza di una teoria«normativa» della democrazia in un filone di pensiero concentrato esclusivamente sullemodalità e gli strumenti della conquista del potere. Replicando all’accusa di «abuso delprincipio di autorità», Danilo Zolo ricordò a Bobbio che ricerche marxiste sulle istituzionipolitiche contemporanee non erano affatto assenti, ma cominciavano a infittirsi notevol-mente, mentre, con maggiore foga polemica, lo stesso Negri, valendosi anche delle indaginicondotte da marxisti come Agnoli, Altvater, O’Connor e Offe, sostenne che l’unico modocorretto di impostare la questione della teoria marxista dello Stato era di intenderla come«un capitolo del Capitale», e cioè come uno sviluppo della teoria dell’accumulazione de-lineata da Marx nei suoi lavori economici53. La replica non era in effetti pretestuosa, perché,proprio battendo sul tasto della continuità della teoria del valore con le nuove funzioniassunte dallo Stato nel capitalismo avanzato, anche nel quadro del filone «operaista» italia-no aveva preso avvio, già dalla fine degli anni Sessanta, una sorta di «riscoperta» delleistituzioni politiche54.
Seppur accennata (in termini estremamente stilizzati) anche nelle prime riflessioni con-dotte da Raniero Panzieri e Mario Tronti sui «Quaderni rossi» tra il ’61 e il ’64, l’idea di unoStato «pianificatore» — dipinto come lo strumento istituzionale adeguato al livello disviluppo raggiunto dal «neo-capitalismo» — iniziò a essere approfondita con maggioreconvinzione e continuità verso la fine del decennio, grazie a indagini che rintracciavanosoprattutto nel New Deal i tratti specifici dello «Stato-piano», e cioè dell’assetto istituzio-nale in grado di gestire il processo della riproduzione in un quadro di fondo definito dallacombinazione di taylorismo, fordismo e keynesismo. Percorrendo proprio questo sentiero,lo stesso Tronti, che in Operai e capitale aveva riletto la teoria del valore in termini cheassegnavano un ruolo decisivo esclusivamente al conflitto salariale, rivide criticamente lapropria sottovalutazione del livello istituzionale e imboccò un percorso di riscoperta del-l’« autonomia del politico» destinato a protrarsi per due decenni. In un seminario tenuto nel1971 all’Università di Torino, Tronti arrivò infatti a riconoscere che, in alcune fasi di forteconflitto sociale e instabilità, proprio l’«autonomia » del livello politico (inteso come com-binazione di ceto politico e struttura amministrativa) poteva emergere come fattore risolu-tivo: in altre parole, quello scontro tra « operai» e «capitale » che qualche anno prima avevadescritto come irresolubile, poteva essere deciso dalla presenza di un ceto politico compat-to, coeso con il personale burocratico e capace di giocare lo strumento istituzionale a pro-prio favore55. Se fino a quel momento, pur con qualche ambiguità, Tronti aveva sostanzial-mente descritto lo Stato come una « funzione» del capitale, evocando anche l’immagineengelsiana del «capitalista collettivo ideale », ora pareva spostarsi più decisamente versouna concezione «strumentalista», secondo cui lo Stato era uno strumento relativamente«flessibile » — e relativamente autonomo sia dalle forze in conflitto, sia dallo stesso proces-so di accumulazione — nelle mani delle frazioni politiche al potere.
Originando anche un articolato lavoro di ricostruzione storico-teorica di alcune fasicruciali di passaggio politico-istituzionale, quelle provvisorie intuizioni si discostavano,
235
più di quanto potesse apparire, dalla versione strumentalista « moderata» proposta da stu-diosi come Poulantzas. Mentre la «relativa autonomia» dello Stato di cui parlavano i teoricistrutturalisti e neo-gramsciani era principalmente un’autonomia dalle varie frazioni della« classe dominante», quella cui Tronti alludeva era invece, propriamente, un’autonomia dellivello istituzionale dal livello «economico» (o meglio, dalle due sfere della produzionediretta e della valorizzazione in cui esso si articolava). In questo senso, Tronti sosteneva chein alcune fasi di blocco del rapporto dinamico tra produzione e valorizzazione, determinatedall’innalzamento dello scontro sociale, il livello istituzionale potesse far valere un’inizia-tiva in larga parte autonoma, capace di ristabilire, su basi mutate, le condizioni dell’equili-brio56. Incentrata in gran parte sull’esempio del New Deal, questa ipotesi, assai più che conla riflessione neo-gramsciana, presentava diverse analogie con la proposta teorica che, ver-so la fine degli anni Settanta, avrebbe formulato Theda Skocpol. Riprendendo alcune sug-gestioni marxiste, nei suoi studi dedicati all’analisi comparata del processo rivoluzionarioin Francia, Russia e Cina, Skocpol avrebbe infatti riconosciuto i contorni di una sostanzialeautonomia dello Stato, delle sue strutture burocratiche e degli obiettivi di quanti operavanoall’interno dei suoi apparati amministrativi57. Anche per Skocpol, inoltre, il New Dealcostituiva un esempio particolarmente illuminante del ruolo che le istituzioni politichepotevano giocare in una fase di crisi economica e sociale (pur non contrassegnata da muta-menti rivoluzionari), perché la stessa introduzione dei meccanismi del Welfare State roo-sveltiano — che nell’analisi di Hardt e Negri viene interpretata come un frutto del cicloconflittuale successivo al ’17 sovietico — era intesa come esito delle scelte « relativamenteautonome» del livello statale58.
Pur avviando un sentiero di indagine estremamente promettente, i lavori di Skocpol edegli altri esponenti del filone neo-statista si trovarono ben presto a scontrarsi contro unostacolo ben più insidioso delle critiche formulate da Gabriel Almond e da altri difensori delparadigma sistemico della political science59, principalmente perché — come ha notatoacutamente Leo Panitch — l’idea dell’autonomia dello Stato veniva rilanciata nel dibattitoscientifico proprio nel momento in cui la sovranità degli Stati-nazione sembrava dissolversisotto l’implacabile azione del processo di globalizzazione60. A minacciare l’ipotesi dell’au-tonomia dello Stato era infatti soprattutto quel processo di rapida crescita di flussi finanzia-ri, scambi di merci e diffusione delle informazioni, che, a partire dagli anni Ottanta, oltre-passando le frontiere nazionali, pareva destinato a erodere ogni residua traccia di effettiva«sovranità» delle istituzioni politiche. Quella stessa minaccia risultava inoltre ancora piùinsidiosa laddove, invitando a riconsiderare uno dei luoghi comuni più consolidati sulla«sovranità» statale, spingeva a riconoscere come l’idea di spazi realmente chiusi, imperme-abili alla penetrazione di attori economici, politici e sociali, si fosse sempre fondata suassunti sostanzialmente irrealistici61. Non diversamente da quanto era avvenuto nel dibat-tito sulla «derivazione» dello Stato, anche le teorie neo-weberiane, concentrandosi sullarelazione Stato-società ed escludendo quasi completamente dallo spettro problematico del-la loro analisi il nodo della relazione con la dimensione internazionale della produzione edegli scambi, si trovavano perciò del tutto impreparate ad affrontare teoricamente la sfidaproveniente da quella che — con la terminologia di Hardt e Negri — può essere definitacome la realizzazione del «mercato mondiale».
Rileggendo criticamente la storia del Novecento, Tronti ha scritto recentemente che la
236
scoperta teorica dell’«autonomia del politico» coincise di fatto «con la sua inapplicabilitàpratica», perché proprio alla fine degli anni Sessanta avrebbe preso avvio l’affermazioneincontrastata della logica di mercato destinata a dissolvere ogni lontana parvenza di poten-ziale autonomia del livello politico da quello economico62. Più che da quella sorta di « illu-sione ottica » che, secondo Tronti, avrebbe impedito di riconoscere già in quel periodo iltramonto della «grande politica», i limiti dell’ipotesi dell’«autonomia del politico » eranoin realtà connessi proprio all’assunto di un sistema sostanzialmente « chiuso». In questosenso, non era ad esempio casuale che lo stesso Tronti, pur avendo a suo tempo riconosciutocome la «dimensione corretta » per comprendere la crisi economica e politica dell’Italiadegli anni Settanta fosse proprio quella « internazionale», si fosse poi limitato a collocarla«sullo sfondo»63. Anche in questo caso, quella che pareva semplicemente una sorta di«sospensione » argomentativa, un artificio retorico occasionale, faceva trasparire una lacu-na di fondo per molti aspetti analoga al limite che aveva caratterizzato il dibattito tedescosulla «derivazione ». Sorvolando sulla dimensione internazionale (e dunque non solo sul-l’assetto dell’ordine interstatuale, ma anche sui flussi trasnazionali di merci e denaro), erapossibile considerare come una circostanza del tutto normale la stanzialità delle relazioniproduttive e lo stabile radicamento degli investimenti all’interno dei confini dello Stato, nelterritorio nazionale e addirittura nel tessuto di ogni singola città. In altri termini, escluderedalla teoria il problema del nesso tra istituzioni politiche e mercato mondiale significavaipostatizzare le condizioni del tutto peculiari ed eccezionali della golden age postbellica, incui gli elevati livelli di profittabilità, fornendo costanti e stabili attrattive agli investitori,avevano conferito una straordinaria solidità all’equilibrio dinamico del «compromesso for-dista». Con il venir meno di quelle condizioni, l’ipotesi dell’autonomia del politico eradestinata a mostrare tutta la fragilità teorica delle proprie basi, determinando anche la crisidegli schemi con cui erano state raffigurate e spiegate le relazioni non solo tra politica edeconomia, ma, soprattutto, tra produzione e mercato e tra « fabbrica » e «società ».
Senza cogliere l’eccezionalità delle condizioni del boom postbellico, Tronti, negli anniSessanta, aveva in effetti incentrato la propria interpretazione della teoria del valore su unarivisitazione del rapporto tra la « fabbrica » e la « società». Rileggendo con indubbia origi-nalità soprattutto il Primo libro del Capitale, aveva individuato la possibilità dell’insorgeredella crisi non in un elemento oggettivo (come avveniva nella teoria ortodossa con il rife-rimento alla caduta del saggio di profitto), ma nell’interruzione del ciclo di valorizzazionedeterminato dalla concreta conflittualità operaia. Il riemergere, all’interno del processolavorativo, di quel Doppelcharakter della forza lavoro di cui aveva parlato Marx, faceva sìche all’interno della cooperazione produttiva potesse lacerarsi l’unità del processo di valo-rizzazione: in questo caso la «fabbrica», in quanto luogo della produzione, poteva mostrarsicome sede dell’accrescimento del valore d’uso del lavoro collettivamente ricomposto, rom-pendo la logica dello scambio monetario vigente nella sfera della circolazione64. Esponen-do dunque i contorni di una teoria del valore fondata sull’idea di una precedenza logica estorica della « classe operaia» rispetto al «capitale», Tronti poteva anche rileggere, pur inuna chiave parzialmente semplificata, alcune categorie elaborate da Marx nella celebreEinleitung inedita del ’57. E, in particolare, poteva riformulare il nesso tra « produzione-circolazione-scambio-consumo» nei termini della contrapposizione tra « fabbrica» e «so-cietà», stabilendo una sostanziale identità, da un lato, tra la produzione e la « fabbrica», e,
237
dall’altro, tra il complesso di «circolazione-scambio-consumo » e la «società ». Benchéquesta rivisitazione fosse in parte viziata da una lettura parziale della dimensione della« produzione», essa risultava particolarmente efficace nel dar corpo a uno scenario nonprivo di suggestioni, perché era proprio mediante queste categorie che Tronti, nel 1962, siera spinto a prevedere il futuro della terziarizzazione e delle nuove funzioni dello Stato,scrivendo:
Quanto più avanza lo sviluppo capitalistico, cioè quanto più penetra e si estende la produzione del
plusvalore relativo, tanto più necessariamente si conchiude il circolo produzione-distribuzione-scam-
bio-consumo, tanto più, cioè, si fa organico il rapporto tra produzione capitalistica e società borghese,
tra fabbrica e società, tra società e Stato. […] È su questa base che la macchina dello Stato politico tende
sempre più a identificarsi con la figura del capitalista collettivo, sempre più diventa proprietà del modo
capitalistico di produzione e quindi funzione del capitalista65.
Benché fornisse un’immagine dello Stato come «funzione del capitale» per gran parteanaloga a quella sviluppata dal dibattito sulla «derivazione », Tronti considerava la contrap-posizione tra « fabbrica» e « società» — e dunque fra « società» e « Stato» — come di fattoirriducibile. Le due dimensioni della « fabbrica» e della « società » — che pure aveva rite-nuto divenissero sempre più organicamente connesse — erano destinate a non sovrapporsimai integralmente. A escludere questa eventualità era la stessa base del modo di produzionecapitalistico, che richiedeva necessariamente la combinazione dialettica del momento dellaproduzione, da un lato, e della fase di distribuzione-scambio-consumo, dall’altro. In questosenso, dunque, benché la « fabbrica» tendesse a impadronirsi della «società» fino al puntodi dare l’illusione di svanire, Tronti — proprio riferendosi alla diversità di queste duelogiche della sintesi sociale — scriveva che i due momenti, anche quando avessero raggiun-to « un perfetto grado di reciproca integrazione a livello economico», avrebbero comunquecontinuato «politicamente a contrapporsi»66.
In qualche modo, l’idea della irresolubile dicotomia tendeva a tradurre in una aggiornataterminologia marxista l’equilibrio instabile al cuore del «compromesso fordista» postbel-lico. Quando però quell’equilibrio andò in crisi — per effetto di un insieme di circostanzetra loro strettamente connesse, che andavano dalla conflittualità operaia della fine degli anniSessanta alla crisi energetica del ’73, dall’inconvertibilità del dollaro alla combinazione diinflazione e stagnazione economica — anche lo schema delineato da Tronti iniziò a mostra-re la corda. Invece di mettere in questione l’affidabilità teorica della dicotomia fabbrica-società, Tronti intravide proprio nella strada dell’autonomia del politico una soluzione:collocato al confine tra fabbrica e società, tra la sfera produttiva e la sfera di circolazione,scambio e consumo, il livello istituzionale avrebbe dovuto giocare un ruolo di mediazionecapace di rimettere in sesto l’equilibrio perduto. Concentrandosi esclusivamente sul terrenonazionale, quella soluzione non si avvedeva però che l’irresolubile dicotomia stava già, inqualche modo, per essere risolta, non grazie a un intervento di mediazione politica e neppu-re mediante un riavvio della virtuosa dialettica del boom, ma, più semplicemente, grazieall’eliminazione del suo primo polo, o, quantomeno, di quella «eccezionale» stanzialitàdegli investimenti che era sembrata « scontata » negli anni Sessanta. In altre parole, l’incre-mento degli scambi mercantili, la diffusione transnazionale della produzione, l’abbattimen-
238
to dei vincoli doganali, e, soprattutto, la crescita senza precedenti dei mercati finanziari —in una parola, l’insieme dei processi connessi alla «globalizzazione» — procedevano ascalzare le basi stesse su cui si era fondata la forza contrattuale dei lavoratori nella stagionefordista.
Difficoltà analoghe a quelle incontrate dal neo-marxismo trontiano si opposero anchealla ricerca condotta in Francia dalla cosiddetta «scuola della regolazione», frutto di unaarticolata combinazione tra lo strutturalismo di Althusser, il filone neo-gramsciano e alcuneintuizioni della tradizione operaista italiana. Insistendo sugli aspetti organizzativi, autoricome Michel Aglietta, Robert Boyer e Alain Lipietz, a partire dalla fine degli Settanta,ripresero la nozione di « fordismo» utilizzata da Gramsci per fornire coerenza all’idea di unben preciso regime di accumulazione, connesso a uno specifico paradigma tecnologico,caratterizzato da un rapporto equilibrato tra investimenti, incrementi di produttività e livellisalariali. Parte integrante di questo assetto complessivo erano considerati naturalmenteanche consolidati compromessi istituzionali, incaricati del governo coordinato delle politi-che dei redditi, e una sorta di blocco egemonico capace di tenere insieme — come un veroe proprio «paradigma» — le diverse dimensioni della dinamica sociale67. Non troppo diver-samente da quanto avvenne per l’ipotesi dell’«autonomia del politico», anche la teoriaregolazionista del « fordismo» assunse i panni della nottola di Minerva, destinata a spiegarele ali soltanto al crepuscolo, nel senso che anch’essa vide la luce proprio nella fase in cuil’assetto « eccezionale» della golden age postbellica si avviava al suo epilogo, lasciandodietro di sé l’immagine di compatti assetti sociali e istituzionali centrati sulla relazionesalariale e sull’idea di investimenti tendenzialmente stabili nel tempo.
Tentando di dar conto della crisi del fordismo, gli autori della scuola regolazionistahanno elaborato, seppure in modo non univoco, l’ipotesi di un nuovo regime di accumula-zione «post-fordista», i cui contorni sono rimasti però fino ad ora piuttosto sfumati. Propriocriticando l’ipotesi del post-fordismo, una serie di autori prevalentemente di area anglosas-sone, come ad esempio Simon Clarke, John Holloway e Werner Bonefeld, ha ripreso alcuneintuizioni accennate nel corso del dibattito sullo Stato degli anni Settanta per uscire dallacontrapposizione tra la concezione «strumentale » e quella « funzionale » e per confrontarsicon la nuova centralità del mercato mondiale. L’idea di fondo al cuore del discorso di questiautori è che lo Stato non sia da intendere né come uno «strumento» e neppure come unasemplice « funzione », ma piuttosto come una «forma » specifica delle relazioni socialicapitalistiche. Questa lettura costituisce per molti versi lo sviluppo di una ipotesi del giuri-sta sovietico Evgenij Pasukanis, che negli anni Trenta delineò i tratti essenziali di una criticamarxista del diritto. Compiendo un’operazione per alcuni aspetti parallela a quella svolta daLukáks in Storia e coscienza di classe, Pasukanis raffigurò il diritto come un prodotto delladivisione del lavoro e della dissoluzione della comunità medievale realizzate dal capitali-smo; mentre però il filosofo ungherese si soffermava soprattutto sull’aspetto della «reifica-zione» ideologica, il giurista intendeva il diritto non tanto come una mistificazione ideolo-gica, quanto, soprattutto, come una «forma » delle relazioni sociali capitalistiche, e cioècome la forma di un rapporto sociale « astratto» tra individui privi di organici legami socia-li 68. Contestando inoltre l’idea di una identità tra Stato e diritto, il giurista attribuiva al-l’istanza statale proprio il compito di esercitare la garanzia dello scambio tra equivalenti, inun quadro in cui la relazione tra diritto e ordinamento statuale si definiva come risultato di
239
un processo di fatto ininterrotto. Riprendendo questa impostazione, già verso la fine deglianni Settanta, John Holloway e Sol Picciotto potevano sostenere che l’analisi dello Statodovesse mostrare come esso costituisse una peculiare «forma» delle relazioni sociali radi-cate nel modo di produzione69. Come nella proposta di Offe e nel dibattito sulla «derivazio-ne », anche secondo questi autori lo Stato agiva come garante dell’insieme della riproduzio-ne, ma l’accento posto sulla « forma » delle relazioni capitalistiche implicava l’idea che la« crisi » derivasse non da leggi economiche «oggettive», bensì dalla crisi delle relazionimercantili determinata dall’insorgere della conflittualità. In qualche modo, l’esistenza dellavoro «astratto» — e cioè l’esistenza della forza lavoro necessaria al processo produttivo— non era considerata come un dato costante, bensì come un presupposto da ricreare co-stantemente. Inoltre, a differenza di quanto aveva sostenuto Marx nel Capitale, secondoquesti autori l’«accumulazione primitiva» non era un processo concluso, ma una dinamicacostante e interminabile, connessa alla stessa sopravvivenza delle relazioni sociali capita-listiche. Sulla scorta di questa ipotesi, diventava possibile non solo ridiscutere la relazionetra «Stato» e «società», ma anche le versioni «strumentali » e « funzionali» del rapporto tra« Stato » e « capitale ». Soprattutto, però, l’ampliamento dello spettro analitico alla dinamicadell’accumulazione primitiva consentiva a questi studiosi di abbandonare l’ipotesi dellacentralità della relazione salariale che, tra l’altro, aveva costituito la base della teoria del-l’autonomia del politico. Da questo punto di vista, non è perciò affatto casuale che lo stessoHolloway, negli anni Novanta, abbia stigmatizzato le letture della globalizzazione centratesulla « fine» della sovranità degli Stati nazionali. Confrontata con la fluidità del rapporto dicapitale, la «sovranità» e l’autonomia dello Stato, lungi dall’essere la regola, potevanoessere infatti descritte soltanto come casi eccezionali e temporalmente molto limitati70.
Quando in Empire, giungendo allo snodo per loro cruciale della formazione del mercatomondiale, Hardt e Negri sostengono la necessità di considerare l’« accumulazione origina-ria» come un processo ininterrotto, operante anche nella società dell’informazione e del lavoroimmateriale, si richiamano proprio a una lettura simile della relazione tra capitale e Stato71.E, proprio sulla scorta di questa ipotesi, possono relativizzare non solo la specifica «ecce-zionalità» della stagione fordista, ma anche la peculiare relazione tra capitale e Stato nazio-nale che quella fase avrebbe espresso. I caratteri propri della « forma-Stato », dunque, nonverrebbero meno, ma, più semplicemente, sarebbero assunti all’interno della geometria va-riabile della « forma-impero ». Per quanto i due autori non esitino a confermare la scomparsadi qualsiasi forma di autonomia del politico, scrivono infatti che « la fase attuale viene com-pletamente fraintesa se viene caratterizzata nel senso della vittoria dei gruppi capitalisticisullo stato», perché « le funzioni statuali e i dispositivi costituzionali sono stati dislocati sualtri livelli e in altri ambiti »72. In altri termini, la forma istituzionale, come forma specificadelle relazioni sociali diretta a riprodurre costantemente le condizioni del processo di accu-mulazione, verrebbe assunta all’interno della rete del controllo imperiale, il cui carattere«sistemico » discenderebbe proprio dal perseguimento dell’obiettivo dell’accumulazioneoriginaria attraverso strategie non formalizzate, ma puntuali e variabili nel tempo.
La stretta connessione tra mercato mondiale e struttura del governo imperiale non è sottoquesto profilo semplicemente l’inevitabile pegno pagato alla fortuna della «globalizzazio-ne » e alle sue raffigurazioni più o meno positive. L’idea chiave della formazione del mer-cato mondiale — centrale per tutta l’argomentazione di Empire — esprime infatti un richia-
240
mo diretto alla riflessione marxiana. Benché Marx non avesse mai effettivamente postomano neppure al progettato volume sul mercato mondiale, i due teorici dell’« Impero »ritengono che nei manoscritti preparatori al Capitale, stesi tra il ’57 e il ’58, egli fosse giuntoa prefigurare quel salto di paradigma storicamente realizzatosi soltanto alla fine del XXsecolo. Immaginando le successive tappe dello sviluppo capitalistico e la dinamica della«sussunzione reale », grazie al proprio metodo di analisi tendenziale, nei Grundrisse Marxsarebbe riuscito a prefigurare non solo la condizione di abbattimento di ogni ostacolo fisicoe politico all’estensione dell’accumulazione, ma anche i contorni di una teoria dello Statonon oscurata dalla presenza dello Stato-nazione. Il punto cruciale di questa lettura è peròche Marx avrebbe colto proprio la centralità, nel nuovo contesto, del « lavoro astratto» edell’«astrazione » del lavoro: un’astrazione intesa non semplicemente come affermazionedi un sistema di scambio di equivalenti, e neppure soltanto come «oggettivazione » nellamerce di determinate quantità di lavoro, ma, piuttosto, come continua creazione del lavoroastratto come base della produzione, come ininterrotta accumulazione originaria volta aricostituire la forma delle relazioni sociali. Sotto questo profilo, giungendo a prefigurare larealizzazione del mercato mondiale, Marx avrebbe anche proceduto a riformulare la leggedel valore come legge del plusvalore, alla luce di un’ipotesi di fondo secondo cui la realiz-zazione storica del « capitale sociale » avrebbe spostato il fuoco dell’analisi sulla determi-nazione sociale del plusvalore, e cioè sui processi conflittuali di consolidamento del lavorosocialmente necessario73.
Se in questo senso la formazione del mercato mondiale è intesa come un processo inin-terrotto di accumulazione originaria, e dunque come un processo virtualmente interminabi-le, l’idea al cuore del testo di Hardt e Negri, insistendo sull’ipotesi della completa realizza-zione del mercato mondiale, va invece in una direzione opposta. La costitutiva tendenza delcapitale a estendersi abbattendo ogni ostacolo naturale o artificiale verrebbe infatti a cozza-re contro il limite invalicabile dell’esaurimento di ogni ulteriore potenziale espansione,rendendo impraticabile la prosecuzione della dinamica dell’accumulazione. In questo modo,il compimento del mercato mondiale — all’interno di un quadro in cui, a prescindere dalleintenzioni degli autori, si riaffacciano il determinismo, l’oggettivismo e persino l’attesa delfinale Zusammenbruch — tramuta la realizzazione dell’imponente edificio imperiale nellacatastrofe della sua imminente caduta. Non è certo casuale, che, per dare coerenza allospettro del « crollo», i due autori si richiamino in più punti della loro argomentazione allateoria dell’accumulazione di Rosa Luxemburg. In effetti, alcune delle idee chiave al cuoredi Empire — come soprattutto l’idea della tensione immanente al capitale di estendersicercando un « fuori» non capitalistico destinato fatalmente a essere inglobato — mostranouna evidente derivazione dalla riflessione della marxista polacca. Proprio Rosa Luxemburg,infatti, ritenendo che gli schemi di riproduzione del Secondo libro del Capitale si riferisseroa una condizione di equilibrio per gran parte irrealistica, sostenne che l’esistenza di unadimensione esterna non capitalistica fosse essenziale alla perpetuazione del processo diaccumulazione. Nell’analisi luxemburghiana, il capitalismo era d’altronde definito — conuna terminologia per molti aspetti vicina a quella di Empire — come la prima forma econo-mica che, pur recando « in sé la tendenza immanente ad espandersi in tutto il mondo e adespellere tutte le altre forme economiche », non poteva «esistere da sola, senza altre formeeconomiche come suo ambiente e terreno di sviluppo»74. A dispetto delle numerose criti-
241
che, centrate sugli errori logici dell’Accumulazione del capitale75, il punto chiave dell’ar-gomentazione luxemburghiana consisteva proprio nell’idea che, prima o poi, la contraddi-zione strutturale tra l’infinita necessità espansiva del capitale e l’irrimediabile limite fisicodel mondo dovesse giungere all’esplosione. In altri termini, proprio quando il mercatocapitalistico avesse spiegato la propria rete su tutto il globo e fosse venuto meno qualsiasiulteriore sbocco esterno, si sarebbero realizzate le condizioni del «crollo» dell’economiafondata sul valore di scambio. In altri termini, nello stesso momento della costituzione delmercato mondiale — come nella costruzione di Hardt e Negri — sarebbe iniziata la suadissoluzione:
L’accumulazione del capitale avanza e si estende a spese degli strati sociali e dei paesi non-capitalistici,
li erode e li incalza in un ritmo sempre più rapido. Tendenza generale e risultato ultimo di questo
processo è la dominazione mondiale esclusiva della produzione capitalistica. Raggiunta questa, entra
in funzione lo schema di Marx: l’accumulazione, cioè l’ulteriore espansione del capitale, diviene im-
possibile, il capitalismo entra in un vicolo cieco, non può più fungere da veicolo storico dello sviluppo
delle forze produttive, raggiunge il suo limite economico obiettivo76.
Se Rosa Luxemburg evocava la prospettiva tendenziale del crollo finale semplicementeper spiegare la logica dell’espansione imperialista, Hardt e Negri pongono invece quellastessa immagine al centro della loro architettura teorica. Quando infatti sostengono che lacostituzione dell’« impero», resa possibile dal compimento del mercato mondiale, aboliscequalsiasi distinzione tra « dentro» e «fuori», tra « interno » ed « esterno», tra «centro » e« periferia » e tra « Nord » e « Sud », rilanciano proprio lo schema luxemburghiano delloZusammenbruch, in cui la contraddizione fondamentale del modo di produzione capitalisti-co non veniva più collocata nella fondazione contraddittoria del «capitale», ma nella irre-solubile opposizione tra una inestinguibile tensione espansiva e un « fuori» irrimediabil-mente limitato. Mentre Luxemburg intendeva il « fuori » essenzialmente nei termini di mer-cati esterni, sfere geografiche e strati sociali non inseriti nell’economia capitalistica, Hardte Negri intendono naturalmente l’«ambiente esterno » soprattutto nei termini di potenzialeforza-lavoro non ancora inglobata nel circuito dell’accumulazione, ma il senso finale delragionamento non risulta per questo differente. Per quanto i due autori dichiarino di rifarsia un approccio «che rompe i ponti metodologici con tutte le filosofie della storia » e che« rifiuta qualsiasi concezione deterministica dello sviluppo storico e qualsiasi celebrazione“ razionale ” del risultato»77, anche la loro ipotesi del « crollo» dell’impero viene infatti aconfigurarsi in termini sostanzialmente deterministici. E, seppure in un quadro differente daquello delineato dalla « legge » della caduta tendenziale del saggio di profitto, la loro raffi-gurazione dell’impero e della sua logica di governo dello spazio globale si chiude all’inter-no di una contraddizione « strutturale», interamente « oggettiva», che finisce col riprodurreproprio il determinismo del marxismo ortodosso.
Sotto il profilo della riflessione sullo Stato, l’aspetto forse più significativo dell’opera-zione consiste nel fatto che la necessità di fornire coerenza al disegno della «caduta» del-l’impero impone ad Hardt e Negri proprio di rivedere criticamente l’ipotesi della « forma-Stato», recuperando l’immagine — certo assai meno originale — della contrapposizione tra« Stato » e «società», oltre che la vecchia ipotesi della irresolubile contrapposizione tra
242
«fabbrica» e «società» formulata da Tronti negli anni Sessanta. La prospettiva della realiz-zazione del mercato mondiale viene infatti a coincidere — nelle pagine di Empire — con ilcompimento della «sussunzione reale » del lavoro e con la celebre prefigurazione della crisidel modo di produzione fondato sullo scambio avanzata da Marx in alcuni passi conclusividei Grundrisse. Nelle pagine del cosiddetto Frammento sulle macchine, Marx aveva infattidelineato sommariamente i contorni di una teoria del crollo del capitalismo diversa daquella centrata sulla caduta del saggio di profitto esposta nel Capitale: in questo caso, ilcapitale era definito come una «contraddizione in processo», che, per il fatto di tendere a«ridurre il tempo di lavoro a un minimo », ma di continuare a porre proprio « il tempo dilavoro come unica misura e fonte della ricchezza », sarebbe esplosa determinando il « crollodella produzione basata sul valore di scambio »78. Richiamandosi a questa lettura — eidentificando tra loro la sussunzione reale, la realizzazione concreta del capitale sociale e ilcompimento del mercato mondiale — anche Hardt e Negri scrivono che nell’impero ilprodotto del lavoro cooperativo risulterebbe incommensurabile nei termini classici dellalegge del valore79. Ciò che più importa non è però che descrivano questo processo come unesito della trasformazione tecnologica e produttiva centrata sulla figura del « lavoro imma-teriale», ma, piuttosto, che per chiarirne la logica ricorrano alla dicotomia costituita da«fabbrica» e «società ». In un loro saggio precedente, dedicato a un’analisi critica dello«Stato postmoderno», Hardt e Negri sono in effetti tornati a riproporre, più di trent’annidopo, le stesse formule che Tronti aveva enunciato all’inizio degli anni Sessanta a propositodel nesso tra « fabbrica » e « società ». Pur riconoscendo come nell’era postmoderna la fab-brica paia svanire in quanto sede fisica della produzione, hanno affermato che la societàrisulterebbe integralmente «permeata dal regime della fabbrica, e cioè dalle regole specifi-che dei rapporti di produzione capitalistici»80. Inoltre, sarebbe illusoria la stessa impressio-ne secondo cui negli anni Ottanta l’area dello Stato si sarebbe contratta a vantaggio delladimensione della società, perché proprio quest’ultima risulterebbe « realmente sussuntaall’interno dello Stato»:
la società civile non esiste più; lo Stato non ha più bisogno di essa come terreno di mediazione e di
recupero dell’antagonismo sociale o di legittimazione del suo ruolo. Più precisamente, se si può dire
che la società civile esiste, si deve dire che essa esiste solo come proiezione virtuale, strutturata all’in-
terno della circolarità del sistema statuale autopoietico, mentre i referenti sociali reali, antagonistici, ne
vengono esclusi attraverso il metodo dell’elusione. […] Gli spazi lisci delle società di controllo e la
compattezza della sussunzione reale sono passati al di sopra dei canali delle istituzioni di mediazione
che hanno dato un appiglio alla strategia socialista81.
Riprendendo questa idea — e connettendola all’immagine deleuziana della «società delcontrollo» — Hardt e Negri tornano a sostenere la tesi della senescenza della «societàcivile», intesa non solo come momento di mediazione politica, ma anche, secondo l’acce-zione hegeliana, come sfera dello scambio di equivalenti82. L’insistenza su questo puntonon deve essere interpretata come una pura esercitazione intellettuale, perché proprio l’ideadella fine della società come sfera dello scambio e della mediazione, se da un lato costituisceil corollario della tesi della sussunzione reale come presupposto del superamento dellalegge del valore, dall’altro risolve definitamente quella dicotomia tra « fabbrica» e « socie-
243
tà » che Tronti aveva ritenuto irresolubile. In altre parole, la chiusura sempre più stretta trala «produzione » e la fase di « distribuzione-scambio-consumo», mentre trasforma la « so-cietà» intera in « fabbrica», dall’altro consente il superamento della necessità logica delloscambio mercantile. Sotto il profilo dell’immagine dello Stato, questo «meccanismo » teo-rico — del tutto deterministico nelle sue forme, perché lo spettro della « moltitudine» nonrappresenta molto più che l’ombra ambigua e sfuggente di un soggetto collettivo — non puòche condurre a una serie di cortocircuiti di fatto insolubili. Mentre infatti la prospettiva della« forma-Stato» intendeva l’esistenza del lavoro astratto come esito di una interminabile«accumulazione originaria» operante all’esterno del processo della produzione immediata,l’ipotesi della « sussunzione reale» e del compimento del mercato mondiale si fondano suun’immagine in cui il lavoro astratto è inteso come risultato della trasformazione tecnolo-gica interna al processo lavorativo. In questo quadro — come avveniva d’altronde nel Fram-mento — l’astrazione del lavoro e la creazione di una cooperazione lavorativa all’internodel processo produttivo possono entrare « logicamente» in conflitto con il meccanismodello scambio di equivalenti operante sul mercato delle merci. In qualche modo, in unosviluppo estremo della dicotomia di « fabbrica» e «società», i due criteri della sintesi socia-le — il denaro e la cooperazione produttiva — entrano in conflitto, determinando, nel fatalescontro contro la barriera del compimento dell’impero, il crollo del sistema fondato sulvalore di scambio. Dal punto di vista della comprensione della logica operativa delle istitu-zioni politiche, l’azione dell’« impero» viene così fatalmente descritta nei termini di unintervento arbitrario, parassitario e «corrotto», secondo modalità non troppo differenti daquelle con cui Lenin, nella certezza della «senescenza» del capitalismo, definiva lo Statodella fase imperialista come «Stato rentier». Ma ciò che forse è ancor più rilevante, è chealla luce di questa nuova riproposizione della teoria del «crollo», sia le modalità operative,sia le concrete funzioni svolte dai differenti livelli istituzionali (sovranazionali, nazionali esubnazionali) risultano sfumarsi fino all’indistinzione, giungendo a suggerire l’immaginedi un sistema totalitario e persino — come ha notato Giorgio Carnevali — ambiguamente«u-topico»83.
6. Conclusione
Se negli anni Novanta lo «Stato » pareva destinato a un declino tanto lento quantoirreversibile, l’avvento — dopo l’11 settembre 2001 — di quella che è stata efficacementedefinita come la «seconda globalizzazione», sembra aver rovesciato almeno in parte lasituazione84. Per quanto l’area del «mercato» appaia ben lontana dal vedere effettivamentescalfita la propria supremazia, l’irrompere sulla scena internazionale di nuovi attori e disfide in larga parte inedite sembra aver riconsegnato agli Stati — o, quantomeno, ad alcunidi essi — spazi di manovra rilevanti, sia sul terreno economico, sia nell’ambito della poli-tica internazionale. Rovesciando semplicemente la tesi del trionfo dell’economia, molteletture del passaggio in atto tendono però a raffigurare i contorni di un ritorno della «poli-tica» in cui quest’ultima è identificata senza residui con l’intervento delle istituzioni nel-l’area delle relazioni mercantili o con l’uso della forza militare. Il paradosso di entrambequeste letture è però che esse continuano a riprodurre proprio la «moderna » identificazione
244
tra « politico » e «statuale», senza porre realmente in questione né il nesso tra «mercato » e« istituzione », né l’assunto della dipendenza dell’uno dall’altro. In questo senso, se le raf-figurazioni della globalizzazione «economica» tendevano a dipingere un quadro nel qualequalsiasi attore «politico» svaniva gradualmente, l’enfasi sul «ritorno» della politica ri-schia invece di spingere verso l’immagine apocalittica dell’« unità del mondo» prefiguratada Schmitt dopo la seconda guerra mondiale. Nonostante la riflessione sull’« impero » e sulnuovo «paradigma» di esercizio della sovranità allestisca una costruzione teorica estrema-mente complessa, capace di svincolarsi da molti dei rischi impliciti nella tesi di un governoglobale, chiamato a «regolare» il magmatico fluire dei mercati internazionali, essa nonsfugge però interamente alle seduzioni dello scenario apocalittico. Pur presentando in ter-mini positivi la conclusione di una colonizzazione capitalistica e tecnologica capace digiungere « fino alla fine del mondo», la tesi della tendenziale scomparsa di ogni ulteriore«frontiera», oltre che di ogni possibile spazio di espansione, finisce col rinchiudere i line-amenti del nuovo «paradigma» all’interno di uno schema determinista in cui mercato eistituzione (ed «economico » e «politico») vengono di fatto a confondersi senza possibilitàdi distinzione, e nel quale vengono a smarrirsi interamente gli stessi confini tra la funzionedirettamente produttiva e quella della creazione degli incentivi sociali all’investimento.
Più ancora che per le soluzioni proposte, il recente dibattito sulla crisi della modernaspazialità, sullo smarrirsi delle nette distinzioni tra inside e outside, oltre che sulle nuove eancora indefinite architetture istituzionali che in questo contesto prenderebbero forma, èimportante per i problemi che sottopone alla riflessione teorica. Oltre a confermare ancorauna volta l’urgenza di una « teoria politica dello Stato contemporaneo » capace di fare real-mente i conti con l’ingombrante eredità dello Stato moderno85, proprio la consapevolezzadello sgretolarsi della consolidata geometria spaziale mostra l’inadeguatezza di gran partedell’armamentario teorico a nostra disposizione, invitando a indirizzare lo sguardo su queinuovi rompicapo scientifici che iniziano a profilarsi ormai nitidamente. A partire da quelsingolare paradosso, che — alla conclusione della parabola moderna, di fronte alla globa-lizzazione dei mercati, alla deterritorializzazione politica e al definitivo fallimento della«moderna » pretesa di ridurre qualsiasi potenziale conflitto « interno» al rapporto giuridico— sembra riconsegnare allo Stato una funzione originariamente «politica». Una funzione— ormai non più diretta al governo « sovrano» di un’economia « senza confini» o di unconflitto anch’esso irresolubile nell’obsoleta dicotomia inimicus-hostis — che torna a sco-prire le radici più profonde del vincolo politico proprio nella riproduzione puntuale di unrapporto di cittadinanza via via più incomponibile all’interno di qualsiasi stabile frontiera,e nella costante ridefinizione dei «confini dell’eccezione ».
245
Note
1. J. Verne, Il giro del mondo in 80 giorni, Mondadori, Milano 1993, p. 19 (ed. or. Le tour du mondeen quatre-vingt jours, Paris 1873).
2. Cfr. C. Schmitt, L’unità del mondo, in Id., L’unità del mondo e altri saggi, Pellicani, Roma 1994,pp. 303-319, specie p. 315 (ed. or. La Unidad del Mundo, Ateneo, Madrid 1951).
3. S. Strange, Capitalismo d’azzardo, Laterza, Roma - Bari 1988, p. 204 (ed. or. Casino Capitalism,Blackwell, Oxford 1986). Sulla suggestione di questa immagine ha richiamato l’attenzione ancheR. Gherardi, Individuo, opinione pubblica e istituzioni nell’era della globalizzazione. Alla ricercadella «disciplina perduta», in G. Cavallari (a cura di), Comunità, individuo e globalizzazione.Idee politiche e mutamenti dello Stato contemporaneo, Carocci, Roma 2001, pp. 205-231.
4. Cfr. S. Strange, Chi governa l’economia mondiale? Crisi dello stato e dispersione del potere, IlMulino, Bologna 1998 (ed. or. The Retreat of the State. The Diffusion of Power in the WorldEconomy, Cambridge University Press 1996). Su questo nodo, si vedano però L. Ornaghi, L’isti-tuzionalizzazione dei rapporti economici, politici, sociali. Trasformazioni del sistema statale esvolta verso la «deregulation», in Eredità del Novecento, Istituto della Enciclopedia Italiana,Roma 2000, pp. 111-130, e V.E. Parsi, Interesse nazionale e globalizzazione. I regimi democraticinelle trasformazioni del sistema post-westfaliano, Jaca Book, Milano 1998.
5. L. Ornaghi, Il ruolo internazionale dello Stato, in G.J. Ikenberry e V.E. Parsi (a cura di), Manualedi Relazioni Internazionali, Laterza, Roma - Bari 2001, pp. 69-87, specie p. 86.
6. Cfr. C. Galli, Spazi politici. L’età moderna e l’età globale, Il Mulino, Bologna 2001.7. Si vedano su questo punto soprattutto gli anticipatori rilievi contenuti in L. Bonanate, 2001: la
politica interna del mondo, in «Teoria politica», XVII (2001), n. 1, pp. 3-25.8. Cfr. S. Strange, The Future of the American Empire, in «Journal of International Affairs», XLII
(1988), n. 1, pp. 1-7. Sul dibattito più recente, si vedano invece T. Barkawi-M. Laffey, The Impe-rial Peace: Democracy, Force and Globalization, in «European Journal of International Rela-tions», V (1999), n. 4, pp. 403-434, M. Cox, T. Dunne e K. Booth, dedicato a Empires, Systemsand States: Great Transformations in International Politics, in «Review of International Stu-dies », XXVII (2001), special issue, pp. 1-15, G.J. Ikenberry, American Power and the Empire ofcapitalist democracy, in «Review of International Studies», XXVII (2001), special issue, pp. 191-212, V.E. Parsi, L’impero come fato? Gli Stati Uniti e l’ordine globale, in « Filosofia politica»,XVI (2002), n. 1, pp. 83-113.
9. In questa ormai vasta letteratura possono essere segnalati testi come A. Asor Rosa, La guerra.Sulle forme attuali della convivenza umana, Einaudi, Torino 2002, C. Johnson, Gli ultimi giornidell’impero americano, Garzanti, Milano 2001 (ed. or. Blowback. The Cost and Consequences ofAmerican Empire, 2000). Su questo dibattito, cfr. E. Diodato, Impero e globalizzazione, in D. dellaPorta e L. Mosca (a cura di), Globalizzazione e movimenti sociali, Manifestolibri, Roma 2003, pp.197-209.
10. M. Hardt e A. Negri, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Rizzoli, Milano 2002 (ed. or.Empire, Harvard University Press, Cambridge - Mass. 2000).
11. Secondo i dati riportati da Ida Dominijanni nel 2002, il libro, tradotto anche in spagnolo, tedesco,francese, cinese, turco e arabo, avrebbe venduto complessivamente mezzo milione di copie: cfr.Il backlash imperialista sull’Impero, in «il Manifesto», 14 settembre 2002, p. 14. Tra gli interventinel dibattito possono essere tra l’altro segnalati, senza alcuna pretesa di completezza, G. Ba-lakrishnan, Virgilian Visions, in «New Left Review», 2000, n. 5, pp. 142-148, T. Barkawi e M.Laffey, Retrieving the Imperial: Empire and Internazional Relations, in «Millennium», XXXI(2002), n. 1, pp. 109-127, J. Bellamy Foster, Imperialism and «Empire», in «Monthly Review»,vol. LIII, n. 7, M. Bull, You Can’t Build a New Society with a Stanley Knife, in «London Reviewof Books», XXIII (2001), n. 19, 4 ottobre, A. Callinicos, The Actuality of Imperialism, in «Millen-nium», XXXI (2002), n. 2, pp. 319-326, E. Eakin, What is the Next Big Idea? Buzz is Growing for«Empire», in «New York Times», 7 luglio 2001, L. Panitch e S. Gindin, Gems and Baubles inEmpire, in «Historical Materialism», 2002, M. Shaw, Post-Imperial and Quasi-Imperial: Stateand Empire in the Global Era, in «Millennium», XXXI (2002), n. 2, pp. 327-336, R.B. Walker, Onthe Immanence/Imminence of Empire, in «Millennium», XXXI (2002), n. 2, pp. 337-345, e icontributi raccolti nei numeri monografici dedicati al volume dalle riviste «Rethinking Marxism»,
246
2001, nn. 3-4, e «Cultural Studies», XVI (2002), n. 2. Tra gli interventi italiani possono inveceessere segnalati, oltre alle note di R. Ciccarelli, Democrazia e Impero secondo Antonio Negri, in«Democrazia e Diritto», XL (2001), n. 2, pp. 41-60, e R. Gasparotti, L’impero e le sue alternative.Note e riflessioni in margine ai recenti libri di Hardt-Negri e Bolaffi Marramao, in «Filosofiapolitica», XVI (2002), n. 1, pp. 145-154, anche il confronto tra Negri e Danilo Zolo, Dialogo suImpero, in «Reset », 2002, n. 73, pp. 8-19 (ora riprodotto in A. Negri, Guide. Cinque lezioni suImpero e dintorni, Raffaello Cortina, Milano 2003, pp. 11-33), e quello tra Negri, Roberto Espo-sito e Salvatore Veca, Dialogo su impero e democrazia, in «Micromega», 2001, n. 5, pp. 115-134.
12. I. Wallerstein, Il sistema mondiale dell’economia moderna. I. L’agricoltura capitalistica e leorigini dell’economia-mondo europea nel XVI secolo, Il Mulino, Bologna 19782, p. 31 (ed. or. TheModern World-System. I. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economyin the Sixteenth Century, Academic Press Inc., New York 1974).
13. Cfr. F. Braudel, Capitalismo e civiltà materiale (secoli XV-XVIII), Einaudi, Torino 1977.14. Wallerstein riprendeva la definizione della sintesi imperiale fornita da S.N. Eisenstadt, Empire, in
International Encyclopedia of the Social Sciences, MacMillan - Free Press, New York 1968, V, eId., The political system of empires, The Free Press, New York 1963. Per una ricostruzione storicae concettuale, si vedano anche: S. Breuer, Imperi, in «Enciclopedia delle Scienze Sociali», Istitutodella Enciclopedia Italiana, Roma 1994, IV, pp. 529-538; K. Breysig, Empire, in E.R.A. Seligman(a cura di), Encyclopedia of Social Sciences, MacMillan, London 1935, V, pp. 497-506; M. Car-tier, Imperi, in Enciclopedia Einaudi, Einaudi, Torino 1979, VII, pp. 145-156; P. Colliva, Impero,in G. Pasquino, N. Bobbio e N. Matteucci (a cura di), Dizionario di politica, 19832 (I ed. 1976),pp. 540-544; G. Miglio, La sovranità limitata (1985), in Id., Le regolarità della politica. Scrittiscelti raccolti e pubblicati dagli allievi, Giuffrè, Milano 1988, II, pp. 1007-1074; V.E. Parsi,Impero, in R. Esposito e C. Galli (a cura di), Enciclopedia del pensiero politico. Autori, concetti,dottrine, Laterza, Roma - Bari 2000, pp. 333-335, e C. Schmitt, Il concetto d’Impero nel dirittointernazionale. Ordinamento dei grandi spazi con esclusione delle potenze estranee, IstitutoNazionale di Cultura Fascista, Roma 1941 (ed. or. Völkrrechtliche Grossraumordnung mit Inter-vetionsverbot für raumfremde Mächte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkrrecht, DeutscherRechtsverlag, Berlin - Leipzig - Wien 1941).
15. Cfr. per questa critica (concentrata soprattutto su G. Arrighi, Il lungo XX secolo. Denaro, poteree le origini del nostro tempo, Il Saggiatore, Milano 1996), M. Hardt e A. Negri, Impero, cit., pp.225-227. Si veda però anche la replica dello stesso Arrighi, Genesi di un impero, in « Il Ponte »,LVIII (2002), nn. 8-9, pp. 104-115.
16. Cfr. M. Hardt e A. Negri, Impero, cit., p. 26.17. Ibidem, p. 31 e p. 39. Sull’idea della «società di controllo», si veda G. Deleuze, Foucault, Feltri-
nelli, Milano 1987 (ed. or. Foucault, Paris 1986), e Id., Postscriptum: sulle società di controllo,in Id., Pourparlers, Quodlibet, Macerata 2000. Per la lettura di Deleuze, cfr. M. Hardt, GillesDeleuze. Un apprendistato in filosofia, A-Change, Milano 2000 (ed. or. Gilles Deleuze. An Ap-prenticeship in Philosophy, University of Minnesota Press, Minneapolis 1993).
18. M. Hardt, A. Negri, Impero, cit., p. 290. Per l’immagine della piramide e della sua strutturazione,cfr. ibidem, pp. 289-294.
19. Ibidem, p. 296.20. Ibidem, p. 298. Su questa immagine del nuovo paradigma della « sovranità», si vedano anche le
precisazioni di M. Hardt e A. Negri, Sovranità, in A. Negri, Guide, cit., pp. 55-66.21. Su questo immaginario, cfr. F. Denunzio e G. Frezza, Gli imperi della fantascienza fra narrativa,
cinema e tv, in «Filosofia politica », XVI (2002), n. 1, pp. 115-126.22. M. Hardt e A Negri, Impero, cit., p. 181.23. Mentre — scrive Cacciari — «solo il patto che nasce dallo sforzo, dal desiderio, dalla passione
anche, di individualità universali, può fondare un’idea di impero come imperium populi», un«foedus tra soggetti già ridotti a uno, precedentemente omologati, non sarebbe tale, ma soltantol’imposizione ai vinti delle norme del vincitore ». Cfr. M. Cacciari, Digressione su impero e treRome, in H. Friese, A. Negri e P. Wagner (a cura di), Europa politica. Ragioni di una necessità,Manifestolibri, Roma 2002, pp. 21-42, specie p. 32.
24. M. Hardt e A. Negri, Impero, cit., p. 160. Su questa lettura della modernità europea come laceratada una crisi congenita e sul ruolo del «potere costituente», sono da vedere però le argomentazioni,certo più articolate, contenute in A. Negri, Problemi di storia dello Stato moderno. Francia: 1610-1650, in «Rivista critica di storia della filosofia», n. 2, pp. 182-220, Id., Descartes politico o della
247
ragionevole ideologia, Feltrinelli, Milano 1970, Id., L’anomalia selvaggia. Saggio su potere epotenza in B. Spinoza, Feltrinelli, Milano 1981, Id., Il potere costituente. Saggio sulle alternativedel moderno, Manifestolibri, Roma 20022 (I ed. SugarCo, Milano 1994).
25. M. Hardt e A. Negri, Impero, cit., p. 174.26. Ibidem, p. 230.27. Per la distinzione tra «sussunzione formale» e «sussunzione reale», cfr. K. Marx, Il Capitale. Per
la critica dell’economia politica, Editori Riuniti, Roma 1989, I, pp. 371-372 (ed. or. Das Kapital.Kritik der politischen Oekonomie. I, 1867), e Id., Il Capitale: Libro I. Capitolo VI inedito. Risultatidel processo di produzione immediato, La Nuova Italia, 1970, pp. 53-63.
28. M. Hardt e A. Negri, Impero, cit., p. 241.29. Molte delle sollecitazioni a riconsiderare il ruolo dello Stato sono giunte peraltro, negli ultimi
anni, proprio da riflessioni critiche e radicali: cfr. sul punto J.H. Hobson, The « second statedebate» in International Relations Theory: theory turned upside-down, in «Review of Internatio-nal Studies», XXVII (2001), pp. 395-414. Sul dibattito più recente, si vedano anche le indicazionidi P.P. Portinaro, Il futuro dello Stato nell’età globale. Un bilancio di fine secolo, in « Teoriapolitica», XIII (1997), n. 3, pp. 17-36, e M. Ricciardi, Politica e scienze della società globale.Istituzioni, individui e rischio del sociale, in R. Gherardi (a cura di), Politica, consenso e legitti-mazione. Trasformazioni e prospettive, Carocci, Roma 2002, pp. 67-82.
30. Cfr. E. Altvater e O. Kallscheuer, Stato e riproduzione complessiva dei rapporti di dominio capi-talistici, in L. Althusser et al., Discutere lo Stato. Posizioni a confronto su una tesi di LouisAlthusser, De Donato, Bari 1978, pp. 205-219.
31. Si veda O. Kallscheuer, Lo Stato come espressione e come strumento. La contraddizione dell’in-terpretazione marxista dello Stato e della democrazia, in «Teoria politica», IX (1993), n. 2, pp.15-35.
32. Cfr. N. Bobbio, Marx, lo stato e i classici (1983), in Id., Teoria generale della politica, a cura diM. Bovero, Einaudi, Torino 1999, pp. 53-70.
33. K. Marx, F. Engels, L’ideologia tedesca, Rinascita, Roma, 1958, p. 60.34. K. Marx, F. Engels, Manifesto del Partito Comunista, Mursia, Milano 1973, p. 25.35. K. Marx, Il Capitale. Critica dell’economia politica, cit., III, p. 520.36. F. Engels, Anti-Düring, Editori Riuniti, Roma 1985, p. 268.37. Per una ricostruzione essenziale del dibattito degli anni Sessanta e Settanta e dei principali filoni
di teorici, cfr. AA.VV., Il capitale e lo stato. Crisi della «gestione della crisi », Bertani, Verona1979, L. Basso (a cura di), Stato e crisi delle istituzioni, Mazzotta, Milano 1978, G. Carandini (acura di), Stato e teorie marxiste, Mazzotta, Milano 1977, M. Carnoy, The State and PoliticalTheory, Princeton University Press, Princeton (NJ) 1984, G. Gozzi (a cura di), Le trasformazionidello Stato. Tendenze del dibattito in Germania e in Usa, La Nuova Italia, Firenze 1980, B. Jessop,The Capitalist State: Marxist Theory and Methods, Martin Robertson, Oxford 1982, G. Marra-mao, Politica e complessità: lo Stato tardo-capitalistico come categoria e come problema storico,in AA.VV., Storia del marxismo, Einaudi, Torino 1982, IV, pp. 513-591, R. Miliband, Marxismand Politics, Oxford University Press, Oxford - New York 1977 e A. Martinelli (a cura di), Statoe accumulazione del capitale, Mazzotta, Milano 1977.
38. R. Miliband, Lo stato nella società capitalistica, Laterza, Bari 1970 (ed. or. The State in CapitalistSociety, Weidenfeld and Nicholson, London 1969).
39. N. Poulantzas, Potere politico e classi sociali, Editori Riuniti, Roma 1971 (ed. or. Pouvoir poli-tique et classes sociales de l’état capitaliste, Paris 1968).
40. Per il dibattito, cfr. N. Poulantzas, The problem of the Capitalist State, in «New Left Review »,1969, n. 58, pp. 67-78, e R. Miliband, The Capitalist State: Reply to Nicosa Poulantzas, in «NewLeft Review », n. 59, 1969, pp. 53-60.
41. Per quanto riguarda la ricerca di Offe, cfr. Strukturprobleme des kapitalistischen Staates, Suhrkamp,Frankfurt a.M 1973, Id., Berufsbildungsreform. Eine Fallstudie über die Reformpolitik, Suhrkamp,Frankfurt a.M., i saggi raccolti Id., Lo stato nel capitalismo maturo, Etas, Milano 1977, Id.,Ingovernabilità e mutamento nelle democrazie, Il Mulino, Bologna 1982, Id., Contradictions ofthe Welfare States, Hutchinson, London 1984, e Id., Disorganized Capitalism, Polity Press, Cam-bridge, 1985. Per il dibattito condotto all’interno di questa prospettiva, si vedano invece C. v.Braunmühl et al., Probleme einer materialistischen Staatstheorie, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1973,R. Ebbinghausen (a cura di), Bürgerliche Staat und politische Legitimation, Suhrkamp, Frankfurta.M., 1976, J. Habermas, La crisi della razionalità nel capitalismo maturo, Laterza, Roma - Bari
248
1975 (ed. or. Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1973), J.Hirsch, Staatsapparat und Reproduktion des Kapitals, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1974, e J. O’Con-nor, La crisi fiscale dello stato, Einaudi, Torino 1977 (ed. or. The Fiscal Crisis of the State, St.Martin’s Press 1973).
42. K. Offe, V. Ronge, Tesi per una fondazione teorica della nozione di «Stato capitalistico» e peruna metodologia materialistica della politologia, in L. Basso (a cura di), Stato e crisi delle istitu-zioni, Mazzotta, Milano 1978, pp. 35-51, specie p. 36.
43. R. Hilferling, Il capitale finanziario, Feltrinelli, Milano 1961 , p. 441 (ed. or. Das Finanzkapital,Verlag der Wiener Volksbuchandlung Ignaz Brand Co, Wien 1910).
44. N. Bucharin, L’economia mondiale e l’imperialismo, Samonà e Savelli, Roma 1966, p. 236 (ed. or.Mirovoie Choziajstvo i Imperializm, Moskva 1915).
45. V.I. Lenin, L’imperialismo fase suprema del capitalismo, Editori Riuniti, Roma 1970, pp. 148-149 (ed. or. Imperializm, kak vyssaja stadija kapitalizma, 1916).
46. Ibidem, p. 142.47. P.A. Baran, P.M. Sweezy, Il capitale monopolistico. Saggio sulla struttura economica e sociale
americana, Einaudi, Torino 1968, p. 58 (ed. or. Monopoly Capital. An Essay on the AmericanEconomic and Social Order, Monthly Review Press, New York 1966).
48. Lo stesso Poulantzas, ad esempio, non aveva sostanziali difficoltà a confrontarsi, già all’iniziodegli anni Settanta con il nodo dell’internazionalizzazione dell’economia, limitandosi a rivisitarela tradizionale teoria dell’imperialismo: cfr. N. Poulantzas, L’internazionalizzazione dei rapporticapitalistici e lo stato nazionale, in L. Ferrari Bravo (a cura di), Imperialismo e classe operaiamultinazionale, Feltrinelli, Milano 1975, pp. 283-317 (ed. or. L’internationalisations des rappor-ts capitalistes et l’Etat-nation, in « Les Temps Modernes », 1973, n. 319, pp. 1456-1500).
49. M. Hardt, A. Negri, Impero, cit., p. 224.50. Cfr. ad esempio U. Cerroni, Esiste una scienza politica marxista?, in Id., Crisi ideale e transizione
al socialismo, Editori Riuniti, Roma 1977, pp. 89-114.51. Cfr., su questi limiti, L. Ornaghi, Stato e società nella teoria marxista contemporanea (a proposito
della riflessione di Umberto Cerroni), in « Il Politico», XLII (1977), n. 2, pp. 353-366, specie pp.359-361.
52. N. Bobbio, Esiste una dottrina marxistica dello Stato? (1973), in Id., Quale socialismo? Discus-sione di un’alternativa, Einaudi, Torino 19775 (I ed. 1976), pp. 21-41, specie p. 26.
53. Cfr. D. Zolo, Stato socialista e libertà borghesi, Laterza, Bari 1976, e A. Negri, Esiste una dottrinamarxista dello Stato? (1976), in Id., La forma stato. Per la critica dell’economia politica dellaCostituzione, Feltrinelli, Milano 1977, pp. 273-287. Una risposta ad entrambi era contenuta nellaPrefazione a N. Bobbio, Quale socialismo?, cit., pp. VII-XVIII.
54. Cfr. C. Donolo, Il ’68 e la ripresa della riflessione marxista sullo Stato, in F. Cavazzutti et al.,Accumulazione, società civile, Stato, Arsenale, Venezia 1980, pp. 19-31.
55. Cfr. M. Tronti, Sull’autonomia del politico, Feltrinelli, Milano 1977.56. Cfr. in particolare M. Tronti (a cura di), Stato e rivoluzione in Inghilterra, Il Saggiatore, Milano
1977, Id., Soggetti, crisi, potere. Antologia di scritti e interventi, Cappelli, Bologna 1980, e Id., Iltempo della politica, Editori Riuniti, Roma 1980.
57. Cfr. T. Skocpol, Stati e rivoluzioni sociali, Il Mulino, Bologna 1981 (ed. or. States and SocialRevolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China, Cambridge University Press,Cambridge 1979).
58. La lettura di Skocpol, in questo caso, ha alimentato un dibattito piuttosto articolato: cfr., ad esem-pio, T. Skocpol, Political response to Capitaliste Crisis: Neo-Marxist Theories of the State and theCase of the New Deal, in «Politics and Society», X (1988), n. 2, T. Skocpol e K. Fingold, Explai-ning New Deal Labor Policy, in «American Political Science Review», vol. 84, 1989, n. 4, pp.1297-1315, ma anche M. Goldfield, Worker Insurgency, Radical Organization, and New Deal LaborLegislation, in «American Political Science Review», vol. 83, 1989, n. 4, pp. 1257-1282.
59. Cfr. il noto articolo di G. Almond, The Return to the State, in «American Political Science Re-view », vol. 82, 1988, n. 3, pp. 853-874, oltre che, nello stesso fascicolo, le osservazioni di E.A.Nordlinger, T.J. Lowi e S. Fabbrini, The Return to the State: Critiques, pp. 875-901.
60. L. Panitch, Rethinking the Role of the State, in J.H. Mittelman (a cura di), Globalization: CriticalReflections, Lynne Rienner, Boulder - London 1996, pp. 83-113.
61. Per questa tesi, cfr. L. Bonanate, Una giornata del mondo. Le contraddizioni della teoria demo-cratica, Bruno Mondadori, Milano 1996, in particolare pp. 74-99.
249
62. M. Tronti, La politica al tramonto, Einaudi, Torino 1998, p. 71.63. M. Tronti, Operaismo e centralità operaia, in F. D’Agostini (a cura di), Operaismo e centralità
operaia, Editori Riuniti, Roma 1978, pp. 15-25, in particolare p. 15.64. Cfr. M. Tronti, Operai e capitale, Einaudi, Torino 19711 (I ed. 1966). Per una rilettura di questa
operazione, cfr. P.F. Bell e H. Cleaver, Marx’s Crisis Theory as a Theory of Class Struggle, in«Review in Policial Economy», 1982, n. 5, pp. 189-261, e S. Wright, Storming Heaven. Classcomposition and struggle in Italian Autonomist Marxism, Pluto Press, London - Sterling (Virgi-nia) 2002.
65. M. Tronti, La fabbrica e la società (1962), in Id., Operai e capitale, cit., pp. 51-52.66. M. Tronti, Operai e capitale, cit., p. 235.67. Cfr., ad esempio, M. Aglietta, Régulation et crise du capitalisme, Calmann-Levy, Paris 1978, Id.,
Les metamorphoses de la société salariale, Calmann-Levy, Paris 1984, R. Boyer, La theorie de larégulation: une analyse critique, La Découverte, Paris 1986, e R. Boyer e J. Mistral, Accumula-zione, inflazione, crisi, Il Mulino, Bologna 1985. Per sintesi, diversamente orientate, si vedano M.de Vroey, A regulation approach interpretation of contemporary crisis, in «Capital & Class»,1984, n. 27, pp. 45-66, S. Clarke, Overaccumulation, class struggle and the regulation approach,in «Capital & Class », 1988, n. 36, e F. Gambino, Critica del fordismo regolazionista, in E. Parise,Stato nazionale, lavoro e moneta nel sistema mondiale integrato. Ipotesi di nuovi profili costitu-zionali, Liguori, Napoli 1997, pp. 215-240. Per quanto al centro delle riflessioni di Gramsci suAmericanismo e fordismo (1934), in Id. Quaderni del carcere, Einaudi, Torino 1975, III, pp. 2137-2181, la nozione di « fordismo » venne delineata negli anni Venti da autori tedeschi: cfr. sul puntoS. Mezzadra, La costituzione del lavoro. Hugo Sinzheimer e il progetto weimeriano di democraziaeconomica, in «Quaderni di azione sociale», 1994, n. 2, pp. 57-71.
68. Cfr. E.B. Pasukanis, La teoria generale del diritto e il marxismo, De Donato, Bari 1975 (ed. or.Obscaja teorija prava i marksizm, Moskva, 19273).
69. J. Holloway e S. Picciotto, Capital, Crisis and the State, in «Capital & Class», 1977, n. 2, pp. 76-101. Cfr. anche, a cura degli stessi autori, State and Capital: A Marxist Debate, Edward Arnold,London 1978.
70. J. Holloway, Global Capital and the National State, in «Capital & Class», 1994, n. 52, pp. 23-49.Sul dibattito condotto nell’ambito di questo filone, cfr. però anche W. Bonefeld e J. Holloway (acura di), Post-fordism and Social Form. A Marxist Debate on the Post-Fordist State, MacMillan,London 1991, S. Clarke (a cura di), The State Debate, MacMillan, London 1991, i tre volumi,curati da Bonefeld, R. Gunn, J. Holloway e K. Psychopedis, Open Marxism, Pluto, London 1992-1995, W. Bonefeld e J. Holloway (a cura di), Global Capital, National State and the Politics ofMoney, MacMillan, London 1996, e W. Bonefeld e K. Psychopedis (a cura di), The Politics ofChange. Globalization, Ideology and Critique, Palgrave, London - New York 2000.
71. Cfr. M. Hardt e A. Negri, Impero, cit., in particolare pp. 242-244 e 281-284.72. Ibidem, pp. 287-288.73. Questa lettura si richiama in parte alla ricostruzione del concetto di «capitale sociale» condotta,
sulle pagine di Marx, da Roman Rosdolsky, Genesi e struttura del «Capitale» di Marx, Laterza,Bari 1971 (ed. or. Zur Entstehungsgeschichte des Marxshen « Kapital », Europäische Verlagsan-stalt - Europa Verlag, Frankfurt - Wien 1955), ma è stata sviluppata organicamente in A. Negri,Marx oltre Marx. Quaderno di lavoro sui Grundrisse, Feltrinelli, Milano 1979. Per i passi relativia questa interpretazione, cfr. in particolare K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica del-l’economia politica. 1857-1858, La Nuova Italia, 1978, II, ad esempio, pp. 95-148, e 241-258.
74. R. Luxemburg, L’accumulazione del capitale. Contributo alla spiegazione economica dell’impe-rialismo, Einaudi, Torino 1960, p. 460 (ed. or. Die Akkumulation des Kapitals, BuchhandlungVorwärts, Berlin 1913).
75. Le critiche mettevano in luce come gran parte del ragionamento di Luxemburg fosse viziato da unerrore logico che escludeva impropriamente che l’espansione della produzione potesse essererealizzata all’interno dello stesso mercato capitalistico grazie a un aumento dei redditi di lavora-tori e capitalisti. Si veda ad esempio il noto testo di N.I. Bucharin, L’imperialismo e l’accumula-zione del capitale, Laterza, Bari 1972 (ed. or. Der Imperialismus und die Akkumulation des Kapi-tals, Wien - Berlin 1926), ma, per una sintetica esposizione del dibattito, P.M. Sweezy, Introdu-zione a R. Luxemburg, L’accumulazione del capitale, cit., pp. IX-XXXII.
76. R. Luxemburg, Ciò che gli epigoni hanno fatto della teoria marxista. Una anticritica, in Id.,L’accumulazione del capitale, cit., p. 574.
250
77. M. Hardt e A. Negri, Impero, cit., p. 60.78. K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, cit., II, pp. 401-402.79. Cfr. M. Hardt e A. Negri, Impero, cit. pp. 330-336.80. M. Hardt e A. Negri, Il lavoro di Dioniso. Per la critica dello Stato postmoderno, Manifestolibri,
Roma 1995, p. 16 (ed. or. integrale Labor of Dionysus. A critique of the State-form, University ofMinnesota Press, Minneapolis - London 1994).
81. Ibidem, p. 79. Su questo stesso nodo, cfr. anche M. Hardt, The Withering of Civil Society, in«Social Text», 1995, n. 45, pp. 27-44.
82. Cfr. M. Hardt e A. Negri, Impero, cit., pp. 303-308.83. G. Carnevali, Dell’impero imperfetto (Voci per un dizionario minimo del dopo 11 settembre), in
«Teoria politica », XVIII (2002), n. 3, pp. 73-84, specie p. 80.84. Cfr. M. Revelli, La seconda globalizzazione, in «Carta », IV (2002), n. 5, pp. 36-67, ma anche Id.,
La globalizzazione. Definizioni e conseguenze, in «Teoria politica», XVIII (2002), n. 3, pp. 45-62.
85. Per l’argomentazione della necessità di una tale teoria, cfr. L. Ornaghi, Per una teoria politicadello Stato. Prime notazioni e schiarimenti, in «Quaderni di scienza politica», II (1995), n. 3, pp.335-369.