La definizione del concetto di ‘musica liturgica’ nel dibattito post-conciliare
«... per capillos adductos ad pillam». Il dibattito cinquecentesco sulla validità del battesimo...
Transcript of «... per capillos adductos ad pillam». Il dibattito cinquecentesco sulla validità del battesimo...
«… per capillos adductos ad pillam». Il dibattito cinquecentesco sulla validità del battesimo forzato degli ebrei in Portogallo (1496-1497)
1. In una lunga lettera scritta da Venezia nel luglio del 1554 al re di Portogallo, D. João III, il gesuita Simão Rodrigues descriveva con queste parole la comunità marrana di Ancona che aveva recente-mente visitato:
Vi sono nella città di Ancona degli ebrei portoghesi. Con sinagoghe pubbli-che e nomi ebraici saranno 2500 o addirittura 3000 anime, secondo quanto loro stessi mi hanno riferito. Tutti ricevettero l’acqua del santo battesimo nel regno di Vostra Altezza, ad eccezione di alcuni bambini che sono nati qua. Provoca molto dispiacere e pianto vedere i bambini parlare in porto-ghese e sentir dire a uno che si chiama Samuel, ad un altro Abraham, ad un altro Isac, mentre là si chiamavano Pedro, António e Francisco, e con altri nomi di santi […]. Mi ha scosso profondamente vedere la desolazione e la perdizione di questa gente, e ciò mi ha spinto a scrivere a Vostra Altezza. Fui sul punto di andare a predicare un sermone presso le loro sinagoghe e mi ero quasi messo d’accordo, ma poi mi parve meglio parlare con alcuni di loro in privato e conoscere quali scuse adducessero per i loro errori e per tanta cecità e infedeltà dopo aver vissuto tanto tempo da cristiani. Mi dicono che sono cristiani nell’animo e ebrei in pubblico perché non possono vivere in altro modo. Dicono che se sono cristiani gli italiani li trattano da marrani e non possono trovare aiuto in loro, e che gli ebrei, comunque, li trattano da cristiani e non li aiutano. Perciò sono costretti ad essere ebrei. Non si intendono, non sono ebrei, né cristiani. Hanno per legge vivere e guadagnare. C’è fra loro chi vive qua da ebreo e là ha figli cristiani, altri fratelli, cugini, zii e altri parenti. È una confusione. E però il demonio ha realizzato e realizza in loro il proprio interesse meglio di quanto non fac-ciamo noi con quello di Cristo. Sono perduti in questa terra, non hanno l’esempio dei cristiani, né occasione per esserlo. Ogni giorno andranno verso il peggio e porteranno altri dietro di sé. Li trovo pieni di nostalgia e desiderio di tornare in Portogallo, e solo questo ambiente umano e questa occasione, credo, li potrà ridurre un’altra volta alla fede di Cristo. E dicono
340 Giuseppe Marcocci
che se Vostra Altezza concederà loro di ritornare liberamente, otterranno dal papa il perdono di tutto il passato e ritorneranno, e saranno cristiani. […] Vostra Altezza è un re incline alla pietà e alla misericordia. Consideri se sia oppurtuno perdonare questa gente e consentire loro di ritornare con il perdono del papa […]. Alcuni di loro mi hanno assicurato che ritornereb-bero tutti. […] Di essere ebrei ne hanno ormai abbastanza e, come uomini stufi della manna che pensavano di trovare e delle fatiche di questo Egitto, renderanno grazie a Dio se si vedranno nella terra promessa. E certo quella terra [il Portogallo] lo sarà per loro, perché vi troveranno Cristo, e Vostra Altezza non accoglie gente nuova nel regno, se non chi ne uscì: almeno si guadagneranno i loro bambini e la loro molteplice discendenza. Alla fine del viaggio saranno molti […]1.
La lettera di Simão Rodrigues rappresenta una eccezionale testi-monianza della posizione di un personaggio di spicco del mondo cattolico lusitano di metà Cinquecento sul problema della diaspora marrana e delle conseguenze insite per gli ebrei convertiti nel ritorno all’antica religione, che avrebbe precluso loro l’accesso alla salvezza eterna. Al momento della composizione della missiva, Rodrigues si trovava in Italia in transito verso la Terrasanta, dove intendeva recarsi in pellegrinaggio. L’anno precedente, infatti, dopo essere stato a lungo il primo provinciale della Compagnia di Gesù in Portogallo ed avere goduto del convinto sostegno dei sovrani, Rodrigues era
1 Lettera di Simão Rodrigues a D. João III, re del Portogallo, Venezia, 10 luglio 1554, edita in As Gavetas da Torre do Tombo, I, Lisboa, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos 1962-1977, pp. 655-658 (la traduzione dal portoghese è mia). Sulla comunità marrana di Ancona e in particolare sulla dura repressione inquisitoriale che la interessò in seguito all’ascesa al soglio pontificio di Paolo IV, esiste una vasta biblio-grafia. Mi limito a rinviare a A. Toaff, Nuova luce sui Marrani di Ancona (1556), in E. Toaff (a cura di), Studi sull’Ebraismo italiano in memoria di C. Roth, Roma, Barulli 1974, pp. 261-280; R. Segre, Nuovi documenti sui Marrani d’Ancona (1555-1559), in «Michael», IX, 1985, pp. 130-233; S. Simonsohn, Marranos in Ancona under Papal Protection, ibid., pp. 234-267; A. Di Leone Leoni, Per una storia della Nazione porto-ghese ad Ancona e a Pesaro, in P.C. Ioly Zorattini (a cura di), L’identità dissimulata. Giudaizzanti iberici nell’Europa cristiana dell’Età Moderna, Firenze, Olschki 2000, pp. 27-97; Id., Ancora sui giudaizzanti portoghesi di Ancona (1556): condanna e riconciliazio-ne, in «Zakhor», V, 2001-2002, pp. 39-51.
341 «... per capillos adductos ad pillam»
stato travolto dalla grave crisi che aveva colpito la provincia gesuita lusitana ed era stato costretto ad abbandonare il regno2. Proprio a Rodrigues era dovuto il primo tentativo, risalente a qualche anno prima, di vietare l’ingresso nella Compagnia agli aspiranti di origine ebraica, inaugurando una tradizione segregazionista e discriminato-ria che suscitò poi anche una dura reazione di condanna da parte di Ignazio di Loyola3. Esperto conoscitore della questione dei nuovi
2 Sulla figura del primo provinciale dei gesuiti in Portogallo, cfr. J.C. Monteiro
Pacheco, Simão Rodrigues. Iniciador da Companhia de Jesus em Portugal, Braga-São Paulo, Editorial A.O.-Edições Loyola 1987. Un’ampia descrizione della crisi del 1551-1553 si trova in F. Rodrigues, História da Companhia de Jesus na assistência de Portugal, 3 voll. in 8 parti, Porto, Livraria Apostolado da Imprensa 1931-1950, I/2, pp. 91-237. Per una rapida sintesi si può ricorrere a R. García-Villoslada, Sant’Ignazio di Loyola, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline 1990 [ed. or. Madrid 1986], pp. 731-745; J. O’ Malley, I Primi Gesuiti, Milano, Vita e Pensiero 1999 [ed. or. Cambridge (Mass.)-London 1993], pp. 364-367.
3 Cfr. le regole stabilite tra il 1546 e il 1550 da Rodrigues intitolate Modo que se ha-de ter nos Collegios da Companhia en o reçeber dos estudantes d’ella (edite in «Monumenta Historica Societatis Iesu», Epistolae PP. Paschasii Broëti, Claudii Iaii, Ioannis Codurii et Simonis Rodericii Societatis Iesu ex autographis vel originalibus exemplis potissimum depromptae, edidit F. Cervós, Matriti, Typis Gabrielis Lopez Del Horno 1903, pp. 859-861). Per la posizione di Ignazio di Loyola in materia, cfr. la lettera scritta su sua commissione a Diego Mirón, Roma, 5 aprile 1554 (edita in «Monumenta Historica Societatis Iesu», Monumenta Ignatiana ex autographis vel ex antiquioribus exemplis collecta. Series prima. Sancti Ignatii de Loyola Societatis Iesu fundatoris Epistolae et Instructiones, VI, edidit M. Lecina-V. Agustí, Matriti, Typis Gabrielis Lopez Del Horno 1907, pp. 567-570) a proposito del caso di Henrique Henriques, un converso destinato a diventare uno dei più famosi teologi lusitani della Compagnia di Gesù. Sui rapporti fra gesuiti ed ebrei convertiti in Portogallo, cfr. Rodrigues, História da Companhia de Jesus cit., II/1, pp. 336-361; I.-S. Révah, Les origines juives de quelques jésuites hispano-portugais de XVIe siècle, in Études ibériques et latino-américaines: IVe Congrès des Hispanistes français, Paris, Presses Universitaires de France 1968, pp. 87-96; A. Borges Coelho, Tradição e mudança na política da Companhia de Jesus face à comunidade dos cristãos-novos, in «Revista de História», (Centro de História da Universidade do Porto), X, 1990, pp. 87-94; F.B. Medina, Ignacio de Loyola y la “limpieza de sangre”, in J. Plazaola (ed.), Ignacio de Loyola y su tiempo, Bilbao, Mensajero-Universidad de Duesto 1992, pp. 579-615; P.-A. Fabre,
342 Giuseppe Marcocci
cristiani (cristãos novos), come erano comunemente chiamati nella penisola iberica gli ebrei convertiti, e rigidamente schierato a favore delle norme di segregazione, Rodrigues tratteggiava nella propria lettera un suggestivo ritratto, che introduce in maniera esemplare in una storia, quella dei marrani, che si svolse entro uno spazio geogra-fico che venne a coincidere con gran parte del mondo cristiano, e non solo, della prima età moderna. Nelle parole del gesuita si intrec-ciavano richiami a temi densi di profonde implicazioni culturali e religiose: da quello, assai sfuggente, dell’identità doppia e dissimulata dei nuovi cristiani a quello, ad esso connesso, dell’insieme dei pro-cessi di auto-rappresentazione che ruotano intorno all’onomastica; da quello della forte ansia per il conseguimento della salvezza eterna che caratterizzava larga parte del mondo cattolico dell’epoca a quel-lo dei possibili provvedimenti da assumere per garantire alle autorità politiche ed ecclesiastiche il pieno controllo sulla fede dei sudditi. Rodrigues appare sinceramente impegnato a denunciare lo scandalo dell’apostasia marrana e a trovare una soluzione per evitare che i nuovi cristiani vanificassero l’occasione di avere accesso al regno di Dio ottenuta grazie all’acqua del battesimo, ipotesi quest’ultima che turbava profondamente la coscienza di molti uomini di Chiesa del tempo. Animato da finalità eminentemente pratiche – il suo obiettivo era quello di consentire il ritorno dei nuovi cristiani in Portogallo, dove solo avrebbero potuto ricuperare la vera fede in Cristo e vivere secondo essa –, Rodrigues non affrontava il nodo del battesimo forzato, a cui accennava appena, ma tornava piuttosto a proporre al sovrano di percorrere ancora una volta la strada del per-dono generale, un provvedimento intorno al quale, come si vedrà, si concentrarono le principali discussioni sulla conversione degli ebrei portoghesi per tutto il Cinquecento, e ancora oltre4.
La conversion infinie des Conversos. Des ‘noveaux-chrétiens’ dans la Compagnie de Jésus au 16e siècle, in «Annales HSS», LIV, 1999, pp. 875-893. Mi permetto infine di rinviare ora al saggio dello scrivente, Inquisição, jesuítas e cristãos novos em Portugal no século XVI, in «Revista de História das Ideias», XXV, 2004, pp. 247-326.
4 Per un migliore inquadramento della lettera di Rodrigues a D. João III nel contesto della storia religiosa portoghese di metà Cinquecento, cfr. dello scrivente, I custodi dell’ortodossia. Chiesa e Inquisizione nel Portogallo del Cinquecento, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 2004, pp. 103-105.
343 «... per capillos adductos ad pillam»
Il documento citato nelle pagine precedenti seguiva di oltre mezzo secolo l’episodio del battesimo coatto di massa degli ebrei e dei musulmani in Portogallo, avvenuto durante il 1497 in seguito al decreto di espulsione delle minoranze religiose emanato dal re D. Manuel nel dicembre del 1496. La decisione di imporre l’uniformità religiosa all’interno del regno lusitano, analogamente a quanto stava accadendo nel resto della penisola iberica, e le peculiari modalità con le quali tale decisione venne messa in pratica furono all’origine della drammatica storia dei nuovi cristiani portoghesi, caratteriz-zata, nei secoli successivi, da una feroce repressione inquisitoriale, da politiche di discriminazione sociale fondate sul criterio della limpeza de sangue e da tentativi, spesso riusciti, da parte degli ebrei convertiti di evitare ulteriori sofferenze e persecuzioni attraverso la fuga. Sovente accomunato e confuso con l’espulsione degli ebrei dai territori della corona spagnola verificatasi nel 1492, il battesi-mo forzato in Portogallo se ne distinse piuttosto per il carattere di eccezionale violenza che ne fece un caso unico nella lunga storia dei tentativi di conversione compiuti da parte del mondo cristiano nei confronti degli ebrei5. Nonostante costituisca un episodio di fondamentale importanza per la comprensione di numerosi aspetti della storia del Portogallo in età moderna, il battesimo forzato è stato sinora oggetto di un’attenzione relativamente scarsa da parte della storiografia, se si escludono le ricostruzioni della vicenda contenute in opere di carattere più generale dedicate alla storia degli ebrei, dei marrani o del Sant’Uffizio lusitano, alle quali è necessario ancora in larga parte ricorrere6. Neppure la ricorrenza del quinto centenario, a
5 Sulla lunga storia dei battesimi forzati degli ebrei esistono numerosi studi. Per il caso dell’Italia in età moderna cfr. L. Allegra, L’antisemitismo come risorsa politica. Battesimi forzati e ghetti nel Piemonte del Settecento (1993), ora in Id., Identità in bilico. Il ghetto ebraico di Torino nel Settecento, Torino, S. Zamorani 1996, pp. 21-53; e il recente volume di M. Caffiero, Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi, Roma, Viella 2004.
6 Cfr. A. Herculano, História da Origem e Estabelecimento da Inquisição em Portugal, 3 voll., Lisboa, Livraria Bertrand 197513 [ed. or. Lisboa 1845-1859], I, pp. 85-129; H. Graetz, Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, Berlin, Arani 1998 [ed. or. Leipzig 1863-1876], VIII, pp. 365-388; M. Kayserling, Geschichte der Juden in Portugal, Leipzig, Leiner 1867; J. Amador de los Ríos, Historia Social, Politica y Religiosa de los Judios de España y Portugal, Madrid, 3 voll.,
344 Giuseppe Marcocci
differenza di quanto è avvenuto per la Spagna nel 1992, ha prodotto studi specifici di rilievo sulla questione. Gli unici lavori recenti a cui si può fare utilmente riferimento sono quelli composti a partire dal-l’inizio degli anni Ottanta da Maria José Pimenta Ferro Tavares e il gruppo di saggi dedicati da Elias Lipiner ai baptizados em pé, un’altra delle efficaci espressioni con cui vennero definiti gli ebrei convertiti a forza7. Si tratta, in ogni caso, di uno stato degli studi che risente non poco del peso della tradizione storiografica di un paese dalla
Ediciones Turner 19843 [ed. or. Madrid 1875-1876], III, pp. 341-362; J. Mendes dos
Remédios, Os Judeus em Portugal, 2 voll., Coimbra, F. França Amado 1895-1928; J.L. De Azevedo, História dos Cristãos Novos Portugueses, Lisboa, Livraria Clássica Editora 19752 [ed. or. Lisboa 1921], pp. 17-26; C. Roth, Storia dei Marrani. L’odissea degli ‘ebrei invisibili’ dall’Inquisizione ai nostri giorni, Milano, Serra e Riva 1991 [ed. or. Philadelphia 1932], pp. 62-79; Y. Baer, Die Juden im Christlichen Spanien, 2 voll., Berlin, Akademie-Verlag 1936; J. Caro Baroja, Los Judios en la España Moderna y Contemporanea, 3 voll., Madrid, Arion 1961, I, pp. 191-195; S.W. Baron, A Social and Religiuos History of the Jews, XI, New York-London, Columbia University Press 19672, pp. 243-249; Y.H. Yerushalmi, Dalla corte al ghetto. La vita, le opere, le pere-grinazioni del marrano Cardoso nell’Europa del Seicento, Milano, Garzanti 1991 [ed. or. New York 1971], pp. 34-38
7 Cfr. M.J. Pimenta Ferro Tavares, Os Judeus em Portugal no século XV, 2 voll., Lisboa, U.N.L., INIC 1982-1985; Ead., Judaísmo e Inquisição. Estudos, Lisboa, Editorial Presença 1987, pp. 15-66; Ead., Los Judios en Portugal, Madrid, Editorial Mapfre 1992, pp. 159-175; Ead., O edito de expulsão e a diáspora dos cristãos novos: o exemplo do bispado do Porto, in Movimientos migratorios y expulsiones en la diáspora occidental. Terceros encuentros judaicos de Tudela. 14-17 de Julio de 1998, Pamplona, Universidad Pública de Navarra-Gobierno de Navarra 1998, pp. 165-183; Ead., A Expulsão dos Judeus de Portugal: conjuntura peninsular, in «Oceanos», XXIX, Janeiro/Março 1998, pp. 10-19; Ead., The Portuguese Jews after Baptism, in I.J. Katz, M.M.
Serels (eds.), Studies on the History of Portuguese Jews from Their Expulsion in 1497 through Their Dispersion, New York, Sepher-Hermon Press 2000, pp. 7-28; E. Lipiner, Os Baptizados em Pé. Estudos acerca da origem e da luta dos cristãos-novos em Portugal, Lisboa, Vega 1998. Si veda anche F. Bethencourt, A expulsão dos Judeus, in D.
Ramada Curto (dir.), O Tempo de Vasco da Gama, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses e Difel 1998, pp. 271-280. Per una sintetica esposizione degli eventi mi permetto, infine, di rinviare alle pagine dello scrivente, I custodi dell’ortodossia cit., pp. 31-40.
345 «... per capillos adductos ad pillam»
compatta ortodossia cattolica come il Portogallo, che ha rivelato sino ad oggi singolari difficoltà nella ricerca e nella riflessione sulla presenza e sul contributo dato dagli ebrei prima, dai nuovi cristiani poi, alla propria storia.
In questa sede non si pretende di affrontare la storia del battesimo forzato portoghese alla luce di nuovi elementi documentari, quan-to piuttosto, partendo da un rapido ma attento riepilogo dei fatti, presentare ed analizzare le letture che nel corso del Cinquecento di quei fatti vennero fornite a più livelli, in primo luogo quello giuri-dico e teologico. Si procederà, dunque, all’individuazione di quelle che furono le principali posizioni, di giustificazione o di condanna con un ampio e sfumato spettro di giudizi intermedi, che vennero espresse all’interno del mondo cattolico lusitano, e non soltanto, di fronte a un evento privo di precedenti per la propria gravità: posizioni che contribuirono, in varia misura, alla rielaborazione e all’accettazione di quella che rappresentò comunque – occorre osservarlo da subito – una palese violazione della comune dottrina sull’amministrazione del sacramento cristiano del battesimo. Come vedremo, il confronto sulla questione conobbe momenti di maggiore o minore intensità in corrispondenza con quello che fu il contesto in cui via via il dibattito prese corpo, non tardando ad estendersi, in conseguenza dell’impatto decisivo che il battesimo forzato ebbe sulla storia religiosa e sociale portoghese, a numerosi ambiti della produzione scritta.
2. Il battesimo forzato degli ebrei in Portogallo potrebbe senza dub-bio essere raccontato come l’epilogo di una lunga vicenda medieva-le, si potrebbero ricercare le condizioni generali e le cause culturali e materiali che lo provocarono, se ne potrebbero leggere le profonde e intime connessioni con la storia più generale della penisola iberi-ca. Tuttavia, in accordo con la prospettiva di analisi esposta sopra, risulta evidente come l’aspetto discriminante fu costituito piuttosto dalle modalità concrete secondo cui si verificò l’episodio, che per la propria inusitata violenza e eccezionalità costrinse numerosi espo-nenti del mondo cattolico a un costante sforzo di rilettura e inqua-dramento dell’accaduto. Nello studio del caso del battesimo forzato portoghese, dunque, piuttosto che sottolineare i legami con il passa-to, si privilegeranno gli elementi di novità e di forte rottura in esso contenuti, che caratterizzarono in forma determinante l’apertura di una delle principali vie lusitane alla modernità, ovvero la creazione
346 Giuseppe Marcocci
di una società uniforme e omogenea sotto il profilo religioso e cultu-rale. In tal senso, risulta più istruttivo stabilire un parallelo – su cui non ci soffermeremo, ma che deve essere sempre tenuto presente per meglio comprendere l’atmosfera in cui si collocano i fatti di cui ci occuperemo – fra la conversione degli ebrei e l’impegno missionario di evangelizzazione dei popoli delle colonie extra-europee. Anche per il Portogallo, infatti, che a fine Quattrocento raccoglieva i frutti di una straordinaria epoca di esplorazioni geografiche durata per quasi tutto il secolo precedente, le grandi scoperte avvennero entro un orizzonte culturale più ampio, che ebbe, come ha sottolineato Adriano Prosperi, nell’aspirazione all’unità sotto il segno della fede cristiana notevoli punti di contatto fra la questione ebraica e le popolazioni extra-europee, non solo dell’America come nel caso della Spagna, ma anche dell’Africa e dell’Asia8. Proprio fra 1497 e 1498, mentre in Portogallo si consumava il sacrificio della religione ebraica, Vasco da Gama realizzava la straordinaria impresa di circum-navigare l’Africa e raggiungere l’India, portando a compimento un progetto che aveva goduto dell’indispensabile apporto delle compe-tenze di cartografi e astrologi ebrei, come Abraham Zacuto9.
Per intendere correttamente i termini del dibattito cinquecente-sco sulla validità del battesimo forzato portoghese occorre comunque rifarsi brevemente ad alcune vicende della storia medievale e alle categorie teologiche e giuridiche che in tale epoca vennero elabora-te. Nel Cinquecento, infatti, chi si trovò a discutere e interpretare la realtà scaturita dalle conversioni della fine del secolo precedente,
8 Cfr. A. Prosperi, L’Inquisizione romana e gli ebrei, in M. Luzzati (a cura di), L’Inquisizione e gli ebrei in Italia, Roma-Bari, Laterza 1994, pp. 67-120, in part. p. 68. Sul clima spirituale in cui si mossero i primi protagonisti della colonizzazione extra-europea, cfr. A. Prosperi, America e Apocalisse. Note sulla «conquista spirituale» del Nuovo Mondo (1976), ora in Id., America e Apocalisse e altri saggi, Pisa-Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali 1999, pp. 16-63; Id., Conclusioni: la coscienza europea davanti alle scoperte geografiche del ’500, in A. Prosperi, W. Reinhard (a cura di), Il Nuovo Mondo nella coscienza italiana e tedesca del Cinquecento, (Quaderno 33 degli Annali dell’Istituto storico italo-germanico), Bologna, Il Mulino 1992, pp. 401-419.
9 Cfr. M.J. Pimenta Ferro Tavares, Judeus, cristãos novos e os descobrimentos portugueses, in «Sefarad», XLVIII, 1988, pp. 293-308; Ead., Os Judeus na época dos descobrimentos, Mafra, Edições Elo 1995.
347 «... per capillos adductos ad pillam»
lo fece continuando a ricorrere alle tradizionali categorie elaborate nel medioevo, che conobbero così nuovo vigore. Anzitutto, un peso notevole ebbero le lontane vicende della Spagna visigotica, in cui la condizione degli ebrei aveva subito un drammatico peggioramento a causa dell’editto di espulsione emanato nel 612 dal re Sisebuto e della legislazione in materia di ebrei e conversos stabilita dai concili di Toledo nella prima metà del VII secolo e derivata per via diretta all’episodio di battesimo forzato che era seguito all’editto del sovra-no10. I pronunciamenti conciliari che ebbero maggiori conseguenze nel fissare la dottrina in materia di conversione degli ebrei furono due: il canone 57 del concilio del 633, in cui da un lato si prescrisse il principio della libera adesione alla fede, ordinando che gli ebrei «non vi sed liberi arbitrii facultate ut convertantur suadendi sunt non potius impellendi», ma dall’altro, richiamando esplicitamente l’episodio avvenuto sotto il regno di Sisebuto, si stabilì che chi fosse stato battezzato dovesse essere costretto a osservare la nuova fede11; e il canone 3 del concilio del 638, che conteneva il testo del solen-ne giuramento che ciascun sovrano iberico avrebbe dovuto recitare prima di ascendere al trono impegnandosi a mantenere la purezza della fede entro i confini del regno12. Ai canoni toledani devono essere aggiunte almeno altre due norme provenienti dal diritto canonico. Nel terzo libro delle Decretali di Gregorio IX, si trovava la fondamentale distinzione fra il battesimo amministrato attraverso una violenza condizionata o relativa, da ritenersi in ogni caso valido poiché, essendo avvenuto mediante una costrizione a cui non era stata opposta una resistenza totale e assoluta (ad esempio, se il bat-
10 Per uno studio d’insieme sulla condizione degli ebrei sotto la dominazione dei visigoti in Spagna, cfr. B. Saitta, L’antisemitismo nella Spagna visigotica, Roma, L’Erma di Bretschneider 1995.
11 Cfr. The Jews in the legal sources of early Middle Ages, edited with Introductions, Translations and Annotations by A. Linder, Detroit, Wayne State University Press 1997, p. 486. Il canone entrò poi a far parte delle norme del diritto canonico. Cfr. Corpus Iuris Canonici. Post Aemilii Ludovici Richteri curas ad librorum manu scriptorum et editionis romanae fidem recognovit et adnotatione critica instruxit Aemilius Friedberg. Editio Lipsiensis secunda, Graz, Akademische und Verlagsanstalt 1955, Decreti Prima Pars, dist. XLV, c. 5, I, coll. 161-162.
12 Cfr. The Jews in the legal sources cit., pp. 492-493.
348 Giuseppe Marcocci
tezzato aveva ceduto di fronte alla minaccia di morte), recava con sé una dose sufficiente di volontà, e quello imposto attraverso una vio-lenza assoluta, privo di qualsiasi, anche minima, forma di consenso (com’era il caso di chi veniva trascinato a forza al fonte battesimale con le mani legate e poi immerso nell’acqua, mentre proclamava ad alta voce il suo rifiuto) e quindi da considerarsi nullo13. La distinzio-ne venne poi ripresa in un capitolo del quinto libro delle Decretali di Bonifacio VIII, in cui si affermava che contro gli ebrei battezzati, «non tamen absolute aut coacte», qualora fossero tornati a praticare l’ebraismo, occorreva procedere come contro gli eretici14.
Anche in ambito teologico la questione del battesimo degli ebrei fu a più riprese esaminata e discussa, dando una sistemazione defi-nitiva alle categorie fondamentali della riflessione in materia, quali volontà, libero arbitrio e uso della ragione, diritto civile e diritto naturale, potestà dei genitori e potestà dei principi, servitù. Mi limiterò qui a richiamare le due principali posizioni, in contrasto fra loro, che a partire dal XIII secolo andarono definendosi come i punti di riferimento a partire dai quali presero le mosse i successivi dibattiti sulla questione. Esse possono essere ricondotte al domeni-cano Tommaso d’Aquino da un lato e al francescano Giovanni Duns Scoto dall’altro. Tommaso affrontò il problema in numerosi passi delle proprie opere. Nella quaestio X della Secunda Secundae, per citare il luogo più noto, egli negò la legittimità del battesimo forza-to degli infedeli, dichiarando che «tales nullo modo sunt ad fidem compellendi, ut ipsi credant: quia credere voluntatis est», ma ribadì tuttavia che coloro che avevano ricevuto la fede e l’avevano profes-sata dovevano invece essere costretti ad osservarla «sicut haeretici […] etiam corporaliter». La posizione di Tommaso, all’apparenza chiara e netta, risultava tuttavia ambigua, perché ometteva qualsiasi riferimento alla distinzione fra violenza relativa e violenza assolu-ta15. Poco oltre, sempre nella medesima quaestio, richiamandosi alla
13 Cfr. Decretalium Gregorii IX Liber III, tit. XLII, De Baptismo, c. 3, Maiores, in Corpus Iuris Canonici cit., II, col. 646.
14 Cfr. Sexti Decretalium Liber V, tit. II, De haereticis, c. 13, Contra Christianos, ibid., II, col. 1075.
15 Cfr. Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Opera Omnia iussu impensaque Leonis XIII P. M. edita, VIII, Secunda Secundae Summae Theologiae a quaestione I ad
349 «... per capillos adductos ad pillam»
consuetudine della Chiesa, egli difese la conclusione che i figli degli ebrei, fino al conseguimento dell’età ragione, non dovessero essere battezzati invitis parentibus e sostenne che il fatto che gli ebrei fossero «servi regum et principum» non conferiva a questi ultimi il potere di battezzare i loro figli eis invitis, perché si trattava di una condizione servile secondo il diritto civile, che tuttavia in nessun caso annullava la vigenza del diritto naturale e divino16. Le conclusioni di Tommaso vennero ribaltate a pochi anni di distanza da Scoto, nel commento alla distinctio IV del quarto libro delle Sentenze di Pietro Lombardo. Al centro del ragionamento di Scoto stava la figura del principe cristiano che, a suo giudizio, aveva non solo il diritto, ma anche il dovere di battezzare i figli degli ebrei, etiam invitis parentibus, purché da ciò non derivassero conseguenze molto gravi, come ad esempio che i genitori, venuti a conoscenza delle intenzioni del principe, decidessero di uccidere i propri figli pur di non farli battezzare. Scoto però si spingeva ancora oltre, affermando che fosse consentito ai principi costringere alla fede con la violenza anche i genitori.
L’argomentazione del teologo francescano era la seguente. I figli degli ebrei e degli infedeli non devono essere battezzati invitis paren-tibus, ma questo vale solo in generale. Nel caso infatti del principe del quale siano sudditi i genitori ebrei o infedeli, la questione si pone in termini affatto differenti. Scoto qui inseriva un ragionamento incentrato sulla gerarchia dei poteri e sul principio della potestà del superiore sull’inferiore. Su un bambino la suprema autorità di Dio ha maggiore potestà dei genitori. Dunque, poiché uno dei princi-
quaestionem LVI ad codices manuscriptos vaticanos exacta cum commentariis Thomae de Vio Caietani Ordinis Praedicatorum S.R.E. Cardinalis cura et studio Fratrum Eiusdem Ordinis, Roma, Typographia Polyglotta 1895, q. X, De infidelitate in communi, art. VIII, Utrum infideles compellendi sint ad fidem, pp. 88-89.
16 Cfr. ibid., art. XII, Utrum pueri Iudaeorum et aliorum infidelium sint invitis paren-tibus baptizandi, pp. 93-95. Il problema veniva poi ripreso anche nella terza parte della Summa Theologiae, q. LVIII, De suscipientibus baptismum, art. XII, Utrum pueri Iudaeorum vel aliorum infidelium sint baptizandi etiam invitis parentibus, ibid., XII, Tertia Pars Summae Theologiae a quaestione LX ad quaestionem XC ad codices manuscriptos vaticanos exacta cum commentariis Thomae de Vio Caietani Ordinis Praedicatorum S.R.E. Cardinalis et supplemento eiusdem Tertiae Partis cura et studio fratrum eiusdem ordinis, Roma, Typographia Polyglotta 1906, pp. 102-103.
350 Giuseppe Marcocci
pali compiti del principe è conservare la potestà di Dio, non solo gli è lecito, ma è addirittura suo dovere strappare i figli alla potestà dei genitori che li vogliano educare in una religione contraria alla vera fede, e convertirli perché possano accedere alla vita eterna. Pertanto, proseguiva Scoto, se il principe opera con la giusta cautela e, dopo avere battezzato i figli degli ebrei o degli infedeli, li farà educare nella religione cristiana, agirà legittimamente. Non solo – e su questo punto la posizione di Scoto si mostrava in tutta la sua radi-calità –, il principe agirà in modo pio e religioso se, oltre ai figli, gli stessi genitori saranno costretti con minacce e violenze a ricevere il battesimo e a conservare la nuova fede una volta ricevuta, perché, anche ammesso che essi non siano veri fedeli nel loro animo, tutta-via è un male minore se non possono più osservare impunemente la loro legge illecita, piuttosto che esseri liberi di osservarla. E d’altra parte, se i loro figli saranno educati rettamente, alla terza o quarta generazione diventeranno veri fedeli. Per difendere la propria linea aggressiva circa il battesimo degli adulti ebrei o infedeli, Scoto si appellava, non a caso, alla legittimazione del battesimo forzato imposto agli ebrei dal re visigoto Sisebuto, contenuta nella seconda parte del canone 57 del concilio toledano del 63317.
Dunque all’impostazione tomista, incentrata sulla difesa del diritto naturale dei genitori e sulla libera adesione alla fede cristiana da parte di coloro che avevano raggiunto l’età dell’uso della ragione, Scoto contrapponeva una visione più marcatamente politica, in cui la derivazione divina della potestà dei principi sui loro sudditi apriva il campo a interventi radicali nella sfera religiosa verso coloro che non professavano la fede cristiana. L’interpretazione di Scoto, che include-va fra i doveri del principe cristiano quello di convertire, anche con la violenza, ebrei e infedeli, fu evidentemente alla base della legitti-mazione teologica e giuridica del battesimo forzato lusitano18. Ed è proprio alle vicende concrete della conversione coatta degli ebrei in Portogallo a fine Quattrocento che occorre adesso guardare.
17 Ho usato un’edizione cinquecentesca: cfr. Fratris Ioannis Duns Scoti, Ordinis Minorum Sacrae Theologiae Doctoris Subtilis, In Quartum Lib. Sententiarum […], Venetiis, apud haeredes Melchioris Sessae 1598, ff. 22v-23.
18 Sulla diffusione nel Portogallo medievale della riflessione teologico-canonistica sulla conversione degli infedeli si trovano alcuni elementi in J. Antunes, Acerca da
351 «... per capillos adductos ad pillam»
3. È stato spesso osservato come, a differenza che in Spagna, in Portogallo durante il basso medioevo, e in particolare nel Quattrocento, non esistesse un vero problema conversos19. Ebrei e cristiani vivevano fianco a fianco senza forti sussulti20. Non manca-rono, certo, episodi di tensione e violenza arrecata dalla maggioranza cristiana alla minoranza ebraica, tuttavia i casi di ebrei passati alla fede cristiana furono molto rari, così come abbastanza scarsa fu la propaganda religiosa cristiana tesa a favorire le conversioni: come ha segnalato Israel-Salvator Révah, per tutto il medioevo in Portogallo si conoscono appena quattro opere pienamente ascrivibili al genere della letteratura apologetica anti-giudaica, e sono molto poche le notizie che si hanno a proposito di cicli di predicazioni pubbliche finalizzate a fare proseliti fra gli ebrei, come quelle realizzate a metà Quattrocento dal converso mestre Paulo de Braga21. Ancora meno, infine, sono le tracce di un controllo giudiziario sull’ortodossia della
Liberdade de Religião na Idade Média. Mouros e Judeus perante um problema teológico-canónico, in «Revista de História das Ideias», XI, 1989, pp. 63-84; Id., Dos Direitos do Homem aos Direitos dos Povos (Do Portugal Medieval à Época Moderna), ibid., XIV, 1992, pp. 23-56, in part. pp. 24-41.
19 Per la ricostruzione dei fatti che seguono in questo e nel prossimo paragrafo (3 e 4) farò in generale riferimento agli studi citati supra alle note 6 e 7.
20 Alcuni dubbi relativi alla tradizionale immagine di una pacifica convivenza fra cristiani ed ebrei in Portogallo durante il medioevo sono stati sollevati da H. Baquero Moreno, Movimentos sociais antjudaicos em Portugal no século XV (1984), ora in Id., Marginalidade e conflitos sociais em Portugal nos séculos XIV e XV. Estudos de História, Lisboa, Editorial Presença 1985, pp. 79-88. Sulla legislazione basso-medievale portoghese in materia di ebrei, cfr. E. Lipiner, O tempo dos judeus segundo as Ordenações do Reino, São Paulo, Livraria Nobel 1982.
21 Sulla letteratura anti-giudaica medievale in Portogallo, cfr. l’introduzione di I.-S. Révah a Diálogo Evangélico sobre os Artigos da Fé contra o Talmud dos Judeus. Manuscrito Inédito de João de Barros, Lisboa, Livraria Studium 1950, ora ripubblicata in Id., Études Portugaises, Paris, Fundação Calouste Gulbenkian-Centro Cultural Português 1975, pp. 51-95, in part. pp. 53-54. Sull’attività di Paulo de Braga, cfr. H. Baquero Moreno, As pregações de mestre Paulo contra os judeus bracarenses nos fins do século XV, in «Bracara Augusta», XXX, 1976, pp. 53-62; Id., Novos elementos relativos a Mestre Paulo, pregador do século XV, contra os judeus bracarenses, ibid., XXXII, 1978, pp. 117-124.
352 Giuseppe Marcocci
fede degli ebrei convertiti. A quanto si sa, il primo giudaizzante condannato a morte in Portogallo – ma siamo già dopo la nascita dell’Inquisizione spagnola che aveva da subito cominciato a fare pressioni sui sovrani lusitani perché incrementassero la vigilanza religiosa – fu João de Niebla, arso sul rogo a Santarém nel 148722.
Pochi dubbi sussitono circa il fatto che furono le vicende che si verificarono nella seconda metà del Quattrocento nei vicini regni iberici a imprimere un mutamento radicale e decisivo negli equilibri religiosi esistenti in Portogallo. Dopo la creazione dell’Inquisizione moderna in Castiglia, nata anzitutto in funzione anti-conversos, e soprattutto dopo l’editto di espulsione del 1492, vi fu un esodo massiccio di ebrei verso il Portogallo. A coloro che già dagli anni Ottanta avevano cercato rifugio nei territori del regno lusitano, come soluzione di passaggio o definitiva, si aggiunsero dopo l’editto quanti scelsero la via dell’esilio entrando in Portogallo attraverso i quattro accessi messi a disposizione dal re D. João II (Olivença, Arronches, Castelo Rodrigo e Melgaço) in base agli accordi presi con i capi di alcune importanti famiglie ebraiche spagnole, oppure, come avvenne nella maggior parte dei casi, in maniera clandestina. Nell’arco di poco tempo il numero di ebrei presenti nel regno di Portogallo quasi raddoppiò. Ne derivarono aspre tensioni tanto nella convivenza fra ebrei e cristiani, quanto all’interno del mondo ebraico stesso, fra immigrati e portoghesi. Anche nei rapporti fra le due corone iberiche la questione suscitò non pochi contrasti, che si vennero poi a manifestare in tutta la loro evidenza durante le trattative per definire i termini del contratto di matrimonio fra il re del Portogallo, D. Manuel, succeduto a D. João II nel 1495, e la principessa Isabella, figlia dei re Cattolici.
Le vicende degli anni che intercorsero fra l’editto di espulsione in Spagna e l’analogo provvedimento assunto dalla corona portoghe-se nel dicembre del 1496 sono molto dense e ricche di episodi di notevole rilievo, ancora in buona misura da chiarire. Sarà però qui sufficiente sottolineare appena tre aspetti che permettono di inqua-drare la situazione portoghese alla vigilia del decreto di espulsione emanato da D. Manuel. In primo luogo occorre osservare come
22 Cfr. Tavares, Os Judeus em Portugal no século XV cit., I, pp. 445-446.
353 «... per capillos adductos ad pillam»
non mancassero all’interno della Chiesa lusitana alcune figure che avevano assunto una posizione critica nei riguardi della politica per-secutoria promossa dalla corona spagnola e verso la repressione con-dotta dall’Inquisizione. Lo rivela, ad esempio, lo scontro che oppose il vescovo di Évora, Garcia de Meneses, agli inquisitori di Siviglia in merito a un gruppo di giudaizzanti sivigliani rifugiatisi in Portogallo per sfuggire al Sant’Uffizio che aveva aperto processi a loro carico. Alla fine, nel marzo del 1494, il tribunale andaluso ottenne da papa Alessandro VI l’approvazione del proprio operato e l’annullamento dell’assoluzione concessa dal prelato lusitano agli esuli conversos23. Si trattava di vicende che ruotavano attorno a quella che era ormai – e questo è il secondo elemento che preme porre in evidenza – la più potente comunità ebraica, o di origine ebraica (in questi anni di conversioni estorte e ritrattate e di continui passaggi da una parte all’altra del confine fra i due regni, la distinzione fra ebrei e conversos, perlopiù di origine spagnola, non era facilmente defini-bile), nell’Europa occidentale dell’epoca. In questo clima carico di tensioni, secondo molte fonti, era già maturata l’idea di unificare la fede all’interno del regno lusitano. Il terzo e ultimo punto da rileva-re, dunque, è che il provvedimento di espellere nel giro di due anni tutti gli infedeli dal Portogallo sarebbe stato assunto già nel 1494 da D. João II, la cui strategia verso gli ebrei fuggiti dalla Spagna, seb-bene potesse apparire un compromesso accettabile agli occhi di chi non aveva alternative, presentava in realtà tratti di estrema durezza, tanto che in base agli accordi presi nel 1492, che prevedevano una permanenza temporanea degli ebrei accolti, alla morte del re quanti risultavano ancora presenti nel regno si trovavano ormai in una con-dizione giuridica di inferiorità, quella di ‘servi’ secondo il diritto civi-le. Illuminante a tale proposito è la lettura di un passo dal diario del-l’umanista e cosmografo di Norimberga Hieronymus Münzer, che fra 1494 e 1495 fece un ampio viaggio attraverso Spagna e Portogallo. La pagina in cui descriveva la città di Lisbona riassume con efficacia quale fosse la condizione della prospera e opulenta comunità ebraica
23 Cfr. il breve Sicut accepimus, inviato da papa Alessandro VI ai sovrani Ferdinando di Aragona e Isabella di Castiglia, Roma, 12 marzo 1494, pubblicato in S. Simonsohn, The Apostolic See and the Jews, 8 voll., Toronto, Pontifical Institute of Medieval Studies 1988-1991, III, doc. 1155, pp. 1439-1441.
354 Giuseppe Marcocci
a breve distanza di tempo dal battesimo forzato, e la percezione che di essa potesse averne un attento visitatore straniero:
Il 26 novembre [1494] arrivammo finalmente nell’inclita città di Lisbona. È un monte altissimo, sulla cui sommità si trovano due fortezze reali, e al di sotto di esse tutto il monte è abitato, pieno di case, monasteri e altre chiese. A occidente si trova un altro monte, il cui versante orientale è tutto abitato, e nel mezzo una grande pianura fino al mare molto popolata. È più grande di Norimberga e molto più popolosa, perché in una sola abitazione ci sono in genere tre, quattro o cinque vicini. […] Gli ebrei hanno tre quartieri propri, sotto al castello, ai piedi della montagna, che vengono chiusi tutte le notti. Il sabato, vigilia di S. Andrea, entrai nella loro sinagoga, non ne ho mai vista una uguale. Davanti alla sinagoga c’è un grande edificio, ricoperto da una grande vite, il cui tronco misurava quattro palmi di circonferenza. Che bellissimo luogo e che cattedra per predicare, come nelle moschee! All’interno della sinagoga ardevano dieci grandi candelabri, ciascuno di essi con cinquanta o sessanta candele, senza contare le altre. Le donne ave-vano una sinagoga a parte, dove pure ardevano molte candele. Gli ebrei di Lisbona sono molto ricchi, e riscuotono i tributi reali che hanno acquistato dal re. Si mostrano molto insolenti con i cristiani e hanno un profondo timore dell’esilio, perché il re di Spagna ordinò a quello di Portogallo di ster-minare i marrani, come gli ebrei, altrimenti sarebbe entrato in guerra con lui. Il re di Portogallo, seguendo il comportamento del re di Spagna, dette mandato che entro Natale tutti i marrani abbandonassero il suo regno. Essi hanno preso a nolo la nave Regina, bellissima imbarcazione, e alla metà di dicembre si trasferiranno a Napoli. Quanto agli ebrei, il re ha concesso loro una tregua di due anni pieni perché possano lasciare il regno con calma24.
24 Il manoscritto latino dell’Itinerarium sive Peregrinatio excellentissimi viri, artium ac utriusque medicine doctoris, Hieronimi Monetarii de Feltkirchen, civis Nurembergensis è stato edito per la prima volta da L. Pfandl nella «Revue Hispanique», XLVIII, 1920, pp. 1-179. Qui si cita però dalla recente edizione spagnola, a cura e con introduzione di R. Alba, che riproduce la versione in lingua castigliana eseguita da José López Toro nel 1951: cfr. J. Münzer, Viaje por España y Portugal (1494-1495), Madrid, Ediciones Polifemo 1991, pp. 171-173 (la traduzione dallo spagnolo è mia).
355 «... per capillos adductos ad pillam»
La decisione definitiva di trasformare anche il Portogallo in un regno senza ebrei e, a differenza della Spagna, da subito caratteriz-zato dall’assoluta purezza della fede in virtù della contemporanea espulsione anche dei musulmani, fu presa sul finire del 1496 da D. Manuel, che pure non appena salito al trono aveva assunto fra i primi provvedimenti quello di restituire la libertà civile agli ebrei spagnoli presenti in Portogallo. Pur senza occuparci del problema delle cause del battesimo forzato lusitano, non si può tralasciare di ricordare che un’influenza diretta sulla svolta maturata dal sovrano provenne da una delle condizioni poste dall’infanta Isabella per accettare di recarsi in Portogallo e celebrare le nozze con D. Manuel: la soluzione del problema posto dalla presenza degli ebrei in Portogallo attraverso la loro completa scomparsa, scegliendo fra l’espulsione o la conver-sione. In sostanza la corona di Spagna additava a quella lusitana il proprio modello come quello a cui attenersi25. Ma le cose andarono diversamente.
4. La ricostruzione fattuale dell’episodio del battesimo forzato portoghese resta ancora in larga parte da compiere e il quadro di conoscenze che si hanno a disposizione appare incerto e confuso. Per limitarsi a una breve riflessione sulle fonti, le cronache cin-quecentesche – anzitutto quelle celebri di Damião de Góis e di Jerónimo Osório – presentano non poche contraddizioni e lacune; i provvedimenti legislativi che si conoscono non consentono di per-
25 In una lettera, datata 21 giugno 1497, scritta in risposta alle proteste di D. Manuel, che si lamentava perché l’infanta Isabella continuava a rifiutarsi di entrare in Portogallo per celebrare il matrimonio, nonostante gli accordi ratificati il 30 novembre 1496, i Re Cattolici scrivevano: «ya sabe que, al tiempo que se tratava este casamento, la princesa pidio por condiçion que el rey huviesse de echar todos los hereges de sus reynos y señorios antes que ella entrasse en ellos, y esto mismo pidio al tiempo que se fizo el desposorio; y no lo queria hazer hasta que fuessen salidos, sino que todos deximos que no lo detoviesse por aquello, que, antes que ella fuesse a Portugal, serian echados los dichos hereges; y con esta condyçion fizo ella el desposorio», in Documentos referentes a las relaciones con Portugal durante el reina-do de los Reyes Catolicos, 3 voll., edicion preparada y adnotada por A. de la Torre, L. Suarez Fernandez, Valladolid, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 1958-1963, III, doc. 470, p. 13.
356 Giuseppe Marcocci
cepire quale fu il loro impatto concreto e in che misura e modalità esatte essi vennero posti in esecuzione; assai poco esplorata, infine, è stata sinora una delle fonti che meglio permetterebbe – e in parte ha già permesso, come rivelano gli studi di Maria José Pimenta Ferro Tavares – di ricostruire più in dettaglio episodi concreti di amministrazione del battesimo: si tratta dei primi processi inquisi-toriali portoghesi, che tra la fine degli anni Trenta (l’introduzione del Sant’Uffizio in Portogallo risale al 1536) e la metà del secolo colpirono in molti casi nuovi cristiani di età già avanzata, che ave-vano vissuto in prima persona i drammatici fatti del 1497 ed erano in grado di ricordare e di riferirne agli inquisitori durante la fase dei primi interrogatori in cui venivano richiesti di ripercorrere le principali tappe della propria biografia. È un percorso di ricerca che sarebbe doveroso privilegiare, soprattutto se si considera che tracce del battesimo lusitano ci giungono copiose anche dalle carte delle altre inquisizioni cattoliche d’Europa. Con queste parole un marrano portoghese processato dal Sant’Uffizio di Venezia nel 1555 ricordava il battesimo ricevuto quasi sessant’anni prima:
In quel che se batazavano li Zudei in Portogalo si chaturavano li figlioli delli padri et li mettevano fra Christiani et battizzavano per volontà o per forza […]. Mi he’ stato detto da mio padre che io fui tolto dal petto de mia madre et che fui battezzato26.
Nella narrazione del battesimo forzato in Portogallo, di cui persino l’esatta successione cronologica degli eventi è comunque piutto-sto dubbia, si evidenzieranno le fasi più importanti ponendole al contempo in collegamento con il tipo di problemi interpretativi che esse via via dovettero comportare secondo le distinzioni della tradizione canonistico-teologica. Si tratta di un intreccio di que-stioni difficilmente separabili fra loro, tuttavia l’analisi successiva all’esposizione dei fatti si incentrerà più specificamente sull’aspetto della validità del battesimo forzato, o per meglio dire dell’uso quasi sistematico della violenza per costringere gli infedeli ad accettare la
26 Deposizione resa di fronte agli inquisitori di Venezia da Licentiato Costa il 27 giugno 1555, in P.C. Ioly Zorattini (a cura di), Processi del S. Uffizio di Venezia contro ebrei e giudaizzanti, 14 voll., Firenze, Olschki 1980-1999, I, pp. 252-253.
357 «... per capillos adductos ad pillam»
religione cristiana. È questo infatti, come vedremo, l’elemento che rende eccezionale il caso dell’editto di espulsione portoghese, per-ché, a differenza che in Spagna, agli ebrei venne di fatto impedito di praticare la scelta dell’esilio.
Fra la fine di novembre e l’inizio di dicembre del 1496 si riunì il consiglio del re in cui si discusse l’adozione del provvedimento di espulsione degli infedeli dal regno. Il dibattito fu molto acceso e i pareri forniti discordanti. A quanto risulta dalle cronache, alla loro base vi furono tanto considerazioni di ordine teologico, quanto di ordine politico ed economico. La maggior parte dei consiglieri del re, fra i quali il vescovo di Lamego Fernando Coutinho e, a quanto pare, Diogo Ortiz, all’epoca vescovo di Tangeri e cappel-lano maggiore della Cappella Reale27, votarono contro l’editto di espulsione, ma D. Manuel optò ugualmente per la cacciata degli infedeli dal Portogallo. Secondo quanto riferisce Barbosa Machado, una funzione decisiva nell’orientare la decisione del sovrano venne ricoperta dal suo confessore personale, il domenicano Jorge Vogado, che inaugurava così una tradizione di accesa ostilità verso ebrei e nuovi cristiani che avrebbe distinto a lungo numerosi appartenenti all’ordine dei predicatori portoghese28. L’editto prevedeva che gli infedeli avessero tempo fino alla fine di ottobre del 1497 per sce-gliere se abbandonare il regno o convertirsi al cristianesimo. Su chi fosse rimasto dopo tale data in Portogallo senza assumere la fede cristiana gravava la pena della condanna a morte e della confisca
27 La notizia relativa alla posizione di Ortiz sull’editto di espulsione si trova in Tavares, Os Judeus na época dos descobrimentos cit., p. 74.
28 Di famiglia nobile, Jorge Vogado all’epoca in cui entrò nell’ordine domenicano svolgeva la mansione moço da Câmara del re D. João II. In seguito fu vicario degli Osservanti dal 1506 al 1509, e due volte provinciale dal 1517 al 1521 e dal 1527 al 1534, ricoprendo nell’intervallo di tempo fra i due provincialati la carica di priore del convento di Lisbona (cfr. L. Cacegas, L. de Sousa, História de S. Domingos parti-cular do Reino e Conquistas de Portugal, Lisboa, Typographia Panorama 18663 [ed. or. 1623-1733], III, parte II, pp. 231, 312-313; IV, parte III, pp. 23-24). Durante il regno di D. Manuel, il sovrano lo scelse come proprio confessore personale, «devendose ao seu conselho a expulsão que este Monarcha fez dos Mouros, e Judeos que com escandalo da piedade habitavão neste Reyno» (D. Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana, 4 voll., Coimbra, Atlântida 1965-19672, II, p. 819).
358 Giuseppe Marcocci
dei beni. Il decreto venne promulgato a Muge nei primi giorni di dicembre29. Con un’ordinanaza del 31 dicembre il re restrinse inoltre la possibilità di salpare dai porti del regno30. Sin dalla prima fase si posero dunque sia la questione della liceità della costrizione alla fede attraverso i provvedimenti di espulsione, sia quella, ad essa connes-sa, delle facoltà di cui erano investiti i principi cristiani in materia di conversione di infedeli.
All’inizio della Quaresima dell’anno successivo, nei primi giorni di febbraio del 1497, il consiglio del re decretò che tutti i fanciulli ebrei di età inferiore ai 14 anni fossero battezzati e affidati a famiglie cristiane dove venire educati nella nuova fede. Il provvedimento, tenuto segreto, doveva essere messo in opera a partire dalla prima domenica in Albis, l’8 aprile, ma si registrò una fuga di notizie, e per evitare le possibili contromisure dei genitori ebrei, l’attuazione del battesimo degli infanti venne anticipata. La prima data che si conosce è quella del 19 marzo31. Si trattava di una misura tesa a fare pressione sui genitori perché accogliessero anche loro la nuova fede e non perdessero i propri figli. L’episodio, in palese contraddizione con quanto stabilito nell’editto di espulsione, sollevò un’ondata di proteste da parte degli ebrei e suscitò anche la profonda indignazio-ne di ampi settori del mondo cristiano. Con questo secondo duro intervento la politica di conversione coatta adottata da D. Manuel effettuava un ulteriore passo in avanti, chiamando in causa il pro-blema teologico della legittimità del battesimo dei figli degli infedeli invitis parentibus.
Dal principio della primavera in poi la sequenza delle vicende risul-ta meno perspicua. Un numero non esiguo di ebrei decise di lasciare il regno, anche a costo di abbandonare i figli battezzati. D. Manuel, intanto, prese una serie di altre iniziative dal grave valore simbolico
29 Una copia del decreto si può leggere in appendice a Amador de Los Ríos,
Historia cit., III, pp. 614-615.30 Cfr. Gabinete de História da Cidade do Porto, Livro Antigo de Provisões, f. 75r-v.
Il documento è segnalato in Tavares, Os Judeus em Portugal no século XV cit., I, p. 502 nota 10.
31 Cfr. Arquivo Nacional da Torre do Tombo (d’ora in avanti ANTT), Foral de Torres Novas, N. A. 373, f. 1. Il documento è segnalato in Ead., Los Judíos cit., p. 166 nota 3.
359 «... per capillos adductos ad pillam»
agli occhi di ebrei e musulmani, come quella di sopprimere sina-goghe, moschee, cimiteri, biblioteche e altri luoghi di culto appar-tenenti alle due minoranze religiose. Durante il mese di marzo, ad esempio, venne chiusa la sinagoga di Évora e donata a Diogo Ortiz32. Il 30 maggio, inoltre, il sovrano promulgò un decreto di straordinaria importanza in cui oltre a stabilire privilegi di natura economica per chi si era già convertito, concedeva a chi avesse accettato la fede cristiana una serie di garanzie, fra le quali l’impegno a non indagare per un periodo di venti anni sul comportamento religioso dei nuovi cristiani e l’abolizione di ogni distinzione fra i sudditi, confermando ai conversos la piena equiparazione giuridica e il libero accesso alle cariche pubbliche, alla carriera ecclesiastica, all’università33. Non è chiaro se tale decreto precedette o seguì l’evento più rilevante di tutta la vicenda che stiamo narrando, quello del battesimo forzato delle migliaia di ebrei ammassati dentro gli Estaus a Lisbona in attesa di potersi imbarcare.
Le cronache riportano che all’appressarsi della scadenza del ter-mine di tempo accordato da D. Manuel agli ebrei per convertirsi, il sovrano, dopo avere impedito con vari espedienti che le navi con a bordo gli ebrei salpassero da uno dei tre porti che erano stati loro assegnati (sicuramente uno era quello di Lisbona; sugli altri le fonti sono in disaccordo, ma si trattava di due città fra Lagos, Porto, Setúbal e Viana do Castelo), rese noto che intendeva rilasciare a quanti lo avessero voluto l’autorizzazione a partire dal Portogallo, limitando però l’imbarco alla sola città di Lisbona. Migliaia di ebrei provenienti da tutto il regno si radunarono nella grande città e vennero fatti alloggiare in edifici nei pressi del porto, che avevano nome di Estaus. Fu allora che il sovrano mise in azione il proprio piano, separando anzitutto coloro di età inferiore ai venticinque anni da tutti gli altri, convertendoli a forza e usandoli come stru-mento di pressione sui più anziani e determinati. Quindi, di fronte alla resistenza opposta da questi ultimi, costrinse anch’essi a ricevere l’acqua del battesimo, trascinandoli con la violenza presso i fonti delle chiese. Secondo le ricostruzioni tradizionali il battesimo di massa di Lisbona si sarebbe verificato nel mese di ottobre, ma è
32 Cfr. Ead., Os Judeus em Portugal no século XV cit., I, p. 489.33 L’ordinanza è pubblicata in As Gavetas cit., IV, pp. 172-173.
360 Giuseppe Marcocci
oggetto di discussione fra gli storici se, incalzato dall’infanta Isabella, D. Manuel non abbia anticipato la data entro cui ebrei e musulma-ni dovevano compiere la loro scelta fra la conversione o l’esilio. Tale ipotesi è stata suggerita dall’interpretazione di alcuni nuovi documenti. Sulla base di una deposizione del nuovo cristiano Jorge Manuel, che era uno degli ebrei alloggiati negli Estaus e convertiti a forza, processato all’inizio degli anni Quaranta presso il tribunale del Sant’Uffizio di Tomar, Maria José Pimenta Ferro Tavares ha sostenuto che l’episodio degli Estaus sia avvenuto prima del decreto del 30 maggio, probabilmente verso la fine di aprile34. In ogni caso
34 Il contenuto della deposizione resa da Jorge Manuel agli inquisitori di Tomar è il seguente: «E ele Jorge Manuell casou sendo outrosi judeu. E tinha seu filho Antonio Manuell de sete ou oito meses quando ell Rei dom Manuell que santa gloria aja, mandou tomar os meninos aos judeus em estes seus Regnos de Portugall. E dahi a poucos dias depois de lhe tomarem o dito seu filho, elle se foy a Lixboa a arrecadar a fazemda que lhe ficara de seu pai. E estando na dita çidade mandara o dito senhor que os judeus se tornasem cristãos e asi forão metidos nos Estaos donde elle Jorge Manuell sahira com outros e se fora bautizar a samta Justa omde foy bautizado» (il corsivo è mio). Riprendo la citazione da Tavares, Judaísmo cit., p. 35, che però non indica né la data esatta, né le circostanze processuali del costituto di Jorge Manuel. L’interpretazione di Maria José Pimenta Ferro Tavares poggia sull’indicazione cronologica «da lì a pochi giorni» (dahi a poucos dias) che segnala la distanza di tempo intercorsa fra il battesimo forzato del piccolo António Manuel (che presumibilmente si verificò tra la fine di marzo e aprile) e il trasferimento di suo padre Jorge Manuel a Lisbona. Tuttavia la lettura data dalla storica portoghese appare arbitraria, perché nella deposizione Jorge Manuel afferma chiaramente di essersi spostato a Lisbona per occuparsi dell’eredità lasciatagli da suo padre, senza fare alcun cenno all’invito rivolto da D. Manuel agli ebrei che intendevano lasciare il regno perché si recassero a Lisbona, da dove avrebbe autorizzato la loro partenza. Non sappiamo per quanto tempo Jorge Manuel si trattenne a Lisbona, ma nulla vieta di pensare che nel clima incerto e turbolento della primavera-estate del 1497 egli fosse rimasto in città anche per alcuni mesi. A quanto si ricava dal documento, Jorge Manuel fu sorpreso a Lisbona dall’ordine del re di convertire a forza tutti gli ebrei, rimanendone vittima. Dunque nessun elemento impone di anticipare la datazione del battesimo degli ebrei rinchiusi negli Estaus, rispetto all’ottobre 1497. Piuttosto un punto su cui la deposizione di Jorge Manuel lascia aperto qualche dub-bio circa la cronologia dei fatti riguarda il momento esatto e l’intento con cui gli
361 «... per capillos adductos ad pillam»
sono numerose le testimonianze di conversioni fra la fine di maggio e la fine di settembre, quando Isabella fece il proprio ingresso in Portogallo. Si può affermare che, al di là del problema della datazio-ne dell’episodio degli Estaus, risalga ai mesi tra maggio e ottobre la conversione di massa degli ebrei, avvenuta però secondo modalità di vario tipo, con diversi gradi di violenza. Il battesimo assunse forme differenti e si verificò pressoché in tutti i luoghi dove risiedevano gli ebrei. Accanto ai battesimi collettivi, si realizzarono anche molti battesimi individuali. Il passaggio dal nome ebraico a quello cristia-no sancì anche in modo esteriore l’avvenuta conversione35. In alcuni casi più solenni fra i padrini figurò persino il sovrano. In altri casi, invece, il neofita venne accolto da tutta una comunità che svolgeva la funzione di testimone dell’avvenuto passaggio alla fede cristiana: fu questo il caso di André Gonçalves, battezzato a Santa Marinha nei pressi di Porto. Nel battesimo di Joana Lopes, invece, madrine furono la badessa e le monache del convento di Santa Clara di Vila do Conde36.
Molto pochi furono gli ebrei irriducibili che riuscirono a partire senza ricevere l’acqua del battesimo. Fra di loro si annoveravano l’astrologo regio Zacuto, suo figlio Abraham Saba, e un numero esi-guo di anziani e cortigiani ai quali il sovrano, forse in segno di rico-noscenza per i numerosi servigi che essi in passato avevano prestato, concesse di lasciare liberamente il paese.
Tutto quello che è stato raccontato nelle pagine precedenti mostra dunque quanto sia difficile valutare con esattezza le moda-lità secondo cui il sacramento del battesimo venne effettivamente
ebrei furono radunati negli Estaus, perché non è chiaro se l’ordine di D. Manuel, di cui parla Jorge Manuel, fosse un’istruzione segreta e in tal caso gli ebrei ingannati sarebbero entrati negli Estaus con la certezza di una partenza imminente, oppure – e sarebbe una nuova versione dei fatti – se l’ordine fu divulgato pubblicamente e in tal caso gli ebrei avrebbero fatto ingresso negli Estaus già come prigionieri.
35 Sulla questione dei nomi dei nuovi cristiani, cfr. E. Lipiner, Homens à procura de nome. Antroponímia de sobrevivência dos cristãos-novos, in Id., Os Baptizados em Pé cit., pp. 53-104.
36 Gli esempi sono relativi alla diocesi di Porto e sono tratti da quello che costitui-sce il miglior studio dell’impatto del battesimo forzato su una determinata località geografica: cfr. Tavares, O edito cit., p. 174.
362 Giuseppe Marcocci
amministrato. Ma è proprio su questo terreno che si concentrò la questione più importante sotto il profilo teologico e giuridico, quella del battesimo per vim, dato che nessun dubbio sussisteva che così dovesse essere definita la condizione priva di scelta reale in cui si trovò la stragrande maggioranza degli ebrei battezzati: il sacramento che avevano ricevuto per mezzo della violenza era stato sicuramen-te imposto loro in modo illegittimo e contrario alla consuetudine, ma ove si fosse dimostrato che si era trattato di violenza relativa, il battesimo doveva considerarsi valido. Gli ebrei di Portogallo, comunque, portavano ormai nomi cristiani e potevano partecipare in modo teoricamente paritetico ai diritti e agli obblighi della vita religiosa e civile del tempo.
Nel decennio successivo al battesimo forzato la condizione della comunità convertita fu caratterizzata da almeno quattro elementi: la tolleranza nei confronti degli eventuali reati di fede (il provvedi-mento del 30 maggio 1497, fra l’altro, fu confermato nel 1507, subito dopo l’episodio del cosiddetto massacro di Lisbona, su cui torneremo fra breve, e poi prorogato per sedici anni nel 1512 e ancora per altri sedici nel 1522)37; l’equiparazione giuridica fra nuovi cristiani (cristãos novos) e vecchi cristiani (cristãos velhos), secondo una terminolo-gia che, non senza una palese contraddizione, si impose da subito; la proibizione di lasciare liberamente il regno, stabilita nel 1499 e abolita nel 1507, sempre in seguito al massacro di Lisbona, e poi più volte reintrodotta nel corso del secolo38; le azioni di violenza di cui i nuovi cristiani furono periodicamente fatti bersaglio, che raggiunsero il culmine nel massacro di Lisbona, avvenuto nell’aprile del 1506. In seguito a un presunto episodio di miscredenza che vide protagonista
37 Il testo del decreto del 13 marzo 1507 è pubblicato in P. Monteiro, História da Santa Inquisição do Reyno de Portugal e suas Conquistas. Primeira parte, 2 voll., Lisboa, regia Officina Sylviana 1749-1750, II, pp. 430-431. Il privilegio del 21 aprile 1512 è incluso nel decreto di conferma emesso il 18 luglio 1522, che si trova in ANTT,
Chancelaria de D. João III, Livro 1, f. 44v. Il documento è segnalato da Herculano, História cit., I, p. 152 nota 68.
38 La proibizione del 1499 è pubblicata in appendice a Tavares, Judaísmo cit., pp. 193-194. La legge del 1 marzo 1507 si trova edita in Y.H. Yerushalmi, The Lisbon massacre of 1506 and the Royal Image in the Shebet Yehudah, Cincinnati, Hebrew Union College 1976, pp. 87-89.
363 «... per capillos adductos ad pillam»
un nuovo cristiano, la popolazione dei vecchi cristiani di Lisbona, assistita anche da numerosi marinai stranieri presenti in città e istiga-ta dagli infuocati sermoni di alcuni padri domenicani, dette sfogo con inaudita violenza alla propria ostilità e intolleranza verso i conversos, lasciando sul terreno dopo alcuni giorni di mattanza diverse centinaia di nuovi cristiani39. Il massacro di Lisbona, magistralmente studiato alcuni decenni fa da Yosef Hayim Yerushalmi, concluse il decennio di gestazione del nuovo equilibrio religioso portoghese, segnando la rot-tura definitiva rispetto alla tradizione medievale di relativa tolleranza e coesistenza pacifica tra fedi diverse all’interno del regno lusitano40. Agli occhi dei nuovi cristiani apparve così evidente che si era ormai dissolta ogni ambiguità e chiusa ogni speranza di poter trarre qualche vantaggio dalla propria nuova condizione religiosa e sociale. Durante gli anni 1497-1506 si delineò, dunque, in maniera concreta una stra-tegia a suo modo già esplicitata dalle modalità con cui era avvenuto il battesimo forzato. Intenzione di D. Manuel non era solo quella di eliminare la religione ebraica dal Portogallo, ma anche quella di costringere con ogni mezzo l’intera popolazione di origine ebraica a rimanere entro i confini del regno sotto le nuove spoglie di cristiani. Questo fenomeno è ciò che contraddistinse tanto dal punto di vista fattuale, quanto da quello teologico e giuridico il caso lusitano, che si pose dunque come assolutamente unico nel panorama del mondo cristiano fra la fine del medioevo e la prima età moderna.
5. L’eccezionalità dell’episodio e l’estrema difficoltà nel ricostrui-re l’esatta dinamica di una vicenda che tendeva a sfuggire, per la
39 L’ordine domenicano fu duramente punito dal sovrano per il ruolo svolto da alcuni suoi membri in occasione del massacro di Lisbona. Il convento di S. Domenico di Lisbona fu temporaneamente chiuso e due frati, in particolare, ven-nero condannati a morte e arsi sul rogo per le pesanti responsabilità che avevano avuto nell’episodio. Un terzo domenicano, invece, riuscì a fuggire e morì in stato di scomunica nel 1509 ad Arzila, all’epoca sotto la dominazione portoghese, durante un assedio posto alla città dai mori. Sulla figura di questo terzo frate, cfr. R. Ricard, Apuntes para la história eclesiástica de Arzila y Tánger durante la dominación portuguesa, in «Archivo Ibero-Americano», s. II, I, 1941, pp. 56-75 in part. p. 60 e nota 26.
40 Cfr. Yerushalmi, The Lisbon massacre cit.
364 Giuseppe Marcocci
propria disomogeneità, a una lettura univoca, furono alla base della lunga e stratificata riflessione che per tutto il Cinquecento, sebbene con diversa intensità e rilevanza, si sviluppò sul battesimo forzato degli ebrei in Portogallo. Da un lato, infatti, si tentò di esprimere un giudizio complessivo e unitario nei confronti di un episodio colletti-vo che aveva riguardato l’intera comunità ebraica lusitana; dall’altro era chiaro a chiunque che ciò era in realtà impossibile, perché il sacramento del battesimo rimandava a elementi di carattere indivi-duale quali la volontà personale e la libera scelta, e dunque sarebbe stato necessario valutare caso per caso come i fatti si erano svolti esattamente. Ricostruzione storica e interpretazione teologica e giuridica si intrecciarono dunque da subito nel confronto che si aprì sulla validità del battesimo somministrato agli ebrei in Portogallo.
Un aspetto, tuttavia, che non cessa di sorprendere, è il silenzio che accompagnò la vicenda nei primi decenni che ad essa segui-rono. Nessuna voce di esplicita condanna si levò all’interno del mondo cristiano, neppure, come sarebbe stato da attendersi, da parte di esponenti della Chiesa. Se qualche pronunciamento vi fu, in Portogallo o da parte della curia romana, pare che esso non abbia lasciato traccia41. Occorre infatti arrivare fino al 1530, come ha rile-vato Yerushalmi, per incontrare un riferimento diretto al battesimo forzato degli ebrei portoghesi nei documenti ufficiali della Chiesa42. Si tratta del breve di indulgenza papale rilasciato il 20 maggio a Shlomo Molcho, un nuovo cristiano portoghese la cui vicenda aveva destato scalpore alcuni anni prima. Profondamente affasci-nato dalla figura di David Reubeni, il presunto messia che nel corso delle peregrinazioni per l’Europa era giunto in Portogallo nel 1525, Molcho, che all’epoca si chiamava ancora Diogo Pires ed era un giovane segretario alla corte del re D. João III, risolse di tornare pub-
41 Qualche elemento tuttavia in A. Foa, Un vescovo marrano: il processo a Pedro de Aranda (Roma 1498), in «Quaderni Storici», XXXIII, 1998, pp. 533-551.
42 Cfr. Id., Prolegomenon, in A. Herculano, History of the Origin and Establishment of the Inquisition in Portugal, New York, Ktav Publishing House 1972, pp. 7-55, in part. p. 32 nota 32. La questione è stata recentemente ripresa da A. Foa, Converts and Conversos in Sixteenth-Century Italy. Marranos in Rome, in The Jews of Italy: memory and identity, eds. B.D. Cooperman, B. Garvin, Bethesda, University of Maryland 2000, pp. 109-129, in part. pp. 115-118.
365 «... per capillos adductos ad pillam»
blicamente all’ebraismo, determinando la caduta in disgrazia presso il sovrano dello stesso Reubeni. Fuggito dal Portogallo, Molcho si recò in Oriente e negli anni seguenti viaggiò poi attraverso l’Europa, acclamato anch’egli come messia, fino a trovare la morte sul rogo a Mantova nel 153243. Nonostante la durezza con cui venne condan-nata la conversione di Molcho in Portogallo, egli godette comunque di un certo favore presso il pontefice, che infatti nel breve nel 1530 si spinse a dichiarare in sostanza nullo il battesimo che gli era stato impartito. Scriveva Clemente VII:
Cum, sicut nobis nuper exponi fecisti, licet tu, in puerili etate constitutus, invitus sacrum baptismum susceperis, nunquam tamen fidem Catholicam credideris, nec unquam in alia lege quam Hebrea vixeris, neque vivere intendas, Nos, attendentes sedi apostolice convenire Hebreis eo libentius benignitatis sue gremium patefacere, quo specialius sint in testimonium orthodoxe fidei reservati, petitionibus tuis, quantum nobis licet, favorabili-ter annuere volentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, quod propterea a quoquam, quavis auctoritate, absque speciali mandato nostro, molestari minime possis, auctoritate apostolica, tenore praesentium indulgemus44.
Si osservi che nel breve concesso a Molcho si parlava di baptismum invite susceptum, senza accenno alcuno alla violenza, né alla distin-zione tra vis conditionalis e vis absoluta. Inoltre l’indulgenza concessa da Clemente VII costituiva pur sempre un provvedimento ad perso-nam, anche se fornisce un chiaro segnale dei dubbi esistenti a Roma in merito alla legittimità di quanto era avvenuto in Portogallo nel 1497. Il primo momento, invece, in cui emerse un vero confronto e una discussione elaborata e compiuta sul battesimo degli ebrei porto-ghesi fu in occasione dello scontro che oppose la corte lusitana alla curia romana all’inizio degli anni Trenta in merito alla concessione del Sant’Uffizio in Portogallo e, in seguito, alla promulgazione di un perdono generale, o tempus gratiae amplissimum, in favore degli eretici portoghesi o presenti in terra lusitana. Il dibattito che si
43 Sulle vicende di Molcho e Reubeni, cfr. L. Sestieri, David Reubeni. Un ebreo d’Arabia in missione segreta nell’Europa del ’500, Genova, Marietti 1991.
44 Il breve Cum, sicut nobis è pubblicato in Simonsohn, The Apostolic See cit., IV, doc. 1487, pp. 1792-1793.
366 Giuseppe Marcocci
aprì e gli esiti che esso ebbe rivestirono un’importanza decisiva per la vita religiosa e sociale interna del Portogallo e per la storia del marranesimo45.
Già nell’imminenza della prima concessione dell’Inquisizione, con la bolla Cum ad nihil magis del 17 dicembre 1531, una parte del clero lusitano, incaricata di vigilare sull’ortodossia religiosa, tende-va ad agire a parziale tutela della minoranza conversa, sulla base di considerazioni di natura teologica e canonistica che conducevano alla negazione della validità del battesimo ricevuto da molti ebrei portoghesi. Un esempio è rappresentato dalla sentenza emessa nel 1531 dal tribunale diocesano di Silves, in Algarve, nel processo contro il nuovo cristiano Jorge Afonso di Loule46. Una copia della sentenza ci è stata tramandata perché in seguito venne usata dai procuratori dei nuovi cristiani a Roma per provare la veridicità delle proprie argomentazioni contro i fautori del Sant’Uffizio47. Il
45 Sul lungo scontro diplomatico che oppose la curia romana alla corte lusitana fra 1531 e 1536 intorno alla concessione del Sant’Uffizio in Portogallo e alla promul-gazione di un perdono generale resta ancora fondamentale la ricostruzione classica di Herculano, História cit., I, pp. 212-260; II, pp. 11-150.
46 Si tratta degli atti del processo contro Jorge Afonso di Loule, meglio noti come la sentenza Coutinho, dal nome dell’allora vescovo dell’Algarve. Sul documento cfr. ibid., I, pp. 120-121; 208-211. Herculano usò la copia settecentesca conservata in Biblioteca da Ajuda de Lisboa (d’ora in avanti BdA), cod. 46-X-14, Symmicta Lusitanica, XXXI, ff. 73v-81, ma l’apografo cinquecentesco, da cui qui si cita, si trova in Archivio Segreto Vaticano (d’ora in avanti ASV), Fondo Borghese, Serie I, n. 893, ff. 41v-45, e si pubblica nell’appendice documentaria a cui rinvio per una più approfondita presentazione del documento.
47 Una copia degli atti processuali venne eseguita su richiesta di Jorge Afonso di Loule il 16 giugno 1534 presso il tribunale diocesano di Silves e ratificata il 3 luglio 1534 a Évora presso il notaio apostolico Iulianus Chalumela, sulla base delle deposizioni di testimoni fededegni (cfr. ibid., ff. 45-46v). Una lettera dell’amba-sciatore portoghese a Roma ci informa poi che alla fine dell’inverno successivo il documento circolava negli ambienti della curia come prova addotta a sostegno delle proprie posizioni dai procuratori dei nuovi cristiani: «estes procuradores dos christãos novos lhes [ai cardinali e ai consultori romani] apresentarem hum privile-gio, que lhe deu el Rei que Deos aja e Vossa Alteza confirmou, e hum estromento com huma resposta do bispo do Algarve» (Lettera di D. Martinho de Portugal a D.
367 «... per capillos adductos ad pillam»
giudizio che nella sentenza veniva fornito a proposito del battesimo forzato è fra le condanne più nette e radicali di cui si abbia notizia. I nuovi cristiani accusati di giudaizzare, vi si legge, erano ebrei, non cristiani. Il battesimo era stato loro imposto con la forza e dunque non era valido. L’importanza della posizione espressa nella sentenza è ancor più notevole se si tiene presente che essa fu pronunciata da un testimone d’eccezione del battesimo forzato, in quanto protagonista dello scontro nel consiglio del re quando si era discusso dell’editto di espulsione e di conversione degli ebrei: si tratta di Fernando Coutinho, vescovo dell’Algarve dal 150248. La vicenda giudiziaria di Jorge Afonso conobbe diverse fasi. L’imputato fu arrestato per avere proferito affermazioni contro la Vergine Maria. Il modo in cui furo-no condotte le indagini spinse quindi il vescovo a interrompere il
João III, Roma, 14 marzo 1535, pubblicata in Corpo Diplomatico Portuguez conten-do as actas e relações politicas e diplomaticas de Portugal com as diversas potencias do mundo [d’ora in avanti CDP], 15 voll., Lisboa, Typographia da Academia Real das Sciencias 1862-1936, III, pp. 181-191, in part. p. 183; ora anche in As Gavetas cit., I, pp. 166-176). Il «privilegio» a cui accenna D. Martinho de Portugal dovrebbe essere la Lex Ioannis Regis che si trova in ASV, Fondo Borghese, Serie I, n. 893, ff. 46v-48, subito dopo la sentenza di Coutinho. Entrambi i documenti, infatti, furo-no poi inseriti come allegato n. 1 al Memoriale porrectum a noviter conversis Regni Portugalliae, continens narrativam rerum gestarum, circa eos a regibus, et Inquisitoribus illius Regni spatio 48 annorum, presentato a Roma nel 1544 dai procuratori dei nuovi cristiani (su cui cfr. Herculano, História cit., III, p. 100 nota 1), che si trova ibid., ff. 7-33, e che insieme a tutti gli allegati compone il codice intitolato Monumenta ad S. Inquisitionis Tribunal in Regno Portugalliae pertinentia, di cui si possiede una copia cinquecentesca (ASV, Fondo Borghese, Serie I, n. 893), riprodotta nei tomi XXXI-XXXII della Symmicta Lusitanica (BdA, codd. 46-X-14 e 46-X-15), una voluminosa raccolta di copie di documenti romani relativi al Portogallo ordinata nel Settecento da D. João V, su cui cfr. A. Herculano, A Symmicta Lusitana, in «Archivo Historico Portuguez», I, 1903, pp. 369-370.
48 Sull’attività diocesana di Coutinho in Algarve, cfr. J.B. da Silva Lopes,
Memorias para a História Ecclesiastica do Bispado do Algarve, Lisboa, Typographia da Academia Real das Sciencias, 1848, pp. 293-309; F. de Almeida, História da Igreja em Portugal, 4 voll., Porto-Lisboa, Portucalense Editora, Livraria Civilização, 1967-19712 [ed. or. Coimbra 1910-1921], II, p. 653; sull’azione dei tribunali diocesani portoghesi in materia di eresia cripto-giudaica nella prima metà degli anni Trenta, cfr. Tavares, Judaísmo cit., pp. 149-151.
368 Giuseppe Marcocci
procedimento, trasmettendo il caso al tribunale del cardinale infante D. Afonso, con una motivazione in cui non celava il richiamo alle proprie antiche battaglie:
Ego non sum nec possum esse iudex in isto casu quoniam tempore regis Ioannis quem Deus habet, et postea tempore Regis Emanuelis semper fui in consiliis ubi tractatum fuit praecipue an possent isti fieri Christiani median-te ista violentia amissionis bonorum et etiam personae, et omnes litterati fuerunt quod non et ego insapientior omnibus monstravi plurimas auctori-tates et iura quod non poterant cogi ad suscipiendam Christianitatem quae vult et petit libertatem, et non violentiam, et licet ista non fuerit praecisa, scilicet cum pungionibus in pectora, satis tum violentia fuit quoniam Rex voluit dicendo quod pro sua devotione hoc faciebat et non curabat de iuri-bus49.
Coutinho insisteva sulla devotio di D. Manuel, analoga allo zelus di Sisebuto, il riferimento al quale era ormai entrato a far parte della tradizione, e non vi sono dubbi che il termine assumesse nella sentenza del vescovo dell’Algarve una connotazione quanto meno sospetta e ambigua perché in contrasto con il diritto e la giustizia. I giudici del cardinale infante D. Afonso decisero di rimettere nuo-vamente il caso a Coutinho perché si pronunciasse come riteneva opportuno. Anche nella sentenza finale, il vescovo tornò a ricorda-re che i consiglieri del re contrari all’editto di espulsione avevano sostenuto che gli ebrei
non poterant nec debebant Christianis effici cum modis violentibus prout multos vidi per capillos adductos ad pillam et patrem filium adducentem cooperto capite cum capuchis in signum maximae tristitiae et doloris ad pillam baptismatis, protestando et Deum in testem accipiendo quod vole-bant mori in lege Moysi et alia magna exhorbitantia, sed Rex voluit dicendo quod hoc in devotionem habebat, et sua voluntas satis fuit praecisa et vio-lenta ad subditos suos aut servos corporales quia in spiritualitate scilicet in baptismo solum Deum habebant in Dominum ut caracter imprimeretur et res sacramentalis et sic liberatio a peccato originali.
49 Seconda sentenza interlocutoria del processo contro Jorge Afonso di Loule (1531), in ASV, Fondo Borghese, Serie I, n. 893, f. 43v.
369 «... per capillos adductos ad pillam»
Pertanto, proseguiva Coutinho, egli e gli altri giudici che condivi-devano la sua posizione «eos Iudaeos reputabant et non haereticos, et nunc qui coram me comparent tamquam Christianos habeo. Sed quando ad aures meas devenit aliquid hebraicae sectae Iudaeos et non haereticos reputo»50.
La durezza della parole di Coutinho, tuttavia, non significava che egli avesse una posizione indulgente verso i nuovi cristiani. Il vesco-vo dell’Algarve non guardava affatto con favore all’ipocrisia della realtà religiosa portoghese. Anzi, considerava un grave scandalo che un cospicuo numero di ebrei continuassero ad osservare la propria antica fede sotto le sembianze di cristiani, ma, consapevole dell’il-legittimità del battesimo forzato, rifiutava una soluzione giudiziaria del problema51. Occorreva distinguere fra chi era ancora ebreo e chi si era invece sinceramente convertito. Pertanto i nuovi cristiani non dovevano interpretare la sentenza come un’autorizzazione alla libertà di coscienza. Essa rappresentava piuttosto un severo monito contro la condotta delle autorità politiche e religiose del regno. In tal senso si comprende la conclusione della sentenza finale, in cui Coutinho dichiarava: «haec mea pronuntiatio rumpatur quia multi novi Christiani accipient ex hoc fidem ad exonerandas conscientias et legem et alios tedet qui regunt oppida atque provincias Regni»52. Una conferma che tale fosse la posizione di Coutinho proviene anche da un fatto narrato nella cronaca di D. João III di Gaspar
50 Sentenza finale del processo contro Jorge Afonso di Loule (1531), ibid., f. 43.51 La posizione espressa da Coutinho è tipica di un settore dell’episcopato por-
toghese che, in varie forme, fino alla fine del Cinquecento mantenne serie riserve verso l’Inquisizione e rivendicò un maggiore spazio di autonomia nella gestione dei reati di eresia. Su questo tema mi permetto di rinviare agli studi dello scrivente: “Catequização pelo medo”? Inquisitori, vescovi e confessori di fronte ai “nuovi cristiani” nel Portogallo del Cinquecento, in «Atti dei Convegni Lincei», CXCI, Le Inquisizioni cri-stiane e gli Ebrei, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei 2003, pp. 123-193; I custodi dell’ortodossia cit., pp. 46-48, 63-65, 155-235, 337-354. Ma cfr. anche J.P. Paiva, Les évêques et l’Inquisition portugaise (1536-1613), in Inquisition et pouvoir, sous la direction de G. Audisio, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence 2004, pp. 147-169, in cui al contrario si ripropone la tesi di una stretta e piena collaborazione fra vescovi e inquisitori sin dagli anni di nascita e formazione del Sant’Uffizio.
52 Sentenza finale del processo contro Jorge Afonso di Loule (1531), in ASV, Fondo Borghese, Serie I, n. 893, f. 43v.
370 Giuseppe Marcocci
Correia. Durante l’anno 1532 si diffuse la fama di una fanciulla che pronunciava terribili profezie sulla fede e su Cristo. Il grande concorso di gente presso di lei indusse anche Coutinho a recarsi in visita alla casa della fanciulla per incontrarla. La cronaca racconta che il vescovo
trascorse con lei un giorno intero e quando uscì lo fece fra le lacrime. Scrisse al re le grandi cose che aveva passato con la fanciulla e come ella dicesse a gran voce che i mali che c’erano allora in Portogallo, terremoti, peste e fame, Dio li permetteva a causa dei peccati dei nuovi cristiani che avevano fama a quell’epoca di tenere sinagoghe segrete a Lisbona e mai in nessun tempo vi fu regno alcuno che fosse a tal punto ordinato e retto da nuovi cri-stiani come lo era allora il Portogallo. E si disse che il vescovo dell’Algarve scrisse al re che quanto era accaduto sino ad allora non era niente rispetto a quello che Dio doveva fare a causa dei peccati commessi dai nuovi cristiani in Portogallo53.
Nello stesso anno 1532, il 17 ottobre, con il breve Venerabilis frater venne sospesa l’Inquisizione, che comunque non era mai entrata in funzione nei dieci mesi precedenti54. Il provvedimento venne con-fermato anche dalla bolla Sempiterno Regi del 7 aprile 1533 con cui Clemente VII concesse il perdono generale ai nuovi cristiani. Nella bolla, come è stato rilevato, è contenuta la condanna ufficiale più esplicita, sebbene comunque parziale, espressa dalla curia romana sull’episodio del battesimo forzato in Portogallo55. Il pontefice, che dichiarava di essere venuto a conoscenza della realtà lusitana «non
53 G. Correia, Crónicas de D. Manuel e de D. João III (Até 1533), Leitura, Introdução, Notas e Índice por J. Pereira da Costa, Lisboa, Academia das Ciências 1992, p. 304 (la traduzione dal portoghese è mia).
54 Il breve Venerabilis frater inviato da papa Clemente VII al nunzio in Portogallo Marco Vigerio della Rovere, vescovo di Sinigaglia, è pubblicato in CDP, II, p. 409; ora anche in Simonsohn,The Apostolic See cit., IV, doc. 1565, pp. 1840-1841.
55 Cfr. J. Mendes dos Remédios, Os Judeus e os perdões gerais. De D. Manoel ao Cardeal-Rei, in «Biblos», I, 1925, pp. 631-655; Yerushalmi, Prolegomenon cit., pp. 31-34; Simonsohn, The Apostolic See cit., VII, (History), p. 244; K.R. Stow, Ebrei e Inquisitori. 1250-1350, in L’Inquisizione e gli ebrei cit., pp. 3-18, in part. p. 16.
371 «... per capillos adductos ad pillam»
sine gravi mentis […] perturbatione», distingueva fra coloro che «ad fidem Christi et illius sacrum baptisma suscipiendum coacti fuerant» e coloro che erano stati «sponte sua conversi». Fra i primi si com-prendavano anche quanti «inter ecclesiae membra, propterea quod violenter baptizati fuerunt, numerari non debent», lasciando così chiaramente intendere che avessero ricevuto il sacramento per vim praecisam et absolutam56.
I fondamenti giuridici che sorreggevano l’interpretazione del battesimo forzato nella bolla di Clemente VII devono essere ricer-cati in una serie di pareri e consulti richiesti nei mesi precedenti dal pontefice ad alcuni fra i principali esponenti del mondo del diritto accademico italiano dell’epoca. Di loro conosciamo i nomi di Agostino Berò, professore di diritto canonico a Bologna, Filippo Decio, professore di diritto civile a Siena, e, secondo quanto riferi-sce José Amador de los Ríos, anche del celebre giurista e umanista Andrea Alciati, che proprio nel 1533 fece ritorno da Bourges in Italia, ottenendo la cattedra di Pavia57. Ma il consultore che ebbe maggior rilievo fu Pietro Paolo Parisio, un importante personaggio
56 La bolla Sempiterno regi fu pubblicata già nel Collectorio de diversas letras apostoli-cas, provisões reaes, e outros papeis, em que se contém a Instituyção, & primeiro progres-so do Sancto Officio em Portugal, & varios Privilegios que os Summos Pontifices & Reys deste Reynos lhe concederão, Lisboa, nas casas da Sancta Inquisição 1596, ff. 21-25v; ora anche in Simonsohn, The Apostolic See cit., IV, doc. 1601, pp. 1856-1864.
57 Su Agostino Berò (1474-1554) e Filippo Decio (1454-1535/6), cfr. le voci cura-te rispettivamente da F. Sinatti D’amico, in Dizionario Biografico degli Italiani (d’ora in avanti DBI), IX, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani 1967, pp. 379-380, e da A. Mazzacane, ibid., XXXIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani 1987, pp. 554-560. Non ho trovato sinora conferme invece di una partecipazione diretta di Andrea Alciati (1492-1550) alle consultazioni promosse dalla curia romana, secondo quanto invece scrive, senza però citare la propria fonte, Amador de los Ríos, História cit., III, p. 360 nota 1. Alciati avrebbe sostenuto «de ratione et de jure, que no habian incurrido en censura alguna los judios, pues que sólo habian cedido al hecho de la fuerza, al recibir violentemente el bautismo». Dalla nota di Amador de los Ríos, del resto, non risulta neppure chiaro quale fosse il papa dal quale Alciati sarebbe stato sollecitato a fornire un proprio parere intorno alla questione dei nuovi cristiani por-toghesi. Su Alciati, cfr. la voce curata da R. Abbondanza, in DBI, II, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani 1960, pp. 69-77.
372 Giuseppe Marcocci
del tempo, la cui figura sotto molto aspetti resta ancora poco nota. Al tempo delle consultazioni promosse da Clemente VII, Parisio insegnava diritto civile a Bologna e in seguito fu protagonista di una rapida e brillante carriera all’interno delle strutture ecclesiastiche, tutta condotta all’ombra di Paolo III: nel 1536 lasciò l’insegnamento universitario per trasferirsi a Roma dove fu nominato uditore gene-rale della Camera Apostolica; nel 1539 venne promosso cardinale; nel 1542, alla creazione del Sant’Uffizio romano, fu uno dei sei cardinali inquisitori eletti dal pontefice per presiedere la nuova con-gregazione e nell’ottobre dello stesso anno venne scelto, insieme ai cardinali Reginald Pole e Giovanni Morone, come legato pontificio a Trento dove fervevano i preparativi per l’apertura del concilio, che sfumò tuttavia anche in tale occasione58. In merito alla questione della liceità della conversione degli ebrei, Parisio si collocava su un versante opposto rispetto alla corrente di giuristi, pure di altissimo livello, che nei decenni del primo Cinquecento, difendevano una radicale e intransigente politica conversionistica. Si può prendere ad esempio la figura del legista tedesco Ulrich Zasius, docente all’uni-versità di Friburgo. Nelle Quaestiones de parvulis Iudaeorum baptisan-dis (1508), composte in seguito al caso del battesimo di un fanciullo ebreo invito patre realmente avvenuto nella sua città e che aveva poi dato avvio a un acceso dibattito pubblico, Zasius aveva duramente attaccato la tradizione tomista e si era schierato per la validità delle conclusioni di Scoto: «Parvuli Iudaeorum per terrarum principes, invitis etiam a patribus auferendi, et baptismi sacramento in viam
58 Su Pietro Paolo Parisio (1473 ca.-1545), cfr. la voce curata da F.L. Berra, in Novissimo Digesto Italiano, XII, diretto da A. Azara e E. Eula, Torino, UTET 1965, p. 398. Secondo quanto scrive Herculano, Parisio, ormai divenuto cardinale, all’inizio degli anni Quaranta avrebbe agito presso la curia in favore dei procuratori dei nuovi cristiani portoghesi in cambio di denaro (História cit., II, p. 281; III, pp. 94-95). Sulla nomina di Parisio a cardinale inquisitore del Sant’Uffizio romano, cfr. L. von Pastor, Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo, V, Paolo III (1534-1549), Roma, Desclée e C.i Editori Pontifici 1931, pp. 673-675. La scelta di Parisio come legato papale al concilio di Trento avvenne, a giudizio di Sarpi, proprio grazie alle sue doti di «dotto e pratico canonista» (P. Sarpi, Istoria del Concilio Tridentino, seguita dalla Vita del padre Paolo di Fulgenzio Micanzio, a cura di C. Vivanti, Torino, Einaudi 1974, p. 175).
373 «... per capillos adductos ad pillam»
salutis regenerandi sunt, cautione pro viribus adhibita, ne ex hoc homicidia sequantur»59. Tornando a Parisio, egli compose anzitutto insieme a Berò un memoriale in cui ricostruiva la vicenda degli ebrei portoghesi fino alla recente sospensione della bolla dell’Inquisizione. Sul battesimo forzato l’episodio veniva così riassunto:
In Regnis et Dominiis Regni Portugalliae, et Algarbiorum erant plures Iudaei mares et foeminae quos Rex Emanuel praeclarae memoriae decre-vit ad nostram Catholicam fidem convertere. Sunt iam triginta quinque anni elapsi circiter, et licet alias bono sancto fideique consonanti zelo (uti Christianissimus) rem ita sanctam facere proposuisset, ipsos tamen omnes pro maiori parte Christanos fecit anno millesimo quadringentesimo nona-gesimo septimo vel circa, mediis sequentibus.Primo mandavit quod omnes filii, tam masculi quam foeminae, minores aetate, a patribus seu matribus caperentur et Christiani fierent. Qui omnes pro maiori parte sic capti, ipsis contradicentibus, proclamantibus et prote-stantibus, Christiani facti fuerunt.Patres vero et matres caeterosque pene omnes per vim praecisam a sola nominis impositione aquaeque benedictae sparsione Christianos fecerunt et nuncuparunt; multi enim per metum et compulsionem, non tamen praecise ad fidem conversi fuerunt60.
Dunque la descrizione di Parisio e Berò era piuttosto lineare. Nel 1497 in Portogallo si era consumato il battesimo forzato della maggior parte degli ebrei presenti nel regno. Il sovrano aveva agito per zelus, ma secondo modalità ben precise: amministrando il batte-
59 Il trattatello venne ripubblicato con il titolo De Iudaeis Quaestiones tres nel-l’Operum Dn. Udalrici Zasii Iureconsulti clarissimi Tomus Quintus […], Francof. ad Moen., impensis Sigis. Feyrabendij MDLXXX, pp. 102-118, da cui cito. Il passo riportato nel testo si trova a p. 105.
60 Consilia Reverendissimi Parisii ac D. Augustini Veroi (1533), in ASV, Fondo Borghese, Serie I, n. 893, ff. 123-131, in part. f. 123r-v. Il documento si trova nei Monumenta ad S. Inquisitionis Tribunal in Regno Portugalliae pertinentia, e fa parte dell’allegato n. 13 al Memoriale porrectum a noviter conversis Regni Portugalliae, con-tinens narratione rerum gestarum, circa eos a regibus, et Inquisitoribus illius Regni spatio 48 annorum (1544).
374 Giuseppe Marcocci
simo agli infanti invitis parentibus e costringendo poi con la violenza anche gli adulti a ricevere il sacramento. Sul carattere violento del battesimo portoghese non sussistevano dubbi, tuttavia occorreva distinguere fra i casi di vis praecisa e i casi, anch’essi verificatisi in buon numero, di ebrei battezzati con costrizioni e minacce, ma non fatti oggetto di una violenza assoluta.
Quindi, terminata la sezione storica, venivano posti tredici dubbi relativi alla questione degli ebrei portoghesi. Ad essi Parisio rispose in un parere databile sempre al 1533, approvato e controfirmato anche da Filippo Decio, che avrebbe conosciuto una larga fortuna perché inserito nell’edizione dei propri consulti, pubblicati per la prima volta a Venezia nel 154361. Si tratta di un testo giuridico di estremo interesse, non solo per il dibattito sulla validità del battesi-mo forzato degli ebrei, ma anche per la discussione sulla legittimità dell’azione inquisitoriale nei confronti dei nuovi cristiani che veniva svolta nella seconda parte del consulto. Qui di seguito, tuttavia, ci limiteremo ad esaminare la posizione di Parisio riguardo ai fatti del 1496-1497, in particolare in merito alla validità del battesimo forza-to. Dopo avere ricordato che è compito del pontefice proteggere gli
61 Cfr. Quartum Volumen Consiliorum, ac Responsorum Petri Pauli Parisij Consentini, Pontificij, Caesareique Iuris Consultissimi, ob eximiam, ac singularem doctrinam, atque virtutem a Paulo III Pont. Max. Cardinalatus Honore Decorati. Ex archetypo nunc primum in lucem aeditum. Pontificio, Caesareo, Francorumque Regis, venetorum Illustr. Senatus, privilegiis munitum, Venetiis, Apud Aurelium Pincium 1543, cons. II, ff. 5-11v. Una versione manoscritta del parere si trova in ASV, Fondo Borghese, Serie I, n. 893, ff. 154-200. È in fondo a questa versione che si legge l’approvazione di Filippo Decio («Ut supra dictum est et conclusum fuit per Excellentissimum Dominum Petrum Paulum Parisium dico esse de iure, ego Philippus Decius Mediolanensis utriusque iuris doctor hic Senis Iura civilia legens et in fidem mea propria manu subscripsi, et sigillum consuetum apposui saniori iudicio reservato, ad laudem Dei Omnipotentis», ff. 199v-200). L’importanza del consulto di Parisio è stata recente-mente sottolineata da K.R. Stow, Church, Conversion, and Tradition: The Problem of Jewish Conversion in Sixteenth Century Italy, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», II, 1996, pp. 25-34, in part. pp. 27-28, rilevando come la sua posizione venisse ripresa anche da Marquardo de Susannis, l’autore del trattato De Iudaeis et aliis Infidelibus (Venezia 1558), su cui cfr. il fondamentale studio dello stesso Stow, Catholic Thought and Papal Jewry Policy 1555-1593, New York, The Jewish Theological Seminary 1977.
375 «... per capillos adductos ad pillam»
ebrei, il futuro cardinale continuava ad argomentare affrontando la questione dei poteri delle autorità secolari in materia di espulsione degli ebrei e sostenendo che
Reges, seu Principes, sine aliqua iusta causa non debere expellere de eorum regnis iudeos in illis habitantes, et capere ipsorum bona, et si istud faciunt non carent peccato, quando sine causa, et iusta prosequuntur. Et Summus Pontifex persuadere debet Principibus ne istud faciant, quinimmo secundum aliquos precipere, secundum veram, et magis communem opinionem, licet aliqui contrarium tenuerint […]62.
Evidentemente Parisio negava che la speranza della conversione fosse da considerare fra le iustae causae per espellere gli ebrei dal pro-prio regno per via della violenza che tale provvedimento conteneva. Circa l’uso della forza per indurre gli ebrei ad accogliere la fede cri-stiana Parisio dichiarava in modo perentorio e senza mediazioni:
iudeos adultos violenter non esse compellendos et cogendos ad fidem susci-piendam et baptismum. c. sicut. et ibi omnes tradunt, de iude. c. maiores. versi. item queritur. extra de baptis. et ibi omnes firmant quando coactio et vis fuit precisa, et non conditionalis, per quam etiam caracter non impri-mitur, cum potius ille dicatur pati, quam agere c. satis. quod met. cau. et traditur per docto. in d. c. qui sinceram. et in d. c. de iudeis. xlv. distinct. et sentit sanctus doct. ii. ii. quest. x.63.
Fra le altre autorità a proprio sostegno Parisio allegava anche il giurista trecentesco Alberico da Rosate, «expresse volens quod quando aliquis reclamans immergitur violenter, et bapizatur non recipit sacramentum nec rem sacramenti»64. Pertanto, continuava il parere, il battesimo coatto per vim praecisam non era valido:
Militem. n. voluntarium recipit ipse Deus, et non invitem et precise coac-tum, quinimo volentes non statim sunt baptizandi, sed per tempus expectare
62 Quartum Volumen Consiliorum cit., cons. II, nn. 15-16, f. 6.63 Ibid., n. 17, f. 6v. 64 Ibid.
376 Giuseppe Marcocci
debent, ne facile ad vomitum perfidie redeant […]. Unde taliter per vim precisam baptizati non possunt dici christiani, nec fidem christianam tenen-tur servare […]65.
Chiarito il proprio orientamento generale in materia di battesimo forzato degli ebrei, Parisio affrontava finalmente lo specifico caso portoghese sul quale era stato chiamato ad esprimere la sua opinio-ne. Il duro giudizio del professore bolognese costituiva una condanna senza appello. Parisio iniziava da coloro che erano stati oggetto di una indubbia vis praecisa:
illi iudaei adulti, per vim precisam tempore regis emanuelis bo. memo. inviti et reclamantes baptizati per talem baptismum non fuerunt effecti christia-ni, nec sacramentum nec rem sacramenti receperunt nec caracterem. Eo etiam cum in aliquibus ipsorum non appareat fuisse servatam formam in dicto sacramento requisitam et necessariam […]. Eo insuper cum aliqui proclamantes et protestantes per vim precisam tracti et ducti fuerunt ad valvas ecclesiarum et sola impositione nominis et aspersione aque benedicte christiani noncupati fuerint contra omnem formam a iure in predicto sacra-mento traditam et requisitam […]66.
Ma anche nei casi la cui definizione teologica era dubbia, non potevano sussistere attenuanti per la violenza usata agli ebrei por-toghesi. Di questo aspetto Parisio forniva una lettura originale ed estrema, ribattendo recisamente alle argomentazioni dei fautori del-l’instaurazione del Sant’Uffizio in Portogallo: «advertendum insuper est, quod licet talis precisa coactio apparerert purgata» – ad esempio in seguito al fatto che «taliter baptizati per longum temporis spacium nihil in contrarium dixerunt, sed taciti permanserunt» –,
vel aliqui predictorum ad fidem fuerint conversi per coactionem conditiona-lem et violentiam non precisam et consequenter in tali sacramento et ipsius susceptione dicatur intervenisse voluntas coacta saltim, tamen inficiari minime poterit, quin ad talem conversionem non dicantur fuisse inducti per
65 Ibid., n. 20, f. 6v.66 Ibid., nn. 23-24, f. 6v.
377 «... per capillos adductos ad pillam»
metum, fraudem, et modum a iure reprobatum et contrarium libere volunta-ti et libero consensui […]67.
Quella portoghese era dunque una conversione illegittima perché estorta secondo metodi contrari al diritto, con l’inganno e con la paura, violando il principio della libera scelta della fede. «Eo maxi-me», incalzava Parisio,
quando metus inducitur per regem et supremum principem et per pre-ceptum ipsius, uti constat in presenti casu considerato regio precepto et generali disponente ispos iudaeos omnes e regnis suis exire debere, et in illis moram non trahere ad istum finem tendente […]. Et potissimum quando ultra metum intervenisset protestatio […]. Et ultra dictum primum regium preceptum, si consideramus subsequentia precepta regia oblationes et pro-missiones eis factas, minimeque observatas et adimpletas subsequentesque actus ordine et voluntate regia erga ipsos subsecutos, de quibus in themate ad dictum effectum tendentes, ut exitus iam patefecit, qui aperte declarat qualis in praeteritum fuerit animus […]68.
Ben lungi dall’essere, dunque, un diritto e persino un dovere dell’autorità secolare, come sosteneva la tradizione scotista, l’inter-vento del sovrano per imporre il battesimo agli ebrei rappresentava piuttosto un’aggravante, secondo Parisio, perché anche laddove non si fosse avuta vis praecisa, tale intervento, promanando da colui che deteneva il potere supremo, accresceva notevolmente il timore nei sudditi che sarebbero così stati indotti ad accettare la conversione. Dunque il parere di Parisio riapriva, in qualche modo, la questione degli ebrei portoghesi. Nel rispetto del carattere individuale della ricezione di ogni sacramento, Parisio non si spingeva a proclamare l’invalidità di tutti i battesimi somministrati in Portogallo nel 1497. Ma la sua posizione non poteva non apparire eversiva rispetto alla situazione sociale e religiosa esistente in Portogallo, perché condan-nava nettamente la condotta di D. Manuel, dichiarava illegittima la grande maggioranza dei battesimi perché comunque forzati, e
67 Ibid., nn. 26 e 28, f. 6v.68 Ibid., nn. 30-32, f. 6v.
378 Giuseppe Marcocci
inoltre non riteneva validi, e dunque giudicava nulli sia i battesimi degli infanti invitis parentibus, sia quelli quelli imposti agli adulti con violenza assoluta. A proposito di quest’ultima tipologia di battezzati occorre ricordare che Parisio e Berò nel loro memoriale manoscritto sostenevano che fossero quasi la totalità («patres vero matres caete-rosque pene omnes»)69.
L’applicazione della bolla Sempiterno Regi, profondamente influen-zata, come abbiamo visto, dal parere di Parisio, fu tuttavia impedita dall’intenso e acceso dibattito che intorno ad essa si aprì. A causa del contenuto, il sovrano portoghese si rifiutò di pubblicarla nel regno, ed essa finì col rimanere lettera morta. Uno dei punti su cui maggiormente insistettero i consultori della corona lusitana fu pro-prio l’interpretazione del battesimo del 1497. Essi ammettevano che ci fosse stata violenza, ma ne restringevano notevolmente l’ambito a pochi casi, che non potevano costituire un motivo sufficiente per condannare e revocare la conversione di tutti gli altri ebrei, avvenu-ta attraverso un battesimo amministrato entro i termini riconosciuti dalla teologia e dal diritto. Inoltre, sostenevano ancora, se Clemente VII dichiarava che un numero elevato di ebrei erano stati battezzati per vim praecisam, non poteva applicare loro il perdono generale nella forma prevista dalla bolla, cioè mediante la confessione sacra-mentale, perché se erano stati convertiti assolutamente a forza e il loro battesimo era dunque nullo, essi erano ancora ebrei e il pon-tefice non aveva alcuna giurisdizione su di loro in materia di fede, né tantomeno poteva emettere un provvedimento che stabiliva che un cospicuo numero di infedeli si accostasse a un sacramento della Chiesa. Si sarebbe trattato, infatti, di un vero e proprio sacrilegio, per di più autorizzato e promosso dal papa. I consultori portoghesi cercavano di trarre vantaggio dalla palese impossibilità di dare una interpretazione unitaria del battesimo degli ebrei o di stabilire chi, nella realtà dei fatti, fosse stato oggetto di violenza assoluta e dunque non fosse da considerarsi cristiano, e chi invece avesse al massimo ricevuto una violenza condizionata e pertanto poteva legittimamen-te godere del perdono generale da un lato, ma dall’altro sarebbe poi stato inequivocabilmente soggetto alla giurisdizione ecclesiastica e alla coercizione all’ortodossia. Si leggeva, ad esempio, in un elenco
69 Consilia Reverendissimi Parisii ac D. Augustini Veroi cit., f. 123v.
379 «... per capillos adductos ad pillam»
di rationes, presentate dalla corona portoghese alla curia romana nel 1534, che
appare che non vi sia causa giusta ne raggionevolle per doversi sospendere detta Inquisitione, perché […] vi sono ancora le cause giustificatissime, per le quali Vostra Santità la concesse, e per non doversi concedere agl’eretici così ampia venia e perdonanza, perché se si concesse, come appare, per aversi rispetto a quelli, che della ebraica progenie furono battezzati per forza, che allegano essergli fatta, non si dée avere simile considerazione, ne anco per questo rispetto concedersi un tanto perdono, perché, se forza li fu in alquanti, oltrache la tal forza è stata condizionale, com’è detto, è tale che non li scusa per aver tanto tempo che vivono come christiani, pigliando li sagramenti; e quelli che dicono esser battezzati per forza, se alquanti sono stati, sono al presente pochissimi […]70.
Si osservi come i consultori portoghesi nel descrivere il battesi-mo del 1497, pur ammettendo in alcuni casi l’uso della forza, non facevano neppure un accenno al ricorso alla violenza assoluta. Poco oltre, invece, criticando puntualmente il contenuto della Sempiterno Regi, affrontavano la questione:
della forma e del modo di questo perdono nascono l’inconvenienti infra-scritti prout iacet.In primis perché la bolla mostra dire che Vostra Santità informata che in questi reami vi erano alcuni, che avevano preso l’acqua del santo battesimo per forza, li quali dice che non debbino essere riputati per membri della Chiesa, né castigati come christiani, la qual cosa si deve intendere in li battezzati per forza assoluta, perché d’altra forza non si può intendere, e se a costoro dona indulgenza e perdono per mezzo della confessione sacramen-tale, è grande inconveniente e contra ius divinum, perché, giacché costoro non sono cristiani, non se gli può dare sagramento alcuno della Santa Madre Chiesa […]71.
La posizione della curia romana appariva viziata da una contrad-dizione di fondo, di cui in Portogallo si approfittò prontamente e da
70 Rationes alias pro parte Regis et Inquisitorum adductae in tota ista materia (1534), edite in CDP, III, p. 13 (l’originale è in italiano).
71 Ibid., pp. 16-17.
380 Giuseppe Marcocci
cui era molto difficile uscire senza suscitare obiezioni. Tuttavia, nelle responsiones alle rationes dei consultori portoghesi, si continuava a difendere la Sempiterno Regi, ribadendo che poiché era giunto a conoscenza del pontefice che
neminem fere ex ea gente [i nuovi cristiani] ad Christi religionem sua spon-te et Dei timore perclusum pervenisse, sed partim violenter ad sacri bapti-smatis fontes pertractos fuisse, partim imminentium poenarum direptionis bonorum ac filiorum distractionis metu compulsos ad eosdem accessisse […] convertit hic rumor Sanctitatis Suae animum in huius gentis causam diligentius perpendendam, ne fortasse ipso auctore et sub religionis specie, in eos acerbius saeviretur quam humanitas et Christiana mansuetudo ac lex denique divina paterentur72.
Per quanto riguardava poi il problema della confessione sacra-mentale come via per ottenere il perdono generale, si specificava che Clemente VII «ad eam illos solos invitavit, qui huius beneficio sacrosanctae Ecclesiae reconciliari voluissent, sciens fore omnino ut id omnes vellent, qui possent, neminem autem non posse, nisi qui Religionis nostrae nunquam partecipes fuissent»73.
Ma dopo la morte di Clemente VII la posizione della Santa Sede finì con l’essere in parte riveduta e corretta, alla luce anche di pro-babili considerazioni politiche e diplomatiche, perché mantenendosi fedele ad essa la Chiesa di Roma rischiava di giungere ad uno scontro aperto con due fra i principali sovrani cattolici del tempo, D. João III e, soprattutto, Carlo V, che non aveva mai celato il proprio appoggio alla corte portoghese nella questione del Sant’Uffizio e dei nuovi cristiani. Alla fine di lunghe trattative, il nuovo pontefice, Paolo III, ricorse a una formula di compromesso, promulgando il 12 ottobre 1535 una nuova bolla di perdono generale, in cui si limitava a riferirsi al battesimo coatto, senza fare ulteriori precisazioni74. Pur nella con-cessione di un importante provvedimento di indulgenza plenaria, la soluzione della curia romana fu quella di superare lo spinoso proble-
72 Responsiones ad Rationes praecedentes (1534), ibid., p. 29.73 Ibid., p. 36.74 Cfr. bolla Illius vices, pubblicata in Collectorio cit., ff. 30v-38v; ora anche in
Simonsohn, The Apostolic See cit., IV, doc. 1765, pp. 1995-2008.
381 «... per capillos adductos ad pillam»
ma posto dal tipo di violenza ricevuta dagli ebrei portoghesi sempli-cemente evitando di affrontarlo. Ne emerse pertanto una posizione finale di fatto ambigua, che lasciava adito a interpretazioni in contra-sto fra loro, ma che, in ogni caso, segnò l’estromissione definitiva del dibattito sul battesimo forzato dal piano delle conseguenze concrete, soprattutto in relazione agli eventuali limiti da porre al Sant’Uffizio lusitano, che erano invece insite in un’applicazione coerente della linea adottata da Clemente VII nella bolla del 1533.
6. L’anno successivo con la bolla Cum ad nihil magis del 23 maggio 1536 fu introdotto in Portogallo il tribunale dell’Inquisizione, che nacque con il principale obiettivo di individuare e castigare i reati di cripto-giudaismo75. Nella loro attività giudiziaria gli inquisitori non si curarono affatto di tutte le sottili distinzioni emerse durante il dibat-tito degli anni precedenti. Da allora la persecuzione investì i nuovi cristiani considerati alla stregua di eretici senza nessuna attenuante. Ma la riflessione sul battesimo forzato, sebbene priva ormai di una effettiva capacità di incidere direttamente sulla condizione giuridica e teologica dei nuovi cristiani, non cessò affatto. Il mondo dei teologi, in particolare, non si accontentò della sbrigativa lettura dell’episodio for-nita dalla curia al termine della battaglia diplomatica sulla concessione dell’Inquisizione in Portogallo. L’esigenza di comprendere e definire quanto era avvenuto nel 1497 rimaneva impellente, anche perché dall’interpretazione che se ne dava derivava un giudizio più generale su come dovesse strutturarsi il rapporto fra la società cristiana e il mondo esterno, a partire dall’esperienza portoghese in cui si era optato per un’aggressiva inclusione degli infedeli legittimamente presenti nel regno. Inoltre esprimere la propria posizione sulla questione del battesimo forzato equivaleva anche a proporre una valutazione sugli equilibri sociali e religiosi esistenti in Portogallo nel Cinquecento, vale a dire sul problema posto dalla presenza dei conversos e dai metodi da adottare per affrontarlo: in sostanza era anche un modo per mettere in discussione l’Inquisizione.
Sull’argomento della conversione degli infedeli, del resto, si inter-rogarono tutti i principali teologi cinquecenteschi, rielaborando le
75 La bolla fu pubblicata in Collectorio cit., ff. 1v-3v; ora anche in Simonsohn, The Apostolic See cit., IV, doc. 1787, pp. 2028-2032.
382 Giuseppe Marcocci
conclusioni raggiunte nei secoli passati alla luce degli eventi più recenti. Pur esprimendosi con un linguaggio cauto e sottile, non era difficile scorgere nelle parole dei teologi lusitani, e più in generale iberici, un riflesso delle opinioni personali su quanto era avvenuto alla fine del secolo precedente. In Portogallo ebbero una rilevanza e un peso particolari nella discussione in materia i frati domenicani, membri di un ordine che, come abbiamo visto, aveva avuto un ruolo di primo piano nelle vicende che avevano portato al battesimo for-zato e ai primi episodi di persecuzione nei confronti dei nuovi cristia-ni. Si possono prendere in considerazione due importanti figure che intorno alla metà del Cinquecento si espressero sulla questione: il futuro arcivescovo di Braga, Bartolomeu dos Mártires, e lo spagnolo Martín de Ledesma, professore alla facoltà di teologia dell’università di Coimbra. Entrambi recuperavano la lezione dei grandi maestri del primo Cinquecento, anzitutto Tommaso de Vio, detto il Caetano, e Francisco de Vitória, di cui Ledesma in gioventù era stato uno dei migliori discepoli all’università di Salamanca. Il Caetano e Vitória, tuttavia, sulla specifica questione del battesimo forzato avevano espresso posizioni differenti.
Nel commento alla Summa Theologiae di Tommaso d’Aquino, il Caetano aveva duramente attaccato Scoto e i suoi «sequaces» affrontando in particolare il rapporto fra timor e voluntas e con-cludendo che la «coactio principum» determinava una «suscep-tionem fidei […] serviliter voluntariam», e costituiva perciò un «sacrilegium»76. Il concilio toledano, ammoniva ancora il Caetano, lodava l’intenzione di Sisebuto, ma ne disapprovava il gesto proi-bendolo. Pertanto, concludeva, «maius malum videtur infideliter vivere occulte post suscepta fidei sacramenta quam libere infideli-ter vivere: quia evitatur contumelia sacramentorum»77. Anche la liceità del battesimo dei figli di infedeli invitis parentibus, sulla cui legittima amministrazione da parte del principe cristiano Scoto aveva costruito le proprie conclusioni, era risolutamente negata dal Caetano. L’argomentazione di Scoto, sosteneva, poneva il proble-
76 Sancti Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Opera Omnia cit., VIII, Secunda Secundae Summae Theologiae […] cum commentariis Thomae de Vio Caietani, q. X, art. VIII, p. 89. Il Caetano concluse il proprio commento alla Secunda Secundae nel 1517.
77 Ibid., p. 90.
383 «... per capillos adductos ad pillam»
ma della giustizia naturale, perché opponeva lo «ius Dei» allo «ius parentum». Ma Dio «non sic legem fidei instituit ut voluerit pro ea servanda legem naturae solvi, quamvis hoc posset». Secondo Scoto, asseriva ancora il Caetano, i genitori infedeli, che educano i figli nella loro religione erronea, abusano del diritto naturale loro con-cesso. Ma a ciò si poteva obiettare che Dio ha stabilito entrambi gli ordini, quello del diritto naturale e quello del diritto divino perché non entrassero in contraddizione, e dunque, a differenza di quanto pretendeva Scoto, non c’è abuso nell’educare i figli nella propria religione, anche se erronea, e pertanto non è lecito al principe cristiano sottrarli ai genitori perché siano battezzati78. Alla linea del Caetano si sarebbero rifatti illustri rappresentanti della cultura cattolica del Cinquecento, a partire da Domingo de Soto79 e Martín de Azpilcueta, che peraltro proprio in Portogallo a cavallo fra la fine degli anni Trenta e la metà degli anni Cinquanta raggiunse gli onori della carriera accademica80. Da tale linea tuttavia si discostò Vitória, come si ricava dagli appunti manoscritti delle lezioni sulla Secunda Secundae che tenne a Salamanca fra la fine del 1534 e il
78 Ibid., q. X, art. XII, pp. 95-96. Sullo stesso problema il Caetano si espresse in termini analoghi anche nel commento alla Tertia Pars, portato a compimento nel 1522. Cfr. ibid., XII, Tertia Pars Summae Theologiae […] cum commentariis Thomae de Vio Caietani, q. LXVIII, art. X, p. 110.
79 Cfr. D. de Soto, In quartum (quem vocant) Sententiarum. Tomus Primus, Venetiis, Apud Io. Mariam Lenum 1575, d. V, De suscipientibus baptismum, q. unica, art. X, Utrum pueri Iudaeorum vel aliorum infidelium sint inviti parentibus baptizandi, pp. 289-302. La prima edizione del trattato di Soto uscì a Salamanca, presso Juan de Canova, nel 1557.
80 Cfr. M. de Azpilcueta, Commento en romance a manera de repeticion latina y scholastica de iuristas, sobre el capitulo Inter verba XI q. III, Conimbricae, Ex officina Iohannis Barrerii et Iohannis Alvari MDXLIII, pp. 76-77; anni più tardi il Navarro riprese la questione nei suoi consulti. Cfr. Id., Consiliorum Liber III, De Conversione infidelium Consilia Quattuor, in Id., Consiliorum seu Responsorum in quinque Libros iuxta Numerum & Titulos Decretalium, distributorum Tomi Duo, Venetiis, Apud Iuntas MDCXXI, I, pp. 607-626, in part. cons. IV, nn. 15; 19-20; 22; 31-33, pp. 618-623. Sulla figura del Navarro, cfr. ora V. Lavenia, Martín de Azpilcueta (1492-1586). Un profilo, in «Archivio Italiano per la Storia della Pietà», XVI, 2003, pp. 15-148.
384 Giuseppe Marcocci
153781. «Quaestio ista est moralis et pro principibus utilis» attaccava Vitória, commentando la celebre conclusione di Tommaso secondo la quale «principes non possunt compellere infideles ad fidem nec terroribus nec minis»82. Quindi esponenva i propri dubbi, dichiaran-do che il battesimo forzato era proibito «de iure humano», ma circa lo «ius divinum» occorreva osservare come non esistesse nessun passo delle Scritture contenente un divieto in tal senso. La causa della proibizione «de iure humano» era stata fornita da Durando il quale aveva sostenuto che «Deus dedit homini rationem per quam regularetur et ordinaretur seu gubernaretur», ma, obiettava Vitória, non era una spiegazione sufficiente perché la ragione come facoltà umana non bastava per avere la fede cristiana né per stabilire se essa fosse migliore della religione degli ebrei o dei saraceni83. Infine, circa la «proibitio de iure naturali», Vitória affermava che compito del principe cristiano era quello di garantire agli uomini il bene, e dunque anche di convertirli. Perciò egli approvava la posizione di Scoto, ammettendo la legittimità dell’intervento dell’autorità secolare a favore della conversione degli infedeli. Vitória, d’altro lato, riconosceva che, come aveva insegnato Tommaso, «absolute loquendo» gli infedeli non dovessero essere costretti a convertirsi, perché il fatto che fosse lecito battezzare a forza gli infedeli, non significava che ciò fosse utile. La conversione coatta infatti poteva avere anche esiti negativi, perché «fides est in corde», mentre la coazione induce alla finzione, come insegnava l’esperienza dei mori-scos in Spagna84. La posizione ambigua e volutamente sfumata di Vitória si riproponeva anche in merito alla «quaestio solemnis» del battesimo invitis parentibus:
Ego in hac materia possum dicere sicut in articulo octavo huius quaestionis, quod posse baptizari filios infidelium invitis ipsis, non excedit facultatem
81 Cfr. F. de Vitória, Comentarios a la Secunda Secundae de Santo Tomás, 6 voll., edición preparada por V. Beltrán de Heredia, Salamanca, Biblioteca de Teologos Españoles 1932-1952. Si tratta dell’edizione dei manoscritti delle lezioni di Vitória appuntate da un suo discepolo, il baccelliere Francisco Trigo.
82 Ibid., I, q. X, art. VIII, p. 191.83 Ibid., pp. 191-192.84 Ibid., pp. 192-194.
385 «... per capillos adductos ad pillam»
et potestatem Christianorum; sed omnino possunt baptizari invitis eis, si non sit scandalum et periculum de apostasia. Dico igitur quod nullo iure est prohibitum baptizare illos invitis parentibus; et si posset fieri adhibita cau-tela quod essent vere christiani, et quod parentes non scandalizaretur, bene essent baptizandi. Et sic puto quod opinio Scoti est vera. […]Secundum dictum est, ut diximus articulo octavo, quod illud non potest bene fieri nec servari, scilicet quod non sequatur scandalum, quia quod remedium potest adhiberi ad hoc quod parentes et alii sarraceni non scanda-lizentur et non putent quod christiani vi et non miraculis adducunt ad fidem illorum? Certe non video remedium ad illud vitandum. […]Ideo absolute est respondendum quod non sunt baptizandi. Et sanctus Thomas credo quod ita intelligit, quia quamvis adducat illam rationem a priori, scilicet quod de iure naturali sunt sub cura parentum, tamen potius fundat se in auctoritate Ecclesiae85.
In qualche modo, dunque, Vitória rompeva la tradizionale posi-zione anti-scotista della teologia domenicana e poco oltre affermava che
potest rex facere legem quod in spiritualibus cura filiorum non pertineat ad parentes. Ad idem confirmatur ex scriptura. Nam primo Machabaeorum 2, Matthatias fecit circuncidi omnes pueros provinciae quam subiecerat. Idem de Abraham, circumcidit omnes vernaculos et alienigenas. Ergo possunt etiam christiani baptizare filios infidelium invitis parentibus. […] puto quod in casu ubi non esset scandalum et periculum de apostasia, quod possunt filii infidelium baptizari invitis parentibus ipsis86.
I manoscritti delle lezioni di Vitória ebbero ampia circolazione nella penisola iberica. Vi fece largo ricorso anche Bartolomeu dos Mártires durante gli anni Quaranta, quando insegnava teologia presso il convento di Batalha, dove aveva sede il più importante stu-
85 Ibid., q. X, art. XII, pp. 203, 206-207.86 Ibid., pp. 208-209.
386 Giuseppe Marcocci
dium della provincia domenicana portoghese87. Tuttavia in merito al battesimo forzato dos Mártires non accolse le conclusioni di Vitória. Egli leggeva e commentava i passi della Summa Theologiae e delle Sentenze di Pietro Lombardo alle giovani schiere di un ordine che a quell’epoca era senza dubbio il più impegnato e attivo all’interno del Sant’Uffizio88. L’Inquisizione in Portogallo era ormai una realtà e le persecuzioni a cui aveva sottoposto i nuovi cristiani avevano già raggiunto una durezza tale che nel 1544 si aprì un nuovo contenzioso con Roma, che condusse a una parziale interruzione dell’attività dei tribunali, con la sospensione delle sentenze emesse, e alla conces-sione di un secondo perdono generale nel 1547. Dos Mártires, che divenuto arcivescovo nel 1559 avrebbe allora palesato uno spirito di forte autonomia rispetto al Sant’Uffizio, nelle sue lezioni si schie-
87 Sugli anni di insegnamento di dos Mártires a Batalha, cfr. M.A. Rodrigues, As aulas de Frei Bartolomeu dos Mártires no contexto escolar da época, in Actas do I Encontro sobre História Dominicana, Porto, Arquivo Histórico Dominicano Português 1979, pp. 177-192. I manoscritti delle lezioni di teologia tenute a Batalha sono stati editi in B. de Martyribus, Theologica Scripta, 6 voll., cura et studio R. de Almeida Rolo, Braga, Edição do Movimento Bartolomeano 1973-1977. Per un inquadramento generale, cfr. l’ampia introduzione al primo volume, pp. 1-357, in part. pp. 214-225 per la cronologia delle lezioni. Ai manoscritti di Vitória dos Mártires faceva esplicito riferimento in conclusione del proprio commento alla Secunda Secundae: «Em algumas materias moraes da 2a-2ae quando a li na Ordem, algumas cousas tirei e me aproveitei de huns cadernos de Frei Francisco de Vitoria que me emprestou hum seu discipulo, e pus aqui ho que milhor me parecia» (ibid., IV, Annotata in 2am-2ae [qq. 64-154], p. 1299).
88 Alla fine degli anni Quaranta fra i domenicani che prestavano, o avevano prestato, servizio nell’Inquisizione si annoveravano importanti figure come Jorge de Santiago, Jerónimo de Padilha, Bernardo da Cruz e Jerónimo de Azambuja. Contro l’impiego di domenicani nelle fila del Sant’Uffizio si espresse il nunzio Giovanni Ricci. Nel 1545, nel corso di un incontro con Rodrigo Gomes Pinheiro, vescovo di Angra, l’inviato della Santa Sede, ricordando l’episodio del massacro di Lisbona in cui, a suo dire, erano morti più di quattromila nuovi cristiani, aggiunse «que forão castigados por aquelle feito frades da ordem de São Domingos e que dali a toda a ordem avia de ficar hodio aos cristãos novos e que era cousa muito prigosa meter fra-des de Santo Domingo no carrego da santa Inquisição» (Lettera di Rodrigo Gomes Pinheiro al re D. João III, Lisbona, 7 novembre 1545, edita in As Gavetas cit., I, pp. 295-299, in part. p. 296).
387 «... per capillos adductos ad pillam»
rava sulle posizioni di Tommaso d’Aquino e del cardinal Caetano89. Ammetteva che gli infedeli potessero «suaviter ad fidem allici blan-ditiis ac munerum temporalium provisonibus», così come era lecito «eis imponi illa tributa vel onera quae iuste possent imponi fidelibus, quamvis speciali gratia de hoc eximantur fideles, ut scilicet allician-tur ad fidem». Ma subito dopo, discutendo la questione delle facoltà delle autorità secolari in materia di conversione degli infedeli, espri-meva una dura condanna dei provvedimenti di espulsione:
si iudaei in regno commorantes ex sua conversatione nullum penitus nocu-mentum inferunt fidelibus, non poterit eos Rex expellere hac sola inten-sione ut vexati convertantur, in eo casu in quo, ceteris paribus, non posset fideles eiicere a regno90.
Dietro le parole del teologo domenicano era difficile non leggere una severa critica alla politica adottata circa mezzo secolo prima da D. Manuel. In un altro passo, del resto, dos Mártires aveva dichiara-to esplicitamente che gli infedeli «nullo modo licet minis vel metu compellere ad suscipiendum fidem aut baptisma. Et hoc habeo cum beato Thoma et Caietano, 22-2ae, q, 10, art. 8, contra Adrianum […] et Scotum»91. In merito, poi, a coloro che erano stati battezzati a forza, dos Mártires riproponeva la classica distinzione fra vis con-ditionalis e vis praecisa et absoluta. Chi aveva ricevuto il sacramento cristiano doveva essere costretto a osservare la fede. «Conclusio extenditur», specificava dos Mártires,
89 Per maggiori approfondimenti sulla figura di dos Mártires come arcivescovo, mi permetto di rinviare al saggio dello scrivente, Il governo dell’arcidiocesi di Braga al tempo di Bartolomeu dos Mártires (1559-1582). Riflessioni e documenti sull’episcopato portoghese nell’età del Concilio di Trento, in «Archivio Italiano per la Storia della Pietà», XV, 2002, pp. 81-150.
90 Martyribus, Theologica Scripta cit., III, Annotata in 2am-2ae ( qq. 1-63), q. X, art. VIII, p. 67. Le lezioni sulla Secunda Secundae vennero tenute fra il 1548 e il 1552.
91 Ibid., IV, q. C, De simonia, art. XIV, An ob munera temporalia exercere opera spiritualia simoniacum sit, p. 1191.
388 Giuseppe Marcocci
etiam eos qui metu mortis comminatae vel alterius mali tracti sunt ad bap-tismum, ita quod voluerunt ut hic et nunc baptizari, sed nonnisi ob malum comminatum […]. Non autem extenditur ad eos qui actualiter reclamantes baptizati sunt, quia tales nunquam fuerunt christiani neque characterem receperunt92.
Nelle parole del futuro arcivescovo di Braga la fedele ripresa della
tradizione tomista suonava dunque come un duro monito di ripro-vazione non solo verso gli episodi più cruenti del battesimo forzato portoghese, ma anche rispetto ai tentativi di alcuni teologi, come
92 Ibid., III, q. X, art. VIII, pp. 68-69. Per la posizione di dos Mártires sul problema del battesimo dei figli degli infedeli, cfr. ibid., V, Scripta super 4um Sententiarum (3 P., qq. 60-10 Suppl.), p. 3a, q. LXVIII, De suscipientibus baptismum, art. X, pp. 175-182. A questo passo, databile al 1543-1545, rinviava dos Mártires commentando l’art. XII della q. X, cfr. ibid., III, p. 73. Anche dos Mártires fu coinvolto in un episodio di battesimo di ebrei. Durante la terza fase del concilio di Trento, di cui fu uno dei pro-tagonisti, il 10 aprile 1563, vigilia di Pasqua, egli amministrò il sacramento del bat-tesimo a tre ebrei protoghesi adulti, dei quali però si ignorano l’identità e la vicenda biografica. Nei Firmiani Diaria caerimonialia si legge: «In sabato sancto, 10. Aprilis. In mane hora 12, antequam Illmi legati venirent ad ecclesiam, Rmus archiepiscopus Bracarensis Lusitanus accepto pluviali, stola et mitra expectavit in porta ecclesiae adventum legatorum, oratorum et patrum. Quibus perventis ad ecclesiam baptizavit tres Hebreos Lusitanos, quibus fuerunt patrini Rmus episcopus Quinqueeclesiensis, orator missus ab imperatore pro regno Ungariae, orator regis Galliae, et regis Lusitaniae»; negli Psalmei Fragmenta de concilio Tridentino troviamo un’altra attesta-zione: «[Die sabbathi 10. Aprilis] Die sabbathi vigiliae pasche 10. Aprilis interfui summo mane benedictioni novi ignis facte per vicarios S. Vigilii in cemiterio, ubi focus ex lignis confectus est. Deinde redeuntes processionaliter ad fontes benedixe-runt eos more solito, tum ad maius altare chori, ubi benedicto incenso benedictus est quoque cereus. Paulo post archiepiscopus Bracharensis baptizavit in dictis fonti-bus baptismalibus tres Iudaeos catecumenos maiores 25 annis, existentibus patrinis oratoribus Caesareo, Gallo et Lusitano, praesentibus legatis et aliquot episcopis. Qui vocati fuerunt Petrus, Antonius et Paulus» (cfr. Concilium Tridentinum. Diariorum, Actorum, Epistolarum, Tractatuum Nova Collectio, II, Diariorum Pars Secunda, Friburgi Brisgoviae, Societas Görresiana 1911, pp. 566 e 835-836 rispettivamente). L’episodio è menzionato anche da J. de Castro, Portugal no Concílio de Trento, 6 voll., Lisboa, Tipografia União Gráfica 1944-1946, V, pp. 83-84.
389 «... per capillos adductos ad pillam»
Vitória, di reninterpretare con una certa disinvoltura le pagine di Tommaso per dare un fondamento di legittimità alle violente politi-che di conversione coatta che si erano imposte nella penisola iberica alla fine del secolo precedente.
La tendenza all’apertura verso le posizioni di Scoto, delineata da Vitória, venne ripresa, invece, in Portogallo da Ledesma93. Nel commento alla prima parte del quarto libro delle Sentenze di Pietro Lombardo, pubblicato nel 1555, Ledesma evitava di affrontare direttamente la questione del battesimo forzato, ma discutendo il problema ad esso strettamente collegato del battesimo degli infanti invitis parentibus si schierava per un tentativo di conciliazione fra le conclusioni di Tommaso e quelle di Scoto94. Ledesma sosteneva che le autorità ecclesiastiche avessero il pieno diritto di battezzare i figli degli infedeli eis invitis:
De se et absolute loquendo licitum est ministris ecclesiae (pontificibus sci-licet, episcopis, et sacerdotibus) baptizare filios infidelium ipsis invitis: quia nullo iure est prohibitum. Nam rationibus quibus aliqui probant esse contra ius naturale, facile respondetur. Et sic loquendo vera est opinio Scoti95.
Esisteva il problema dello «scandalum» che può derivarne e quello del «periculum apostasiae», proseguiva Ledesma, ma non si poteva mettere in dubbio che i genitori infedeli che educavano i loro figli nella propria erronea religione non abusassero del diritto naturale, perché ne provocavano la morte spirituale. Questa era la tradizionale argomentazione di Scoto, ma Ledesma la attribuiva indirettamente anche a Tommaso, sostenendo che tale fosse la sua vera opinione. La sottrazione dei figli ai genitori infedeli, scriveva Ledesma,
93 Sulla figura di Martín de Ledesma, cfr. M.A. Rodrigues, A cátedra de Sagrada Escritura na Universidade de Coimbra. Primeiro século (1537-1640), Coimbra, Instituto de Estudos Históricos 1974, pp. 47-64.
94 M. de Ledesma, Primus Thomus, Qui et Prima 4. Nuncupatur, Conimbricae, Excudebat Ioannes Alvarus Typographus Regius MDLV, q. 9, De suscipientibus baptismum, art. 10, Utrum pueri iudaeorum vel aliorum infidelium sint invitis parentibus baptizandi, pp. 149-152.
95 Ibid., p. 151.
390 Giuseppe Marcocci
stante legitima causa, seclusis impedimentis licet. Et probatur amplius. Quia si pater vellet occidere filium liceret tollere eum a manibus patris. Ergo etiam si vult perdere spiritualiter. Unde omnes concedunt quod filii de iure naturali sunt sub cura parentum. Sed est difficultas, an propter hoc quod parentes abutuntur illa potestate debeant illa privari. Ego dico cum Scoto, & credo quod est de mente S. Thomae quod de se debent privari, nisi sequa-tur aliquid inconveniens. Caietanus, Capreolum, Durandus, & Marsius, dicunt quod non, & putant hoc esse de mente sancti Thomae. Et probant. Quia Deus qui est supremus dominus noluit quod illud fiat96.
Tuttavia l’allievo di Vitória non si spingeva oltre. L’accostamento fra Tommaso e Scoto, le cui conclusioni sul battesimo forzato degli infedeli e su quello degli infanti invitis parentibus la tradizione aveva sempre contrapposto, costituiva già di per sé una nuova e originale sintesi sulla questione, che sarebbe potuta tornare a vantaggio degli assertori della validità della conversione degli ebrei portoghesi97. La trattazione di Ledesma, come quella di Vitória del resto, terminava in maniera ambigua e piena di distinguo, sconsigliando di praticare il battesimo degli infanti da un lato, ma dall’altro riconoscendone la
96 Ibid.97 Ledesma stesso, del resto, aveva già servito nell’Inquisizione, operando come
esaminatore di libri e deputato del Sant’Uffizio di Coimbra durante gli anni Quaranta. E anche in seguito svolse funzioni inquisitoriali. L’arcivescovo di Braga, Bartolomeu dos Mártires, infatti, lo scelse come proprio sostituto in qualità di ordinario nel tribunale inquisitoriale di Coimbra, riaperto nel 1566. Cfr. ANTT,
Inquisição de Coimbra, processo n. 1080 (Processo di Gil Gomes Vilarinho), f. 16, dove si trova una copia originale della commissione di Bartolomeu dos Mártires, datata 15 giugno 1567, in cui nominava Ledesma come suo rappresentante presso l’Inquisizione di Coimbra. Si può ipotizzare che l’arcivescovo domenicano vedesse nel confratello spagnolo una valida soluzione di compromesso. Ledesma, infatti, era pur sempre un teologo e questo poteva offrire agli occhi di dos Mártires una garanzia sufficiente di mediazione tra la sua posizione personale, caratterizzata da una spicca-ta autonomia dal Sant’Uffizio e da una certa propensione a una strategia pastorale alternativa e talora più moderata verso gli ebrei convertiti e i loro discendenti, e la tendenza al sistematico ricorso a metodi più repressivi propria degli inquisitori, legati a una visione più intransigente e liquidatoria del problema della fede dei nuovi cristiani.
391 «... per capillos adductos ad pillam»
piena legittimità. Duplice era, infatti, la conclusione di Ledesma. In prima istanza egli giustificava il diritto dei principi e dei pontefici di battezzare i figli degli infedeli invitis parentibus. «Et credo», aggiunge-va, «quod est de mente sancti Thomae quicquid dicant aliqui thomi-stae captiosi». Nella seconda conclusione, però, Ledesma ritornava sui propri passi. Infatti, a causa dello «scandalum» che rischiava di seguire e del «periculum apostasiae», quanto sostenuto nella prima conclusione poteva presentare nella realtà non pochi inconvenienti, perciò, terminava l’allievo di Vitória,
non sunt baptizandi filii infidelium invitis parentibus, & si licebat, quantum erat de se. […] Et credo quod hoc solum volebat dicere sanctus Thomas. Sed quia in moralibus respondendum est absolute, secundum id quod ut pluribus evenit, dixit sanctus Thomas absolute quod non sunt baptizandi filii infidelium invitis parentibus. Et ita respondendum est. Secus autem si prius provideretur, quod non sequatur scandalum, aut periculum apostasiae, aut aliquod inconveniens98.
7. Il dibattito sulla validità del battesimo forzato portoghese non rimase comunque chiuso nelle aule dei conventi e delle università o nei trattati di scolastica. L’argomento era delicato e scottante. Nonostante il grande impatto che aveva avuto sugli equilibri della società lusitana, nei primi decenni successivi ai fatti del 1496-1497 si assistette in Portogallo a una vera e propria rimozione del problema, che fu avvolto da un silenzio pressoché totale, se si escludono pochi e sporadici accenni in alcune operette prontamente censurate. Dalla metà del secolo in poi, tuttavia, la questione del battesimo forzato tese a riverberarsi in altri ambiti della produzione scritta, distinti dal diritto e dalla teologia, ma che risentivano profondamente delle categorie interpretative e delle dispute derivate da tali discipline.
Alla metà degli anni Sessanta del Cinquecento risale la prima ricostruzione ufficiale di tipo storico dell’episodio del battesimo degli ebrei portoghesi. Si tratta della cronaca del regno di D. Manuel com-posta dall’umanista Damião de Góis, scritta in lingua portoghese, dedicata al cardinale infante D. Henrique (che all’epoca rivestiva insieme le cariche di reggente per la minorità di D. Sebastião e di
98 Ledesma, Primus Thomus cit., p. 152.
392 Giuseppe Marcocci
inquisitore generale) e pubblicata fra il 1566 e il 1567, avendo in seguito non pochi problemi con la censura99. Non si intende qui esprimere una valutazione sull’attendibilità della cronaca di Góis e delle altre, di cui ci si occuperà più avanti, come fonti necessarie per ricostruire i fatti del 1496-1497. Piuttosto si cercherà di cogliere il giudizio complessivo dato dagli autori su una vicenda che, come abbiamo visto, presentava non poche difficoltà sotto il profilo della comprensione dell’esatta dinamica evenemenziale, ma che proprio sull’impossibilità di restituirne la corretta dimensione storica aveva visto naufragare il tentativo della curia romana di revocare la validi-tà del battesimo amministrato a forza. È a causa di tale ragione che anche all’interno del genere cronachistico si ritrovano echi manife-sti del dibattito teologico e giuridico sull’episodio portoghese.
La cronaca del regno di D. Manuel aveva avuto una lunga gestazione. Nel corso degli anni l’incarico di redigerla era stato di volta in volta affidato a personalità di spicco del mondo culturale lusitano, come Rui de Pina, suo figlio Fernão, António Pinheiro, João de Barros, senza però che essi pervenissero ad alcun risultato concreto. Fu Góis a portare a termine l’impresa. Egli era uno dei più importanti esponenti dell’umanesimo cristiano portoghese. Figura di intellettuale cosmopolita di ascendenza erasmiana, aveva viaggiato per l’Europa negli anni centrali della prima metà del secolo, aven-do contatti con molti fra i protagonisti dell’epoca, sia all’interno dell’area cattolica che di quella riformata100. Rispetto alla condotta
99 Cfr. D. de Góis, Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel. Nova Edição conforme a Primeira de 1566, 4 voll., Coimbra, Universidade de Coimbra 1949-1955, con una ricca introduzione di D. Lopes a cui si rinvia.
100 Sulla figura di Góis esiste una vasta bibliografia. Oltre ai classici, ma ancora fondamentali studi di M. Bataillon, Le cosmopolitisme de Damião de Góis (1938), ora in Id., Études sur le Portugal au Temps de l’Humanisme, Paris, Fundação Calouste Gulbenkian 1974, pp. 121-154; E. Feist Hirsch, Damião de Góis. The Life and Thought of a Portuguese Humanist, The Hague, Martinus Nijhoff 1967; Damião de Góis humaniste européen, Études présentées par J.V. de Pina Martins, Braga, Barbosa & Xavier 1982; A. Torres, Noese e crise na epistolografia latina goesiana, 2 voll., Paris, Fundação Calouste Gulbenkian-Centro Cultural Português 1982, mi limito a segnalare i numerosi contributi raccolti in Congresso Internacional. Damião de Góis na Europa do Renascimento. Actas, Braga, Publicações da Faculdade de Filosofia-Universidade Católica Portuguesa 2003.
393 «... per capillos adductos ad pillam»
tenunta dal sovrano portoghese nel 1496-97 è probabile che Góis fosse su posizioni piuttosto critiche. La sua sensibilità e attenzione nei confronti del problema conversos era stata in passato accentua-ta da fatti che lo avevano riguardato direttamente. Nel 1541, ad esempio, era stata proibita in Portogallo la circolazione di una sua operetta sulla fede, la religione e i costumi degli Etiopi, uscita l’anno precedente a Lovanio101. Nella lettera scritta a Góis il 13 dicembre 1541 l’infante D. Henrique, inquisitore maggiore dal 1539, così motivava le ragioni del divieto:
le cose della fede e le superstizioni degli Etiopi, poiché nel vostro libro sono approvate dall’ambasciatore del prete con spiegazioni distorte e autorità della Sacra Scrittura male intese, e poiché in questo regno ci sono tanti nuovi cristiani e molti di loro sono accusati di eresia, è parso a me e agli inquisitori che in tempi in cui in questi regni sta iniziando ad operare la santa Inquisizione non si dovesse leggere tale opera, perché coloro che sen-tono male della fede non favorissero il loro errore con la cattiva opinione degli Etiopi102.
Le parole di D. Henrique rappresentano un esempio manifesto della saldatura esistente anche in Portogallo fra il problema interno della conversione dei discendenti degli ebrei e le questioni aperte dall’incontro con gli altri popoli che abitavano nelle terre extra-europee, alla quale si è fatto riferimento all’inizio del saggio. Nella cronaca, che in ogni caso in relazione ai capitoli sul battesimo forza-to non subì censure – al massimo si potrebbe ipotizzare una qualche forma di auto-censura –, Góis si attenne a una piana narrazione
101 D. de Góis, Fides, Religio, Moresque Æthiopum sub Imperio Preciosi Ioanni (quem vulgo Presbyterum Ioannem vocant) degentium, una cum enarratione confoederationis ac amicitiae inter ipsos Æthiopum Imperatores, & Reges Lusitaniae initae [...], Lovanii, Ex officina Rutgeri Rescii MDLX.
102 Lettera dell’infante D. Henrique a Damião de Góis, Lisbona, 13 dicembre 1541, pubblicata in Índices dos livros proibidos em Portugal no século XVI, apresentação, estudo introdutório e reprodução fac-similada dos índices por A. Moreira de Sá, Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Científica 1983, doc. XIV, pp. 66-67 (la traduzione dal portoghese è mia).
394 Giuseppe Marcocci
dei fatti, evitando di esprimere un giudizio esplicito, che pure, in qualche modo, trapelava dal netto richiamo al diritto naturale, fatto tutt’altro che privo di implicazioni, come abbiamo visto sinora. Pur senza celare episodi di grave violenza e crudeltà, come quello del battesimo coatto dei fanciulli ebrei invitis parentibus, ma presen-tando, tuttavia, una ricostruzione piuttosto attenuata dell’episodio degli Estaus, Góis insistette sulla «pietà» di D. Manuel, che avrebbe impedito al sovrano di valutare appieno le negative conseguenze della propria politica di conversione, giustificandone così in parte la condotta. Occorre, però, tenere pur sempre presente che siamo di fronte alle parole dell’autore di una cronaca ufficiale del regno, composta su incarico della corona. Seguiamo, dunque, il racconto di Góis:
il Re, per cause che lo indussero a ciò, dette ordine che in un giorno stabi-lito venissero tolti a questi [agli ebrei] i figli e le figlie di età dai quattordici anni in giù e che fossero sparsi per le cittadine e le località del regno, dove a proprie spese ordinò che li educassero e li addottrinassero nella fede del nostro salvatore Gesù Cristo. […] L’episodio non suscitò solo grande terrore, misturato con molte lacrime, dolore e tristezza presso gli Ebrei, ma provocò anche molto spavento e meraviglia fra i cristiani, perché nessuna creatura può patire e soffrire che si allontanino da sé con la forza i propri figli, e nelle cose altrui per naturale comunicazione sente quasi lo stesso, soprattutto nelle razionali, perché con queste la natura comunicò gli effetti della pro-pria legge, con più generosità di quanto fece con le brute irrazionali: questa legge costrinse molti vecchi cristiani (cristãos velhos) a muoversi a tal punto a pietà e misericordia per le urla, lacrime e pianti che facevano i padri e le madri a cui con la forza prendevano i figli, e loro stessi li nascondevano nelle loro case perché non glieli venissero a strappare dalle mani, e glieli salvava-no, con la consapevolezza che così agivano contro la legge e la prammatica del proprio Re e signore, e questa stessa legge naturale fece usare agli stessi ebrei tanta crudezza, che molti di loro uccisero i figli, affogandoli e gettan-doli nei pozzi e nei fiumi, e in molte altre maniere, preferendo vederli fare questa fine, piuttosto di allontanarli da sé senza la speranza di rivederli mai più, e per la stessa ragione molti di loro si toglievano la vita con le proprie mani. Mentre tutto ciò si compiva, il re continuava a pensare a quello che conveniva alla salute delle anime di questa gente, perciò mosso da pietà (piedade) dissimulava con loro e rimandava l’ordine di dare loro l’imbarco, e dei tre porti del suo regno che gli aveva assegnato per ciò, gliene vietò due, e ordinò che tutti si venissero a imbarcare a Lisbona, dando loro gli
395 «... per capillos adductos ad pillam»
Estaus per alloggiare, dove si riunirono più di ventimila anime, e con questi ritardi si oltrepassò il tempo che il re aveva posto come limite per la loro partenza, per cui si trovavano tutti prigionieri. Vedendosi in una condizione così misera, molti di loro decisero di proporre al Re che gli fossero restituiti i loro figli e gli fosse promesso che per vent’anni non si svolgessero indagini sul loro conto, e che si sarebbero fatti cristiani. Il Re glielo concesse insieme a molti altri privilegi, e ordinò subito che si desse l’imbarco a quelli che non vollero essere cristiani, annullando lo stato di prigionieri in cui erano venuti a trovarsi, e passarono tutti in terra di musulmani. […]Certo che l’impresa di fare sì che gli ebrei divenissero cristiani fu degna di molta lode, ammesso che ne potessero derivare gli inconvenienti che nel consiglio del Re furono indicati, e molti altri che si videro poi in cui allora si sarebbe potuti appena cadere, perché la conversione di questa gente non poteva provocare nessuna perdita che si potesse stimare tale a paragone di quello che si guadagnò col far conoscere loro la verità di ciò che dovevano credere […]103.
Aldilà delle comprensibili e ambivalenti sfumature del racconto di Góis, i lettori del tempo non mancarono comunque di scorgervi da subito una chiara denuncia delle ingiustizie subite dagli ebrei portoghesi a fine Quattrocento, come rivela il fatto che nel 1572 il marrano Abraham Righetto, sotto processo inquisitoriale a Venezia, presentò ai giudici una traduzione in italiano del capitolo della cro-naca di Góis relativo al battesimo forzato come parte della propria difesa104.
Una posizione di netta condanna verso la decisione del re porto-ghese di convertire a forza gli ebrei fu invece espressa da Jerónimo
103 Góis, Crónica cit., III, cap. XX, De quomo elrey mandou tomar hos filhos ahos Iudeus que se ihão fora do Regno, & porque causa nam fez ho mesmo ahos mouros, pp. 41-42; cap. XXI, Do fructo que se fez em tornarem hos Iudeus Christãos, p. 43 (la tra-duzione dal portoghese è mia).
104 Il primo a segnalare la lettura della cronaca di Góis da parte di Righetto è stato B. Pullan, ‘A ship with two rudders’: ‘Righetto Marrano’ and the Inquisition in Venice, in «The Historical Journal», XX, 1977, pp. 25-58, in part. p. 49. Per completezza, cfr. gli atti della sessione dell’11 settembre 1572 del processo di Abraham Righetto, pubblicato in Ioly Zorattini (a cura di), Processi cit., III, pp. 143-145.
396 Giuseppe Marcocci
Osório a quattro anni di distanza dalla pubblicazione della cronaca di Góis. Nel 1571 uscì infatti dalla penna di Osório una nuova cronaca del regno di D. Manuel, scritta stavolta in latino e dedi-cata anch’essa al cardinale infante D. Henrique105. Osório fu una personalità di primissimo piano nella vita culturale e religiosa del Cinquecento portoghese. Aveva studiato teologia, filosofia e diritto nelle più prestigiose università europee, come Salamanca, Parigi e Bologna. Durante il soggiorno in Italia aveva stretto legami con figure del calibro di Sadoleto e Bembo. Tornato in Portogallo, aveva ricoperto negli anni Cinquanta incarichi di rilievo a corte e nelle istituzioni culturali del paese, finché non era stato eletto vescovo dell’Algarve nel 1564106. Nei capitoli in cui affrontava il battesimo forzato, Osório riprendeva con lievi aggiunte lo schema dell’esposi-zione dei fatti proposto da Góis, del quale peraltro tesseva un lungo elogio nell’epistola dedicatoria, scritta proprio in corrispondenza con la cattura dello stesso Góis da parte del Sant’Uffizio avvenuta il 4 aprile 1571107. Ma rispetto alla cronaca precedente, le pagine di Osório rappresentavano uno scarto notevole. Occorre tenere pre-sente che il loro autore, oltre ad avere una vasta preparazione giuri-dica e teologica, era anche un vescovo profondamente influenzato
105 La cronaca di Osório uscì a Lisbona nel 1571 presso la tipografia di António Gonçalves. Qui però cito da J. Osório, De rebus Emmanuelis Regis Lusitaniae invic-tissimi virtute et auspicio gestis Libri XII, in Id., Opera omnia, Hieronymi Osorii nepotis canonici eborensis diligentia in unum collecta, & in quattuor volumina distributa [...], Romae, ex Bibliotheca Georgii Ferrarii MDXCII, I, coll. 562-1122.
106 Sull’attività espiscopale di Osório, cfr. Lopes, Memorias cit., pp. 323-338; Almeida, História cit., II, p. 655; sul suo orientamento all’interno degli equilibri religiosi ed ecclesiastici lusitani, cfr. J.S. da Silva Dias, Correntes do sentimento religioso em Portugal (séculos XVI-XVIII), Coimbra, Instituto de Estudos Filosoficos Universidade de Coimbra 1960, p. 465; Id., A política cultural de D. João III, Coimbra, Universidade de Coimbra 1969, p. 946.
107 Sul processo inquisitoriale di Góis, cfr. ora J.P. Paiva, «Católico sou e não lute-rano»: o processo de Damião de Góis na Inquisição (1571-1572), in Damião de Góis. Um humanista na Torre do Tombo, coord. J.V. Serrão, Lisboa, Instituto dos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo 2002, pp. 20-42. Il processo è pubblicato in Inéditos Goesianos. Fac-simile da Edição de 1896, por G.J.C. Henriques (da Carnota), II - O Processo na Inquisição, Arruda dos Vinhos, Arruda Editores 2002.
397 «... per capillos adductos ad pillam»
dall’ideale tridentino e si trovava quotidianamente impegnato nel difficile compito di amministrare una diocesi come quella algarbia dove era radicata una nutrita comunità di nuovi cristiani. Era, dun-que, anche a partire dall’esperienza diretta e personale del problema conversos che Osório aveva maturato probabilmente le proprie severe opinioni circa il battesimo forzato degli ebrei, i cui effetti continuavano a suscitare uno scandalo che era sotto gli occhi di tutti. La condanna di Osório era affidata una dura apostrofe contro il sovrano portoghese che il vescovo dell’Algarve inserì al termine della racconto del drammatico episodio degli Estaus di Lisbona. Si tratta di un esemplare pezzo di oratoria umanistica, di notevole effi-cacia e che presenta una valutazione della vicenda la cui derivazione giuridica e teologica appare a tutta prima evidente:
Fuit quidem hoc nec ex lege, nec ex religione factum. Quid enim? Tu [il re D. Manuel] rebelles animos, nullaque ad id suscepta religione constrictos, adigas ad credendum ea, quae summa contentione aspernatur et respuunt? Idque tibi assumas, ut libertatem voluntatis impedias, et vincula mentibus effrenatis inicias? At id neque fieri potest, neque Christi sanctissimum numen approbat. Voluntarium enim sacrificium, non vi, et malo coactum ab hominibus expetit; neque vim mentibus inferri, sed voluntates ad studium verae religionis allici, et invitari iubet. Porro autem, quis sibi id arrogare potest, quod solus Divinus spiritus efficit in eorum animis, qui non ad extremum vitae spiritum illius benignitati repugnare contendunt? Ille namque solus est, qui mentes illustrat, et allicit, et invitat; et eos, qui tantum munus non animo pertinaci, et ingrato repudiant, ad Christi confessionem, et societatem perducit. Postremo, quis non videt, quam indignum sit, hominibus in religionis studio suspectis tot myste-ria, tot res sacrosanctas, tantam rerum Divinarum rationem committere? Et sceleris occasionem iis, qui Christi disciplinam ludibrio habent, inconsiderate praebere? Et ita religionem per religionis simulationem indignissime violari? Regis tamen animus multis merito laudandus esse videtur, quod id religionis studio, ut ea ratione gentis Hebraeae salus constitui aliquando posset, effice-ret, maxime cum viri, religionis, et doctrinae opinione praestantes, id licere dicerent, et fuisse iam a principibus Christianis olim factitatum. Numquam enim defuere, nec umquam deerunt, qui ad Principum gratiam aucupandam orationes accomodent108.
108 Osório, De rebus Emmanuelis cit., col. 585.
398 Giuseppe Marcocci
Il brano di Osório mostrava in maniera esplicita come il piano della ricostruzione storica del battesimo forzato degli ebrei in Portogallo tendesse a intrecciarsi strettamente con quello delle interpretazioni teologiche e giuridiche. E se Ledesma aveva attaccato i «thomistae captiosi» per la loro difesa a oltranza del diritto naturale dei genitori infedeli, Osório non esitava ad accusare i consiglieri di D. Manuel, ricordando come non mancarono allora, né mancavano ai suoi giorni, «qui ad Principum gratiam aucupandam orationes accomo-dent».
Affatto diverso, naturalmente, era il caso della storiografia ebrai-ca, che però merita di essere almeno richiamato, se non altro per-ché, come ha osservato Yerushalmi, le drammatiche vicende che colpirono le comunità ebraiche della penisola iberica alla fine del Quattrocento segnarono un momento di svolta nella maturazione della sensibilità storica all’interno della cultura ebraica109. In età rinascimentale, infatti, il peso che assunse la narrazione della sto-ria recente nelle cronache ebraiche crebbe in modo notevole. Ciò pone, senza dubbio, il problema dell’uso che la storiografia odierna può fare di tali fonti, ma le differenze rispetto alla cronachistica cristiana rimasero in ogni caso evidenti. Per quanto riguarda il bat-tesimo forzato degli ebrei lusitani, si può considerare il caso della Consolaçam as Tribulaçoens de Israel, opera del marrano portoghese Samuel Usque, pubblicata a Ferrara nel 1553. Scopo dichiarato di Usque era quello di esortare i marrani che vivevano da cristiani a gettare la maschera e a ritornare a professare pubblicamente la propria antica religione. Nel racconto di Usque netto e reciso era il rifiuto del battesimo e della violenza, sentita come indiscrimina-ta, che subirono gli ebrei da parte di D. Manuel. Si può citare, ad esempio, la pagina in cui Usque descriveva la vicenda degli Estaus di Lisbona. Dopo che erano stati battezzati a forza tutti gli ebrei di età inferiore ai venticinque anni, i cristiani
ritornarono dai padri, che sopportavano ormai con grande sofferenza la vita che detestavano, per dargli un’altra angoscia mortale, dicendogli che i loro figli si erano già convertiti al cristianesimo e che lo dovevano fare anch’essi
109 Cfr. Y.H. Yerushalmi, Zakhor. Storia ebraica e memoria ebraica, Parma, Pratiche editrice 1983 [ed. or. Seattle-London 1982], in part. pp. 67-88.
399 «... per capillos adductos ad pillam»
se volevano continuare a vivere in loro compagnia. Neppure di fronte a ciò gli adulti tentennarono, finché il re non gli fece levare il cibo e il bere per tre giorni di seguito, per tentarli con la sofferenza della fame, ma sopporta-rono anche questo con grande coraggio. Il re, rendendosi conto che neppure questo bastava e che se li avesse fatti ancora soffrire sarebbero morti, decise di usare la violenza che aveva usato con i loro figli, e trascinandoli alcuni per le gambe, altri per la barba e i capelli, dando loro pugni sul viso, e per-cuotendoli, li portarono nelle chiese dove gli gettarono addosso l’acqua. Dei molti che compirono grandi gesti estremi per difendersi, se ne distinse uno che, coprendo sei figli con il suo taled, e con parole di saggezza dando loro la forza di morire per la loro legge, uno a uno, con loro tutti alla fine si uccise; e altri, moglie e marito, si impiccarono e coloro che li vollero portare a seppellire furono uccisi dai nemici a colpi di lancia; ci furono molti che si gettarono nei pozzi; e altri si facevano a pezzi buttandosi giù dalle finestre. E tutti questi corpi israeliti morti in questa maniera i carnefici delle mie membra li portavano a bruciare davanti agli occhi dei loro fratelli, perché maggiore paura e timore della loro crudeltà li prendesse110.
L’intero episodio era letto come un avveramento delle profezie di castigo per le colpe di Israele contenute nella Bibbia, come mostra-va chiaramente la conclusione del capitolo dedicato al battesimo forzato:
Con questa violenza contro le leggi divine e umane furono fatti cristiani molti corpi, ma nelle anime mai li toccò macchia, anzi sempre ebbero impresso il sigillo della loro antica fede. Chi potrà sfuggire alla tua ira, o Signore? Quando con tanta causa si muove come i miei delitti la risvegliaro-no, che fino a qua in queste ultime parti della terra mi cinge, perché abbiano esecuzione queste crudeli sentenze che per bocca dei tuoi profeti hai dato contro di me dicendo:Ti spargerà il Signore fra tutti i popoli da un capo della terra fino alla fine di essa, lì servirai altri dei, che né tu né i tuoi padri conobbero e servirai il tuo
110 S. Usque, Consolação às Tribulações de Israel, edição de Ferrara, 1553, 2 voll., com estudios introductorius por Y.H. Yerushalmi, J.V. de Pina Martins, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian-Centro Cultural Português 1989, II, dial. III, cap. XXVIII, Quando os fizerom cristãos por força. Portugal. Año 5257, ff. 203v-204 (la traduzione dal portoghese è mia).
400 Giuseppe Marcocci
nemico […]. E tutti quelli che rimarranno di questa malvagia generazione, piuttosto sceglieranno la morte che la vita. E nel giorno (di questa) tribo-lazione (nella terra straniera) gli volterò le spalle e non la faccia così come loro mi voltarono le spalle e non la faccia, e adorarono dei altrui (nelle loro terre).Però (la verità è) che se noi ci dimentichiamo del nome del nostro D. e solleviamo le nostre palme al dio altrui non cessa il Signore di scrutare ciò (che è con forza) perché egli conosce i segreti del cuore111.
Una terza e più delicata posizione, infine, si può cogliere nei
numerosi memoriali inviati a Roma dai nuovi cristiani portoghe-si. In questo caso l’intenzione degli estensori era quella di tenere insieme da un lato la denuncia, su basi teologiche e giuridiche, della violenza assoluta subita, dall’altro la professione della propria since-ra fede cattolica, dando di sé l’immagine di vittime sacrificate alla persecuzione dura e arbitraria dell’Inquisizione. Di fatto, già dopo il perdono generale del 1535-1536 e più ancora dopo quello del 1547-1548, l’obiettivo reale dei diplomatici nuovi cristiani a Roma non era più quello di vedere annullata la validità del battesimo forzato, ma quello di ottenere almeno qualche garanzia in più per la propria incolumità e nuovi limiti all’azione del Sant’Uffizio112.
Ritorniamo alla cronaca di Osório. Grazie all’autorevolezza del-l’autore e al fatto di essere scritta in latino, essa ebbe una ampia diffusione nel resto d’Europa e la narrazione del battesimo forzato ivi
111 Ibid., ff. 204-205.112 Manca ancora uno studio sui numerosi memoriali presentati a Roma dai
nuovi cristiani portoghesi nel corso del Cinquecento. Essi continuarono sempre a insistere sulla questione del battesimo forzato. Nel 1560, ad esempio, per ottenere la revoca del breve Dudum cum foelicis recordationibus del 2 gennaio 1560, con cui il pontefice aveva concesso all’Inquisizione la facoltà di processare gli imputati senza l’obbligo di rendere noti i nomi dei testimoni dell’accusa e le circostanze delle colpe, fu inviato a Pio IV un nuovo memoriale, in cui si legge: «E perché la Santità Vostra sia informata, ha da sapere, per cosa chiara e manifesta, che nel 1497 detti nuovi Christiani per ordine e commandamento del Serenissimo Re Emanuele di chiara memoria sono stati violentemente battezzati per forza precisa invitis contra-dicentibus praefatis novis Christianis» (BdA, cod. 46-IX-2, Rerum Lusitanicarum, II [Negoziato del vescovo di Chiasmo, 1560], ff. 150 r-v).
401 «... per capillos adductos ad pillam»
contenuta si impose come la versione di riferimento sull’accaduto. All’interno del mondo cattolico la dura invettiva del prelato lusi-tano lasciò una traccia profonda. Ad essa si rispose in vario modo. Uno dei testi dove ciò apparve con maggiore chiarezza furono i Diálogos del carmelitano Amador Arrais, pubblicati a Coimbra nel 1589113. All’epoca Arrais era vescovo di Portalegre. Aveva compiuto studi teologici presso l’università di Coimbra, dove invano per anni aveva tentato di intraprendere la via dell’insegnamento accademi-co. La sua carriera ecclesiastica era stata invece più brillante, ed era avvenuta tutta all’ombra di due fra i principali rappresentati dello schieramento più severo e intransigente del mondo cattolico portoghese del Cinquecento: il carmelitano Baltasar Limpo, vesco-vo e inquisitore di Porto e poi arcivescovo di Braga, e il cardinale infante D. Henrique, che lo aveva scelto come vescovo coadiutore nell’arcidiocesi di Évora a partire dal 1578114. I Diálogos, riconosciuti come uno dei capolavori in prosa della letteratura lusitana del tardo Cinquecento, si richiamavano esplicitamente nella struttura e nello stile al modello del dialogo della letteratura classica e, al tempo stesso, appartenevano al genere delle opere di edificazione morale cristiana: attraverso dieci dialoghi con vari interlocutori il prota-gonista Antioco, infermo nel corpo e nell’anima, intraprendeva un cammino di perfezione che lo conduceva a giungere preparato all’appuntamento con la morte. Il terzo dialogo, intitolato Da gente Iudaica, costituiva un efficace esempio dei duri sentimenti anti-con-versos dell’autore, tuttavia la struttura dialogica e controversistica dell’opera lasciava ampio spazio alla presentazione e alla discus-sione di posizioni più aperte e tolleranti nei confronti dei nuovi cristiani115. Si legga l’inizio del dialogo, con l’incontro fra Antioco
113 Cfr. Diálogos de D. Frei Amador Arrais, Introdução e Revisão de M. Lopes de Almeida, Porto, Lello & Irmão 1974, che riproduce il testo della seconda edizione dell’opera, pubblicata a Coimbra nel 1604.
114 Sulla figura di Arrais, cfr. l’introduzione di Lopes de Almeida, ibid., in part. pp. x-xxvii. Cfr. inoltre Almeida, História cit., II, p. 645; B. Velasco Bayón, História da Ordem do Carmo em Portugal, Lisboa, Paulinas 2001, pp. 160-169.
115 La rilevanza del contenuto anti-giudaico del terzo Da gente Iudaica fu messa in evidenza già nell’introduzione a un’edizione antologizzata dell’opera di Arrais: cfr. A. Arrais, Diálogos, selecção, prefácio e notas de F. de Figueiredo, Lisboa, Sá da Costa 1944, pp. xvii-xxx.
402 Giuseppe Marcocci
e il colto nobile Aureliano, il quale rimprovera l’amico per avere cercato rimedio ai propri mali nelle cure del medico nuovo cristiano Apollonio:
AURELIANO: […] Dite, non sarebbe stato meglio se aveste prestato più attenzione alla vostra salute, e considerato senza affetto la qualità delle persone a cui affidate la vostra vita? Non avete mai visto bruciare ebrei in Portogallo? Non sapete che si è scoperto per esperienza che molti di quelli che mostravano la miglior apparenza di cristiani, si erano invece più abban-donati alla perfidia ebraica? C’è da stupirsi, che essendo così ostinati nel loro errore, non si sia ancora visto nessuno pronto in nome di ciò a mettere da parte moglie, figli, e averi, e la propria vita; anzi, per non perdere niente di tutto ciò, lo nascondono, e occultano, e dissimulano quanto possono, e fanno quello che gli si ordina, come persuasi che non sia peccato negare a parole l’ebraismo, che custodiscono nel cuore e ritengono la vera fede.ANTIOCO: Questi erano gli ebrei, e io, fino a prova contraria, considero cristiani tutti gli altri che vivono al giorno d’oggi; soprattutto il dottor Apollonio, mio medico.AURELIANO: Allora vi dico che gli ebrei hanno in voi un buon avvocato per perorare la loro causa116.
In realtà Antioco si rivelerà nel resto del dialogo l’esatto opposto di un «buon avvocato» per i nuovi cristiani. Attaccherà duramen-te ebrei e marrani, rivelandosi il vero portavoce della posizione di Arrais. Tuttavia non si può non rilevare come, a distanza di mezzo secolo dal divieto di pubblicazione che aveva colpito l’operetta di Góis e negli stessi mesi, per ragioni analoghe, l’Espelho dos cristãos-novos di Francisco Machado e il Diálogo Evangélico sobre os Artigos da Fé contra o Talmud dos Judeus di João de Barros, i margini di discussione sul problema conversos, secodo un processo i cui prodro-mi erano già evidenti nelle cronache di Góis e di Osório, si fossero decisamente allargati117. A quasi un secolo di distanza dal battesimo
116 Diálogos cit., dial. III, cap. I, Quem trouxe os Judeus à Hespanha, & os lançou della, p. 111 (la traduzione dal portoghese è mia).
117 Le opere di Machado (scritta nell’agosto-settembre 1541) e di Barros (scrit-ta sul finire del 1542) rimasero manoscritte e sono state edite solo di recente: cfr. The Mirrors of the New Christians (Espelho dos Cristãos Novos) of Francisco
403 «... per capillos adductos ad pillam»
forzato e con il Sant’Uffizio che ormai era una realtà consolidata da oltre cinquanta anni di repressione anti-giudaizzante, il confronto pubblico sui nuovi cristiani non presentava più rischi. Altre e ben più urgenti erano nella seconda metà degli anni Ottanta le preoccu-pazioni degli apparati di controllo della Chiesa, in primo luogo del-l’Inquisizione. Come sottolineò per primo Henry Charles Lea, con il passaggio dinastico del Portogallo sotto la corona di Filippo II di Spagna avvenuto nel 1580, riprese notevolmente la mobilità penin-sulare dei nuovi cristiani, che tentavano di sfuggire agli attacchi degli inquistori passando da una parte all’altra del confine fra i due regni118. Le due Inquisizioni iberiche, che continuavano a operare separatamente anche se secondo strategie di collaborazione sempre più definite, avevano serie difficoltà a riprendere il controllo della situazione e in Portogallo l’impegno profuso in tal senso condusse a un forte incremento della persecuzione inquisitoriale tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, soprattutto nell’area settentrionale del paese. In questo clima si consumò anche l’ultimo tentativo di ricorrere a strumenti tesi ad ottenere, attraverso la via della persuasione e dell’indottrinamento graduale, una conversione sincera e consapevole dei discendenti degli ebrei battezzati a fine Quattrocento. Si tratta della vicenda del fallito progetto di redigere in Portogallo un catechismo appositamente rivolto ai nuovi cristia-ni119. La questione fu ufficialmente posta nel luglio del 1592 dall’in-quisitore generale dell’epoca, il cardinale Alberto arciduca d’Au-stria, che inviò una lettera circolare ai vescovi del regno per avere
Machado, Edited, Translated, and with an Introduction by M.E. Vieira, F.E. Talmage, Toronto, Pontifical Institute of Medieval Studies 1977; Diálogo Evangélico cit. All’introduzione a quest’ultimo volume, ora riedita anche in Révah, Études Portugaises cit., pp. 51-95, si rinvia per un inquadramento complessivo delle vicende censorie lusitane all’inizio degli anni Quaranta.
118 Cfr. H.Ch. Lea, A History of the Inquisition of Spain, 4 voll., New York, Macmillan Co. 1906-1907, III, pp. 266-278.
119 Sulla storia del catechismo per i nuovi cristiani rimane fondamentale A. Baião, A Inquisição em Portugal e no Brasil. Subsídios para a sua História, Lisboa, Edição do Arquivo Histórico Português 1920, pp. 39-42. Cfr. anche dello scrivente «Catequização pelo medo»? cit., pp. 173-177; I custodi dell’ortodossia cit., pp. 349-353.
404 Giuseppe Marcocci
un loro parere sull’ipotesi della realizzazione del catechismo120. Con l’eccezione del vescovo dell’Algarve Francisco Cano, tutti i prelati di cui si sono conservate le risposte si schierarono contro il progetto di catechismo, che infatti non venne mai scritto121. Il dibattito intor-no alla questione, tuttavia, doveva essere già vivo almeno dalla fine degli anni Ottanta, come induce a ritenere un riferimento diretto al progetto del catechismo contenuto nel capitolo conclusivo del terzo dialogo dell’opera di Arrais122. Si può addirittura pensare, anzi, che l’inserzione nei Dialogos dell’intera terza sezione, dedicata agli ebrei e ai loro discendenti, debba essere letta come il tentativo di dare un fondamento culturale più ampio al rifiuto opposto da Arrais, attraverso la posizione di Antioco, all’ipotesi di un catechismo per i nuovi cristiani; rifiuto che ritornò poi in termini analoghi nella lettera di risposta che il vescovo carmelitano indirizzò al cardinale Alberto nel 1592123.
Ma quello che qui più interessa è che al Da gente Iudaica Arrais affidava anche la propria risposta a Osório. Dopo avere narrato l’episodio del battesimo forzato, riprendeva alla lettera l’apostrofe
120 Lettera del cardinale Alberto arciduca d’Austria ai vescovi del regno, Lisbona, 28 luglio 1592, edita in appendice a Baião, A Inquisição cit., doc. XII.
121 Cfr. lettera di Francisco Cano, vescovo dell’Algarve, al cardinale Alberto arci-duca d’Austria, Faro, 29 agosto 1592, edita in ibid., doc. XIII. Su Cano, cfr. Lopes, Memorias cit., pp. 364-367; Almeida, História cit., II, pp. 655-656. Gli altri vescovi di cui conosciamo gli interventi sulla questione sono: Afonso de Castelo Branco, vescovo di Coimbra, António Matos de Noronha, vescovo di Elvas, Amador Arrais, vescovo di Portalegre, e Nuno de Noronha, vescovo di Viseu.
122 Cfr. Diálogos cit., dial. III, cap. XXXV, Que humanamente parece não ter reme-dio a obstinação dos Judeus, per via de disputas, & argumentos, pp. 209-213, in cui Antioco rifiuta la seguente proposta, avanzata da Aureliano alla fine del capitolo precedente: «[…] vos digo que se o juizo me nam mente, fareis hum assinalado serviço à Igreja Catholica se destas tam qualificadas razões, & doutros discursos que entendi irdes cortando por abreviar, ordenasseis (dando vos Deos forças para isso) algum Sumario em forma de Cathechismo, do qual me parece se deveria esperar bom successo na conversam desta gente: porque em fim a verdade, & razam tudo acabam» (p. 209).
123 Cfr. lettera di Amador Arrais, vescovo di Portalegre, al cardinale Alberto arci-duca d’Austria, Inquisitore generale, s.l.n.d, ma 1592, edita in appendice a Baião, A Inquisição cit., doc. XIV.
405 «... per capillos adductos ad pillam»
osoriana a D. Manuel, riproponendola però in forma dialogica con il risultato di ribaltarne, pur accettandole in parte, le conclusioni:
AURELIANO: E non vi pare che fu sottrarre l’autorità a Dio e andare contro la giustizia e la dolcezza del Vangelo costringere ad essa anime ribelli e impe-dire la libertà della volontà? Cos’altro fu questo, se non dare l’occasione perché attraverso la finzione si profanasse la santa religione del figlio di Dio e si aprisse la porta ai perfidi ebrei perché ogni giorno ricevessero in modo indegno i sacramenti che Cristo ha ordinato a prezzo del suo sangue e vio-lassero i misteri e la santità della nostra fede con simulata e finta devozione? Chi mi darà così tante lacrime per piangere notte e giorno? Perciò declinano le nostre cose e la prosperità di una repubblica cristiana tanto fiorente va sempre più peggiorando. Ho sentito dire che da Costantinopoli un ebreo aveva scritto a quelli della sua nazione che abitano vicini a questi regni, che facessero i loro figli medici e sacerdoti, perché fossero signori delle anime e dei corpi dei cristiani.ANTIOCO: Tuttavia non potete incolpare l’intenzione e la pretesa del re pietosissimo che agì con buon zelo e ardentissimo desiderio di mettere la gente cieca e pertinace sul cammino della salvezza. Tanto più che ci furono uomini illustri nelle lettere e nelle virtù, il cui parere fu che lo poteva fare lecitamente, e che Sisebuto, principe religiosissimo, lo aveva fatto, come si contiene nel quarto Concilio Toledano.AURELIANO: Voi li chiamate illustri nelle lettere? Io li chiamo adulatori, che si vogliono insinuare nella grazia dei principi124.
Fin qui la ripresa delle parole di Osório, la cui posizione veniva difesa da Aureliano, che rendeva poi esplicito il senso della pole-mica finale del vescovo dell’Algarve contro i consiglieri adulatori «qui ad Principum gratiam aucupandam orationes accomodent»125. Domandava infatti: «Quale dottore teologo ha detto che si potevano trascinare per i capelli gli infedeli al battesimo, o che lecitamente si potevano battezzare i figli degli infedeli contro la volontà dei loro genitori?»126 A questo punto Arrais affidava ad Antioco la risposta
124 Diálogos cit., dial. III, cap. III, Do baptismo dos Judeus, ordenado pelo Christianissimo Rey Dom Manuel, & do zelo da fé delRey Dom João seu filho, p. 116.
125 Osório, De rebus Emmanuelis cit., col. 585.126 Diálogos cit., dial. III, cap. III, p. 116.
406 Giuseppe Marcocci
all’obiezione di Osório, facendo ampio ricorso alle armi della teologia. Era un argomento delicato, ammoniva Antioco, di cui non si doveva parlare con troppa libertà. Occorreva distinguere fra battesimo per vim praecisam et absolutam e battesimo per vim conditionalem, che doveva essere considerato valido. Di quest’ultimo, proseguiva Antioco, «si occupava il concilio toledano, dichiarando che gli ebrei così battezzati per ordine del visigoto Sisebuto, re di Spagna, fossero costretti alla fede di Cristo, al suo compimento. E notate che nello stesso decreto si proibisce che qualcuno sia battezzato a forza, nonostante Sisebuto abbia agito con lo zelo della religione, ma non secondo la scienza, e lo stesso si può dire del re D. Manuel». In ogni caso, asseriva anco-ra Antioco, non senza una certa ambiguità, «in qualunque modo il battezzato acconsenta, rimane obbligato al cristianesimo. Tuttavia gli ebrei, che solamente con la voce acconsentirono senza alcun consenso interiore, non sono cristiani, nonostante la Chiesa li possa costringere e li costringa ad osservare le leggi di Cristo». Si affrontava poi il nodo dei fondamenti teologici dell’atto compiuto da D. Manuel:
Scoto disse che credeva che fosse un’opera religiosa se gli infedeli che hanno l’uso della ragione venissero costretti con minacce e terrori a ricevere il bat-tesimo; può essere che proprio questo alcuni teologi consigliassero al re feli-cissimo. Ma è contro la comune opinione dei dottori, ed è vero che in nessun modo è lecito costringere una persona a ricevere il sacramento della nostra fede. E per questo c’è l’autorità della Santa scrittura, dei sacri Concili e dei santi padri, che contraddicono tutte il parere di Scoto. Quanto ai figli degli infedeli che ancora non usano il libero arbitrio, Scoto disse che si potevano battezzare contro la volontà dei genitori o dei tutori, se era possibile farlo con cautela e dottrina dei battezzati. Dal momento che non si devono battezzare tali creature, perché dopo restino in potere dei genitori infedeli, sotto pena di gravissimo sacrilegio. E il re Emanuele avrebbe seguito questa opinione di Scoto su consiglio di alcuni letrados, che hanno zelo senza prudenza127.
Dunque D. Manuel non aveva agito «nec ex lege, nec ex religione», come aveva scritto Osório128. La decisione del sovrano non era stata
127 Ibid., p. 117.128 Osório, De rebus Emmanuelis cit., col. 585.
407 «... per capillos adductos ad pillam»
inaudita e arbitraria, bensì fondata su un’interpretazione teologica plausibile, sebbene minoritaria, come quella di Scoto. L’imprudenza dei consiglieri del re aveva poi altre attenuanti. Su questo punto non avevano oscillato anche grandi teologi del Cinquecento come Vitória e il suo discepolo Ledesma, che ne aveva ripreso la lezione in Portogallo? Arrais era stato allievo di Ledesma in gioventù. Nelle parole di Antioco si rifletteva così la lontana esperienza di studente universitario dell’autore:
Ai nostri tempi il mio maestro Ledesma, cattedratico di Prima in Teologia all’università di Coimbra, insegnava queste due conclusioni. Parlando in assoluto, è lecito ai Principi e ai Pontefici battezzare i figli degli infedeli contro la volontà dei loro genitori perché nessun diritto lo proibisce, ed essi usano male del naturale. Però non si deve fare, perché nella maggior parte dei casi ne deriva scandalo e il pericolo di seguire la setta e la falsa credenza dei genitori o di essere cristiani simulati129.
Il ragionamento di Arrais appare non privo di contraddizioni. Egli
intendeva giustificare il battesimo forzato degli ebrei portoghesi, ma le conclusioni teologiche che presentava, pur non esprimendo una negazione categorica della legittimità di tale episodio, pende-vano senza dubbio in tale direzione. Tuttavia Arrais non esitava ad appoggiarsi ad esse forzandole, per motivare le scelte compiute da D. Manuel. Si comprende così quanto l’ambivalenza di una posi-zione come quella di Ledesma potesse prestarsi nel Portogallo del Cinquecento a una rilettura a sostegno dei fautori della validità del battesimo forzato. Al termine del proprio discorso, dunque, Antioco poteva tranquillamente dire ad Aureliano: «mi sembra che modere-rete la vostra censura e non darete tanta colpa al re, amicissimo e zelosissimo della vera religione di Cristo». Il buon principe, infatti, «ha sempre Dio davanti ai suoi occhi, ed è la guida che segue nelle sue imprese e nelle sue pretese. E così credo che sia per il pietosis-simo re D. Manuel, nel caso che alcuni» – e qui era naturale che il pensiero corresse subito a Osório – «giudichino una colpa ciò che non vogliono intendere»130.
129 Diálogos cit., dial. III, cap. III, p. 117.130 Ibid., pp. 117-119.
408 Giuseppe Marcocci
8. A fine Cinquecento la discussione sul battesimo forzato venne ripresa anche dalla letteratura inquisitoriale. Nel 1598 Luis de Paramo affrontò l’argomento, discutendo però i termini teologici e giuridici della questione a proposito dell’espulsione degli ebrei dalla Spagna, che presentava sensibili differenze rispetto al caso lusitano, al quale invece era dedicato solo un rapido paragrafo131. Paramo, comunque, non risparmiava le proprie critiche al sovrano portoghe-se, sottolineando in particolare gli effetti nefasti che alla lunga aveva prodotto la violenza imposta agli ebrei:
Priusquam Ioannis III eius nominis, regnis Portugalliae solicitudine Sanctae Inquisitionis Officium ad normam Castellae in illud Regnum inductum esset, D. Emmanuel eius pater tanta fuerat praeditus pietate, ac religionis studio tenebatur, quantum Iudaeorum perfidiam, ac maurorum feces exe-cratus est.I. Nam Catholicorum Regum imitatione, anno Domini 1496. 25. Septembris, edicto praecipit intra statutum certum temporis curriculum omnes Iudaeos ac Mauros suo Regno exilire, exceptis eorum filiis, qui decimum tertium annum non excessissent, quos in Regno detinuit, qui invitis parentibus baptismalibus aquis loti sunt.II. Deinde vero idem Rex suorum consiliariorum decreto de maurorum ac Iudaeorum conversione, quorum plures ex iis, qui Castellae Regno fuerant amandati, in Lusitania erant, sententia mutavit, et (ut quidam referunt) narrante Garibay libr. 25. suae Historiae, cap. 27. anno sequenti 1497. sub gravissimis poenis omnes compulit baptizari, ex quo plura mala orta sunt: nam ab illis qui inviti atque coacte ad fidem accesserant (quo nihil magis a fide abhorret) neophytorum more scelera quam plurima contra fidem, quam fuerant professi, commissa sunt132.
131 Cfr. L. de Paramo, De Origine et Progressu Officii Sanctae Inquisitionis eiusque dignitate & utilitate, de Romani Pontificis potestate & delegata Inquisitorum, Edicto Fidei, & ordine iudiciario Sancti Officii, quaestiones decem, Madrid, Ex Typographia Regia 1598. La discussione sul caso spagnolo si trova in ibid., Liber II, De origine et progressu sanctae Inquisitionis delegatae, tit. II, De propagatione Sanctae Inquisitionis per orbis provincias, cap. VI, Quo tempore Sarraceni, Iudaeique ab Hispania expulsi sint, VI-IX, pp. 164-166.
132 Ibid., cap. XVI, De expulsione Iudaeorum a Lusitania, I-II, pp. 234-235. Così descriveva l’episodio portoghese Garibay, la fonte spagnola a cui Paramo si rifaceva:
409 «... per capillos adductos ad pillam»
Sull’episodio portoghese si soffermò con maggiore ampiezza il giu-reconsulto spagnolo Francisco Peña in un trattatello rimasto mano-scritto, ma che conobbe comunque una discreta circolazione, dedica-to al tempo di grazia133. Scritto all’inizio del Seicento, probabilmente in occasione del dibattito, cominciato sin dai primi anni Novanta del secolo precedente, intorno alla concessione di un terzo perdono generale ai nuovi cristiani portoghesi, poi accordato loro nel 1604 e pubblicato nel 1605134, il trattato di Peña ricostruiva minutamente
«El Rey Don Manuel con acuerdo y consulta de los de su consejo, mudando parecer, en lo que tocava a la conversion de los Judios y Moros, de quienes, aun de los que avian venido de Castilla, avia grande numero, mandó segun algunas relaciones en el año seguiente de mil y quatro cientos y noventa y siete, so graves penas, que todos recibiessen la agua d’el Sancto Baptismo, y haziendolo por fuerça, socedian despues, como gente neofita, fresca y aun violenta en la Fe Catholica, grandes apostasias secretas, perpetrando gravissimas heregias, judaizando y mahometizando» (E. Garibay y Zamalloa, Los XL. Libros d’el Compendio Historial de las Chronicas y Universal Historia de todos los Reynos d’España, 4 voll., Impresso en Anveres, por Christophoro Plantino, prototypographo de la Catholica Magestad, a costa d’el auctor MDLXXI-MDLXXII, II, lib. XXXV, cap. XXVII, De los titulos de conde, que el rey Don Manuel dio, y conversion de los Moros y Judios, y matrimonio d’el Rey, y primera navegacion de Calicut, p. 907).
133 Cfr. F. Peña, De tempore gratiae, quod ab haeresi ad catholicam [fidem] redeunti-bus interdum concedi solet. Liber Singularis. Cito dall’esemplare conservato presso la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli, ms. Bracacciano 11 F 8. Sulla figura di Peña e sulle sue opere, cfr. A. Borromeo, A proposito del Directorium inqui-sitorum di Nicolás Eymerich e delle sue edizioni cinquecentesche, in «Critica Storica», XX, 1983, pp. 499-547.
134 L’inizio delle trattative che portarono alla concessione del terzo perdono generale deve essere probabilmente indicato nell’ottobre 1591, data a cui risale una petizione inviata a Filippo II da parte dei procuratori dei nuovi cristiani por-toghesi allo scopo di ottenere un nuovo perdono. Una copia del documento si trova in ANTT, Conselho Geral do Santo Ofício, Livro 301, ff. 46-53, a cui segue un parere emesso il 7 dicembre 1591 dal Consiglio Generale consultato al riguardo dal cardinale Alberto per conto del sovrano: cfr. ibid., ff. 53v-57v. Sulle vicende che condussero al perdono generale del 1604-1605, cfr. Azevedo, História cit., pp. 153-162; J. Marques, Filipe III de Espanha (II de Portugal) e a Inquisição portuguesa face ao projecto do 3° perdão geral para os cristãos novos portugueses, in «Revista da
410 Giuseppe Marcocci
la vicenda del battesimo forzato in Portogallo e l’acceso scontro avvenuto intorno ad esso negli anni Trenta del Cinquecento. Peña prese una posizione nettamente contraria alla promulgazione di un terzo perdono generale. Approvava invece la condotta di Clemente VII e di Paolo III, pur sottolineando il carattere ecccezionale del provvedimento di indulgenza da essi emanato:
Cum uterque Pontifex [Clemente VII e Paolo III] re mature deliberata, ardue perpensa, amplissimum gratiae tempus, et veniam delictorum contra fidem catholicam peccatorum generalem novis Christianis Portugalliae concesserit, qualem post hominum memoriam nec vidi, nec legi, nec audivi ab aliquo Romano Pontifice unquam fuisse concessum, necesse est fateri gravissimis eos, et urgentissimis causis permotos id fecisse, licet solas consti-tutiones sine his causis legentibus satis mirabile in ecclesia exemplum videri posset135.
In merito al giudizio sulla conversione degli ebrei lusitani il giure-consulto spagnolo ritornava sulla polemica di Osório, criticandone la ricostruzione storica e il giudizio espresso nella cronaca del regno di D. Manuel e palesando le proprie perplessità intorno al carattere di violenza assoluta del battesimo ricevuto a fine Quattrocento dagli ebrei in Portogallo:
In universo hoc Portugalensium Iudaeorum conversionis negotio maior difficultas in verificando, et intelligendo facto, quam in iure constituendo versabatur. Et propterea diu certatum fuit et expectatum, ut facti veritas haberetur. Ex auctoribus, et scripturis illius temporis, et ex casus narratione tunc iussu Clementis VII iurisperitis dato, ut dicerent sententiam suam, ita
Faculdade de Letras», (Universidade do Porto), s. II, X, 1993, pp. 177-203; Id., O Arcebispo de Évora, D. Teotónio de Bragança, contra o perdão geral aos cristãos-novos portugueses, em 1601-1602, in Congresso de História no IV Centenário do Seminário de Évora. Actas, 2 voll., Évora, Instituto Superior de teologia-Seminário Maior de Évora 1994, I, pp. 329-341.
135 Peña, De tempore gratiae cit., cap. XXIII, An sit concedendum tempus gratiae descendentibus ab his qui dicunt Maiores suos per vim fuisse conversos, §. IX, Rationes, quibus permoti Romani Pontifices suspensa tantisper Inquisitione generalem veniam seu tempus gratiae amplissimum concedere novis Christianis decreverunt, p. 186.
411 «... per capillos adductos ad pillam»
negotium gestum fuisse videtur, quemadmodum a nobis in hoc cap. 23. § 3. 4. et 5. explicatum est, videlicet Iudaeos e regnis Castellae exules a rege Portugaliae cum quibusdam pactis in suo regno susceptos non sponte sed vi et metu ad baptismum fuisse pertractos; et licet vis illa non fuerit omnino praecisa, et absoluta (id enim Iudaei probare non potuerunt) ac nec fortasse tanta quantam Osorius rhetorice exaggeravit, satis tamen est eam, etsi con-ditionalem, fuisse tamen maximam, et contra statuta Canonum ad conver-sionem adhibitam, quae debet esse libera, et spontanea […]136.
Le conclusioni del trattato De tempore gratiae di Peña vennero riprese, accolte e diffuse in Portogallo dal domenicano António de Sousa, deputato del Sant’Uffizio di Lisbona, nei suoi Aphorismi Inquisitorum, editi nel 1630137. Tuttavia Sousa, nella breve narrazio-ne storica sull’origine dell’Inquisizione in Portogallo che premetteva alla propria opera, ricostruiva l’episodio del battesimo forzato in una forma assai più attenuata. Non vi compariva nessun accenno alla violenza, né ombra alcuna gravava sulla condotta di D. Manuel, di cui anzi si rimarcava la «clementiam». La maggior parte degli ebrei avevano lasciato il paese, mentre solo alcuni erano rimasti, o perché trattenuti dal timore delle vessazioni dei marinai delle navi su cui dovevano fuggire, o perché speravano di trarne in futuro qualche beneficio. Tuttavia la loro volontaria conversione era stata fittizia, perché in segreto erano rimasti ebrei, ancor più minacciosi perché occulti, come dimostravano i loro discendenti nell’esperienza di tutti i giorni. Nelle parole di Sousa, dopo l’espulsione degli ebrei dalla Spagna, molti di essi, con il consenso del re D. João II,
ad Lusitaniam se contulerunt. Pius quidem Rex, pietate quadam, se appa-rente tantum, ductus est, cui insidiarum, traditionum, pluriumque malo-rum, quae gens haec in aliis provinciis, ac regnis perpetraverat, omnino defuit consideratio. Recepit illos ad destinatum tantum tempus, quo sub amittendae libertatis paena, e regno exire tenerentur. Elapso tempore,
136 Ibid., §. X, Explicatio praedictorum, et ostensio quod pie et prudenter fuerint con-stituta, pp. 191-192.
137 Cfr. A. de Sousa, Aphorismi Inquisitorum in quattuor libros distributi, Olyssipone, apud Petrum Craesbeeck 1630.
412 Giuseppe Marcocci
plures, qui non abierant, libertate privati, atque in servitutem redacti, ut captivi venundabantur. Praefato Regi Ioanni II Rex Emmanuel, magnus ille Orientalis Indiae triumphator successit, qui anno Domini 1497 omnes Iudaeos, sub eadem paena libertatis amittendae, ex Lusitaniae Regnis publico edicto migrare praecipit; & licet in paenam inciderunt, non tamen ipsa, ob Regis clementiam, suum sortita est effectum. Plures quidem ex illis abierunt, quidam vero, apud quos plus valuit metus ac timor vexationum, quibus a ministris, nautis, & aliis, qui eos suis navigiis ad alias regiones transferebant, opprimebantur, vel etiam utilitas, quam ex ubertate regionis, quam incolebant, & in qua sibi bene erat, se adepturos sperabant, Christiani se fieri postularunt, hac tamen conditione, ut ante viginti annos elapsos, de eis circa res Fidei inquiri non liceret. Atque hac conditione, sacra baptisma-tis aqua abluti sunt.Cum tamen huiusmodi Iudaei Catholicam Fidem non vere, atque animo, sed ficte tantum, atque exterius fuerint professi, Iudaei quidem, sicut antea, permanserunt, quamvis, ao quod occulti, perniciores. Unde filios suos in antiquis Iudaismi erroribus nutriebant. Quod hodie quoque plures eorum facere experientia quotidiana demonstrat138.
La pagina degli Aphorismi Inquisitorum chiudeva, in qualche modo, un secolare dibattito, offrendo una visione alquanto edulcorata dei fatti del 1496-97 e riflettendo il duro pregiudizio anti-conversos pro-fondamente radicato nella società lusitana, che assisteva ormai quasi indifferente all’incessante persecuzione di una Inquisizione ogni giorno sempre più simile a una «fabbrica di ebrei»139.
138 Ibid., De origine Tribunalis S. Officii Inquisitionis Lusitaniae, ff. 2v-3.139 Ancora intorno agli anni 1622-1627 si era aperto un dibattito sui rimedi per
estirpare il cripto-giudaismo dal Portogallo, in cui aveva preso posizione anche l’inquisitore generale, Fernão Martins Mascarenhas, in un’operetta uscita anonima, intitolata Tratado sobre os varios meyos, que se offerecerão a sua Magestade catholica para remedio do judaismo neste Reyno de Portugal, s.l.n.d. (l’attribuzione è sostenuta da Machado, Bibliotheca Lusitana cit., II, pp, 34-36, che data il testo al 1625), in cui accogliendo in parte le conclusioni, fra gli altri, di Parisio e del Navarro si adottava una soluzione presentata come moderata e si proponevano sei possibili strategie: 1) l’abrogazione del divieto per i nuovi cristiani di lasciare il regno, con la sola limitazione che non potevano portare con sé denaro e oro, ma solo beni investiti in mercanzie e lettere di cambio; 2) la piena disponibilità degli inquisitori a tenere
413 «... per capillos adductos ad pillam»
9. Per concludere, vorrei rapidamente tornare sul complesso e sfuggente problema dell’identità, su cui era stata richiamata la nostra attenzione in apertura del saggio dalla lettera di Simão Rodrigues. Per il mondo cristiano l’acqua del battesimo che asperse gli ebrei portoghesi nel 1497 e i loro discendenti nuovi cristiani ne segnò l’ingresso nella comunità dei fedeli, nella Chiesa. Il prolungato dibattito relativo al ricorso alla violenza e ai gradi di volontà con cui gli ebrei si accostarono al battesimo rispecchiava il problema del carattere cogente insito nel sacramento di iniziazione cristiano. Ci si può allora, di riflesso, domandare se e in che forma vi fu una accoglienza di tale cogenza presso gli appartenenti a una cultura estremamente forte e resistente come quella ebraica. Si entra così in contatto con un aspetto della storia del marranesimo che è giunto fino ai nostri giorni.
Fra gli ebrei, che alla fine del Quattrocento furono battezzati contro la propria volontà, molti non considerarono mai valido il sacramen-to ricevuto e scelsero la via della fuga. Come abbiamo visto, Samuel
sempre aperta la porta del perdono completo e della riconciliazione segreta; 3) l’esilio fuori dal regno e dalle terre soggette al sovrano di tutti i nuovi cristiani di cui si fosse provata l’adesione all’ebraismo e che avevano subito una condanna per apostasia; 4) un analogo esilio per tutti i nuovi cristiani che fossero stati condannati a recitare l’abiura de vehementi negli autos-da-fé; 5) la condanna come dogmatisti per tutti coloro che si fosse dimostrato che avevano insegnato l’ebraismo ad altri, anche se loro figli; 6) la piena accettazione da parte del sovrano delle costituzioni di Clemente VIII e Paolo V che vietavano ai nuovi cristiani di avere un beneficio ecclesiastico con cura d’anime e ogni tipo di carica, rispettivamente fino al quinto e al settimo grado di parentela, ad eccezione dal tribunale del Sant’Uffizio da cui dovevano comunque restare esclusi. Sulla figura dell’inquisitore generale Fernão Martins Mascarenhas, cfr. J. Romero Magalhães, E assim se abriu Judaismo no Algarve, in «Revista da Universidade de Coimbra», XXIX, 1983, pp. 1-73, in part. 20-23. Sul dibattito della metà degli anni Venti del Seicento, cfr. Lea, A History cit., III, pp. 275-276; Azevedo, História cit., pp. 183-190. Riprendo l’espressione «fabbrica di ebrei» dal saggio di Saraiva su Inquisizione e nuovi cristiani (1969), recentemente tradotto in inglese: cfr. J.A. Saraiva, The Marrano Factory: the Portuguese Inquisition and its New Christians 1536-1765, translated, revised and aug-mented by H.P. Salomon, I.S.D Sassoon, Leiden-Boston, Brill 2001.
414 Giuseppe Marcocci
Usque a metà Cinquecento scrisse a proposito del battesimo forzato degli ebrei portoghesi: «Con questa violenza contro le leggi divine e umane furono fatti cristiani molti corpi, ma nelle anime mai li toccò macchia, anzi sempre ebbero impresso il sigillo della loro antica fede»140. Del resto, con l’esclusione di chi si convertì sinceramente e con piena convinzione, anche coloro, che per una scelta di con-venienza o perché impossibilitati a fare altrimenti rimasero in paesi cattolici vivendo da cristiani, non si considerarono interiormente vincolati da esso, ma si limitarono piuttosto a impostare la propria condotta esteriore secondo le strategie della simulazione e della dis-simulazione. Tuttavia, secondo un movimento tipico della religiosità marrana, con il trascorrere delle generazioni l’atteggiamento dei più si fece meno nitido e univoco e il rapporto con la religione cristiana tese a strutturarsi secondo modalità di tipo sincretistico. Si spiega così il reperimento di alcune tracce di una parziale accoglienza e inconsapevole introiezione presso i marrani del valore cogente insito nel sacramento cristiano. Si tratta di un fenomeno ancora in larga misura da definire e da studiare, ma l’impressione è che l’aspetto in qualche modo magico contenuto in un rito come il battesimo, che ha vigore ex opere operato, abbia gradualmente soppiantato, in alcu-ni nuovi cristiani, l’elemento del consenso e della libera adesione necessaria alla validità del sacramento. Si tratta, d’altra parte, dello stesso problema indicato da Nathan Wachtel nel recente libro che ha dedicato alla storia dei marrani delle colonie spagnole e porto-ghesi d’America. Nell’epilogo, significativamente intitolato «…cin-quecento anni di fame». I ritorni, Wachtel espone i risultati di una ricerca in corso su alcuni marrani ‘riscoperti’ in Brasile negli ultimi anni, ponendo la questione del loro ritorno così tardivo all’ebraismo – il fenomeno ha assunto una qualche consistenza solo fra la metà degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta – di una parte di essi, e neppure tutti. Wachtel ne descrive dubbi e perplessità, diffi-coltà e contrasti con l’ebraismo ufficiale, tentativi di organizzazione, scelte e percorsi individuali. Per quei marrani del Brasile, che sono ritornati a professare pubblicamente l’ebraismo, continua però a sussistere un concreto problema di riconoscimento e di accettazione da parte degli altri ebrei. La maggior parte dei marrani ha optato per
140 Usque, Consolação cit., II, f. 204,
415 «... per capillos adductos ad pillam»
l’ingresso nell’ebraismo ortodosso, ma tale opzione si accompagna al rifiuto categorico di un rito di conversione formale che segni il rientro nell’antica religione degli avi. Tale rito viene espressamente richiesto ai marrani dalle comunità ebraiche, ma essi considerano ciò un oltraggio, perché senza dubbio i loro antenati sarebbero stati ‘costretti’ ad accettare la ‘macchia’ del battesimo, ma l’avrebbero come ‘cancellata’ perpetuando clandestinamente per secoli creden-ze, pratiche e costumi degli ebrei. I discendenti di questi uomini, dunque, sarebbero ebrei a pieno titolo, e non dovranno in nessuna maniera sottomettersi a un nuovo rito di passaggio141.
In realtà però la storia dei marrani nei secoli dell’età moderna rivela come già allora siano stati elaborati riti di annullamento del battesimo ricevuto. Se ne hanno attestazioni relative ai casi di vecchi cristiani che decidevano di farsi ebrei e di giudaizzare, come ricordava il re D. João III di Portogallo in una lettera scritta a papa Paolo III all’inizio degli anni Quaranta del Cinquecento: i nuovi cristiani, denunciava il monarca lusitano,
vivono così male che non solo arrecano danno gli uni agli altri, ma perver-tono pure alcuni vecchi cristiani, facendoli giudaizzare e apostatare dalla nostra santa fede fino a togliere loro il battesimo, l’olio e il crisma attraverso l’azione di riti ebraici […]142.
Ma ad essere oggetto di tali riti furono anche i nuovi cristiani.
Un esempio particolarmente suggestivo è stato conservato dalle carte dell’Inquisizione pisana, che testimoniano di un rito di rinne-gamento del battesimo e di abiura della fede cristiana praticato da una famiglia di ebrei di Livorno su una fanciulla battezzata. Si tratta della denuncia sporta il 23 dicembre 1651 presso il Sant’Uffizio di Pisa dal frate cappuccino Placido Benedetti da Lucca, che all’epoca soggiornava nel convento cittadino143. Frate Placido aveva appreso
141 Cfr. N. Wachtel, La fede del ricordo. Ritratti e itinerari di marrani in America (XVI-XX secolo), Torino, Einaudi 2003 [ed. or. Paris 2001], pp. 273-295.
142 Lettera del re D. João III a papa Paolo III, Lisbona, 18 settembre 1542, edita in As Gavetas cit., I, pp. 40-43 (la traduzione dal portoghese è mia).
143 Cfr. Archivio Diocesano di Pisa (d’ora in avanti ADP), Tribunale dell’Inqui-sizione, filza 13, cc. 726-727. La denuncia fa parte di un un dossier di documenti
416 Giuseppe Marcocci
della vicenda da un altro cappuccino, Giovan Maria da Serravezza, che di ritorno da Livorno dove si era recato a predicare ne aveva parlato la sera del 14 dicembre in compagnia di altri confratelli mentre si trovavano nella cucina del convento davanti al fuoco per riscaldarsi. Colpito dai fatti contenuti nel racconto di frate Giovan Maria, il cappuccino non aveva esitato a presentarsi all’inquisitore riferendo di essere venuto a conoscenza che
a Livorno una figliolina nata di padri ebrei era ricorsa all’Auditore per farsi christiana, e da lui era stata ricevuta e fatta battezzare, e che dopoi, o per via di presenti, o comunque si fosse, era stata restituita alli hebrei, i quali li ave-vano fatto abiurare ogni altra santificazzione o unzione della Chiesa, e di più li havevano fatto calpestare con li piedi l’imagine della Santissima Vergine Maria Nostra Signora e di Giesu Christo Nostro Signore Crocefisso144.
Ricevuta la denuncia, l’inquisitore sottopose frate Placido ad
un breve interrogatorio, da cui è possibile desumere anche alcune notizie circa le concrete modalità secondo cui era avvenuto il rito di annullamento del battesimo:
relativi all’attività di delazione presso il Sant’Uffizio di Pisa svolta da frate Placido Benedetti da Lucca fra il 26 luglio 1650 e il 23 settembre 1653 (cc. 726-744v). Il cappuccino era un convinto assertore di un ricorso allargato all’Inquisizone. Nella lettera scritta il 25 dicembre 1651 (c. 737), ad esempio, egli raccontava di aver avuto proprio per questa ragione un alterco in materia di obbedienza con il padre vicario del convento in cui dimorava: frate Placido considerava, infatti, i poteri del Sant’Uffizio superiori a quelli di qualunque altra autorità, e pertanto chiedeva all’in-quisitore che intercedesse in difesa della libertà di ricorrere al tribunale. All’origine di tali tensioni vi era probabilmente l’eccessiva tendenza di frate Placido a risolvere i problemi interni ai conventi cappuccini mediante l’arma dell’Inquisizione: cfr. le denunce presentate da frate Placido da Lucca a frate Iacopo Tosini da Castiglione Fiorentino, vicario lucchese dell’Inquisitore di Pisa, fra il 2 e il 4 agosto 1650 (cc. 375-380v). Ringrazio Lucia Frattarelli Fischer per avermi segnalato il documento. Per un quadro generale sulla storia degli ebrei a Livorno e a Pisa in età moderna, cfr. R. Toaff, La Nazione Ebrea a Livorno e a Pisa (1591-1750), Firenze, Olschki 1990.
144 Denuncia di frate Placido Benedetti da Lucca presentata al Sant’Uffizio di Pisa il 23 dicembre 1651, in ADP, Tribunale dell’Inquisizione, filza 13, c. 726.
417 «... per capillos adductos ad pillam»
Interrogatus, an praefatus P. Joannes Maria dixerit, seu declamaverit, quo-modo hebrei fecerint abiurare puellam, seu rinegare Baptismum.Respondit, disse che l’hebrei li toccorno le labra con il fuoco sive con un ferro infocato, com’anco la fronte, o ciglia, per abulire e levare il contatto del sale e dell’oglio santo e chrisma in riguardo della Santa Chiesa Cattolica da loro aborriti145.
Il caso riferito dal cappuccino pisano era relativo a una fanciulla. Una funzione analoga per quanto riguardava i nuovi cristiani di sesso maschile era svolta probabilmente dalla circoncisione, che nono-stante i gravi rischi a cui esponeva, continuò in varie forme a essere praticata fra i marrani. Le modalità del rito compiuto dagli ebrei di Livorno a metà Seicento consistevano nel purificare le parti del volto coinvolte dal sacramento cristiano con un ferro rovente. Esse presentano evidenti analogie con altri riti di purificazione osservati presso gli ebrei convertiti e i loro discendenti per rendere inefficaci i sacramenti cristiani ricevuti. Si consideri, ad esempio, l’evoluzione marrana della cerimonia ebraica del lavaggio del morto nella forma in cui si presentava a fine Cinquecento all’interno della comunità conversa di Quintanar, nella Mancha, alle cui drammatiche vicende ha dedicato di recente un saggio Charles Amiel. Invece di proce-dere al lavaggio completo del morto, compiuto rigorosamente da parte dei familiari dello stesso sesso, a Quintanar si assiste ormai a una operazione in cui le donne purificano con l’acqua le parti del corpo che sono state segnate con l’olio santo durante il sacramento dell’estrema unzione146.
145 Interrogatorio di frate Placido Benedetti da Lucca avvenuto presso il Sant’Uffizio di Pisa il 23 dicembre 1561, ibid., c. 726v.
146 Cfr. Ch. Amiel, Les cent voix de Quintanar. Le modèle castillan du Marranisme, in «Revue de l’histoire des religions», CCXVIII, 4, 2001, pp. 487-577. Durante il secondo processo a suo carico, svoltosi fra il 1590 e il 1592, così Francisco de Mora Molina descrisse agli inquisitori di Cuenca il rito del lavaggio funebre di suo padre, Diego de Mora, osservato a Quintanar: «Al dicho Diego de Mora, su padre, quando muriò, le lavò Juana de Mora, su tìa deste confesante, y Inés de Mora, difunta, mujer de Francisco Navarro, y que estuvieron presentes las dichas sus hermanas deste confesante, y todas rezando alderedor y llorando, y que no sabe este confesante las
418 Giuseppe Marcocci
Concludendo sulle pratiche di purificazione dei sacramenti cristia-ni, e su quella del rinnegamento del battesimo in particolare, non si può non osservare come esse costituiscano un terreno di studio ancora in buona parte inesplorato, ma in ogni caso privilegiato per seguire a un livello sfuggente e sotterraneo, come quello del rapporto fra rito e storia, uno degli effetti più duraturi del battesimo forzato in Portogallo. Sono le tracce di una lunga storia che non ha ancora cessato di essere viva.
Appendice documentaria
Copia delle sentenze emesse dal vescovo dell’Algarve Fernando Coutinho nel processo contro il nuovo cristiano Jorge Afonso di Loule (1530-1531)147
(ASV, Fondo Borghese, Serie I, n. 893, ff. 41v-45)
oraciones que rezaban, mas que es cosa cierta que serían las oraciones de Moisén […]. Dijo que este confesante no vio lavar al dicho su padre actualmente […] y que entendió realmente que le habían lavado, y que las partes del cuerpo que le lavarían serían todas aquellas donde le hobiesen puesto cruces con el olio cuando le olearon, porque asi ha oído decir que se ha de hacer […]» (p. 270, nn. 146 e 147). Commenta Amiel: «la toilette du mort, qui selon le rite juif comporte une aspersion générale du corps, est ici ‘marranisée’ en quelque sorte, puisque la purification porte exclusivement sur les parties du corps touchée par l’extrême-onction. Le caractère symbolique de ce lavage explique peut-être la présence de femmes (les deux tants dont a parlé plus haut) pour la toilette de leur frère, car dans la religion juive les hommes lavent les homme et les femmes lavent les femmes» (p. 272).
147 Gli atti processuali pubblicati qui di seguito fanno parte dell’allegato n. 1 del Memoriale porrectum a noviter conversis Regni Portugalliae, continens narrativam rerum gestarum, circa eos a regibus, et Inquisitoribus illius Regni spatio 48 annorum (1544), composto di due sezioni: una, intitolata Instrumentum sententias continens Episcopi Algarbiorum corroboratum manu et sigillo sui notarii et etiam alterius cum testibus fidedignis – de violentia praecisa (ASV, Fondo Borghese, Serie I, n. 893, ff. 40-46v), e l’altra, intitolata Lex Ioannis Regis (ibid., ff. 46v-48). Il documento che si pubblica riproduce una parte della copia dell’Instrumentum inserita nei Monumenta ad S. Inquisitionis Tribunal in Regno Portugalliae pertinentia: si tratta di un certificato emesso
419 «... per capillos adductos ad pillam»
Ferdinandus Coutinho Dei atque Sanctae Matris Ecclesiae Romanae gratia Episcopus Algarbiorum Regni Regisque Domini mei Consiliarius omnibus qui hoc publicum instrumentum datum cum tenore cuiusdam petitionis, et nostrarum sententiarum insertarum atque publicatarum in actis et pro-cessibus qui coram nobis tractati fuere in nostro ordinario palatio anno 1531 viderint salus in Christo Iesu Salvatore Nostro. Notum facimus quod pro parte Georgii Alphonsi incolae oppidi de Loule fuit nobis praesentata quaedam petitio cuius tenor est sequens. Quod dicit Georgius Alphonsus incola in oppido de Loule quod in auditorio Dominationis Vestrae pro parte officialium Suae Iustitiae processus quidam fuit tractatus contra eum qui a iudicibus saecularibus remissus fuit quia dictum fuit quod cum verbis hae-reticis, et indebitis posuerat os [42] in Nostra Domina in quo processu Sua Dominatio posuit quandam interloquutoriam et duas sententias remissionis, quandam scilicet Regi Domino Nostro qui similiter Rex ei iterum remisit quod causae finem imponeret secundum ius, et aliam consilio seu auditorio
dal tribunale diocesano dell’Algarve nel giugno 1534 e ratificato da un notaio apo-stolico a Évora nel luglio successivo, contenente estratti delle sentenze pronunciate dal vescovo Fernando Coutinho nel 1531 nel corso del processo contro il nuovo cristiano Jorge Afonso di Loule. La struttura dell’Instrumentum è la seguente: a) presentazione degli atti processuali redatta dagli autori del Memoriale (ff. 40-41v); b) certificato emesso dal tribunale dell’Algarve nel giugno 1534 – la parte che qui si pubblica – (ff. 41v-45), così suddiviso: atto di ricezione di una petizione di Jorge Afonso (f. 41v), sintesi della petizione (ff. 41v-42), ordine di riproduzione degli atti processuali del 1531 (ff. 42-42v), prima sentenza interlocutoria, datata 9 maggio 1531, in cui si incarica il vicario di Loule di svolgere un’indagine circa le modalità del battesimo ricevuto da Jorge Afonso (f. 42v), sentenza finale (ff. 42v-44), secon-da sentenza interlocutoria in cui si rimette il caso al tribunale del cardinale infante D. Afonso (ff. 44-44v), autentificazione del certificato datata 16 giugno 1534 e firmata da Fernando Coutinho (ff. 44v-45), ratifica dell’autenticità del certificato datata sempre 16 giugno 1534 e firmata dallo scrivano e notaio apostolico Gil Mathoso (f. 45); c) ulteriore ratifica dell’autenticità del certificato eseguita a Évora presso il notaio apostolico Iulianus Chalumela il 7 luglio 1534 (ff. 45-46v). Gli atti delle sentenze di Coutinho furono già parzialmente pubblicati, sulla base della copia settecentesca conservata in BdA, 46-X-14, Symmicta Lusitanica, XXXI, in G. Heine, Beiträge sur Geschichte im Zeitalter der Reformation, aus Spanischen und Portugieschen Archiven mitgetheilt, II. Die Einführung der Inquisition in Portugal, in «Allgemeine Zeitschrift für Geschichte», IX, 1848, pp. 139-180, in part. pp. 178-180.
420 Giuseppe Marcocci
Illustrissimi Domini Cardinalis et Sedis Metripolitanae Ulixbonensis, et quia ei supplicanti oportet ad sui iuris conservationem praedictae interlocu-toriae et sententiarum remissionis certitudinisque temporis transumptum in autentica forma ad perpetuam rei memoriam habere supplicat Dominationi Vestrae ut ei tradi faciat in quo iusticiam et gratiam sibi faciet. Et a tergo praedictae supplicationis taliter per nos fuit pronunciatum ante pronun-ciationem super praesenti petitione acta, processus et sententia quarum in ea fit mentio sic adducantur et per nos visis et examinatis pronunciabimus prout ius et iustitia fuerit cui scilicet interloquutoriae per tabellionem sati-sfactum fuit et visis et per nos examinatis ac etiam sententiis nostris in eis insertis per nos subscriptis visisque terminis suarum publicationum taliter circa dictam petitionem pronunciavimus. Visis actis sententiisque nostris in eis insertis et publicatis anno Domini 1531 mandamus quod eius tenor supplicanti detur in forma autentica ad perpetuam rei memoriam secundum formam suae petitionis cui pronunciationi satisfactum fuit et tenor [42v] dictarum sententiarum est sequens. [Interlocutoria prima lata anno 1531 die 5 Maii, ut fieret diligentia de vi]148 Ante aliam pronunciationem denuncietur vicario de Loule quod examinet Reum in quo tempore fuit factus Christianus et declaret annum et mensem et aliquos eorum qui cum eo Christiani facti fuerunt et praestabitur ei iuramentum in omnibus legibus.[Sententia finalis lata ab Episcopo post remissionem ad se factam ab auditoribus Reverendissimi Cardinalis Portugalliae ubi clarissime probatur violentia praecisa] Domini Rotae seu Consilii mihi remiserunt hunc processum tanquam crimen haereseos viso libello quaerelarum Iustitiae et accusatione officialis Iustitiae in quo processu ego non possum esse iudex secundum conscientiam quia tem-pore Ioannis Regis cuius anima in pace requiescat et bonae memoriae Regis Emanuelis omnibus consiliis interfui in quibus tractatum fuit de faciendo Iudeos Christianos novos exquistis modis. Ego omnium litterarum insapientior et omnes alii scientiae et doctrinae viri magni [Consuluerunt regi ne faceret talem violentiam quia non poterat fieri] unanimiter determinarunt quod non poterant nec debebant Christiani effici cum modis violentibus prout multos vidi per capillos adductos ad pillam et patrem filium adducentem cooperto capite cum capuchis in signum maximae tristitiae, et doloris ad pillam baptismatis, [Ecce praecisam violentiam probatam per Episcopum tantae auctoritatis et mediante sententia] protestando et Deum in testem accipiendo quod volebant mori in
148 Le brevi annotazioni riprodotte in corsivo fra parentesi quadre rappresentano le indicazioni a margine del documento inserite dagli autori del Memoriale.
421 «... per capillos adductos ad pillam»
Lege Moysi et alia magna exhorbitantia sed Rex Emanuel hoc voluit dicendo quod hoc in devotionem habebat, et sua [43] voluntas satis fuit praecisa et violenta ad subditos suos aut servos corporales quia in spiritualitate scilicet in baptismo solum Deum habebant in Dominum ut caracter imprimeretur et res sacramentalis et sic liberatio a peccato originali. Et ideo aliqui qui coram me adducti fuere tanquam inculpati a crimine haeresis [Pronunciabant ipsi et alii valentissimi doctores istos liberos a poenis quia Iudaeos esse reputabant] Doctor Ioannes Petrus et Episcopus Funchalensis et Doctor Ferdinandus Rodericus cum aliis clericis eos pronunciabant liberandos quia eos Iudaeos reputabant et non haereticos et nunc qui coram me comparent tamquam Christianos habeo. Sed quando ad aures meas devenit aliquid haebraicae sectae Iudaeos et non haereticos reputo. Et quia sunt facti Christiani bene possunt habere caracterem sed non rem Sacramenti. Et cum fructum baptismi non receperunt [Hac de causa dicitur prius esse fiendam diligentiam de ista violentia] non convenit ut poenitentiam recipiant. Et quod peius est filii qui baptizati fuerunt in fide parentum talium, ita sunt sicut eorum patres licet hucusque adulti sunt prout determinat Summa Silvestrina in verbo baptismus. Et licet essent Christiani quia sunt neophiti non sunt integri testes in causis Christianorum nec tabel-liones, nec iudices esse possunt et hoc specialiter prohibitum est per quoddam Romanum Consilium cuidam Regi Neapolitano et cuidam Archiepiscopo, et de iure Regi Portugalliae nec dubitarem in Concilio quod nunc speratur fieri poni hoc diffamatorium [43v] aedictum adversus eos specialiter per praelatos Regni Castellae quare sequendo doctrinam Doctorum in c. 2. de off. ord. lavo manus ab isto Processu licet non sim Pilatus. Iudicent alteri litterati moderni. Et quando hoc [Etiam contra istum qui vere Christianus non erat testes fuerunt falsi. Quid ergo praesumendum et credendum est in aliis?] iudicarem prius officia-les seu barricellum torturae subiicerem, et aliquos testes quia aliqui sunt falsi sed ipse aufugit alias ego iam carceribus vinculatum haberem quia non sunt ista talis qualitatis in quibus leviter recipienda est quaerela nec debet disputari inter ebrios quamvis Reus dicat quod vino captus seu ebrius dixit quia in mira-culis Nostrae Dominae nec Crucifixi quem adoramus non debet in publico disputari sub poena mortis, ut in L. nemo C. de Sacrosanctae Ecclesiae. Et quia haec pronunciatio aliqualiter scandalum praebet infamiamque portat moneo Praesidentem seu Rectorem et Regem Dominum meum, et ego conscientiam meam depono et Sua Serenitas videat quid ad Suum atque Regni honorem expediat. Et quia tanta multitudo istorum est apud Turchas et in partibus Africae, et sicut Iudaei vivunt et quod peius est [Dicit iam fuisse determinatum in Consistorio istos non esse christianos] contra aliquos fuit in Papae Consistorio temporibus meis propositum et fuit determinatum quod viverent sicut Iudaei et aliqui Venetiis et Florentiae ita vixerunt, Deus qui est pater legum et ani-
422 Giuseppe Marcocci
marum [44] provideat omnibus cum salvatione et bonum esset ut iste ebrius verberibus fustigaretur auresque ei abscinderentur et in insulam perpetuo relegaretur absque praeconio vel alio actu iudiciali. [Mediante ista sententia fuit iste taliter absolutus, quia Rex vidit illam et statim mandavit simul ac Epsicopus ut liberaretur a carcere et ita fuit factum] Et haec mea pronuntiatio rumpatur quia multi novi Christiani accipient ex hoc fidem ad exonerandas conscientias et legem et alios tedet qui regunt oppida atque provincias Regni.[2.a pronunciatio ante finalem supra proximam per quam remisit acta ad Cardinalem Portugalliae] Ego non sum nec possum esse iudex in isto casu quoniam tempore Regis Ioannis quem Deus habet, et postea tempore Regis Emanuelis semper fui in Consiliis, ubi tractatum fuit praecipue an possent isti fieri Christiani mediante ista violentia ammissionis bonorum et etiam personae et omnes litterati fuerunt quod non et ego insapientior omnibus monstravi plurimas auctoritates et iura quod non poterant cogi ad susci-piendam Christianitatem quae vult et petit libertatem, et non violentiam et licet ista non fuerit praecisa, [Praecisa vis] scilicet cum pungionibus in pectora, satis tum violentia fuit quoniam Rex voluit dicendo quod pro sua devotione hoc faciebat et non curabat de iuribus. Qua de causa Episcopus Funchalensis, et Doctor Joannes Petrus et ego illos qui ad nostras manus veniebant propter similes causas haereseos dimitti mandamus facientes fundamentum in quodam Concilio facto Neapoli quod sic hoc determinat et etiam minatur Regem Neapolitanum ne [44v] alia vice faciat istam vio-lentiam nisi recipiet correptionem a Sancta Sede Apostolica, et quoniam Reges Portugalliae qui postea successerunt illos pro Christianis habent et in commercio Christianorum recipiunt dantes eisdem dignitates et officia ac honores super Christianos veteres ipsi iudicent et quando Sua Maiestas a me personaliter petierit huius rei causam ego eam dabo. Propterea remitto haec acta ad auditores Illustrissimi Domini Cardinalis ut illa iudicent secundum iustitiam temporis.[Vidit probationem violentiae ita claram quod si non scivisset et vidisset esse omnia vera propter aetatem 70 annorum quam habebat crederat illam esse falsam] Quia ego si septuagenarius non essem, et fueram huius modernae aetatis hanc probationem pro falsa habueram quia est tam clara et tam aperta quod ius illam pro falsa habet et barricellus qui quaerelavit, et testes omnes debuerant venire ad torturam quoniam non est de consuetudine quaerelam proponere de haeresi, et testes omnes esse de auro, [Testes falsi contra istum] et simili colore. Propterea faciant Domini examen quod sibi visum fuerit et iudicent ut sibi iuris esse videbitur quia ego lavo manus ab omnibus absque eo quod sim Pilatus.
423 «... per capillos adductos ad pillam»
Et collationata sic pro parte dicti supplicantis nobis fuit supplicatum ut sibi mandassemus cum effetcu dari praefatum tenorem in autentica forma secundum formam praecedentis suae supplicationis. Et nos attendentes petitionem suam esse [45] iustam, mandamus tibi dari praesentes. Quibus mandamus tantam fidem adhiberi sicut dicto originali. Datus in hoc Silves novo sub nostris signo et sigillo decimo sexto die mensis Iunii, Philippus Gometius scriba noster fecit anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi 1534.
Episcopus Algarbiorum Manus Episcopi.Hic est sigillum Episcopi.
Solvit 28 asses.
Ego Gil Matoso scriba et notarius apostolicus et in dicto auditorio praefati Domini Episcopi qui omnibus suprascriptis dictis et contentis in praefatis litteris testimonialibus praefati Domini interfui, et omnia vidi et eorum et quod sic est fidem adhibeo, et propterea scripsi hoc, et corroboravi mea propria manu et sigillo quod tale est dictis die mense et anno in dictis literis testimonialibus contentis testibus ad hoc praesentibus Licentiato Bartholomeo Ferdinando auditore generali praefati Domini et Ferdinando Conceptionis cappellano suo et vicario generali et aliis.
Concordatum cum proprio originali. Gil Mathoso.
Giuseppe Marcocci























































































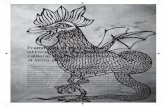







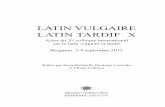








![Il dibattito recente sul presunto declino economico italiano [The recent debate about the alleged Italian economic decline]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6335c196379741109e00c4bd/il-dibattito-recente-sul-presunto-declino-economico-italiano-the-recent-debate.jpg)

