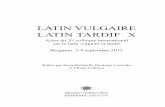La preparazione argomentativa del giudice di dibattito
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of La preparazione argomentativa del giudice di dibattito
ERIS Rivista internazionale di argomentazione e
dibattito
eris.fisppa.unipd.it/Eris [email protected]
De Conti Manuele. La preparazione argomentativa del giudice di dibattito Eris, Vol. 1, n. 1, pp. 34-46 (2015) 34
La preparazione argomentativa del giudice di dibattito
Manuele De Conti Università di Padova
Abstract Competitive debate requires judges to acquire the appropriate knowledge needed to analyze and evaluate argumentative exchanges and, above all, to provide students with the necessary guidance for their learning. Indeed, judge unpreparedness may even affect students’ motivation to improve. However, the absence of comprehensive judge training literature calls for an overview of the different ways argumentation is articulated in debate. Therefore, the purpose of this paper is to sketch the design of an argumentative training guide for both judges and students, and for the development of a more comprehensive debate evaluation method. Keywords: competitive debate, judges training, debate judging. Sommario L’importanza della dimensione argomentativa nel dibattito regolamentato impone ai giudici di dibattito di dotarsi delle conoscenze argomentative adeguate per analizzare e valutare gli scambi dibattimentali, ma soprattutto per fornire agli studenti le opportune indicazioni per orientare il loro apprendimento. Mancando tuttavia una esauriente letteratura per la formazione dei giudici, lacuna tanto più inopportuna quanto più l’impreparazione del giudice può pregiudicare la motivazione degli allievi a perfezionarsi, si rende necessario tratteggiare un quadro delle varie modalità in cui il fenomeno argomentativo si articola nel dibattito regolamentato. Pertanto il presente contributo si propone di fornire una premessa per progettare la formazione di giudici e allievi, ma anche per l'elaborazione di più adatte schede di valutazione dei dibattiti stessi.
Parole chiave: dibattito regolamentato, formazione dei giudici, valutazione del dibattito.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1. Introduzione
Il dibattito è un confronto argomentativo su temi controversi in cui le parti
coinvolte mirano a convincere una giuria o un pubblico, della bontà della propria
posizione, avanzando, contestando e difendendo argomenti rilevanti alla questione
dibattuta (Branham, 1991). Ciò che rende un generico dibattito un dibattito regolamentato è: il
protocollo, ossia l'insieme di regole che stabilisce il numero dei partecipanti, la funzione degli
interventi e la loro durata, garantendo al dibattito uno sviluppo lineare, ordinato e
conclusivo (De Conti, 2013a; Hanson, 1991; Nicolli e Cattani, 2008); la sua promozione e
ERIS Rivista internazionale di argomentazione e
dibattito
eris.fisppa.unipd.it/Eris [email protected]
De Conti Manuele. La preparazione argomentativa del giudice di dibattito Eris, Vol. 1, n. 1, pp. 34-46 (2015) 35
adozione da parte di un’istituzione educativa che assicuri al dibattito d’essere un’occasione
d’apprendimento (Freeley e Steinberg, 2008).
Il dibattito regolamentato è attualmente impiegato negli Istituti di Istruzione Secondari
e nelle Università di tutto il mondo per la molteplicità di competenze che permette di
promuovere (De Conti, in stampa). Tra queste, anche se con maggior o minor
considerazione e orientamenti diversi, quella argomentativa è sicuramente una delle
principali. Infatti, sfogliando alcuni dei più noti manuali di preparazione al dibattito è
consuetudine, e appropriato, rilevare la presenza di capitoli intitolati “Doveri del
disputante”, “La valutazione degli argomenti”, “Come replicare” (Cattani, 2012), “The
Skills of Reasoning”, “Affirmative case construction” (Fryar, Thomas e Goodnight, 1995),
“Organizing arguments”, “Evaluating evidence” o “Rebuttals” (Snider, 2008).
L’importanza della dimensione argomentativa per quest’attività emerge anche
analizzando le schede che i giudici adottano per valutare. “Argomentazione e
controargomentazione” per il protocollo Patavina Libertas, “Content” per il World School
Debate Format1, “Reasoning”, “Evidence”, “Organization” e “Refutation” per l’American
Forensic Association. Anche quando la valutazione non avviene secondo indicatori specifici
ma in base a generici speaker points o per protocolli di dibattito come il Lincoln Douglas, in
cui l’aspetto comunicativo prevale su quello logico, il giudice è sollecitato a considerare gli
aspetti argomentativi del dibattito mediante specifiche linee guida poste sulla scheda2.
Pertanto, se promuovere la competenza argomentativa è uno dei principali scopi
dell'adozione del dibattito, il giudice di dibattito dovrà dotarsi delle conoscenze adeguate
per analizzare e valutare lo scambio dibattimentale e per fornire gli opportuni suggermenti
agli studenti al fine di orientare il loro apprendimento e svilupparne le abilità di auto-
controllo e auto-regolazione, da una prospettiva argomentativa.
Raramente, però, questi elementi sono forniti dalla letteratura riguardante la
formazione al dibattito. Addirittura testi specifici come Judging Academic Debate (Ulrich,
1 L’indicatore “Content” riguarda “gli argomenti usati, separati dagli aspetti para-verbali e non verbali della comunicazione. [...] Devi valutare la forza degli argomenti senza essere influenzato dalla modo in cui l'oratore li presenta”. (WSD, Notes for Adjudicators. Reperito da: http://www.schoolsdebate.com/guides.asp) 2 Ad es. “Il giudice deve ignorare nuovi argomenti introdotti nella fase di replica”; “Gli interventi devono essere chiari e comprensibili. Di conseguenza, un giudice deve valutare solo gli argomenti presentati in un modo a lui comprensibile e chiaro”. Lincoln Douglas Debate Ballot, National Forensic League, Reperito da: http://www.nflonline.org/uploads/NationalTournament/LDBallot101807Sample.pdf
ERIS Rivista internazionale di argomentazione e
dibattito
eris.fisppa.unipd.it/Eris [email protected]
De Conti Manuele. La preparazione argomentativa del giudice di dibattito Eris, Vol. 1, n. 1, pp. 34-46 (2015) 36
1986) o Judging Debates (Schuster e Meany, 2004) non forniscono le nozioni necessarie per
un’approfondita preparazione argomentativa del giudice.
Questa lacuna è tanto più inopportuna quanto più l’impreparazione del giudice
vanifica gli sforzi dei dibattenti, pregiudicandone la motivazione a intraprendere
perfezionamenti. Si rende pertanto necessario fornire un quadro delle varie modalità in cui
il fenomeno argomentativo si articola nel dibattito regolamentato. Il presente contributo potrà
servire sia da base per la preparazione di giudici e studenti, permettendo alle rispettive
istituzioni educative di progettare l’adeguata formazione, sia per l'elaborazione di più
adatte schede di valutazione dei dibattiti stessi.
Tale obiettivo sarà realizzato mediante l'analisi di dibattiti realmente disputati che
permetteranno di individuare o esemplificare le diverse dimensioni3 in cui il fenomeno
argomentativo può essere scomposto. Occasionalmente, invece, verranno date brevi
indicazioni sulle più comuni problematiche che tali dimensioni pongono ai disputanti al
fine di delinearle meglio. Il quadro tratteggiato non sarà tuttavia che un lavoro preliminare
che potrà, e dovrà, essere integrato con specifiche nozioni per ciascuna delle dimensioni
isolate, proprio come il presente contributo è integrazione del precedente Autori e testi tra
argomentazione e dibattito regolamentato (De Conti, 2012).
2. Dimensione linguistica
Una primo aspetto in cui l’attività argomentativa può essere scomposta compare
analizzando il seguente testo tratto da un incontro di dibattito regolamentato e qui
riportato quasi integralmente:
In questo periodo basta aprire un qualsiasi giornale per notare quanto
sia rilevante la questione della disoccupazione nel nostro paese che ha
una percentuale dell’11%. Tuttavia è un problema anche negli altri
paesi e [nome eliso] vi ha spiegato come sia essenziale che lo Stato
intervenga per arginare questo problema. Ma come? Quando parliamo
1
3 Per «dimensione» si intende ciascun aspetto in cui un concetto (in questo caso quello di argomentazione) può essere articolato al fine di individuarne gli indicatori empirici più congrui.
ERIS Rivista internazionale di argomentazione e
dibattito
eris.fisppa.unipd.it/Eris [email protected]
De Conti Manuele. La preparazione argomentativa del giudice di dibattito Eris, Vol. 1, n. 1, pp. 34-46 (2015) 37
di interventismo statale al fine di accrescere l’occupazione ci riferiamo
ad un intervento diretto dello Stato per migliorare l’economia; un
intervento che chiaramente non chiede alle industrie degli sforzi
impossibili per creare dei posti di lavoro ed assumere nuovi lavoratori,
bensì un intervento che crei i presupposti ideali affinché questo
avvenga lasciando comunque un buon margine di guadagno alle
imprese. Lo Stato deve intervenire in due direzioni. Innanzitutto per
migliorare l’occupabilità, cioè aumentare le competenze dei suoi
cittadini affinché siano maggiormente assorbibili dalle imprese. Un
esempio sono l’Olanda e il Belgio dove grazie a stages formativi fatti
già in età scolare si permette ai lavoratori di entrare meglio nel mercato
lavorativo. In secondo luogo lo Stato ha come obiettivo il
miglioramento dell’imprenditorialità…
5
10
Il problema che l’analisi di questo testo pone è di comprendere quali siano gli
argomenti avanzati e quale la tesi sostenuta. Le righe 1-4 sono un’introduzione al
problema della disoccupazione e una ricapitolazione del precedente intervento; le righe 5-
10 specificano il concetto di «interventismo statale» assunto; la tesi, ossia che lo Stato
debba intervenire per ridurre la disoccupazione, sembra essere presentata alla riga 11.
Tuttavia, a partire dalla stessa riga, e come specificato nelle righe 5 e 15, l’intervento si
focalizza su come lo Stato possa intervenire per ridurre l’occupazione e rende tale testo
espositivo − ossia un testo in cui vengono presentate idee, informazioni e motivazioni che
tuttavia non sono assunte come controverse − piuttosto che argomentativo − ossia mirato a
persuadere il destinatario (Colombo, 1992, pp. 68-69) e le cui componenti fondamentali,
la controversia, la tesi e gli argomenti4, sono presenti in modo esplicito (Lo Cascio, 2009,
pp. 15-33; Romani, 1992 , p. 25) −. Nel testo in esame si descrive piuttosto che sostenere,
4 Coirier et al. (1999) riconoscono le componenti di un testo argomentativo accurato: a) nel riconoscimento dell’esistenza di un conflitto tra due differenti posizioni; b) nel riconoscimento che l’argomento è trattato come controverso socialmente, ideologicamente e contestualmente; c) nella funzione risolutiva di un conflitto (la qual cosa presuppone un contesto negoziale favorevole; d) nella funzione risolutiva di un conflitto mediante il linguaggio; e) nel sostegno di una posizione; f) nel sostegno di una asserzione mediante ragioni; g) nell’assegnazione di un minimo valore alle asserzioni e alle ragioni opposte; h) nel ridimensionamento delle opposte asserzioni mediante controargomenti (p. 8).
ERIS Rivista internazionale di argomentazione e
dibattito
eris.fisppa.unipd.it/Eris [email protected]
De Conti Manuele. La preparazione argomentativa del giudice di dibattito Eris, Vol. 1, n. 1, pp. 34-46 (2015) 38
contestare o difendere una tesi; si risponde ad un neutro “come?”, piuttosto che esplicitare i
perché della posizione assunta come controversa. Si configura così una prima dimensione
costitutiva del fenomeno argomentativo, ossia quella linguistica riferita in particolare alla
pragmatica del testo argomentativo.
La dimensione linguistica può articolarsi ulteriormente. Affinché la forma logica
dei ragionamenti e l’organizzazione delle argomentazioni (ossia delle porzioni di testi
scritti o orali composti da più ragionamenti tra loro organizzati) sia resa esplicita e
comprensibile, è fondamentale impiegare termini o espressioni denominati indicatori di
forza, ossia termini o espressioni che esprimono il modo in cui un enunciato è usato,
come, ad esempio, il modo ed il tempo dei verbi, avverbi e connettivi, i verbi modali etc.
Se…allora, a causa di ciò, perciò, etc., esplicitano la funzione causale tra ciò che precede tali
espressioni e ciò che le segue; infatti, in effetti, etc., sottolineano la funzione dimostrativa di
quanto segue loro; dunque, allora, quindi, etc., esplicitano la funzione conclusiva
dell’enunciato che viene fatto loro succedere; certamente, probabilmente, indubbiamente, etc.,
indicano il grado epistemico di quanto sarà asserito. A questi termini ed espressioni, possono
aggiungersi anche i connettivi logici e, o, e la particella non; le espressioni di rinforzo quali
senza contare che, o tenendo presente anche che; le espressioni per indicare una contro-opinione o
alternativa come ad esempio, tuttavia, nonostante ciò, etc. (Lo Cascio, 2009; Desideri, 1991;
Stati, 2002).
Per esemplificare questa articolazione della dimensione linguistica riportiamo uno
stralcio di dibattito svoltosi sull’argomento “È giusto permettere ai genitori di non
vaccinare i propri figli?” e precisamente dell’intervento effettuato dalla squadra favorevole
all’obbligatorietà dei vaccini.
[…] Risultano quindi legittimati comportamenti imposti d’autorità che
toccano anche la sfera delle libertà individuali. Chiarito questo
concetto risulta sufficientemente evidente la necessità dell’obbligatorietà di
alcuni vaccini. La libertà di trattamento potrà essere espressa sui tipi di
cura, di farmaci e di trattamenti chirurgici dove prevale l’autonomia e
l’autodeterminazione, ma non nelle scelte di sanità pubblica dove
prevale il concetto di tutela della collettività, prima di quello del singolo
1
ERIS Rivista internazionale di argomentazione e
dibattito
eris.fisppa.unipd.it/Eris [email protected]
De Conti Manuele. La preparazione argomentativa del giudice di dibattito Eris, Vol. 1, n. 1, pp. 34-46 (2015) 39
individuo. 5
Nel presente testo le espressioni risultano quindi (riga 1) e risulta sufficientemente
evidente (riga 2-3) esplicitano l’introduzione di una conclusione derivata da quanto in
precedenza detto: la prima una conclusione etico-legale, la seconda epistemica. Inoltre,
con l’impiego di potrà (riga 4) viene riconosciuta la libertà di scelta, mossa che ammette la
validità del principio invocato dalla squadra opponente (la tutela della libertà personale),
ma con ma non (riga 5) viene delimitato il suo ambito di applicazione e introdotto un
principio concorrente − la tutela della collettività (riga 6) − rendendo, assieme alla
concessione fatta in precedenza, più difficili i fraintendimenti o le generalizzazioni da
parte della squadra antagonista.
Questa sintesi, per quanto non esauriente, permette di comprendere quanto la
struttura logico-argomentativa possa, e in un dibattito debba, essere esplicitata mediante
gli opportuni dispositivi sintattici e lessicali per essere comprensibile. Il giudice, pertanto,
dovrà essere in possesso delle nozioni basilari relative all’aspetto pragmatico lessicale, ossia
relativo al significato pragmatico dei lessemi del fenomeno argomentativo, al fine di poter
fornire ai dibattenti le opportune indicazioni, ad esempio, per rendere più chiari ed
espliciti il ruolo e la funzione delle varie parti del discorso.
3. Dimensione dialettica
La trascrizione che segue offre un esempio nitido di una seconda dimensione del
fenomeno argomentativo, quella dialettica, ossia relativa all’abilità di dimostrare, contestare
o difendere un assunto.
La parola è il solo vantaggio che la natura ci ha dato sugli animali
rendendoci così superiori a tutto il resto. Così nel IV secolo Isocrate
indicava nel linguaggio il fondamento della civiltà. Ma se la parola ci
permette di comunicare, solo l’abilità di parola apre all’uomo la
possibilità di pronunciarsi, condizionando i propri interlocutori.
1
ERIS Rivista internazionale di argomentazione e
dibattito
eris.fisppa.unipd.it/Eris [email protected]
De Conti Manuele. La preparazione argomentativa del giudice di dibattito Eris, Vol. 1, n. 1, pp. 34-46 (2015) 40
Dunque, abilità di parola come sinonimo di retorica nel senso classico,
ossia arte di persuadere attraverso la parola, che gli antichi greci
indicavano con un termine tanto polivalente quanto affascinante:
téchne, studio, codifica, pianificazione, ma anche eloquio bello e forbito.
Il fine della retorica è quello di persuadere, ossia indurre qualcuno a
credere in qualcosa ammaliandolo con un ricamo di figure retoriche o
costringendolo in una catena di ragionamenti corroborati da esempi e
analogie. Tuttavia, a ben guardare, la persuasione non implica alcun
stringente rapporto con la verità né a livello logico, né metodologico, e
la retorica, di cui anche ora stiamo provando le possibilità, nulla può
dirci sul vero e neppure sul falso, né sul giusto né sull’ingiusto.
5
10
Il presente discorso, il cui ritmo ponderato questa trascrizione non riesce a
rendere fedelmente, conclude affermando che la retorica può essere impiegata a fin di
bene, ma anche a fin di male. Il ragionamento che da esso emerge è che se l’abilità di
parola è persuasione (riga 6), e la persuasione non implica alcun rapporto con la verità
(righe 12-13), allora, l’abilità di parola può essere impiegata beneficamente o in modo
controproducente. Accettate le definizioni esplicite e alcune definizioni implicite assunte,
il presente ragionamento può essere anche considerato logicamente valido. Il problema
per il quale è stato riportato è però il seguente: sebbene l’argomento sia valido esso
sostiene una tesi diversa da quella che avrebbe dovuto. Infatti, mentre conclude che la
retorica può essere impiegata a fin di bene, ma anche a fin di male, il dibattito chiedeva a
questa squadra di sostenere che l’abilità di parola arreca più bene che male. In questo caso
l’intervento supporta una conclusione diversa da quella che il dibattito richiede. Questo
errore, denominato ignoratio elenchi, e che consiste nel sostenere una tesi diversa rispetto a
quanto è in discussione, è solo una delle fallacie che infrangono le regole dialettiche del
fenomeno argomentativo in situazioni dibattimentali a cui possono aggiungersi, tra le
altre, l’attacco al fantoccio, ossia attaccare una posizione diversa e più debole rispetto a quella
presentata dall’opponente, la falsa pista, ossia non rispondere alle obiezioni dell’opponente
ERIS Rivista internazionale di argomentazione e
dibattito
eris.fisppa.unipd.it/Eris [email protected]
De Conti Manuele. La preparazione argomentativa del giudice di dibattito Eris, Vol. 1, n. 1, pp. 34-46 (2015) 41
ma divagare, e la domanda complessa, ossia una domanda che assume presupposti non
accettati dall’avversario (De Conti, 2013).
4. Dimensione logica
A partire dal seguente esempio sarà possibile delineare nella sua complessità
un’ulteriore dimensione di cui il fenomento argomentativo nelle situazioni dibattimentali
si compone:
Infatti, se esse [le bibite gassate e zuccherate] fossero così dannose per
l’organismo, lo Stato, dopo averlo dimostrato con le dovute prove
scientifiche, potrebbe arrivare a vietarne la vendita e non imporrebbe
quindi un’accisa a titolo simbolico per far comprendere ai cittadini che
consumarle non è salutare.
1
Il ragionamento di quest’intervento segue una particolare regola deduttiva di
derivazione denominata modus tollendo tollens. Secondo questa regola, dalle premesse «se le
bibite gassate e zuccherate fossero così dannose, lo Stato ne vieterebbe la vendita» (righe
1-3) e dal fatto che lo Stato non vieta la loro vendita (righe 3-4) − quel «non imporrebbe
quindi un’accisa a titolo simbolico» allusivamente rimanda all’asserzione «lo Stato non
vieta la loro vendita» − si può correttamente concludere che «le bibite gassate e
zuccherate non sono molto dannose». L’impiego di questa, come di altre regole deduttive
di ragionamento, permette di rilevare la dimensione logica − in questo caso deduttiva −, in cui
il fenomeno argomentativo può manifestarsi in una situazione dibattimentale, ossia
relativa alla disciplina che studia le condizioni di validità delle argomentazioni.
Quella logico-deduttiva non è però la sola articolazione della dimensione logica.
Consideriamo il seguente stralcio:
In questa prima argomentazione ci troviamo ad affrontare un caso a
1
ERIS Rivista internazionale di argomentazione e
dibattito
eris.fisppa.unipd.it/Eris [email protected]
De Conti Manuele. La preparazione argomentativa del giudice di dibattito Eris, Vol. 1, n. 1, pp. 34-46 (2015) 42
noi emblematico in cui l’interventismo statale si è rivelato fallimentare
ed inutile. Per risolvere il problema del sottosviluppo economico e
sociale del mezzogiorno, i governi post-bellici si sono affidati
all’interventismo statale il quale, inizialmente, era incentrato su grandi
opere strutturali. Tuttavia, spesso, dei giganteschi appalti e altre
iniziative statali finivano per creare solo delle enormi infrastrutture che
non avrebbero trovato un’applicazione pratica nel meridione in quanto
totalmente estranee alla realtà economica del sud, o perché rimaste
incompiute, le cosiddette cattedrali del deserto.
5
Il presente testo riflette un argomento induttivo, ossia un argomento in cui le
premesse forniscono solo un certo grado di supporto, o forza, alla conclusione. La
conclusione «l’interventismo statale si è rivelato fallimentare ed inutile» (riga 2) viene
derivata infatti dall’esempio storico riportato nelle righe 3-9 e non da premesse che
implicano la conclusione necessariamente. Si configura così un’ulteriore articolazione
della dimensione logica del fenomeno argomentativo ossia quella induttiva, specificazione
che non satura gli aspetti di cui può comporsi tale dimensione. Infatti, non è raro
riscontrare in situazioni dibattimentali l’impiego di argomenti che ricorrono nel linguaggio
naturale, ordinario, ma che non rispettano propriamente le regole logiche deduttive o
induttive dei ragionamenti scientifici, legali etc., come esibisce il seguente estratto:
Per questi motivi noi siamo contrari ad uno Stato eccessivamente
interventista, uno stato eccessivamente intrusivo, perché, attraverso
questi piccoli interventi, non fa altro che aprire la strada ad altri
interventi che condurrebbero lo Stato ad un atteggiamento di totale
[interventismo].
1
In questo caso l’argomento introdotto, e sottolineamo non sufficientemente
sviluppato, rappresenta un tipo specifico di ragionamento denominato della brutta china o
ERIS Rivista internazionale di argomentazione e
dibattito
eris.fisppa.unipd.it/Eris [email protected]
De Conti Manuele. La preparazione argomentativa del giudice di dibattito Eris, Vol. 1, n. 1, pp. 34-46 (2015) 43
del pendio scivoloso secondo il quale dall’accettare una semplice azione o decisione, ne
conseguirà una serie di azioni o decisioni che inevitabilmente condurrà ad esiti
indersiderati. Tale argomento esemplifica un ulteriore aspetto in cui la dimensione logica
si articola ed è denominato informale, ossia proprio della logica con cui si ragiona nel
linguaggio naturale e ordinario.
5. Dimensione retorica
A fianco alle dimensioni finora considerate non può mancare, poiché anch’essa
fondamentale, quella retorica, ossia relativa alla scelta delle forme espressive per convincere
o persuadere l’uditorio. Come quella logica, anche la dimensione retorica si articola in più
aspetti che corrispondono alla partizione greca di tale disciplina, ossia l’inventio, la dispositio,
l’elocutio e l’actio. Solo i primi tre, tuttavia, saranno d’interesse per il giudice che valuta
l’argomentazione poiché l’actio, la quale includerà in epoca romana anche la memoria, è di
pertinenza della valutazione non-verbale.
L’aspetto inventivo, come indica Aristotele nei Topici, è la disciplina dei luoghi,
schemi argomentativi o premesse da utilizzare nel discorso ma anche, come verrà poi
sviluppata in epoca romana, delle prove, degli esempi e dei dati più adatti a sostenere le
proprie posizioni. A livello internazionale esso è non di rado distribuito in indicatori quali
il contenuto (Content) e la strategia (Strategy), ma potrebbe aggiudicarsi un indicatore
proprio vista l’incidenza dei processi di reperimento e selezione del materiale nella
preparazione dei dibattiti. Come il testo Strategic Debate di Ray Wood e Lynn Goodnight
(1994) ben esplicita, «per scegliere la strategia adatta ad un dibattito la squadra deve
soppesare molti elementi come, ad esempio: quali sono le domande che pone la questione
da dibattere? Qual è la potenziale forza e debolezza del materiale raccolto? Quale analisi,
basata su prove, è più efficace per affrontare il dibattito? Cosa potrebbe fare la
controparte? […] Quali prove è preferibile usare nel dibattito?» (p. 8).
L’aspetto dispositivo o organizzativo riguarda invece la modalità più adatta e
opportuna di disporre il materiale nel discorso. Ciascun protocollo di dibattito, ossia
l’insieme di regole che struttura e guida lo sviluppo del dibattito stesso, esplicita le
modalità in cui il materiale deve essere organizzato per i singoli interventi di ciascuna
ERIS Rivista internazionale di argomentazione e
dibattito
eris.fisppa.unipd.it/Eris [email protected]
De Conti Manuele. La preparazione argomentativa del giudice di dibattito Eris, Vol. 1, n. 1, pp. 34-46 (2015) 44
disputa. Il prologo deve contenere la problematizzazione della controversia, la definizione
dei termini e l’anticipazione delle argomentazioni che la squadra esporrà; l’epilogo dovrà
invece ricapitolare il dibattito sintetizzando gli argomenti esposti dalle squadre oppure
esplicitando i punti su cui c’è stata maggior controversia per poi evidenziare la preferibilità
della propria posizione su quella opposta. Tuttavia, l’ampia discrezionalità riguardo alla
distribuzione degli argomenti e l’alta complessità del compito non garantiscono sempre
una struttura chiara degli interventi e uno sviluppo progressivo degli elementi che
costituiscono i discorsi, soprattutto durante le prime esperienze degli studenti col
dibattito. Pertanto il giudice, non raramente, dovrà fornire le opportune indicazioni e
correzioni.
Infine, nel dibattito non può essere trascurata la funzione esornativa di alcune
figure del discorso. Esse, quali ad esempio l’analogia o la metafora, non svolgono mai
semplicemente un ruolo “ornamentale”, bensì anche didattico e argomentativo: con
appropriate immagini si rende più chiaro e semplice il concetto da esprimere
promuovendone la comprensione e l’adesione del destinatario.
[…] Paradossale dunque pensare che il capitalismo sia nemico
dell’ecologia, come paradossale è pensare di poter tagliare un albero
alla base per raccoglierne i frutti. Sicuramente in questo caso ci sarà un
dispendio di forze, tempo e denaro molto minore. Ma ovviamente
converrà investire delle notevoli cure su quell’albero, e quindi sulla
concimazione e sulla potatura […] dei rami.
1
Tratto da un dibattito riguardante il rapporto tra capitalismo ed ecologia, la squadra
che doveva sostenere che il capitalismo non è nemico della natura introdusse l’analogia tra
strategie capitalistiche e la cura e coltura delle piante. Con questa espressiva immagine,
però, chiarì anche il concetto che il massimo profitto, cui il capitalismo tende, si può
raggiungere solo prendendosi cura di ciò che produce profitto.
6. Conclusione
ERIS Rivista internazionale di argomentazione e
dibattito
eris.fisppa.unipd.it/Eris [email protected]
De Conti Manuele. La preparazione argomentativa del giudice di dibattito Eris, Vol. 1, n. 1, pp. 34-46 (2015) 45
Il quadro che emerge dall'analisi dei dibattiti è alquanto articolato. Ammesso e non
concesso che queste siano tutte le dimensioni in cui l'attività argomentativa possa essere
scomposta, che non ci sia ridondanza tra loro, e che il giudice sia già pratico con i
procedimenti per raggiungere una valutazione organica delle squadre e del dibattito, il
compito dell’arbitro dell’argomentazione si presenta arduo quanto in realtà è.
Ciononostante è a partire da questa complessità che la preparazione del giudice e
l'elaborazione degli strumenti e dei criteri per valutare il dibattito devono discendere,
selezionandone gli aspetti da considerare, approfondendoli e traducendoli in indicatori
adatti. Senza un’approfondita preparazione tale complessità non potrà che sovrastare il
giudice, rendendolo passibile della critica d'arbitrarietà. Ma soprattutto, la motivazione per
una corretta preparazione va attinta dalla funzione educativa del suo ruolo che se non
ricoperto responsabilmente diventerà un ostacolo, anziché un supporto, nel processo
formativo intrapreso dagli allievi col dibattito regolamentato.
Bibliografia
Aristotele (2003). Topici. In G. Colli (Tr.), Organon (pp. 407-643). Milano: Adelphi.
Branham, R. (1991). Debate and Critical Analysis: The Harmony of Conflict. Hillsdale: Lawrence
Erlbaum Associates.
Cattani, A. (2012). Dibattito. Doveri e diritti, regole e mosse. Napoli: Loffredo University Press.
Coirier, P., Andriessen, J., & Chanquoy, L. (1999). From Planning to Translating: The
specificity of Argumentative Writing. In J. Andriessen & P. Coirier (Eds.),
Foundations of Argumentative Text Processing (pp. 1-41). Amsterdam: Amsterdam
University Press.
Colombo, A. (1992). Il testo argomentativo: presupposti pedagogici e modello di analisi.
In Colombo A. (Ed.), I pro e i contro. Teoria e didattica dei testi argomentativi (pp. 59-
84). Firenze: La nuova Italia.
De Conti, M. (2012). Autori e testi tra argomentazione e dibattito regolamentato. In A.
Cattani, & M. De Conti (Eds.), Didattica, dibattito, fallacie e altri campi
dell’argomentazione (pp. 13-24). Napoli. Loffredo University Press.
ERIS Rivista internazionale di argomentazione e
dibattito
eris.fisppa.unipd.it/Eris [email protected]
De Conti Manuele. La preparazione argomentativa del giudice di dibattito Eris, Vol. 1, n. 1, pp. 34-46 (2015) 46
De Conti, M. (2013). Dibattere a scuola: scegliere il proprio percorso educativo. Studi sulla
formazione, 1, 111-120.
De Conti, M. (2013b). Fallacies Selection Criteria for Effective Debate Training. In A.L.
Sellami, (Ed.), Argumentation, Rhetoric, Debate and Pedagogy: Proceedings of the 2013 4th
International Conference on Argumentation, Rhetoric, Debate, and Pedagogy (pp. 199-214).
Doha, January 11–13, 2013.
De Conti, M. (in stampa). Il dibattito regolamentato come strumento educativo.
Orientamenti pedagogici.
Desideri, P. (1991). Il testo argomentativo: processi e strumenti di analisi. In P. Desideri
(Ed.), La centralità del testo nelle pratiche didattiche (pp. 121-143). Firenze: La Nuova
Italia.
Freeley, A. J., & Steinberg, D. L. (2008). Argumentation and Debate: Critical Thinking for
Reasoned Decision Making. Belmont: Wadsworth.
Fryar, M., Thomas, D. A., & Goodnight, L. (1995). Basic Debate. Lincolnwood: National
Textbook Company.
Hanson, J. (1991). NTC’s Dictionary of Debate. Lincolnwood: National Textbook Company.
Lo Cascio, V. (2009). Persuadere e convincere oggi. Nuovo manuale dell’argomentazione. Città di
Castello: Academia University Press.
Nicolli, S., & Cattani, A. (Eds.) (2008). Palestra di botta e risposta. La disputa filosofica come
formazione al dibattito nella scuola. Padova: CLEUP.
Romani, W. (1992). Tipologia testuale e testo argomentativo. In Colombo A. (Ed.), I pro e
i contro. Teoria e didattica dei testi argomentativi (pp. 11-58). Firenze: La nuova Italia.
Schuster, K., & Meany, R. (2004). Judging Debates. The Middle School Public Debate
Program Judge Certification Manual. Reperito da:
http://www.middleschooldebate.com/documents/MSPDPjudgingmanual.pdf
Snider, A. (2008). The Code of the Debater: Introduction to Parliamentary Debate. New York:
IDEA.
Stati, S. (2002). Principi di analisi argomentativa. Bologna: Pàtron.
Ulrich, W. (1986). Judging Academic Debate. Lincolnwood: National Textbook Company.
Wood. R., & Goodnight, L. (1994). Strategic Debate. Lincolnwood: National Textbook
Company.


























![Il dibattito recente sul presunto declino economico italiano [The recent debate about the alleged Italian economic decline]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6335c196379741109e00c4bd/il-dibattito-recente-sul-presunto-declino-economico-italiano-the-recent-debate.jpg)