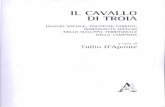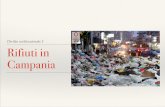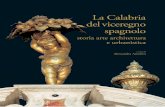Dark Earth, rifiuti urbani e uso delle acque a Napoli tra X e XII secolo
Transcript of Dark Earth, rifiuti urbani e uso delle acque a Napoli tra X e XII secolo
Inquadrare il problema dello smaltimento dei rifiuti è di capitale importan-za per capire la città medievale nel suo assetto infrastrutturale e socio-econo-mico. Il tema è stato ampiamente esaminato dal punto di vista archeologico,meno da quello storiografico, ed è stato utilizzato nel più ampio dibattito sullacontinuità o rottura della città nel passaggio dall’antichità al medioevo1. Porta-re al centro dell’attenzione della storiografia argomenti di questo genere signi-ficherebbe, tra le altre cose, reinterpretare costruttivamente l’enorme mole didati archeologici, spesso letta in chiave catastrofista. Il fenomeno delle darkearth (strati di terra nera, ricca di sostanze organiche che si rinvengono di so-vente nei depositi urbani) è stato interpretato ora come il prodotto di un preco-ce deterioramento delle infrastrutture romane, ora come un fenomeno fisiolo-gico di evoluzione urbana che cambiava non necessariamente in peggio2. Perquanto riguarda Napoli il parziale abbandono di parti della città è da leggersinell’ottica di una diversa destinazione d’uso di alcuni degli spazi cittadini(spazi che, come vedremo, verranno destinati consapevolmente allo smalti-mento delle immondizie e all’utilizzo a fini igienici)3.
L’analisi dell’impatto dei rifiuti nell’economia urbana permetterebbe inol-tre di valorizzare meglio l’enorme giro di affari che la gestione dello smalti-
DARK EARTH, RIFIUTI URBANI E USO DELLE ACQUE A NAPOLITRA X E XII SECOLO
di Leonardo Carriero
Società e storia n. 145, 2014
1. Solo per citare alcuni studi che hanno segnato il dibattito: Bognetti (1966), pp. 671-708; Bognetti (1959), pp. 59-87; Cagiano de Azevedo (1970), pp. 73-89; Cagiano de Aze-vedo (1974a), pp. 1-41; Cagiano de Azevedo (1974b), pp. 641-677; Carver (1993); Halsall(1995); Hodges (1982); Ward-Perkins (1984); Ward-Perkins (1988); Ward-Perkins (1996),pp. 4-17; Ward-Perkins (2008).
2. Per quanto riguarda l’Italia, gli scavi archeologici di Brescia e Verona sono assurti amodello per una presunta efficienza o meno del sistema di smaltimento dei rifiuti e delle fo-gne nel periodo di passaggio da antichità ad alto medioevo. Brogiolo (1984), pp. 48-56, 88-91. La Rocca (1986), pp. 31-78. Per quanto riguarda Napoli: Arthur (1994), pp. 1-34; Vito-lo (2005), pp. 219-247. Su Roma: Wickham (2013). La più recente riflessione archeologicasul tema, soprattutto in ambito europeo: Davidson et al. (2006), pp. 778-783. Devos et al.(2011), pp. 51-76.
3. È un tema che attrae molta ricerca anche di ambito economico e ecologista: Barthela,Isendahld (2013), pp. 224-234.
mento comportava e che suscitava gli interessi di esponenti di importanti fa-miglie cittadine e coinvolgeva direttamente il duca e i più influenti enti reli-giosi della città. Il potere pubblico, in maniera particolare, nutriva uno spicca-to interesse per la gestione del patrimonio infrastrutturale legato all’accumuloe allo smaltimento delle risorse idriche, in virtù dell’enorme impatto ideologi-co che avevano le grandi opere idrauliche nell’esercizio del potere; impiantiche, più in generale, erano intimamente connessi con i servizi di smaltimentodei rifiuti4.
Napoli si configura come un caso di studio ottimale per la relativa abbon-danza di fonti che rende possibile una serie di riflessioni di carattere generale eaperte alla comparazione con altre situazioni urbane, proprio partendo da noti-zie e dati di carattere squisitamente materiale. L’enorme impatto di carattereinsediativo, economico e sociale che dovevano avere questioni legate al siste-ma fognario, all’igiene pubblica e privata e allo smaltimento degli escrementie di scarti di produzioni si rifletteva necessariamente sugli assetti urbani e de-cretava la valorizzazione di alcune aree piuttosto che di altre, la fortuna econo-mica di alcuni gruppi familiari e influiva in maniera determinante sul tenore divita delle società locali. Il caso di Napoli, se confrontato con quello delle altrecittà della Penisola, sembra essere decisamente all’insegna di una marcatacontinuità infrastrutturale e insediativa con l’antichità e costituisce un esempiolampante di come i requisiti igienici e abitativi di quest’area fossero intima-mente e idealmente connessi con quelli propri delle aree sotto influenza bizan-tina. Lo stretto legame con l’Impero d’oriente era veicolo di un determinatostandard abitativo: la facilità di approvvigionamento idrico, la possibilità di di-sporre facilmente di un sistema fognario e di bagni pubblici erano tutte carat-teristiche proprie degli insediamenti più grandi del sistema politico e culturalebizantino5.
Nel X secolo la città di Napoli possedeva un sistema fognario e di smalti-mento dei rifiuti liquidi complesso e pienamente funzionante, consistente inuna serie di canali pubblici, di superficie e sotterranei, che confluivano in un
434 L. Carriero
4. Riguardo al ruolo del duca di Napoli nella gestione pubblica delle infrastrutture ri-mando a Carriero (2013), pp. 49-57. L’approvvigionamento idrico pubblico era basato sulmantenimento dell’acquedotto e delle fontane da esso alimentate (integrato da un certo nu-mero di pozzi). Questo era tuttavia complessivamente insufficiente: era necessario che ogninucleo familiare dotasse privatamente le abitazioni di un sistema di raccolta e conservazio-ne. Squatriti (1998), pp. 17-18. Delogu (1977). A Salerno in modo particolare si può vede-re come il progetto dell’ideologia principesca, esplicitamente ispirato alla grandezza roma-na, si manifestasse proprio con la costruzione di un imponente acquedotto che dalla sorgen-te de Palmula riforniva tutta la città, compreso lo stesso palazzo del potere. L’acquedotto«pubblico» fu messo a disposizione di tutti, anche se sotto il controllo del principe. Nel959, dopo due secoli di servizio, era comunemente chiamato «acquedotto dello Stato». Sul-l’importanza del publicum a Napoli: Martin (2005), pp. 59-77; Feniello (2011), pp. 67-70;Feniello (2012), pp. 325-342.
5. La tradizione dell’utilizzo pubblico delle acque e del restauro delle infrastrutture ro-mane è una costante della realtà urbana altomedievale nell’Oriente bizantino: Squatriti(1998), pp. 17-18; Magdalino (1990), p. 167.
unico grande canale e infine in mare. Non è da escludere che questo fosse ilfrutto della naturale evoluzione dei sistemi tardoantichi, adeguati alle nuoveesigenze cittadine: si parla nei documenti di generiche cloache e di una cloacamassima. A questo sistema pubblico si affiancava una rete di canali e canali-celli privati: ogni abitazione infatti doveva essere munita di un sistema di gron-daie che dai tetti e dalle finestre convogliavano le acque in eccesso direttamen-te sulla strada per poi ricongiungersi al sistema di smaltimento idrico pubbli-co. Anche le latrine erano direttamente collegate alle cloache. Dove non erapossibile mettere in comunicazione la rete idrica privata con quella comunita-ria, allora le acque reflue dovevano necessariamente essere scaricate in luoghiappositi, solitamente in corti o in orti privati dotati probabilmente di pozzineri. Tale sistema, come vedremo, è descritto dalle fonti documentarie con ab-bondanza di dettagli6.
Fogne, canali e sistemi di scolo
Bartolomeo Capasso, nella sua ricostruzione topografica di Napoli, indivi-dua il canalis publicus nella parte meridionale della città, circondato dallemura cittadine e stretto tra le chiese di San Giovanni Maggiore e di Santa Ma-ria la Nova7. La funzione era quella di raccolta delle acque in eccesso che ve-nivano dai quartieri posti sui punti più elevati della città, e segnatamente neipressi del monastero di Sant’Agnello e della Summa platea. Le acque del ca-nalis publicus dunque seguivano l’alveo che si formava naturalmente tra l’altu-ra di Monterone e l’altura della chiesa di San Giovanni Maggiore. Una voltagiunto nei pressi della plagia maris, il canale scaricava le sue acque nei fusa-ria et aquaria (vasche in cui si effettuava la lavorazione del lino) nei pressidella porta Calcarea; ed infine in mare. Nel canalis publicus dovevano conflui-re altri due canali urbani8. Il primo era situato nel cuore della città, nel quartie-re Nilo: «intus civitatem Neapolis iusta platea publici seum [sic] et iusta caputde alia platea publici qui vadit at pretorium istius civitatis at Nilo». Il secondocanale era invece posto ai margini orientali9: «intus civitatem Neapolis intus
Dark earth, rifiuti urbani e uso delle acque a Napoli tra X e XII secolo 435
6. Da tenere presente la forte impronta ellenizzante della società napoletana che tende-va a modelli di vita orientali: Von Falkenhausen (1992), pp. 24-26; Martin (2005), pp. 59-77; Feniello (2011), pp. 18-20.
7. Non vi è motivo di dubitare del continuo funzionamento del canalis publicus: le no-tizie documentarie sono attestate fino a tutto l’XI secolo. Capasso (1895), pp. 30, 186-187.I documenti che riguardano le strutture fognarie della città sono numerosi: Capasso (1895),84, 323, 435, 524, 615, 617, 619, 623; Pilone (1999), II, p. 822.
8. Capasso (1895), 615, pp. 374-377.9. Capasso (1895), 617, pp. 377-378. La città sembra essere servita da un sistema fo-
gnario efficiente e capillare, a differenza di quanto sostiene Cagiano de Azevedo (1974b),p. 675. Contrariamente alla distribuzione dell’acqua alimentata dall’acquedotto, la rete del-le fognature (probabilmente mantenutasi in funzione fin dall’età antica) risulta estesa in tut-ta l’area della città di Napoli, senza quella caratteristica disposizione a macchia di leopardo,che caratterizza invece le fontane ad acqua corrente: Carriero (2013), pp. 49-57.
porticum et trasennam communem secus plateam publicam, per quam decurritclabaca maxima que venit de Pistasia, regione Furcillense».
Un documento datato 2 luglio 1118 descrive la cloaca massima di Napoliche percorreva tutta la platea publica del quartiere di Forcella. Sulla stradaprincipale si affacciavano i portici e gli edifici abitati: sembrerebbe delinearsil’immagine di una città efficientemente servita da un sistema fognario inconte-stabilmente funzionante.
In un altro documento degli stessi anni i fratelli Inferno (in una lite chevede Giovanni e Gregorio contro Stefano) compilano una chartula combenien-tiae in merito alla casa ricevuta in eredità dal padre10. Poiché una delle partivoleva compiervi dei lavori di ristrutturazione, per contratto l’edificio avrebbedovuto essere dotato «tantu in altu quantum in ista portione» di un sistema digrondaie che «versare debeat vel in curte commune a parte orientis vel in pla-tea publici in parte occidentis». Allo stesso modo la latrina doveva essere col-legata per contratto alla cloaca pubblica, che in questa parte della città era ad-dirittura sotterranea: «Insuper in ista portio ab ipsa domo que ibidem feceritmonimen [latrina] et aquaria facere voluerit, ut descendit in illa clabaca publi-ci qui badit subtus terra per antomata per ipsi parietibus iusta se, licentiam ha-beat».
Il problema dello smaltimento idrico era ritenuto capitale e regolamentatominuziosamente: gli abitanti della città avevano l’obbligo di non arrecare di-sturbo ai vicini con il reflusso delle acque e pertanto dovevano dotare le loroabitazioni (qualora ne fossero sprovviste o abbisognassero di restauro) di ca-nali che convogliassero i liquidi prodotti in appositi spazi, ricavati privatamen-te nelle corti oppure più spesso nelle vie pubbliche. Le latrine inoltre doveva-no essere collegate alla cloaca più vicina e, qualora non fosse stato possibile,dovevano essere dotate di pozzi sotterranei capaci di accogliere i liquidi in ec-cesso.
Il caso di Napoli sembra essere qualitativamente diverso rispetto a quellodelineato dagli scavi archeologici condotti nelle città di altre aree italiane, al-meno per quanto riguarda i secoli presi qui in considerazione. Infatti, mentre aNapoli è chiaramente attestata la presenza di una fitta rete di canalizzazioneprivata che si congiungeva a quella pubblica, in città come Ferrara, ad esem-pio, sembrerebbe emergere uno scenario decisamente più semplificato. Ancoranel XIII secolo, con l’edificazione di un nuovo quartiere, la raccolta dei rifiutisolidi e liquidi sembra essere esclusivamente organizzata dai singoli privati11.
436 L. Carriero
10. Capasso (1895), 615, pp. 374-377. La casa si trovava all’incrocio di due vie pubbli-che nel quartiere Nilo, una delle quali portava al palazzo pretorio. Il documento mostracome questioni legate alle fognature potessero essere causa di lite perfino tra fratelli e comeprivato e pubblico si integrassero in un sistema complesso e ben regolamentato. L’impor-tanza delle infrastrutture idriche nella topografia delle città medievali è messa in rilievo daPellegrini (1973), pp. 450-456.
11. Gelichi (2000), pp. 13-23; Gelichi (1992), pp. 66-98. Sebbene anche per Napoli, ne-gli scavi archeologici di Carminiello ai Mannesi, siano stati registrati fenomeni paragonabi-li a quelli rinvenuti nelle città del nord Italia (in particolare la pratica di riempire di rifiuti
A Ferrara, come in molte città del nord della Penisola, il sistema di smalti-mento verteva sostanzialmente su una serie di fosse nelle corti; era inoltre unapratica comune riempire di rifiuti gli interstizi tra un edificio e l’altro. Nono-stante sia possibile supporre che i condotti fognari di epoca romana fosseroutilizzati anche nei primi secoli alto medievali, gli archeologi, per le città set-tentrionali, intravvedono elementi di marcato degrado delle strutture più anti-che12.
In molti documenti napoletani gli edifici paiono essere muniti di struttureatte a convogliare i liquidi. In caso di carenza infrastrutturale nasce una litegiudiziaria che porta, il più delle volte, alla riappacificazione delle parti trami-te la dotazione degli edifici di questo genere di impianti.
A metà del X secolo i fratelli Erario, esponenti dell’aristocrazia napoletana,si accordano per la divisione di un grande edificio nel cuore della città13. L’e-dificio in questione era molto prestigioso sia per la posizione centrale, sia perl’articolazione interna: constava di almeno due appartamenti al primo piano, diun ambiente al piano terra ove si svolgeva un’attività commerciale e di ungrande solaio pavimentato; era inoltre corredato da alcuni elementi di pregioquali colonne marmoree e orti pensili14. Il problema dello smaltimento delleacque sembra essere fondamentale per la risoluzione corretta del contratto:«sed aquas de edificio, qui ibi utrique facere voluerint, recipere et versare de-beant in proprio». I fratelli Erario si accordano per fare una serie di lavori direstauro e di adeguamento dell’edificio «ad omne communem expendium».Per quanto riguarda invece l’acqua entrambe hanno l’obbligo di munire le ri-spettive proprietà di un corretto sistema di scolo15.
L’esigenza di un corretto smaltimento delle acque emerge anche in altri do-cumenti: ognuno era ritenuto responsabile dello smaltimento dei liquidi discarto prodotti. Nel 1119 Marotta, figlia del suddiacono Giovanni, si scontracon Giacomo, igumeno del monastero dei Santi Sergio e Bacco, proprio per
Dark earth, rifiuti urbani e uso delle acque a Napoli tra X e XII secolo 437
gli interstizi tra un edificio e l’altro), la situazione che emerge dalle fonti sembra essere benpiù complessa ed articolata. Le testimonianze del complesso sistema di smaltimento fogna-rio ancora in funzione nei secoli X-XI integrano l’immagine della città fornita dal dato ar-cheologico. Arthur (1994), pp. 1-34; Vitolo (2005), pp. 219-247.
12. Brogiolo (1984), pp. 88-91. Non vi è dubbio che lo scenario ricostruito per la cittàdi Brescia risulti poco funzionale per comprendere il caso di Napoli, assai più complesso eradicalmente diverso. Tuttavia l’ipotesi di un reimpiego delle strutture romane, seppure perun lasso di tempo limitato per quanto riguarda Brescia, è un punto in comune per le duecittà.
13. Capasso (1895), 84, pp. 68-69.14. A Napoli gli orti erano diffusissimi, come anche sostiene Vitolo (1993), p. 167. Ma
Napoli non è l’unico esempio di città-orto: Lucca è un esempio con Belli Barsali (1973),pp. 488-489. Il ruolo fondamentale dell’orto nell’economia di un territorio è dunque da ri-considerarsi – secondo le valutazioni di Andreolli (1990), p. 209 – proprio nell’ottica diparticolati complessi produttivi.
15. Riguardo alle liti giudiziarie e ai motivi di tensione nelle società cittadine dei secoliX-XI: Skinner (1998), pp. 159-176, per la Puglia bizantina; Delogu (1997), pp. 257-308,per l’Italia meridionale longobarda; Cortese (1997), pp. 621-647; Nicolaj (1997), pp. 347-379, per il Regnum Italiae; Wickham (2000), per la Toscana.
una questione di grondaie16. La casa di proprietà del monastero aveva il tettodistrutto e si trovava in stato di abbandono: l’antico sistema di grondaie, cheprobabilmente convogliava le acque nella vicina piscina, sempre di proprietàdel monastero, era logoro, così che le acque dell’edificio finivano nel confi-nante orto di Marotta. Una situazione alquanto incresciosa per il vicinato: si hanotizia anche di altri confinanti che citano in giudizio l’igumeno, probabilmen-te per lo stesso motivo. È evidente come lo stato di incuria degli edifici cau-sasse non pochi problemi per i proprietari distratti. Siamo qui di fronte a unareazione a catena da parte dei vicini della casa distrutta, che viene innescataproprio per motivi di scorretto smaltimento delle acque. Come si capisce dauna postilla finale del documento, la questione aveva avuto connotazioni piut-tosto colorite e aveva coinvolto numerosi componenti delle rispettive famiglie:Marotta, esasperata dal continuo stillicidio nella sua proprietà, prima di recar-si dai giudici, aveva coinvolto nella questione il marito, i fratelli, le sorelle e icugini che avevano minacciato l’igumeno17.
Ma non bastava, come detto, dotare gli edifici di strutture atte a smaltire leacque in eccesso: a Napoli occorreva creare un sistema di canali in grado dimettere in comunicazione le abitazioni private con il sistema pubblico di cana-lizzazione oppure con appositi spazi concordati tra le parti18. In una lite giudi-ziaria del 1032 Laurenzio, rettore del monastero dei Santi Sergio e Bacco, citain giudizio Pietro Barese a causa dello smaltimento delle acque reflue priva-te19. Pietro aveva costruito un piccolo canale che dal pavimento della sua casa,al primo piano, scaricava l’acqua nel viottolo che portava alla chiesa di SantaAgata, posta sotto la giurisdizione del monastero dei Santi Sergio e Bacco.Laurenzio, grazie a una cartula comparationis in tumbo scripta, dimostra din-nanzi ai giudici che il passaggio apparteneva al monastero. I giudici dunqueobbligano Pietro Barese a costruire a sue spese un ulteriore canale «ut per ipsadomum sua nullas aquas decurrere aut versare in memoratum aheditor de-beat». Nonostante le lacune del documento, le informazioni sono numerose edettagliate: anzitutto non vi era tolleranza per gli scarichi abusivi e non regola-mentati, inoltre sembrerebbe che le norme in materia fossero schierate netta-mente in favore del ripristino della normalità infrastrutturale. In secondo luogo
438 L. Carriero
16. Capasso (1895), 619, p. 379. Documenti come questo ci permettono di gettare lucesugli standard abitativi della città e sui problemi ad esso connessi: il modo in cui si risolveuna questione di tal genere chiarisce inoltre la posizione di forza della publica potestas nel-la figura dei giudici pubblici. Carriero (2013), pp. 49-50.
17. Capasso (1895), 619, p. 379: «Insuper promittit (Marotta) numquam aliquando tem-pore monasterium molestare et tacitos facere omnes germanos et germanas suas, biros etconsobrinos».
18. La notizia di giudizi pubblici che obbligano i privati a collegare le proprie abitazio-ni alla rete fognaria comune dimostra la grande attenzione riservata a questo genere di pro-blematiche ed è sentore di una più vasta regolamentazione in materia. Chiodi (2008), pp.505-582.
19. Capasso (1895), 435, pp. 272-273. A proposito di questo documento è da notare l’e-norme importanza che ebbe la documentazione scritta nella risoluzione di questi delicaticasi giudiziari. Pratesi (1987), pp. 137-168.
si apprende che le abitazioni erano dotate di scarichi direttamente collegati auna serie di canalizzazioni che convogliavano le acque e i liquidi di scarto inpunti precisi. Infine è da notare come i cittadini fossero a conoscenza dellenorme in materia e cercassero (con accordi tra privati, con documentazionepregressa e con il ricorso ai giudici pubblici) di far valere i propri diritti20.
In un evidente caso di abuso edilizio, come quello che presenteremo di se-guito, è curioso notare come anche nelle più precarie condizioni di abitazionefosse diffusamente sentita l’esigenza di un sistema di canalizzazione che assi-curasse lo scarico delle acque di rifiuto, e allo stesso modo la raccolta delle ac-que indispensabili per la vita di tutti i giorni21. Siamo nel 1038 e Bona Sissanastipula con Laurenzio, nel frattempo divenuto igumeno del monastero dei San-ti Sergio e Bacco, un accordo riguardo ad alcuni spazi in comune. Il caso èpiuttosto complesso poiché Bona Sissana aveva costruito abusivamente un so-laio proprio sopra l’anditum communalem esistente tra la sua casa e quella diproprietà del monastero. È da immaginare che il solaio sorgesse sopra i secon-di piani degli edifici (probabilmente a circa otto metri da terra) e che fosse ap-poggiato grazie a un sistema di pali e forche di legno, oscurando così comple-tamente la via comune. Nel pubblico giudizio i giudici decretano per le dueparti una soluzione di conciliazione22. Poiché il solaio non era stato ancora ul-timato, se ne vietava a Bona Sissana il completamento: con il tempo i pali e illegname già collocati si sarebbero deteriorati e dunque la donna avrebbe prov-veduto a eliminarli personalmente. Veniva vietata la costruzione del solaio,tuttavia il monastero doveva acconsentire il passaggio dell’acqua piovana finoalla piscina privata di Bona Sissana (apprendiamo infatti che lei si era inge-gnata a realizzare una serie di «canales ligneos, unde currit aqua celestis at il-lam piscinam eorum»). Il documento si rivela importante nella sua originalitàper vari aspetti: uno è sicuramente la condanna degli abusi edilizi, attraverso iquali si cercava di appropriarsi degli spazi comunitari, sebbene in questo casosi giunga a una mediazione. Un altro aspetto di grande importanza qui ribaditocon forza è come gli edifici possedessero sofisticati sistemi di canalizzazione.Inoltre, il possesso di un bene come l’acqua pulita costituisce uno dei fattorideterminanti per la risoluzione dei problemi abitativi. Questo documento infi-ne sembra ulteriormente confermare la grande importanza che ebbero nellaNapoli pienomedievale le piscine private, coi loro sistemi di raccolta delle ac-que.
Dark earth, rifiuti urbani e uso delle acque a Napoli tra X e XII secolo 439
20. A Napoli, ancora fino al XII secolo vengono utilizzati pergamena e papiro: Martin(2000), pp. 183-189.
21. Capasso (1895), 466, pp. 287-288. Si badi che i casi di abuso, come quello registra-to in questa fonte, sono da ritenersi per Napoli eccezionali e non facilmente documentabili.È interessante notare come anche nelle condizioni più precarie ci sia il riferimento a condi-zioni di abitabilità ritenute indispensabili.
22. La costante che emerge dall’analisi delle dispute giudiziarie a Napoli è che la stra-grande maggioranza dei casi si risolve con un accordo tale da non comprometterne l’effetti-va attuabilità. Carriero (2012), pp. 157-166. Per quanto riguarda la risoluzione dei conflittinel nord Italia: Chiodi (2008), pp. 505-582.
Per il possesso dell’acqua dunque si litiga e ci si accorda, ma allo stessotempo ci si impegna a costruire nuove infrastrutture tali da poterne regolarel’accumulo e il deflusso. Alcuni ne fanno addirittura un lavoro. Urso Cafatinasi accorda con la badessa del monastero dei Santi Marcellino e Pietro, Aloasa,in merito ad alcuni servizi legati proprio all’accumulo e al deflusso delle ac-que23. La badessa ha il permesso di convogliare l’acqua di proprietà di Ursofino alla corte della chiesa di San Renato, posta sotto la giurisdizione del mo-nastero, ove è situato un bagno. Le monache evidentemente hanno bisogno diuna grande quantità di acqua, così come hanno la necessità di smaltire l’acquautilizzata. Urso Cafatina dunque, oltre alla concessione dell’acqua, si accordacon le monache per costruire un sistema di canali in entrata e in uscita dallacorte di San Renato, ricevendo in cambio di tali servizi 3 tarì l’anno. Alla lucedi queste informazioni si comprende meglio non solo l’importanza di strutturequali le piscine e i pozzi, ma anche di efficaci ed estesi sistemi di canalizza-zione. L’acqua era, nella Napoli del medioevo, una risorsa di capitale impor-tanza per la sopravvivenza della città, come è ovvio, ma allo stesso tempo co-stituiva una enorme ricchezza commerciabile. Al sistema pubblico dunque siaffiancava un complesso insieme di strutture private legate all’accumulo, altrasporto e allo smaltimento delle acque: tale sistema era reso possibile graziealla grande quantità di denaro e possibilità di lucro che stavano dietro tali ser-vizi24. Se infatti consideriamo che nel 1126 (pochi anni più tardi rispetto alprecedente documento relativo a Urso) viene venduto un appartamento in pie-no centro cittadino per la somma di otto tarì, allora comprendiamo che la con-cessione di tre tarì annui a Urso Cafatina in cambio dei suoi servizi legati al-l’acqua era decisamente redditizia.
Diaconie, bagni e servizi igienici
Di vitale importanza per una città di grosse dimensioni era naturalmente lapossibilità di accedere a una serie di servizi che fossero in grado di supportare leesigenze igieniche di una società urbana complessa. Il sistema idrico di Napoli,nei secoli del ducato, fu organizzato per soddisfare questo genere di richieste25.
440 L. Carriero
23. Capasso (1895), 577, 350. Il monastero dei Santi Marcellino e Pietro si offre di pa-gare profumatamente i servigi di Urso Cafatina che, molto probabilmente, ha fatto della suaabilità un mestiere assai remunerativo.
24. Capasso (1895), 628, pp. 389-391. Viene qui a delinearsi un panorama urbano total-mente nuovo: questo genere di infrastrutture idriche caratterizzano la città non solo inun’ottica di servizio alla popolazione (sia che questo fosse fornito dalla publica potestas odai privati cittadini) ma anche in un’ottica di sfruttamento e ottimizzazione di un bene tan-to redditizio.
25. Sono numerosi gli studi che dimostrano come nel corso dei secoli centrali del me-dioevo (X-XII) l’esigenza di accedere ai bagni fosse ritenuta fondamentale (in Orientecome in diverse città delle Penisola). Stasolla (2008), p. 873; Montanari (2008), pp. 779-804; Angeletti (2008), pp. 821-864; Squatriti (1998); Magdalino (1990), p. 167; Vitale(2005), pp. 1-48.
Come emerge dalla documentazione superstite, i metodi di raccolta e distribu-zione delle acque erano diversi e si integravano tra loro per sopperire il comples-sivo rifornimento idrico cittadino. La rete di bagni, pubblici e privati, che si ven-ne a creare all’altezza del X-XII secolo fu il risultato di una serie di evoluzioniche permisero a Napoli di dotarsi di un sistema igienico variegato, paragonabileprobabilmente a quello delle altre città sotto la sfera d’influenza bizantina.
Il ritrovamento di un bagno presso il monastero tardo medievale di SantaChiara (bagno di origine antica e in uso ancora dopo il VI secolo) è di notevo-le interesse26; la struttura igienica era articolata in due stanze: la prima era ca-ratterizzata da un tetto con volta a crociera e possedeva probabilmente una cu-pola, modificata con la successiva costruzione del monastero di Santa Chiara.La seconda stanza invece conservava la cupola originale di forma conica e ogi-vale. La scoperta di bagni in uso dopo il VI secolo è eccezionale: è probabileche il bagno in questione fosse stato alimentato dall’antico acquedotto romano(continuamente restaurato e non casualmente vicino). Mentre per i primi seco-li del medioevo non è inverosimile ipotizzare un insieme di strutture igienicherifornite dall’acquedotto, su modello degli antichi bagni romani, nei secolisuccessivi la situazione si complica. Infatti, con la continua urbanizzazionedella zona all’interno delle mura, divenne più problematico il restauro e man-tenimento di tali strutture, che vennero progressivamente inglobate dagli edifi-ci circostanti, come nel caso del settore orientale delle mura.
A partire dai primissimi secoli del medioevo, alla rete pubblica di bagni siaffiancò quella delle diaconie. Il sistema delle diaconie è antichissimo e a Na-poli permane per tutti i secoli della dominazione ducale. Le prime attestazioniin Italia cominciarono a partire dal VI secolo e sono individuabili a Roma, Pe-saro e Napoli27. Nella ricostruzione topografica di Napoli, è possibile indivi-duare almeno sette diaconie (S. Andrea, S. Giorgio al Foro, S. Gennaro, SS.Giovanni e Paolo, S. Maria Cosmedin, S. Maria Rotonda e S. Pietro all’Anfi-teatro). Le diaconie hanno «il compito specifico di provvedere alle opere cari-tative e assistenziali a favore dei poveri», tra cui quello di provvedere ai servi-zi igienici di coloro che non potevano accedervi in altra maniera28. Secondodiversi studiosi, oltre a quello prettamente igienico, le diaconie provvedevanoa una esigenza cultuale propiziatrice e di purificazione attraverso l’acqua29.
Dark earth, rifiuti urbani e uso delle acque a Napoli tra X e XII secolo 441
26. Il bagno del monastero di Santa Chiara è di fondamentale importanza per questo ge-nere di studi poiché le testimonianze archeologiche permettono di ricostruirne la storia inin-terrottamente dalla tarda antichità fino alla fine del medioevo. De Franciscis (1954), pp.277-283; Arthur (1999), pp. 135-146.
27. Le diaconie erano degli istituti di origine orientale a carattere monastico, largamen-te diffuse nell’impero bizantino e attestate sporadicamente anche nell’Italia sotto domina-zione greca. Lestocquoy (1930), pp. 261-295; Cilento (1967), pp. 641-735; Bertolini(1947), pp. 1-145.
28. Vitolo (1982), pp. 42-54.29. Morcaldi (1873-1893), II, pp. 344, 174; Vitolo (1982), pp. 43-44. Il rapporto tra ac-
qua e sfera sacra è stato efficacemente indagato in alcuni recenti studi: Orselli (2008), p.1323; Paroli (2008), p. 1237; Falla Castelfranchi (2008), p. 1173.
Con la corruzione del sistema igienico improntato sui bagni di tradizionetardo antica, si assistette a una frammentazione e particolarizzazione di questogenere di servizi. I bagni riforniti dalle acque correnti diminuirono di numeroe si localizzarono principalmente ai margini della città (soprattutto nel settoreorientale), presso le poche fontane ancora alimentate dall’acquedotto pubblico.Gli altri servizi, posti specialmente nei quartieri centrali di Napoli, si avvalse-ro di risorse idriche alternative: l’uso di pozzi e di acque piovane, raccolte nel-le piscine private, divenne fondamentale. Nei secoli pienomedievali, dunque,si assistette al moltiplicarsi delle fonti di attingimento idrico; allo stesso modosi pluralizzò anche il metodo di offerta dei servizi igienici. Nell’alto medioevoè possibile individuare un sistema di bagni per lo più pubblico, improntato suiservizi di tradizione antica e sulle diaconie messe a disposizione dagli istitutiecclesiastici. Successivamente si affiancarono infrastrutture alternative: bagniesclusivamente privati da una parte, e bagni pubblici detenuti e amministratida privati cittadini dall’altra.
I bagni privati corrispondevano generalmente a una tipologia piuttosto dif-fusa nell’intero complesso cittadino. Un gruppo di edifici abitati aveva a di-sposizione uno spazio in comune, la corte, ove era presente un piccolo luogochiuso, un pozzo e/o una piscina di raccolte delle acque30. Spesso si ha notiziadi forni capaci di riscaldare determinate quantità d’acqua, e magari lo stessopiccolo locale al chiuso. Questa è l’immagine d’insieme di un bagno privatoad uso di una o poche famiglie. Un’immagine alternativa di bagno cittadino ciè data da un documento degli ultimi anni del ducato31:
«Instrumentum […] qui dicitur offertionis cuiusdam balnei, quem offeruit a dicto mo-nasterio et conventum Iohannes, humilis abbas monasteri ipsius Sancti Severini, posi-tum vero intus hanc civitatem Neapolis, […] et est suptus illis domibus et habitationi-bus dicti monasterii. Fines vero dicti balnei sunt hii: a duabus partibus sunt vie pupliceunde habet introitum, a tertia et quarta parte sunt domibus dicti monasterii et alios con-fines».
Il bagno in questione dunque non si trova in una corte privata, come avvie-ne per le altre strutture menzionate nei documenti: si affaccia direttamente sul-la strada pubblica su due lati ed è posto al piano terreno di un edificio. È daprecisare il fatto che in questo caso si sia in presenza di un bagno di un entereligioso, mentre in altri casi si tratta di bagni di proprietà di laici. Non è pos-sibile affermare con certezza che la tipologia del bagno situato nella corte pri-vata sia quella maggiormente in uso per i privati cittadini, mentre il bagno aipiani inferiori degli edifici rispecchi soprattutto una tipologia preferita dagli
442 L. Carriero
30. Talvolta si ha notizia di un vero e proprio sistema di grondaie che convogliava daitetti delle case l’acqua piovana direttamente nelle piscine.
31. Pilone (1999), I, 27, pp. 271-272. I bagni sembrano essere talmente diffusi all’inter-no della città che sono attestati nelle fonti in diversi quartieri e realizzati con divese solu-zioni architettoniche, a seconda dello spazio a disposizione.
enti religiosi; tuttavia si può supporre che differenti generi di esigenze sfocias-sero anche in diverse soluzioni costruttive32.
Il binomio bagno-piscina sembra imprescindibile: nei documenti dei secoliX-XII appaiono numerosi riferimenti a questo genere di strutture anche in am-bito rurale. Nel 962 Pietro, figlio di Stauracio Farricelli, in seguito alla deci-sione di farsi monaco, fa richiesta di essere accolto nel monastero dei SantiTeodoro e Sebastiano. In cambio della sua accettazione da parte dell’igumenooffre una terra: «que vocatur ad illa balnearia, […] una cum ipsa balnearia etcum ipsa pischina, que in ipsa balnearia videtur».
La terra si chiama balnearia poiché è presente un bagno e al bagno è colle-gata una piscina. La terra offerta confina inoltre da un lato con un orto già inpossesso del monastero, ove è presente un’altra piscina. Non è improbabileche tutt’intorno vi fossero altre strutture idriche di questo genere e magari unaltro bagno. È interessante inoltre notare come il bagno di cui si parla nel do-cumento, prima naturalmente che venga dato al monastero, fosse stato esclusi-vamente privato: infatti il monaco in fieri Pietro, per disporre del bene, devechiedere il consenso alla cognata Eupraxia. Si apprende dunque che il bagnoera di proprietà comune tra le famiglie di due fratelli33.
Come abbiamo visto, dunque, i bagni privati erano molto spesso in comu-nione tra membri della stessa famiglia, che condividevano l’abitazione o piùspesso abitavano in una serie di case adiacenti. Il modello del bagno costruitonella corte in comune tra alcuni edifici abitati trova conferma in un documentocittadino del 98434. Giovanni, figlio di Pietro Mundulo, assicura l’ingresso allerispettive case dei fratelli Naupigi attraverso la terra di sua proprietà «que estconiuncta cum balneo dicti Iohannes prope monasterium Ss. Marcellini et Pe-tri […] et iuxta sinagogam Hebreorum». I fratelli Naupigi sono cinque e sonocoloro che hanno venduto a Pietro Mundulo la terra con il bagno, passato così
Dark earth, rifiuti urbani e uso delle acque a Napoli tra X e XII secolo 443
32. Riguardo a ciò è da sottolineare la complessa articolazione sociale che emerge dalladocumentazione napoletana. Questo fatto si rifletterebbe con evidenza anche nelle struttureed infrastrutture urbane. A diversi modelli costruttivi corrisponderebbe, in parte, una effet-tiva varietà sociale. Sulla complessità sociale di Napoli e del Mezzogiorno nel XII secolo:Wickham (2004), pp. 12-26; Vitolo (1990), pp. 29-46; Fuiano (1967), pp. 440-448; Galasso(1995), pp. 77-97.
33. Da notare come Eupraxia esercitasse lo stesso tipo di diritti del cognato. Riguardo alpeso delle donne nelle società dell’Italia meridionale dell’XI-XII secolo: Skinner (2004),pp. 119-133. La presenza di bagni in condivisione tra diversi membri dell’aristocrazia loca-le è attestata anche ad Amalfi: Squatriti (2008), pp. 597-618.
34. Capasso (1895), 243, p. 152: «Iohannes filius q. d. Petri Munduli promittit BonoNaupigio et Eupraxie seu Stephano, Sergio seu Petro Naupigiis germanis filiis q. LeonisNaupigii ex uno genitore et de singulis genitrice vid. Bonus et Eupraxia nati ex dicto Iohan-ne et una genitrice, et dicti Stephanus, Sergius et Petrus de alia genitrice et ipsa Eupraxiarelicta q. Domoli qui cognominabatur de Anurisculo, ex eo quod dicti germani dederunt ettradiderunt dicto Iohanni certam terram, que est coniuncta cum balneo dicti Iohannis propemonasterium Ss. Marcellini et Petri, que habet pro termino signum crucis signate in parietedomus de q. Gregorio, cui supranominatur de Altana et iuxta sinagogam Hebreorum; prop-terea promittit eis facultatem intrandi et egrediendi in eorum domum».
da cinque proprietari, appartenenti alla stessa famiglia, a un unico proprietario.Lo status di bagno privato non cambia, ma cambia il numero di famiglie chehanno il diritto di usufrutto. Si delinea dunque un’idea di struttura preferibil-mente esclusiva e qualora debba essere condivisa si preferisce farlo con mem-bri legati da vincoli familiari. Emergerebbero così alcuni elementi che farebbe-ro pensare a una società urbana attenta alle necessità igieniche in una manieradiversa e più articolata rispetto al passato, fatto che si spiegherebbe in manieraduplice: da una parte vi è la volontà di disporre di alcuni privilegi tipicamenteelitari, una sorta di affermazione del proprio status sociale; dall’altra è possibi-le ipotizzare che in una società urbana complessa maturi un’esigenza di igienepiù spiccata. I bagni pubblici dunque non corrispondono più alle esigenze av-vertite dalle aristocrazie cittadine. Si afferma così un’idea complessiva di igie-ne privata, qualora se ne abbia la possibilità35.
In quest’ottica è anche possibile concepire diversamente la diminuzione delnumero di bagni pubblici, oltreché la loro stessa funzione. Certamente l’istitu-zione del bagno collettivo subì un ridimensionamento a causa della progressi-va corruzione del sistema idrico pubblico che lo alimentava; ma allo stessomodo non si deve escludere un contesto sociale mutato. Cambiava dunque lostesso modello da perseguire, non solo nella mentalità delle famiglie più ab-bienti, ma nel complesso della cittadinanza36.
Un luogo come il bagno, per i canoni abitativi dell’epoca, era ritenuto indi-spensabile non solo in città, ma anche in ambito rurale: è il gennaio del 1016 eStefano Levorano, abitante del loco qui vocatur Arinianum foris Flubeum,promette all’igumeno del monastero dei Santi Sergio e Bacco di corrispondereuna serie di beni in cambio di una terra37. Di contro il religioso gli concede lalicenza di costruire una piscina e un forno qualora avesse intenzione di abitarein quella terra, dove era probabilmente posta una casa. È interessante notarecome il testo sia esplicito al riguardo: «etiam si ipse Stephanus ibidem habita-re voluerint, et piscina aut furnum facere licentiam habeat».
L’accostamento di una struttura idrica al forno è da considerarsi contestua-le alla costruzione del bagno: sono molti i documenti che testimoniano i lega-mi tra questi impianti38. In un documento della metà dell’XI secolo, con l’e-
444 L. Carriero
35. L’idea di un’acqua inquietante e la fine, nel medioevo, della percezione del bagnocome un piacere per il corpo – Vigarello (1985), pp. 15-48 – è un’idea non valida per que-st’area geografica a quest’altezza cronologica. È piuttosto da ricondursi allo scorcio del me-dioevo, in seguito al terrore del contagio suscitato dal dilagare della peste, come sostegonoAndreolli, Squatriti (2008), pp. 622-624.
36. Il bagno non è una prerogativa degli strati ecclesiastici della società: l’esigenza diquesto genere di servizi è decisamente più diffusa. A questo proposito si rimanda ai se-guenti studi: Delogu (1977); DeLaine, Johnson (2000); Magdalino (1990), pp. 167-182;Squatriti (1998), pp. 17-25; Casartelli Novelli (2008), pp. 931-1028.
37. Capasso (1895), 358, pp. 222-223. Il documento, sebbene abbia per oggetto dei benidi ambito rurale, utilizza lo stesso formulario già visto in città per i beni riguardanti le in-frastrutture idriche (in particolare quelle legate alla costruzione dei bagni).
38. Pilone (1999), I, 177, pp. 398-400. La possibilità di riscaldare l’acqua è largamenteattestata per centri urbani come Gaeta, Benevento, Pavia, Lucca e Roma, tuttavia anche mo-
lencazione dei diversi beni venduti insieme a un fondo extra-urbano, si dice:«furnum et balneum insimul fabritum et cum puteo aque vibe»39. Il bagno ne-cessitava di una riserva idrica da cui attingere acqua in abbondanza (una pisci-na o un pozzo) e di una struttura capace di riscaldare il locale e l’acqua stessa.In città abbiamo visto, oltre a bagni ad uso di un’unica famiglia, strutture incomunione tra un ristretto numero di persone. In ambito rurale invece i bagni,per ovvi motivi dettati dalla rarefazione degli abitati, sembrano utilizzati da unsolo nucleo. Ciò che emerge dunque da un quadro di questo genere è che l’esi-genza di poter disporre di tali strutture andava oltre il semplice possesso di unbene di prestigio sociale cittadino: il bagno era legato a una diffusa sensibilitàigienica40. In città coloro che non potevano disporre di bagni privati, come lefamiglie più abbienti, usufruivano di quelli delle diaconie o di altre strutturesemi-pubbliche, che vedremo presto nel dettaglio; in ambito rurale, invece, lefamiglie si industriavano per costruire poche ma essenziali infrastrutture, capa-ci di assicurare l’accesso a servizi igienici fondamentali.
Ma veniamo alle strutture che abbiamo definito semi-pubbliche: si trattasostanzialmente di bagni privati aperti al pubblico dietro compenso. In un do-cumento del 983 Drosu, badessa del monastero dei Santi Marcellino e Pietro,prese accordi con tale Giovanni figlio di Pietro monaco e con sua moglieAnna, gloriosa femina, dando loro un luogo per la costruzione di un bagno,che, in caso di mancanza di eredi, sarebbe tornato al monastero41. Il documen-to in questione si rivela interessante per la singolarità delle informazioni con-tenute. Le monache contrattano minuziosamente le modalità per utilizzare ilbagno: esse hanno licenza di usufruirne una volta al mese, mentre ai coniugispetta il compito di fornire loro acqua e tutto il resto in abbondanza e gratuita-mente. Nessun’altra persona deve essere presente nel momento in cui le mona-che sono al bagno42. Il fatto che si ribadisca più volte la gratuità di utilizzo del
Dark earth, rifiuti urbani e uso delle acque a Napoli tra X e XII secolo 445
nasteri minori localizzati in aperta campagna «fornivano ai loro occupanti servizi e struttu-re termali non molto dissimili» da quelle presenti in città: Squatriti (2008), p. 597. L’acquaera riscaldata anche nei bagni della Spagna: Martín-Bueno, Reklaityte (2008), pp. 219-228.
39. Capasso (1895), 474, pp. 290-291.40. Capasso (1895), 123, p. 90. La notizia di bagni extra-urbani risulta certamente
straordinaria. Tuttavia bisogna considerare che diversi loci e vici rurali nel corso dell’XI eXII secolo si tramutarono in veri e propri centri abitati. Questi centri, seppure di dimensio-ni ridotte, erano spesso crocevia di interessi economici importanti. Nel Principato di Saler-no è stato individuato perfino un piccolo vicus (qui Amalphitanorum vocant) sede di un em-porio fluviale: Pucci (2004), p. 282.
41. Capasso (1895), 241, pp. 150-151. È evidente che l’esigenza di bagni era diffusa benoltre gli strati sociali legati al clero, coinvolgendo per lo meno le classi più abbienti, comegià dimostrato da Paul Magdalino nello studio sull’accesso ai servizi idrici nella Costantino-poli medievale: il caso di Napoli risulta essere esemplare proprio in questo ambito di intera-zione tra chiese e monasteri e privati per la costruzione di bagni. Magdalino (1990), p. 167.
42. Il bagno era regolamentato in maniera quasi ossessiva dalle regole monastiche: po-teva costituire infatti una tentazione di carattere sessuale. Prima la regola di San Benedetto,poi i Capitolari carolingi – Boretius (1883), I, p. 344 – e numerose altre normative limita-vano la libertà, da parte dei monaci e delle monache, di potersi recare autonomamente aibagni: Squatriti (2008), pp. 600-601.
bagno indica di per sé che ciò non doveva essere una cosa comune. Sembre-rebbe che in questo documento si parli proprio di un bagno aperto al pubblico.Non è un caso che riguardo all’attività e agli interessi dei due coniugi ci siesprima con la seguente formula: «pro stationes sua». Stationes è il vocabolonormalmente utilizzato per indicare proprio un esercizio commerciale e pub-blico. Si capisce meglio dunque anche la postilla che prevede l’assoluta solitu-dine delle monache durante la loro permanenza al bagno: evidentemente in unbagno «pubblico» la presenza di altri clienti avrebbe compromesso la virtùdelle sorelle43. A Napoli era presente una capillare rete di bagni privati e aquesti si affiancavano una serie di esercizi commerciali in grado di soddisfareuna domanda molto diffusa. È lecito supporre che dietro queste attività ci fos-sero interessi economici di non piccola entità44.
Latrine private e condominiali
Non è inverosimile supporre che a Napoli, all’altezza dei secoli X-XII, sifosse creata e consolidata una struttura molto capillare di latrine private (posti-cium e monimen). Questo genere di servizi era evidentemente di piccole di-mensioni e ad uso prettamente privato, legato a un’unica famiglia o a volte aun ristretto numero di famiglie. Come succedeva per i bagni, le strutture eranoimperniate sugli spazi privati delle corti, luoghi aperti e in comune tra alcuniedifici adiacenti, dotate di un ambiente chiuso e solitamente di una riservad’acqua, che poteva essere un pozzo o più spesso una pischina.
La documentazione napoletana del X-XII secolo sembra delineare un siste-ma di latrine private del tutto analogo a quello rinvenuto negli scavi archeolo-gici per le epoche precedenti45. Jansen ipotizza un sistema di smaltimento del-le urine basato sostanzialmente su pozzi neri e fogne. Non è inverosimile, inol-tre, che le urine concentrate nei pozzi neri delle corti private fossero commer-ciate per la tintura dei panni: sono numerose le iscrizioni di epoca romana cheattestano questo genere di traffici46. A Napoli, città conosciuta in tutto il Medi-
446 L. Carriero
43. Nella Spagna musulmana, cristiana ed ebrea alcuni bagni (sia nelle città sotto domi-nio musulmano, sia in quelle sotto il dominio cristiano) davano la possibilità a uomini edonne di recarsi contemporaneamente a fare il bagno: Martín-Bueno, Reklaityte (2008), p.226.
44. La presenza di bagni collettivi nel corso del medioevo è sostenuta da molti studiosianche per l’Occidente latino: Caskey (1999), pp. 170-195; Coates-Stevens (2002), pp. 135-153; Feniello (2002), pp. 72-81; Squatriti (1998), pp. 11-21, 44-48.
45. Jansen (2000), pp. 37-49. L’uso dei pozzi neri e delle fogne per lo smaltimento del-le urine è attestato diffusamente fin dall’epoca romana e i documenti medievali napoletaniconfermerebbero questa prassi. La permanenza di parte delle infrastrutture urbane antiche èoggetto di numerosi studi e scavi archeologici che interessano l’intera Penisola: Francovich,Noyé (1994); Augenti (1994), pp. 659-691; (1996).
46. Koloski-Ostrow (1996), pp. 79-86. Napoli è famosa in tutto il mondo arabo e medi-terraneo per i suoi capi di lino: in città sono presenti numerose strutture destinate alla lavo-razione dei panni (fusaria et aquaria).
terraneo per il lino, la tintura dei panni costituiva una fonte di ricchezza di unacerta consistenza. Potrebbe non essere un caso inoltre il fatto che i fusaria etaquaria fossero posti proprio in adiacenza dello scarico in mare della cloacamassima.
Nel centrale vicus S. Georgii in Diaconia, in un documento del 24 marzo990, Leone Ferrario vende a Palumbo vicedomino un piano terreno di unacasa, che «ha parte meridiana coheret introitum, in quo est posticum et regiassuas»47. Il termine posticum, nel latino classico, ha come primi significati quel-lo di latrina. Un documento dell’epoca dell’imperatore Basilio II (976-1025) sirivela estremamente interessante per capire come avveniva lo smaltimento deirifiuti umani48.
Instrumentum unum curialiscum scriptum, factum in tempore dominum Basilium ma-gno imperatore, continente quomodo fuit quedam q[uesti]o inter Petrum, filium quon-dam dompni Petri Buccapiczola, ex una parte et monasterium Sanctorum Severini deduo foramina que stabant in uno pariete, unde de uno de ipsius foramine gectabantstercus et ab alio erat aquario posito vero in regione Portanobense; unde devenerunt adconcordiam, ad cautelam dicti monasterii, ut ipsi foramina claudere debeant, et in dic-to pariete non debeat esse nec tres cancellas que ipso muro est iuxta parte orientis.
Pietro, figlio del fu Pietro Buccapiczola, aveva dunque la cattiva abitudinedi gettare i propri escrementi da buchi praticati nel muro della casa. Se ipotiz-ziamo che la casa di Pietro fosse più o meno simile a tante altre case del con-testo urbano napoletano, allora dobbiamo immaginare un appartamento al pri-mo piano, probabilmente affacciato su una corte interna in comune con altriedifici, dove risulta essere un contenitore d’acqua (aquarium), probabilmenteil corrispondente delle pischinae già viste in altri documenti. Possiamo capireche un’azione di tal genere fosse mal vista da chi condivideva con Pietro lacorte e probabilmente la piscina, non solo perché poteva contaminare le acque,ma anche perché, sporcando lo spazio in comune, Pietro si avvaleva di un di-ritto non suo. È assai probabile che Pietro non possedesse nella propria casauna latrina49, come invece è sicuro per altre case, mentre i vicini, visto che eb-bero una disputa con lui a causa del suo comportamento, o possedevano unacasa munita di latrina oppure condividevano con altri una latrina usata da piùfamiglie, probabilmente posta in una corte, magari la stessa del documento.
Dark earth, rifiuti urbani e uso delle acque a Napoli tra X e XII secolo 447
47. Capasso (1895), 265, pp. 164-165.48. Pilone (1999), 822, pp. 890-891. Questo documento non è da ritenersi come esem-
pio di un ordinario sistema di smaltimento degli escrementi: prova ne sia il fatto che taleabitudine provoca una forte reazione da parte di tutto il vicinato e il pubblico giudizio ob-bliga il protagonista a cambiare il suo comportamento.
49. Le testimonianze di abitatazioni dotate di latrine ad uso esclusivo sono poche – unaltro caso ci è dato da Capasso (1895), 60, p. 54 –, tuttavia attestano un forte interesse perquesto genere di servizi. Inoltre la latrina privata sembra delineare uno status sociale parti-colarmente elevato e si prospetta come un requisito necessario per uno standard abitativoeccellente. Assai più diffuse sono invece le latrine comunitarie, spesso ad uso di pochi nu-clei familiari (non di rado in parentela tra di loro).
È possibile dunque immaginare un apparato di smaltimento dei rifiutiumani basato su due tipi di raccolta: uno privato e uno comunitario. Il primogravitante su latrine proprie di ogni singola casa, il secondo basato su latrinein comune tra più famiglie, per lo più ubicate in corti in comune tra più edifi-ci. Dai documenti non appare come questi rifiuti venissero poi smaltiti, tutta-via è probabile che il sistema si basasse sui pozzi neri. È così possibile rileg-gere anche la funzione delle pischinae, che abbiamo ipotizzato essere dellepiccole riserve di acqua. Infatti oltre a svolgere una funzione di rifornimentoidrico per le attività domestiche quotidiane (pulizia dei panni, abbeveraggiodegli animali ecc.) non è da escludere che avessero un ruolo determinantenell’igiene personale. Troviamo infatti le pischinae in gran parte delle corti:se ipotizziamo che una parte di queste corti fosse destinata a ospitare latrinecomuni, allora non possiamo escludere che le stesse piscine facessero parteintegrante, insieme ai bagni e alle latrine, di un sistema di igiene pubblica ca-pillarmente diffuso.
In un documento del 932 troviamo la permuta di un posticium50: questo sitrova in una curte maiore comunale e viene ceduto insieme con il diritto di«ingredere et egredere die noctuque, quandocunque voluerint». È interessantenotare come, in un contratto pubblico, rientri anche la postilla di un completousufrutto della struttura anche per esigenze improvvise e notturne. Dai docu-menti emerge dunque un elemento cittadino fondamentale non solo per com-prendere l’urbanistica della Napoli pienomedievale, ma anche per capire unacittà viva e assolutamente attenta a ogni minimo aspetto della vita quotidiana.La qualità della vita urbana era legata a standard igienici, di convivenza e diaccesso a un determinato genere di strutture che influenzavano fortemente l’in-sediamento o meno di un certo gruppo di persone in una zona capace di assi-curare questi servizi. La società e il tessuto urbano che emergono dall’analisiattenta dei documenti sono tutt’altro che piatti e semplificati. Una società incontinuo fermento con una popolazione che tende a sempre migliori posizionisi inserisce in un quadro urbanistico in evoluzione e capace di soddisfare pro-gressivamente le esigenze mutevoli dei vari cittadini, che sono disposti a ven-dere, comprare, litigare e accordarsi: il tutto per conseguire migliori standardsociali, abitativi e di lavoro51.
Il primo aprile 947, un edificio viene integralmente venduto da Pietro Fer-rario a Stefano figlio di Bono. Il documento pare non avere particolarità rispet-to ad altri, e rientrare nell’ordinarietà che caratterizza questo genere di contrat-ti. Tuttavia un termine desta non poca attenzione: monimen. Bartolomeo Ca-passo si sofferma a lungo per chiarirne il significato: alla fine giunge alla con-
448 L. Carriero
50. Capasso (1895), 19, p. 29. Posticum, in latino classico, ha come significato quello di«parte posteriore» oppure di «porta posteriore», per traslato significa anche «latrina» (laparte dell’edificio che sta sul retro). Posticium nell’accezione di latrina appare numerosevolte nelle fonti napoletane: Capasso (1895), 265, pp. 164-165.
51. In un quadro del genere allora lo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi assume unparticolare significato: è imprescindibile dai bisogni maturati in questo genere di società edin questo genere di città.
clusione che si trattasse di una latrina52. Se fosse vero che la casa in questionefosse stata accessoriata di una latrina, allora sarebbe da ripensare un po’ tuttal’urbanistica della città. Dai documenti appare una città caratterizzata da ampispazi vuoti, intervallati da edifici e corti. Finora questo assetto urbanistico si ègiustificato con la «ruralizzazione» delle città, causata dalla decadenza socialeed economica generalizzata. Gli stessi spazi vuoti, recentemente, con ipotesimeno pessimistiche, sono stati ripensati come aree adibite ad orti e attivitàagricole integrative. Finora tuttavia in nessuna delle ipotesi prospettate si è pre-so in considerazione un aspetto tanto fondamentale della vita cittadina, che aragione possiamo pensare di impatto urbanistico fortissimo: la capillare diffu-sione di piccole strutture igieniche quali bagni e latrine. I documenti sembre-rebbero infatti dimostrare che spazi vuoti, macerie, corti e orti urbani fosseroutilizzati per usi igienici in senso lato e non per fini agricoli, come si è semprepensato53. Se si considera l’esigenza fondamentale di servizi igienici nella quo-tidianità di ogni singola persona, allora si comprende l’ipotesi di un’urbanisti-ca alternativa, in cui i terreni liberi sono adibiti a latrine e bagni. Non è un casoche negli esempi riportati da Capasso per giustificare la sua ipotesi di spiega-zione di monimen, vi sia una clausola del contratto che vieta esplicitamente ditrasformare in latrina la corte permutata, posta in pieno centro cittadino e con-finante con alcune case e con il dormitorio di un monastero. Questo sembre-rebbe attestare una pratica piuttosto comune che, per l’impatto stesso dellacosa, non si può certo supporre costituisca una novità in ambito cittadino. Inconsiderazione di ciò dunque si potrebbero rileggere alcuni dati archeologicisotto una luce diversa. Parte delle zone cittadine abbandonate nei secoli alto-medievali (Verona, Brescia e Bergamo sono dal punto di vista archeologico icentri meglio studiati)54 potrebbero dunque essere interpretate, almeno per ilcaso di Napoli, non come semplici discariche, ma come un sistema di latrine55.
Dark earth, rifiuti urbani e uso delle acque a Napoli tra X e XII secolo 449
52. Capasso (1895), 60, p. 54: «quid heic sibi velit vox munimen ex sequentibus docu-mentis erui potest; quorum primum, quamvis imperatorum byzantinorum notas chronologi-cas non habeat, tamen ad haec tempora, uti ex collatione cum superiori adfirmare licet, pro-cul dubio spectat. Illud breviatum est huiusmodi. – “Die 12 m. augusti ind. VIII. Neapoli.Eustratius Ferrarius, cui supranomen Cicinum […]” Regii Neapolitani Archivii Monumenta,tomo VI, p. 214. – Alterum documentum, quod vocabulum clarius explicat, item breviatumsic se habet: “A. 1334 Neapoli. Landolfus cognomento de Arco, filius d. Nicolai de Arco”Notam. Instrum. S. Gregorii n. 616 – Privasa, vox neapolitane dialectus, latrinam signifi-cat». I due documenti riportati dal Capasso (qui è trascritto solo l’incipit) non lasciano dub-bi sul reale significato del termine monimen nelle fonti napoletane: latrina.
53. In quest’ottica si deve rileggere la tesi di Arthur (1991), p. 768 che interpretava il ri-trovamento delle dark earth come il segno di una diffusa ruralità all’interno del perimetromurario. Gli orti urbani sono certamente presenti ed in gran numero, ma probabilmente unaparte degli spazi vuoti (terrae vacuae) veniva sfruttato per ospitare le latrine.
54. La città di Brescia è assurta a modello per gli studiosi sostenitori della sostanziale di-scontinuità urbana tra antichità e medioevo; la città di Verona invece rappresenta, secondo i«continuisti», un efficace esempio di continuità con il passato e di lento ma progressivo rias-setto urbanistico. Brogiolo (1984); Brogiolo, Gelichi (1998); La Rocca (1986), pp. 31-78.
55. Tra i documenti del ducato del X secolo, solo una piccola percentuale (che si aggi-
Immondizie e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Un altro aspetto di grande interesse che emerge dall’analisi dei documentinapoletani del X-XII secolo riguarda lo smaltimento dei rifiuti solidi. In qualemodo in una grande città medievale si smaltissero le immondizie rimane anco-ra, in gran parte, una questione aperta. Preliminarmente è da considerarsi l’e-strema importanza del problema: una città di circa ventimila abitanti (con nu-merose botteghe artigianali e ricca di esercizi commerciali e attività portuali)doveva produrre giornalmente quantità di rifiuti non piccole56. Una ulterioreconsiderazione riguarda la qualità, oltre che la quantità, dei rifiuti quotidiana-mente prodotti. Non a caso, nelle riflessioni in materia di rifiuti riguardanti lacittà antica (Roma in particolare) si è coniata la dizione di città self-cleaning57.Non è superfluo infatti sottolineare come la città pre-industriale producesseuna quantità di rifiuti enormemente minore: in un congresso di archeologia ro-mana tenutosi nel 1996 a Roma, Emilio Rodríguez-Almeida fa notare comequelli che oggi sono i rifiuti più ingombranti e recano maggiori problemi dismaltimento, nella città antica fossero semplicemente riutilizzati. È questo ilcaso delle macerie edilizie, dei metalli, del legno, dei contenitori ceramicicommerciali, del vetro e dei rifiuti organici: tutti questi elementi, oggi ritenutiqualitativamente dei rifiuti, in passato erano parte integrante di una economiadel riutilizzo58. Se si escludono dunque dalla categoria di immondizie tuttequeste cose, allora risulterà più semplice capire come i reali scarti da smaltire,nella città antica come in quella medievale, fossero stati un numero ben mino-re rispetto a oggi. Naturalmente l’idea di una città autopulentesi è una provo-cazione. Tuttavia, a parere unanime degli studiosi, prima di affrontare questogenere di problemi è bene tenere presente queste premesse.
Le ipotesi circa lo smaltimento dei rifiuti sono diverse: una parte dei rifiuti,anche solidi, probabilmente finiva nelle fogne cittadine (che abbiamo comun-que visto pienamente in funzione per Napoli). È probabile che un’altra fossedepositata in buche poste nelle corti private o trasportati in zone della città par-ticolarmente degradate. Una porzione dei rifiuti solidi inoltre veniva accumula-ta lungo le strade cittadine, nei pressi delle abitazioni59. La cosa sorprendenteè che, secondo l’indagine archeologica condotta per alcune città del nord Ita-
450 L. Carriero
ra intorno al 7%) menziona esplicitamente degli orti coltivati. Gli spazi vuoti all’internodella città non sembrano essere principalmente adibiti a questo genere di attività.
56. La stima della popolazione di Napoli nel corso dell’alto medioevo è stata ricavataalla luce dei dati archeologici condotti nelle recenti campagne di scavo: Arthur (1986), pp.515-523; Arthur (1991), pp. 759-784; Arthur (2002).
57. La definizione di città «autopulentesi» o self-cleaning è di Rodríguez-Almeida(2000), pp. 123-127, e risulta estremamente efficace per comprendere appieno le dinamichedi riutilizzo e riciclaggio in uso nel corso dei secoli, a partire dall’antichità.
58. Un efficace esempio di riutilizzo di edifici romani, riadattati ad abitazioni private, èemerso dagli scavi del sito di Carminiello ai Mannesi Arthur (1994), dove almeno tre stan-ze dell’insula romana nell’VIII secolo furono provviste di porte che davano sulla stradaparzialmente ostruita dalle rovine dell’insula stessa.
59. Jansen (2000), pp. 37-38.
lia, nel periodo altomedievale (sicuramente per i primi secoli) doveva esserepresente in città «un sistema di raccolta e trasferimento extra-urbe dei rifiuti,insieme a forme organizzate di riciclaggio»60. L’elemento del riciclo e dellaconcentrazione extra-urbana delle immondizie organizzata dai privati del quar-tiere è ipotizzata anche per i periodi precedenti61. In un breve saggio di NatalioFernández Marcos viene analizzata la corrispondenza della mitica Gehenna (lavalle nei dintorni di Gerusalemme, luogo di dannazione nella letteratura anti-ca) con la cavità naturale in cui venivano accumulate le immondizie e le car-casse degli animali62.
Anche Napoli è caratterizzata da una geografia del suolo piuttosto adattaalla raccolta dei rifiuti in luoghi concentrati. La presenza di numerose cavitàsotterranee e di valli e alture negli immediati dintorni del circuito murario, ol-tre che del fossato (carbonarius), non costituisce di per sé una prova dell’ac-cumulo dei rifiuti in area extra-urbana, sebbene già nel XIX secolo Bartolo-meo Capasso ipotizzasse per il fossato pubblico una destinazione d’uso comepunto di raccolta delle immondizie63. Dall’indagine archeologica su Napolicondotta da Paul Arthur non sembrerebbe tuttavia emergere un sistema orga-nizzato di smaltimento, e proprio nella mancanza di un sistema pubblico diraccolta delle immondizie sarebbe da individuare una delle cause principalidella crescita del livello di calpestio del terreno64. Tuttavia l’innalzamento è ri-scontrabile solo e unicamente in poche parti della città: a detta dello stessoArthur a Napoli gran parte degli antichi edifici vennero utilizzati ancora persecoli dopo la caduta dell’Impero d’occidente.
A partire dal X secolo, le testimonianze scritte attestano una grande atten-zione dei cittadini per le questioni legate all’immondizia. Sembra dunque deli-nearsi una questione di gran lunga più complessa di quanto ipotizzato prece-dentemente. Le fonti scritte indurrebbero per lo meno a mitigare i risultati de-gli scavi archeologici: l’accumulo dei rifiuti davanti alla facciata e all’ingressodegli edifici è esplicitamente proibito. In un documento del 955, tra i vari ac-cordi tra due fratelli in merito alla divisione di un edificio, vi è un riferimentoesplicito proprio all’accumulo dell’immondizia (definita nel documento spur-citia) davanti all’ingresso delle abitazioni65. Allo stesso modo non è possibileaccumulare spazzatura nelle strade di proprietà condominiale66. Nel 1077 i fra-
Dark earth, rifiuti urbani e uso delle acque a Napoli tra X e XII secolo 451
60. Gelichi (2000), p. 17. Il trasferimento fuori città per Napoli era già stato ipotizzatoda Capasso (1895), p. 13 (nel XIX secolo) e individuava il carbonarius pubblico come luo-go di deposito delle immondizie. Sebbene non pensi che il fossato pubblico ospitasse i ri-fiuti, sono d’accordo con Capasso e Gelichi sull’idea generale del trasferimento extra-urbe.
61. Liebeschuetz (2000), p. 54.62. Lynch (1992), p. 44; Fernández Marcos (2000), pp. 3-11; Viale (1994), p. 24.63. Capasso (1895), pp. 12-13.64. Arthur (2002), p. 39.65. Capasso (1885), 84, pp. 68-69: «Set ipse Petrus ibidem habere debeat unam regiam
iustam, et ante ipsa regiam ipse Leo et heredes sui nullam sporcitia faciant per nullum mo-dum […] et ipse Petrus et heredes sui nullam sporcitiam faciant in memoratis sex unciis no-minati Leoni ex ipsa inferiora».
telli Giovanni e Maura Boccia si contendono in pubblico giudizio la proprietàdi una corte, in comune tra le loro abitazioni, dotata di una serie di infrastrut-ture atte alla lavorazione dei panni, del cibo e delle pelli67. Dal minuzioso ac-cordo tra i due emerge un importante riferimento all’accumulo della spazzatu-ra: da una parte questo è permesso all’interno della corte, dall’altra è categori-camente vietato davanti all’ingresso degli edifici68. Sembrerebbe dunque che lecorti fossero attrezzate a ricevere rifiuti (con quelle che abbiamo supposto es-sere buche nel terreno).
Il fatto che si faccia cenno a clausole di questo genere in diverse tipologiedi documenti (compravendite e permute), e non solo nelle liti giudiziarie, fapensare che questi riferimenti debbano essere stati considerati all’ordine delgiorno. Inoltre, l’utilizzo di identiche formule notarili sia per una semplicevendita che per la risoluzione di un conflitto testimonia come l’accumulo delleimmondizie sia regolato a priori da patti tra vicini. Sembrerebbe dunque emer-gere uno scenario paragonabile a quello ipotizzato da Wolf Liebeschuetz per lecittà romane dell’Anatolia, in cui la raccolta della spazzatura veniva organiz-zata sulla basi di accordi tra vicini, strutturati in gruppi di quartiere69.
Naturalmente non è possibile sostenere in maniera assoluta l’esistenza diquesto tipo di organizzazione per la Napoli del X secolo. Tuttavia quello che lefonti attestano inequivocabilmente è che in qualsiasi forma venisse condotto losmaltimento dei rifiuti, in città si doveva tenere conto del vicinato. Dunque sesi considera che in area urbana le zone abbandonate furono davvero poche eche era impossibile accumulare immondizia per le strade e negli spazi condo-miniali, allora si possono ipotizzare tre sistemi di accumulo e smaltimento deirifiuti, sulla scia dei recenti studi in materia condotti per la città tardoantica ealtomedievale70. Il primo si basava su una serie di buche private poste nelle
452 L. Carriero
66. Capasso (1885), 323, pp. 198-199: «qui nullatenus presummet ipse aut heredes suinec abeat licentiam aliquando tempore per ipse finestre et regia in ipsa trasenda communiqualibet spurcitia vel ante parata facere aut versare per nullum modum»; 435, pp. 272-273:«ut per ipsa domum sua nullas aquas decurrere aut versare in memoratum aheditor debeatnec ibidem ante parata qualivet spurcitiam».
67. Capasso (1885), 524, pp. 317-319: «Definimus nos […] de intentione que inter noshabuimus de integra curte communi in qua habet furnum astracavile commune et cum can-taru muratu pittulum tofignum commune»; «ego supradicta Maura honesta femina et haere-des mei licentiam habeamus quando voluerimus in suprad. Curte communi […] spanderepannos et victum et per tempore ibidem lavare buttas et ipsa buttas spandere siccare et tem-poniare quomodo meruerit»; «et super ipsum anditum et introitum commune qui est da in-tus supradicta porta commune nullo filatorium».
68. Capasso (1885), 524, pp. 317-319: «ego supradicta Maura honesta femina et haere-des mei licentiam habeamus quando voluerimus in suprad. Curte communi intrare aqua etexporcitia»; «et super ipsum anditum et introitum commune qui est da intus supradicta por-ta commune nulla […] sporcitia facere».
69. Liebeschuetz (2000), p. 54.70. Gelichi (2000), pp. 13-23. Il modello proposto da Gelichi per le città del nord Italia
è da ritenersi valido anche per il Mezogiorno. D’altronde questo modello si delinea comeuna costante in gran parte del mondo tardo-antico e medievale.
corti, che accoglievano probabilmente i rifiuti della quotidianità familiare. Ilsecondo verteva su un parziale utilizzo delle stesse fognature (almeno per i ri-fiuti meno ingombranti); il terzo infine si serviva di un sistema di concentra-mento della spazzatura nelle numerose cavità naturali presenti in ambito extraurbano, probabilmente organizzato dalle consorterie e dai singoli privati. Nonsi può non tenere presente che l’area extra-urbana era comunque alla portatatutti gli abitanti della città: se infatti consideriamo che certamente la cinta mu-raria di Napoli non superava i 5 km, allora si comprende come l’accumulo ex-tra-urbano dei rifiuti possa essere stato considerato completamente accessibi-le71. È probabile che i tre sistemi coesistessero e si integrassero con una diffu-sa attitudine al riciclo degli scarti a cui è stato accennato in precedenza.
Il mare, inoltre, costituirebbe teoricamente un luogo di smaltimento facil-mente accessibile e alla portata di tutti. Tuttavia, sebbene per i rifiuti liquidi(urine e scarti di lavorazione dei panni) vi sono prove documentarie che atte-stano il diretto scarico in mare mediante un complesso sistema di fogne e ca-nali, per quanto riguarda i rifiuti solidi non è possibile riscontrare ciò. La pre-senza del complesso portuale probabilmente rendeva impossibile la discaricain mare di oggetti ingombranti, che avrebbero compromesso le stesse attivitàportuali.
Conclusioni
Concludendo si può dunque sostenere che dalle fonti scritte napoletaneemergerebbe una società urbana, almeno a partire dal X secolo, particolarmen-te attenta alle questioni igieniche e a quella che potremmo definire la cura delcorpo (oltreché una società particolarmente attenta a utilizzare in positivo le ri-sorse derivate dall’uso dei rifiuti). Questo atteggiamento si trasformerebbe inun controllo, più o meno diretto, del sistema di smaltimento dei rifiuti e com-porterebbe la sopravvivenza di molte infrastrutture pubbliche (oltre che lacreazione di nuove, in mano ai privati). Il dato è di notevole interesse soprat-tutto se confrontato con i modelli che sono stati prodotti da una parte dell’ar-cheologia degli ultimi venti anni. Le fonti archeologiche, prodotte su Napoli,sono state in passato talvolta interpretate sulla scorta di paradigmi elaboratiper altre città (ad esempio quelle del nord Italia): recuperare il vecchio para-digma della bizantinità (già usato per le città dell’Esarcato e della Pentapoli)permetterebbe al contempo di conciliare fonti scritte e fonti materiali (in talu-ni casi apparentemente inconciliabili), e favorire una futura migliore compara-zione con le altre città bizantine d’Italia (soprattutto in relazione allo spaziourbano dell’Italia meridionale). L’eredità bizantina e la densità demografica(per quanto riguarda il caso di Napoli) condizionano inconfutabilmente model-li d’insediamento urbano, permanenza di infrastrutture e sviluppi della stessaeconomia cittadina.
Dark earth, rifiuti urbani e uso delle acque a Napoli tra X e XII secolo 453
71. Capasso (1895), pp. 229, 240-242; Kreutz (1991), p. 165.
Riferimenti bibliografici
Andreolli B. (1990), Il ruolo dell’orticoltura e della frutticoltura nelle campagne del-l’alto Medioevo, in L’ambiente vegetale nell’alto Medioevo. Atti (dal 30 marzo al5 aprile 1989), Spoleto, Cisam, pp. 175-220.
Angeletti L.R. (2008), Usi terapeutici delle acque nella trattatistica medica della tar-da antichità (secoli IV-VII d.C.), in L’acqua nei secoli altomedievali, (Spoleto2007), Spoleto, Cisam, pp. 821-864.
Arthur P. (1986), Archeologia urbana a Napoli; riflessioni sugli ultimi tre anni, in«Archeologia Medievale», XIII, pp. 515-523.
Arthur P. (1991), Naples: a case of urban survival in early medieval ages?, in «Mé-langes de l’Ecole Française de Rome. Moyen Age», 103, pp. 759-784.
Arthur P. (1999), The “Byzantine” baths at Santa Chiara, Neaples, in DeLaine J.,Johnston D.E. (eds.), Roman Baths and Bathing, Part 1: Bathing and Society, in«Journal of Roman Archaeology», XXXVII, pp. 135-146.
Arthur P. (2002), Naples, from Roman town to city-state: an archaeological perspecti-ve, London, British School at Rome.
Arthur P. (a cura di) (1994), Il complesso archeologico di Carminiello ai Mannesi. Na-poli (scavi 1983-1984), Lecce, Università di Lecce.
Augenti A. (1994), Il Palatino nell’alto medioevo, in Francovich R., Noyé G. (a curadi), La storia dell’alto medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce dell’archeologia.Convegno internazionale (Siena, 2-6 dicembre 1992), Firenze, All’Insegna del Gi-glio, pp. 659-691.
Augenti A. (1996), Il Palatino nel Medioevo. Archeologia e topografia (secoli VI-XIII), Roma, L’Erma.
Barthela S., Isendahld C. (2013), Urban gardens, agriculture, and water management:Sources of resilience for long-term food security in cities, in «Ecological Econo-mics», 86, pp. 224-234.
Belli Barsali I. (1973), La topografia di Lucca nei secoli VIII-XI, in Lucca e la Tuscianell’alto Medioevo. (Atti del 5 Congresso internazionale di Studi sull’alto Medioe-vo, Lucca, 3-7 ottobre 1971), Spoleto, Cisam, pp. 461-552.
Bertolini O. (1947), Per la storia delle diaconie romane nell’alto medioevo sino allafine del sec. VIII, in «Archivio della Società romana di Storia patria», 70, pp. 1-145.
Bognetti G.P. (1959), Problemi di metodo ed oggetti di studio nella storia delle cittàitaliane dell’alto medioevo, in Caratteri del secolo VII in Occidente. VI Settimanadi Studi sull’Alto medioevo (Spoleto 1958), Spoleto, Cisam, pp. 59-87.
Bognetti G.P. (1966), L’exceptor civitatis e il problema della continuità, in «Studi Me-dievali», III, pp. 1-39.
Bologna F. (1993), Momenti della cultura figurativa nella Campania medievale, in Pu-gliese Caratelli G. (a cura di), Storia e civiltà della Campania, il medioevo, Napo-li, Electa.
Boretius A. (a cura di) (1883), Capitularia Regum Francorum, I, LXXIV.6, Hannover,Monumenta Germaniae Historica.
Brogiolo G.P. (1984), Brescia. La città tra tarda antichità e altomedioevo: la crescitadella stratificazione, in Brogiolo G.P. (a cura di), Archeologia urbana in Lombar-dia, Modena, Panini.
Brogiolo G.P., Gelichi S. (1998), La città nell’alto medioevo italiano. Archeologia estoria, Roma-Bari, Laterza.
454 L. Carriero
Cagiano de Azevedo M. (1970), Gli edifici menzionati da Paolo Diacono nella “Hi-storia Langobardorum”, in Atti del Convegno di Studi Longobardi (Udine 1969),Udine, Deputazione di Storia Patria per il Friuli, pp. 73-89.
Cagiano de Azevedo M. (1974a), Esistono una architettura ed una urbanistica longo-barde?, in La civiltà dei Longobardi in Europa, Atti del Convegno, (Roma 1971),Roma, Accademia nazionale dei Lincei, pp. 1-41.
Cagiano de Azevedo M. (1974b), Aspetti urbanistici delle città altomedievali, in Topo-grafia urbana e vita cittadina nell’Alto Medioevo. XXI Settimana di Studi sull’AltoMedioevo (Spoleto 1973), Spoleto, Cisam, pp. 641-677.
Capasso B. (1895), Topografia della città di Napoli nell’XI secolo, Napoli, Forni.Capasso B. (a cura di) (1885), Monumenta ad Neapolitani Ducatus Historiam Perti-
nentia, III, Napoli, Esi.Carriero L. (2012), La città medievale: insediamento, economia e società nei docu-
menti napoletani del X secolo, Relaigh, Aonia.Carriero L. (2013), Sistemi urbani di approvvigionamento idrico pubblico e privato. Il
caso di Napoli nei secoli X-XII, in Medioevo in formazione. I giovani e il futurodella ricerca, Livorno, Debatte, pp. 49-57.
Carver M.O.H. (1993), Arguments in stone: archaeological research and the Euro-pean towns in the first millennium, Oxford, Oxford University Press.
Casartelli Novelli S. (2008), Il simbolo dell’acqua di vita, in L’acqua nei secoli alto-medievali, (Spoleto 2007), Spoleto, Cisam, pp. 931-1028.
Caskey J. (1999), Stealm and Sanitas in the Domestic Realm, in «Journal of the So-ciety of Architectural Historians», LVIII, pp. 170-195.
Chiodi G. (2008), Conflitti per l’uso delle acque nella Milano del XII secolo, in L’ac-qua nei secoli altomedievali, (Spoleto, 12 - 17 aprile 2007), Spoleto, Cisam, pp.505-582.
Cilento N. (1967), La chiesa di Napoli nell’alto medioevo, in Pontieri E. (a cura di),Storia di Napoli, Napoli, Esi, pp. 641-735.
Coates-Stevens R. (2002), Gli impianti ad acqua e la rete idrica urbana, in «Medede-lingen van het Nederlands Instituut te Rom», LX-LXI, pp. 135-153.
Cortese E. (1997), Il processo longobardo tra romanità e germanesimo, in La giustizianell’alto medioevo (secoli IX-XI). Settimane di studio Cisam, XLIV (Spoleto, 11-17aprile 1996), Spoleto, Cisam, pp. 621-647.
Davidson D.A. et al. (2006), The legacy of past urban waste disposal on local soils, in«Journal of Archaeological Science», 33, pp. 778-783.
De Franciscis A. (1954), Le recenti scoperte in Santa Chiara e la topografia di Napoliromana, in «Archeologia Classica»,VI, pp. 277-283.
DeLaine J., Johnson D.E. (eds.) (2000), Roman baths and bathing: proceedings of thefirst international conference on Roman baths held at Bath, England, 30 March - 4April 1992, Portsmouth, Journal of Roman Archaeology.
Delogu P. (1977), Mito di una città meridionale. (Salerno, secoli VIII-XI), Napoli, Li-guori.
Delogu P. (1997), La giustizia nell’Italia meridionale longobarda, in La giustizia nel-l’alto medioevo (secoli IX-XI). Settimane di studio Cisam, XLIV (Spoleto, 11-17aprile 1996), Spoleto, Cisam, pp. 257-308.
Devos Y. et al. (2011), Unravelling urban stratigraphy. The study of Brussels’ (Bel-gium) Dark Earth. An archaeopedological perspective, in «Medieval and ModernMatters», 2, pp. 51-76.
Falla Castelfranchi M. (2008), L’edificio battesimale: architettura, ritualità, sistemiidraulici, in L’acqua nei secoli altomedievali, (Spoleto 2007), Spoleto, Cisam, pp.1173-1236.
Dark earth, rifiuti urbani e uso delle acque a Napoli tra X e XII secolo 455
Feniello A. (2002), Un aspect du paysage napolitain au Moyen Age: les bains dans laville du Xe au XIIe siècle, in «Médiévales», XLIII, pp. 72-81.
Feniello A. (2011), Napoli. Società ed economia (902-1137), Roma, Isime.Feniello A. (2012), Poteri pubblici nei ducati tirrenici, in Martin J.-M., Peters-Custot
A., Prigent V. (a cura di), L’héritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècle), II, Lescadres juridiques et sociaux et les institutions publiques, Roma, École Française deRome, pp. 325-342.
Fernández Marcos N. (2000), La Gehena de Jerusalén: geografía histórica y geografíamítica, in Sordes urbis. La eliminacíon de residuos en la ciudad romana. Actas dela reunión de Roma (15-16 de noviembre de 1996), Roma, L’Erma, pp. 3-11.
Francovich R., Noyé G. (a cura di) (1994), La storia dell’alto medioevo italiano (VI-Xsecolo) alla luce dell’archeologia. Convegno internazionale (Siena, 2-6 dicembre1992), Firenze, All’Insegna del Giglio.
Fuiano M. (1967), Napoli normanna e sveva, in Pontieri E. (a cura di), Storia di Napo-li, Napoli, Esi, pp. 411-518.
Galasso G. (1995), L’eredità municipale del ducato di Napoli, in «Mélanges de l’Eco-le française de Rome. Moyen age», 107, pp. 77-97.
Gelichi S. (2000), L’eliminazione dei rifiuti nelle città romane del Nord Italia tra Anti-chità e Alto Medioevo, in Sordes urbis. La eliminacíon de residuos en la ciudad ro-mana. Actas de la reunión de Roma (15-16 de noviembre de 1996), Roma, L’Erma,pp. 13-23.
Gelichi S. (a cura di) (1992), Igiene e smaltimento dei rifiuti, in Ferrara prima e dopoil Castello: testimonianze archeologiche per la storia della città, Ferrara, SpazioLibri, pp. 66-98.
Halsall G. (1995), Settlement and social organization. The Merovingian region ofMetz, Cambridge, Cambridge University Press.
Hodges R. (1982), Dark age economics. The origin of Towns and trade, AD 600-1000,London, Duckworth.
Jansen G.C.M. (2000), System for the disposal of waste and excreta in Roman cities.The situation in Pompeii, Herculaneum and Ostia, in Sordes urbis. La eliminacíonde residuos en la ciudad romana. Actas de la reunión de Roma (15-16 de noviem-bre de 1996), Roma, L’Erma, pp. 37-49.
Koloski-Ostrow A.O. (1996), Finding social meaning in the public latrines, in deHaan N., Jansen G. (a cura di), Cura Aquarum in Campania. Proceeding of the 9th
International Congress on the History of Water Management and Hydraulic Engi-neering in the Mediterraneum Region, Leiden, Babesch, pp. 79-86.
Kreutz B. (1991), Before the Normans, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.La Rocca C. (1986), Dark ages a Verona: edilizia privata, aree aperte e strutture pub-
bliche in una città dell’Italia settentrionale, in «Archeologia Medievale», XIII, pp.31-78.
Lestocquoy J. (1930), Administration de Rome et diaconies du VII siècle, in «Rivistadi archeologia cristiana», VII, pp. 261-295.
Liebeschuetz W. (2000), Rubbish disposal in Greek and Roman cities, in Sordes urbis.La eliminacíon de residuos en la ciudad romana. Actas de la reunión de Roma (15-16 de noviembre de 1996), Roma, L’Erma, pp. 51-61.
Lynch K. (1992), Deperire. Rifiuti e spreco, Napoli, Cuen.Magdalino P. (1990), Church, bath and “diakonia” in medieval Constantinople, in
Morris R. (ed.), Church and People in Byzantium, Birmingham, University of Bir-mingham, pp. 165-188.
456 L. Carriero
Maier J.L. (1964), Le baptistère de Naples et ses mosaïques: étude historique et icono-graphique, Freiburg, Editions Universitaires.
Martin J.M. (2000), «Chartula in tumbo scripta, bolumen chartacium». Le papyrusdans les duchés tyrrhéniens pedant le haut Moyen Âge, in «Mélanges de l’EcoleFrançaise de Rome. Moyen Age», 112, pp. 183-189.
Martin J.M. (2005), Hellénisme politique, hellénisme religieux et pseudohellénisme àNaples (VIIème-XIème siècle), in «___ ____. Rivista di ricerche bizantinistiche»,2, pp. 59-77.
Martín-Bueno M., Reklaityte I. (2008), L’acqua nella Spagna del Medioevo: elementoprimordiale per tre ambienti culturali diversi, in L’acqua nei secoli altomedievali,(Spoleto 2007), Spoleto, Cisam, pp. 201-244.
Montanari M. (2008), Il sapore dell’acqua, in L’acqua nei secoli altomedievali (Spole-to 2007), Spoleto, Cisam, pp. 779-804.
Morcaldi M., Schiano M., De Stefano S. (a cura di) (1873-1893), Codex DiplomaticusCavensis, II, Napoli-Milano-Pisa, Badia di Cava.
Nicolaj G. (1997), Formulari e nuovo formalismo nei processi del Regnum Italiae, inLa giustizia nell’alto medioevo (secoli IX-XI). Settimane di studio Cisam, XLIV(Spoleto, 11-17 aprile 1996), Spoleto, Cisam, pp. 347-379.
Orselli A.M. (2008), I monaci tardoantichi in dialogo con l’acqua, in L’acqua nei se-coli altomedievali (Spoleto 2007), Spoleto, Cisam, pp. 1323-1380.
Pani Ermini L. (1978), I mosaici campani anteriori a Giustiniano, in L’Art dans l’Ita-lie Méridionale. Aggiornamento dell’opera di Emile Bertaux, Roma, ÉcoleFrançaise de Rome.
Pannuti U. (1988), Intorno alla cosiddetta “Testa Carafa” del Museo Nazionale diNapoli, in «Mitteilungen des Deutschen Archaölogischen Instituts, Römische Ab-teilung», LXXXXV, pp. 129-157.
Paroli T. (2008), L’acqua come elemento tra vita e morte nella cultura germanica me-dievale, in L’acqua nei secoli altomedievali (Spoleto 2007), Spoleto, Cisam, pp.1237-1322.
Pellegrini G.B. (1973), Attraverso la toponomastica medioevale in Italia, in Topogra-fia urbana e vita cittadina nell’Alto Medioevo. XXI Settimana di Studi sull’AltoMedioevo (Spoleto 1973), Spoleto, Cisam, pp. 401-499.
Pilone R. (a cura di) (1999), L’antico inventario delle pergamene del Monastero deiSS.Severino e Sossio, (Archivio di Stato di Napoli, Monasteri Soppressi, vol. 1788),Roma, Isime.
Pratesi A. (1987), Il notariato latino nel Mezzogiorno medievale d’Italia, in BellomoM. (a cura di), Scuole, diritto e società nel Mezzogiorno medievale d’Italia, Cata-nia, Tringale, pp. 137-168.
Pucci M. (2004), Il territorio rurale, in Delogu P., Perduto P. (a cura di), Salerno nelXII secolo. Istituzioni, società, cultura. Atti del convegno internazionale, Salerno,Cisam, p. 278-309.
Rodríguez-Almeida E. (2000), Roma, una città self-cleaning, in Sordes urbis. La eli-minacíon de residuos en la ciudad romana. Actas de la reunión de Roma (15-16 denoviembre de 1996), Roma, L’Erma, pp. 123-127.
Skinner P. (1998), Room for tension: urban life in Apulia in the eleventh and twelfthcenturies, in «Papers of British School at Rome», LXVI, pp. 159-176.
Skinner P. (2004), Daughters of Sichelgaita, in Delogu P., Perduto P. (a cura di), Sa-lerno nel XII secolo. Istituzioni, società, cultura. Atti del convegno internazionale,Salerno, Cisam, pp. 119-133.
Dark earth, rifiuti urbani e uso delle acque a Napoli tra X e XII secolo 457
Squatriti P. (1998), Water and society in early medieval Italy, AD 400-1000, Cambrid-ge, Cambridge University Press.
Squatriti P. (2008), I pericoli dell’acqua nell’alto Medioevo italiano, in L’acqua neisecoli altomedievali (Spoleto 2007), Spoleto, Cisam, pp. 583-629.
Stasolla F.R. (2008), Tra igiene e piacere: thermae e balnea nell’alto medioevo, inL’acqua nei secoli altomedievali (Spoleto 2007), Spoleto, Cisam, pp. 873-930.
Venditti A. (1967), Architettura bizantina nell’Italia meridionale, Napoli, Esi.Viale G. (1994), Un mondo usa e getta. La civiltà dei rifiuti e i rifiuti della civiltà, Mi-
lano, Feltrinelli.Vigarello G. (1985), Le Propre et le sale: l’hygiène du corps depuis le Moyen Âge, Pa-
ris, Seuil.Vitale G. (2005), I bagni a Napoli nel Medioevo, in «Archivio Storico per le Province
Napoletane», 123, pp. 1-48.Vitolo G. (1982), Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa dei laici nel Mezzogiorno
medievale. Il codice della confraternita di Santa Maria di Montefusco. (sec. XII),Roma, Herder.
Vitolo G. (1990), Città e coscienza cittadina nel Mezzogiorno medievale. Secoli IX-XII, Salerno, Carlone.
Vitolo G. (1993), I prodotti della terra: orti e frutteti, in Terra e uomini nel Mezzo-giorno normanno-svevo. (Atti delle settime giornate normanno-sveve, Bari, 1989),Bari, Dedalo, pp. 159-185.
Vitolo G. (a cura di) (2005), Città campane fra Tarda Antichità e Alto Medioevo, Sa-lerno, Carlone.
Von Falkenahausen V. (1992), La Campania tra Goti e Bizantini, in G. Pugliese Car-ratelli (a cura di), Storia e civiltà della Campania. Il Medioevo, Napoli, Electa, pp.7-35.
Ward Perkins B. (1988), The towns of northern Italy: rebirth or renoval?, in HodgesR., Hobley B. (eds.). The rebirth of towns in the west. AD 700-1050. London 1986,Oxford, Oxford University press, pp. 16-27.
Ward Perkins B. (1996), Urban Continuity?, in Christie N. (ed.), Towns in Transition.Urban evolution in late Antiquity and the early Middle Ages, Aldershot, ScolarPress, pp. 4-17.
Ward Perkins B. (2008), La caduta di Roma e la fine della civiltà, Roma-Bari, Laterza.Ward-Perkins B. (1984), From Classical Antiquity to the Middle Ages: Pubblic Buil-
ding in Northern and Central Italy 300-850, Oxford, Oxford University Press.Wickham C. (2000), Legge, pratiche e conflitti: tribunali e risoluzione delle dispute
nella Toscana del XII secolo, Roma, Viella.Wickham C. (2004), City society in twelfth-century Italy and the example of Salerno,
in Delogu P., Perduto P. (a cura di), Salerno nel XII secolo. Istituzioni, società, cul-tura. Atti del convegno internazionale, Salerno, Cisam, pp. 12-26.
Wickham C. (2013), Roma medievale. Crisi e stabilità di una città, 900-1150, Roma,Viella.
458 L. Carriero