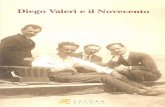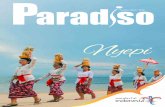A DON SABATINO, NEL TRENTESIMO ANNIVERSARIO DEL SUO ARRIVO IN PARADISO
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of A DON SABATINO, NEL TRENTESIMO ANNIVERSARIO DEL SUO ARRIVO IN PARADISO
Indice
PREMESSA ......................................................... - 1 -
DON SABATINO E IL MIO MAESTRO ........... - 2 -
NATALE CON PADRE MINOZZI .................... - 7 -
LA SCAPPATA ................................................. - 10 -
L’UVA E IL VOLPACCHIOTTO .................... - 20 -
IL TORRONE DI SAN MICHELE ................... - 23 -
A GIOVANNI .................................................... - 25 -
I RACCONTI DI BENEDETTO ....................... - 28 -
LA MAMMA ..................................................... - 30 -
LA BEFANA VIEN DI NOTTE ....................... - 33 -
A DON SABATINO, NEL TRENTESIMO
ANNIVERSARIO DEL SUO ARRIVO IN
PARADISO ........................................................ - 36 -
- 1 -
PREMESSA
L’infanzia di Palmo non è stata indubbiamente
semplice ma ciò che l’ha resa accettabile è l’aver in-
contrato durante questa fase della sua vita una per-
sona speciale: don Sabatino, un “mammo” a tutti gli
effetti che si è preso cura di questo bimbo di appena
5 anni catapultato in una realtà nuova e complessa
come quella di un collegio che ospitava altri 400
bimbi soli come lui.
Palmo ha respirato sin da piccolo l’aria salubre
dai valori morali e umani, fautori di un carattere
propositivo e propenso all’onestà, al senso del dove-
re e all’amore verso la famiglia. L’affetto che gratui-
tamente ha ricevuto lo ha condiviso con gli altri pic-
coli suoi amici con i quali il legame si è consolidato
e profondamente radicato nel tempo.
Questi brevi racconti fanno emergere ciò che è
rimasto sempre nel suo cuore, un dolce caro ricordo
di un periodo della sua vita da lui definito bellissi-
mo. Con affetto Ninì
- 2 -
DON SABATINO E IL MIO MAESTRO
Il giorno 24/6/2007 sarà per me indimenticabile
poiché pieno di intense emozioni. Partimmo da Bari
io e mia moglie per la certosa di San Lorenzo di Pa-
dula, invitati dalla Associazione Nuove Idee al radu-
no degli orfani ex alunni. Dopo un viaggio in cui il
disagio della guida veniva addolcito dal ricordo della
fanciullezza, arrivammo alla “Certosa ai muri”.
È la stessa prima entrata, per chi scende dalla
strada, che ti presenta l’incantevole visione, come se
tu ponessi l’occhio ad un cannocchiale che ti apre il
cielo.
Ma per me fu una cosa ancora più emozionante!
Vidi, appena uscito dalla direzione, don Sabatino, il
Direttore per noi orfani del dopoguerra, che, davanti
al portone, mi aspettava sul pianerottolo sovrastante
i pochi scalini.
La sua figura snella, col suo sorriso, cui gli occhi
aggiungevano un’espressione magica, si avvicinava
sempre più, via via che io le andavo incontro. Salito
- 3 -
le scale, mi disse “Vieni, Palmuccio!” e mi abbrac-
ciò. Sentii nell’abbraccio tutta la forza dell’amore
che Lui sapeva dare a tutti, e che io percepivo in
modo particolare. Sì, questa era una caratteristica di
quell’uomo: amare tutti e saper cogliere e custodire
di tutti le necessità e i valori affettivi.
Io, sbigottito, rimasi perplesso e dissi: “Ma…”.
Lui, anticipandomi, soggiunse: ”Sono stato invitato
anch’io, e non potevo mancare tra i miei amatissimi
orfani; ho chiesto il permesso e il mio Direttore mi
ha fatto scendere”. Mi convinse!
Mi prese per mano e, sorridendomi, mi condusse
lungo il primo cortile, attiguo al campanone; quindi
passammo al cortile seguente, sulla sinistra, dove
d’estate si pranzava e si cenava all’aperto.
Camminare con Lui, attraverso quei luoghi, in
quel silenzio, con quella frescura creata dalla Certo-
sa, mi rendeva libero, disteso, pienamente soddisfat-
to. Entrai nel chiostro grande, vicino alla cella n. 1,
ci apparve la maestosità delle arcate e del susseguirsi
delle colonne, la bellezza geometrica delle aiuole in
- 4 -
perfetta armonia con la conchiglia centrale dalla
quale sgorgavano zampilli rigogliosi di acqua. Sulla
conchiglia giocavano due bambini che riconobbi: si,
erano loro, Armando Rodriguez e Antonio Bonavita,
il mio compagno di banco. Ma capitò di più, perché
in men che non si dica le aiuole della parte superiore
del chiostro si popolarono di bambini che giocavano
con palle di pezza, correndo e ricorrendosi felici
come passerotti, che pur tanti volavano in quel cielo
della Certosa.
C’ero anche io tra quei bambini o era un sosia?
comunque godevo della felicità che sprizzava da tut-
ti i pori di quei piccoli, bisognosi sì, ma mai soli. Sì,
noi ci siamo sentiti sempre sicuri perché protetti da
quest’Uomo che mi conduceva per mano, Uomo dal
cuore talmente grande, da poter offrire a ciascuno di
noi un cantuccio sicuro.
Era Lui, durante i lunghi anni del dopoguerra, ca-
pace di preparare per ben due volte al giorno il pen-
tolone per sfamarci. E quando non c’era che metterci
dentro, ci versava le castagne raccolte da noi in uno
- 5 -
dei boschi che si trovavano procedendo a destra lun-
go la via, dopo il Convento dei Monaci; ne usciva
una zuppa ricca di nutrimento e gradita a tutti.
Era Lui che la sera, dopo cena, passava tra noi, ci
sorrideva e ci dava la buona notte.
Nell’osservare tutto ciò si era giunto alla cella n.
7. Andando avanti sembrava chetarsi il chiasso di
quei circa cinquecento bambini e veniva a crearsi
una nuova zona da scoprire.
Si era giunti vicino all’androne situato in uno dei
vertici del chiostro, tra la cella n. 9 e la cella n. 11,
antistante lo scalone ellittico.
Chi ti vedo? Stento a crederci! Era il mio maestro
Mario Ferrigno che, con una palla di gomma, questa
volta, da lui comprata, giocava con gli alunni della
sua quinta classe: sì, con Armenio, Ascione, Bonavi-
ta ormai sceso dalla conchiglia, Forgione, Occhineri,
Iannino, Loffredo, Caputo, Ruggiero, Guastaferri,
Gruosso, Ferrone, i fratelli Merone, Puca, Zito, A-
verno lo zoppo, Alvaro Vitale, Spallacci Bruno ed
- 6 -
altri. Stetti alcuni minuti con gli occhi chiusi, per
meglio sognare quell’incanto.
Poi, aprendo gli occhi, sentii la mano sempre più
libera dalla stretta affettuosa. Non ebbi il tempo per
tirare delle conclusioni perché, stando ai piedi dello
scalone, vidi il Direttore don Sabatino, il nostro pa-
pà, iniziare a salire lungo un’ala e il mio Maestro,
Ferrigno Mario, nostro fratello maggiore, lungo
l’altra ala.
Io, giù, alzando gli occhi, facilmente riuscivo a
seguire il loro involarsi ellittico, a chiusura del quale
li attendevano San Lorenzo e San Brunone per aprir
loro la porta del Paradiso.
GRAZIE A VOI DA PARTE DI TUTTI NOI OR-
FANI, PER AVERCI AMATI E PREPARATI AD ES-
SERE UOMINI.
- 7 -
NATALE CON PADRE MINOZZI
Padre G. Minozzi costituisce per me e, penso, per
tutti gli orfani che lo hanno conosciuto, una figura
trasparente e nello stesso tempo concreta.
La trasparenza gli permetteva di esprimere con-
cetti e di assumere atteggiamenti con tale semplicità
da dare forza maggiore ai significati delle sue parole
e alle sue azioni.
Diverse volte p. G. Minozzi è venuto a trovarci
nel periodo della mia permanenza nell’orfanotrofio
della Cerosa di Padula o nel Convitto Principe di
Piemonte di Potenza, ma è per me indimenticabile la
sua prima venuta.
Era il dicembre freddo del 1946. Da poco erava-
mo scesi nella Certosa lasciando vuota la casa che ci
aveva ospitato, ai piedi del paese, vicino ad Alfieri.
Ogni giorno gruppi sempre più numerosi di orfani
aumentavano le bocche di don Sabatino che doveva
cercare di sfamare. Si avvicinava il Santo Natale e si
- 8 -
era nell’attesa della nascita del Bambino Gesù, ma
anche della venuta fra noi di padre G. Minozzi.
Don Sabatino ci descriveva quest’uomo e ci dice-
va dell’immenso amore che nutriva per noi; era poi
la nostra fantasia di bambini a crearne un’immagine
personalizzata.
Si era ormai quasi alla vigilia di Natale; l’attesa
era spasmodica; le novene che si susseguivano scan-
divano i giorni restanti. La neve era sempre più alta
sulle aiuole del chiostro grande, ma le stufe di terra-
cotta poste nei vari studi, dalla cella numero 5 alla
numero 9, ci davano sufficiente calore e tepore.
E venne la vigilia di Natale. Il cenone? Un bel
piatto di polenta, dei fichi secchi dolcissimi e anche
qualche prugna secca per ciascuno di noi. E poi, si
sapeva che don Sabatino, avendo organizzato per noi
la tombola, avrebbe posto tra i premi altri fichi sec-
chi, ma anche delle castagne e dei torroncini.
Il clima natalizio era perfetto e l’attesa della ve-
nuta di p. Minozzi costituiva un incanto.
- 9 -
Dopo cena, verso le ore 20:30, entrò nel refettorio
don Sabatino con la tombola. Quasi a sorpresa, im-
mediatamente dopo, entrò anche p. G. Minozzi che,
con le braccia aperte e gli occhi luminosi di gioia, ci
venne incontro per abbracciarci.
Eravamo tanti, ma ciononostante ci sentimmo tut-
ti coperti sotto il suo mantello.
Giocando con noi ogni tanto dava a qualcuno un
pizzicotto o una carezza.
Andammo poi in chiesa con don Sabatino e p. G.
Minozzi, in quella notte fredda del 24 dicembre
1946, perché per noi nasceva Gesù Bambino.
Bari, 16/6/2008
- 10 -
LA SCAPPATA
Succedeva ogni giorno che sei o sette bambini “se
ne scappassero” dalla Certosa, ma la sera li ritrova-
vamo nel refettorio ove ci raccontavano le loro av-
venture. In generale erano ragazzi della provincia di
Napoli, raramente della Basilicata.
Io e Bonavita Antonio Dante rispettivamente di
Grassano e Rotondella, in provincia di Matera, era-
vamo pronti per iniziare questa avventura.
A rafforzare il nostro progetto contribuiva anche
la convinzione di aver ideato una scorciatoia per il
cammino che ci doveva portare ai nostri paesi di ori-
gine.
Infatti, anziché andare a piedi verso Sala Consili-
na, come facevano i napoletani, noi avevamo pensa-
to, raggiunta la stazione di Padula, di procedere in
senso opposto, verso Buonabitacolo, per poi inol-
trarci, superata Lagonegro, nella Basilicata.
- 11 -
I nostri progetti erano di raggiungere Grassano,
ove mia nonna Teresa avrebbe dato i soldi ad Anto-
nio per permettergli di raggiungere Rotondella in
treno.
L’ora più idonea per iniziare la fuga era le sette,
ora della sveglia; infatti si poteva ben sfruttare la
mezz’ora utile per lavarci e rifare i letti, ma anche la
mezz’ora seguente in cui si andava in chiesa per le
preghiere del mattino.
Dopo ci si recava nel refettorio e solo allora sa-
rebbe apparsa chiara e lampante la nostra assenza
agli occhi dell’assistente Piemonte, quando avrebbe
visto vuoti i nostri posti a tavola, ma, nel frattempo,
noi ci saremmo già trovati in fuga da un’ora.
Era il febbraio del 1948. Da alcuni giorni si era
sciolta la neve caduta e non ne appariva traccia ne-
anche sulle cime dei monti circostanti. Comunque,
qualora il tempo peggiorasse, eravamo dotati di una
mantella blu che indossavamo quando uscivamo
dall’orfanotrofio della Certosa per andare a passeg-
gio a Padula.
- 12 -
Alle sette io e Bonavita scendemmo per lo scalo-
ne a ridosso della cella numero 10, scavalcammo
uno dei due cancelli gemelli, al di là dei quali da una
parte appariva il campo sportivo a dall’altra si sten-
deva la fertile campagna della Certosa.
Imboccammo il vialone che, solcando la campa-
gna, portava ad un altro cancello incastrato nelle mu-
ra perimetrali; scavalcammo anche questo, incuranti
delle lance appuntite montate in alto.
Eravamo liberi, noi bambini di terza elementare
all’età di otto anni! La colazione? Ce n’era in ab-
bondanza; infatti i campi vicini alla strada selciata,
procedendo verso la stazione, erano pieni di mucchi
di rape i cui tuberi erano freschi e dolciastri.
Arrivati alla stazione prendemmo la strada asfal-
tata che portava a Buonabitacolo. La giornata era
bella e splendeva un caldo sole. Camminavamo lun-
go il lato della strada alla ricerca di qualche albero
da frutto o di qualche mela selvatica da poter man-
giare.
- 13 -
Avevamo fatto anche il pensierino di rubare una
gallina che gironzolava intorno ad un casolare, ma
rinunciammo subito all’idea sia perché capimmo che
non era cosa per noi possibile spennarla e cucinarla,
ma soprattutto perché ci convinse l’abbaiare di un
cane che apparve nello stesso momento in cui io e
Antonio avevamo iniziato a progettare la cosa.
Cammina e cammina si era arrivati all’abitato di
Buonabitacolo. Avevamo una fame che aumentava
sempre più!
Ci guardammo con gli occhi spaventati quasi pen-
tendoci di quanto stavamo combinando, ma proce-
demmo ancora avanti.
Ad un certo istante vedemmo in lontananza avan-
zare una persona in bicicletta, che mentre si avvici-
nava diminuiva la velocità; ci passò accanto quasi
scrutandoci.
Noi, visto un fagotto avvolto in un panno appeso
dietro la bici, gli facemmo cenno con le mani di
fermarsi. Si fermò. Gli chiedemmo del pane o da
- 14 -
mangiare. Fummo delusi. Però, fatti due passi, ci
voltammo per vedere quella “mappatella” appesa al-
la bici e, nello stesso istante, si voltò anche quella
persona.
Ricordo benissimo che, tornando indietro con la
bici, venne verso di noi, aprì il grosso fazzoletto che
avvolgeva del pane e una frittata e divise tutto con
noi, ci sorrise e se andò.
Oltrepassato il paese di Buonabitacolo, la prima
pietra miliare che incontrammo ci averti che dopo 30
chilometri saremmo arrivati a Lagonegro.
Erano probabilmente le quindici quando, lungo la
strada, in lontananza scorgemmo delle casette parti-
colarmente colorate. Accelerammo il passo ma, arri-
vati, ci rendemmo conto che si trattava delle cappel-
le di un cimitero il cui cancello dava sulla strada.
Sinceramente ci spaventammo molto e forse c’è
la facemmo pure sotto: certo è che, affrettammo il
passo, guardandoci terrorizzati negli occhi.
L’incedere era sempre lesto, ma Lagonegro era an-
- 15 -
cora lontana tanti chilometri e la luce di quella bella
giornata di sole incominciava a diminuire. Anzi, ver-
so le diciassette la luce aveva già ceduto all’ombra e
l’oscurità incominciava a calarci addosso. La strada
era lunga; Lagonegro era troppo lontano!
E se, andando ancora avanti lungo la strada, aves-
simo incontrato anche il cimitero di Lagonegro? Non
ce lo dicemmo apertamente, ma i nostri sguardi in-
crociandosi rivelavano chiaramente la nostra paura,
anzi il nostro terrore, visto che ormai la strada e gli
alberi costituivano quasi un tutt’unico oscuro.
Sopraggiungeva la notte! Però, per nostra fortuna
vedemmo, prima di una curva, a distanza di qualche
centinaio di metri, dei pali di luce elettrica con la
lampada accesa. Ci si aprì il petto e il cuore palpitò
con aumentata frequenza.
Dopo la curva, lungo la strada, c’erano delle case
rustiche con il focolare acceso; delle donne chiac-
chieravano e si salutavano passando da una casa
all’altra.
- 16 -
Eravamo salvi!
Ci coprimmo bene con le mantelle e, fermi nel
mezzo della strada, nel punto più altro della curva, ci
affidammo al buon Dio.
Uscì da un casolare illuminato una donna, ci vide,
si avvicinò; poi un’altra donna si avvicinò a noi;
fummo subito circondati da donne che, insieme ad
un continuo chiacchierio, ci portarono in quel bel ca-
solare illuminato. Ci guardavano con occhi sorriden-
ti e pieni di materno affetto. Entrati, ci fecero sedere
vicino ad un focolare pieno di legna ardente.
Tutte ci facevano contemporaneamente le più
svariate domande e noi non sapevamo a chi rispon-
dere per prima.
Entrò poi una donna con un tavoliere in testa pie-
no di forme di pane fresco. Io ed Antonio, che ci ri-
scaldavamo alla fiamma di quel bel focolare e che
nel contempo guardavamo le numerose salsicce che
stavano ad affumicare in quell’ambiente, immedia-
- 17 -
tamente fummo calamitati ed attratti da quel buon
profumo di pane fresco.
Immediatamente le donne tagliarono delle salsic-
ce e del pane e , amorevolmente, ci fecero mangiare.
Stavamo in paradiso! Quando improvvisamente si
sentì vicino alla porta del casolare il rumore di una
camionetta: due uomini, di cui uno in divisa, scesero
ed entrarono salutati da tutte le donne che ci circon-
davano. La nostra presenza fu per loro una sorpresa.
Incominciarono a farci domande precise, cosicché
non potevamo dire più bugie, quali quella di essere i
nipoti del Conte Malazia di Sala Consilina, come
avevamo raccontato alle donne. Subito fummo in-
dotti dall’uomo in divisa, il maresciallo dei carabi-
nieri di Buonabitacolo a dire la verità.
Ci riscaldammo ancora un po’ e, finito di mangia-
re pane e salsiccia, il maresciallo sorridendoci ci fe-
ce salire sulla camionetta.
Le donne ci salutarono affettuosamente e noi ci
avviammo verso il paese. Chissà cosa ci aspettava.
- 18 -
Giunti al paese il maresciallo ci portò a casa sua
dove la moglie aveva preparato la cena anche per
noi. Cenammo alla stessa tavola del maresciallo e
dopo, essendo abbastanza tardi, la signora ci accom-
pagnò a letto: dormimmo io e Bonavita nel lettone di
questa brava gente. Più tardi venne la signora col
marito a darci la buonanotte. Eravamo proprio stan-
chi!
L’indomani, di buon mattino, facemmo colazione
col maresciallo e la moglie e poi andammo alla sta-
zione di Buonabitacolo per prendere la littorina che
ci avrebbe portato a Padula. Il viaggio fu breve.
Il maresciallo scese con noi dalla littorina, ci pre-
se per mano e parlando con noi ci accompagnò dal
direttore. Entrati in direzione il maresciallo ci lasciò
a tu per tu con Don Sabatino.
Fu questo un momento che ricordo tra i più brutti
della mia vita.
- 19 -
Don Sabatino ci guardò, mi guardò, penetrandomi
con i suoi occhi. Quanto dispiacere e dolore gli ave-
vo dato: mi pentii amaramente!
Ci prese per mano e ci condusse nel refettorio per
riprendere con gli altri la nuova giornata.
Bari, 11/5/2010
- 20 -
L’UVA E IL VOLPACCHIOTTO
Era il settembre del 1946; ci si preparava per en-
trare nella Certosa. Infatti, probabilmente in attesa di
necessarie ristrutturazioni, eravamo alloggiati nella
cosiddetta Certosa piccola, cioè in quel reparto im-
mediatamente a sinistra dell’entrata principale della
vera e propria Certosa.
Eravamo circa sessanta orfani: io ero il più picco-
lo. C’erano dei giovanotti: Meloro, i fratelli Mano-
lio, Lagrotta, i fratelli Di Stefano, Travascio ed altri
un po’ più grandi di me.
Si giocava nello spiazzo sottostante le camerate e
vicino al refettorio. Tutti ci volevamo bene e mi vo-
levano bene.
Una scarpata ci divideva dalla campagna della
Certosa. Sotto la scarpata si stendeva un terreno col-
tivato ad erba medica, in pratica trifoglio molto alto
e robusto. Al di là di questa distesa seguiva una vi-
gna stracolma di grappoli d’uva. “Dai, Palmuzzo,
vieni qua!” mi chiamavano i grandi.
- 21 -
“Senti, Palmuzzo; don Sabatino è andato a Sala
Consilina con la Topolino (era la macchina
d’ordinanza della direzione); allora tu scendi nella
scarpata, attraversa l’erba medica e va’ a prendere
l’uva della vigna”. Tutti mi incitavano e mi sprona-
vano verso la vigna.
L’incitamento e il tifo erano calorosi e numerosi:
“Bravo, Palmuccio, vai, vai! Forza, Palmuccio!” En-
trato nella vigna, incominciai a prelevare i grappoli
più grossi facendomeli pendere dalle mani, dal collo
e dalle braccia. Dovevo portare quanta più uva pos-
sibile ai miei amici che, stranamente, non gridavano
più per incitarmi, anzi, tutto quel chiasso si era tra-
mutato in un intenso silenzio!
Qualcosa non andava nel verso giusto! Capii che
era bugia che don Sabatino era andato a Sala Consi-
lina, anzi pensai subito che, preso da tutto quel
chiasso, fosse uscito dalla direzione per capire cosa
stesse succedendo.
Era proprio così: don Sabatino mi aspettava sopra
la scarpata. Allora io mi spostai lateralmente nel
- 22 -
campo di erba medica e depositai l’uva in un punto.
Mi diressi in senso opposto per un venti metri e
quindi puntai perpendicolarmente alla scarpata nel
punto in cui mi attendeva don Sabatino.
Capì tutto! Mi prese per mano, tornammo nel
campo di erba medica e insieme andammo ad ispe-
zionarlo a destra e a manca al fine di ritrovare la re-
furtiva. Ma niente da fare; nonostante la dedizione e
la pazienza don Sabatino, non c’era traccia dell’uva.
Anzi, ad un certo punto, mi era sembrato di capire
che si fosse convinto che di uva non ce n’era.
Stavamo tornando verso la scarpata quando, dopo
due o tre passi, apparve il mucchio d’uva. Diventai
tutto rosso! Don Sabatino me ne fece raccogliere un
po’ e l’altra la prese lui. Uscimmo dal campo, sa-
limmo la scarpata e, davanti a tutti, mi diede due
sculacciate. Ne meritavo di più!
La sera, a cena, oltre alla parca pietanza, trovam-
mo l’uva come frutta.
Bari, 25/9/2010
- 23 -
IL TORRONE DI SAN MICHELE
San Michele è il patrono di Padula. Bellissimi e-
rano i fuochi di artificio realizzati da ditte concor-
renti sovvenzionate da paesani ricchi emigrati in
America. Ma per noi bambini della Certosa era più
affascinante la grotta di San Michele, che per tale fe-
stività, andavamo ogni anno a visitare.
Ci incantava il percorso a piedi che correva lungo
il pendio di una montagna, costituito da sentieri
spesso stretti; ma la fatica era compensata dalla vi-
sione della grotta, ampia nell’entrata, illuminata e
caratterizzata all’interno da una grossa roccia spor-
gente e quasi in bilico, dominata dalla statua di San
Michele.
Davanti all’entrata c’erano diversi rivenditori che
esponevano sulle loro bancarelle frutta secca, ara-
chidi e soprattutto torroni disposti e ordinati a mo’ di
piramide.
- 24 -
Era forte la tentazione e la voglia di prenderli; al-
lungai la mano e ne tirai uno. Tutta la piramide dei
torroncini rovinò per terra, cosicché fui scoperto.
Il padrone mi guardò, non si arrabbiò, raccolse
tutti i torroni e li dispose ricomponendo la piramide.
Io rimasi si stucco quando, anziché disporre in al-
to l’ultimo torroncino, mi guardò, mi sorrise e me lo
regalò.
Bari, 31/10/2010
- 25 -
A GIOVANNI
Caro Giovanni,
sono sinceramente emozionato per il fatto che sto
scrivendo a te, mio compagno di banco di prima e-
lementare.
Ricordo benissimo quando il nostro maestro Mi-
chele Gallo, facendo leggere a turno dal sussidiario,
diceva: “Continua Ruggiero”, ma tu non portavi il
segno, e poi “Continua Bevilacqua”, ma anch’io non
portavo il segno e non ero in grado di continuare la
lettura; noi, infatti, scherzavamo sempre, incuranti
del lavoro in classe.
Abbiamo vissuto, insieme a tanti altri bambini,
gli anni della nostra fanciullezza, che erano gli anni
del dopoguerra; abbiamo giocato tutti insieme prima
nelle aiuole del chiostro della Certosa, poi nel campo
sportivo; abbiamo tutti sofferto i morsi della fame,
che, quando si andava a passeggio, ci induceva a
raccogliere da terra qualunque cosa si potesse man-
giare. Era una grande festa per noi quando si andava
- 26 -
nei boschi di castagne; eppure mai un mal di pancia,
nonostante fossero molte le castagne che mangia-
vamo lì nel bosco e che continuavamo a mangiare
tornati alla Certosa, dopo averle nascoste nei posti
più impensabili del nostro modesto vestiario.
Io ricordavo tutto, i momenti felici e quelli tristi,
ma quello che mi rimane più impresso è l’affetto,
che era il collante che ci teneva tutti uniti, e l’amore
che ho ricevuto da don Sabatino e dal maestro Mario
Ferrigno dalla seconda alla quinta elementare.
Ti invio dei racconti che ho scritto, mi auguro che
ti piacciano. Né scriverò altri. Con questi racconti
non voglio rievocare le nostre sofferenze, fin troppo
numerose, ma voglio evidenziare che la nostra sem-
plicità: bastava poco per renderci felici.
Intendo anche rendere omaggio alle persone che
mi hanno voluto bene e che, credo, hanno voluto be-
ne a tutti noi.
Ti abbraccio con affetto e mi unisco al tuo dolore
per la scomparsa del caro Roberto. Ma la vita conti-
- 28 -
I RACCONTI DI BENEDETTO
Una cosa che ora ritengo un sogno, ma che allora
costituiva un fatto reale, è il ricordo delle serate che
trascorrevamo nel chiostro grande, dopo cena, du-
rante i caldi mesi estivi.
Usciti in fila dal refettorio, verso le venti e trenta,
ci intrattenevamo nelle aiuole della parte superiore
del chiostro. Le lucciole, numerosissime, partecipa-
vano al nostro schiamazzo rendendo l’ambiente qua-
si fatato.
Man mano che si faceva notte, si riuniva un grup-
po di bambini che si accoccolavano per terra o sui
gradini di separazione tra il colonnato e le aiuole, nei
pressi della cella numero cinque.
Al centro del gruppo, sempre più folto, emergeva
il giovane discepolo don Benedetto, una figura dolce
e fraterna, un angelo per noi.
- 29 -
Ogni sera ci narrava racconti bellissimi e noi, rac-
colti attorno, ascoltavamo in silenzio, con entusia-
smo ed estasi.
Era un incanto vedere il cielo blu, incastonato di
stelle, coprire quasi come una cupola il chiostro del-
la Certosa, le lucciole rincorrersi sempre più nume-
rose e noi far nido attorno a Benedetto che ci raccon-
tava le favole.
Bari, 18/8/2011
- 30 -
LA MAMMA
Era una domenica del novembre del 1947; ordina-
ti per classi ci preparavamo per andare a passeggio.
Nei mesi estivi si andava a passeggio verso il Tana-
gro, dove era ancora possibile tuffarsi nell’acqua
limpida ed era piacevole anche raccogliere le more,
mature ed abbondanti, dei rovi che costeggiavano il
fiume.
Ma la passeggiata di novembre era tutt’altra cosa,
perché si andava nei boschi di castagne con i com-
pagni di classe: Armenio, Bonavita, Iannico, Puca,
Vietri, Lombardi, i fratelli Merone, Ferrone Rocco,
Spallacci Bruno, Alvaro Vitale, Gruosso, Occhineri,
Caputo Ciro, ed i gemelli Giovanni e Roberto Rug-
giero; tutti contenti e felici ci mettemmo in cammi-
no.
Usciti dalla Certosa, per andare nei boschi occor-
reva proseguire verso il paese e precisamente passa-
re davanti al convento dei monaci, per svoltare poi a
destra.
- 31 -
Mentre ci si avvicinava al convento perveniva
sempre più chiaro il suono di una musica e la voce di
Luciano Taioli che cantava la canzone “mamma”.
I primi del gruppo, anziché proseguire, si erano
seduti, alcuni per terra, altri sul muretto sul quale era
poggiato un grammofono dalla cui tromba usciva la
bella voce del cantare: “… quanto ti voglio bene!
Queste parole d’amore che ti sussurra il mio cuore
forse non s’usano più, … mamma, ma la canzone
mia più bella sei tu, sei tu la vita e per la vita non ti
lascio mai più…”
Quando tutti avevamo raggiunto la piazzetta del
convento uscì dalla chiesa un frate che, vedendo tutti
noi bambini in estasi, rimise il disco per farci sentire
la canzone. A questo punto non pensavamo più al
bosco pieno di castagne, ma, tutti seduti, ascoltava-
mo in silenzio la voce di Luciano Taioli con traspor-
to tale che a qualcuno scesero delle lacrime sul viso.
Fu un momento di intensa commozione: quasi
tutti erano tristi e piangevano pensando alle loro
mamme.
- 32 -
Forse piansi un po’ anch’io: non ricordo bene; io
che non ho mai pianto per la mancanza della mam-
ma, visto che, avendola persa all’età di un mese, non
ho avuto modo di capire e godere l’immenso amore
che una madre dà alla sua creatura. In compenso, pe-
rò, molte persone mi hanno aiutato ed amato.
Intanto si era fatto tardi e non era più possibile
proseguire per raggiungere i boschi; c’è ne tornam-
mo quasi in silenzio alla Certosa.
Bari, 23/8/2012
- 33 -
LA BEFANA VIEN DI NOTTE
Era il gennaio del 1946: erano trascorsi tre mesi
da quando nonna Teresa e zia Lucia mi avevano por-
tato all’orfanotrofio di Padula che, era ubicato ai
piedi del paese, vicino ad Alfieri.
Passato il Santo Natale si attendeva l’Epifania:
eravamo una cinquantina di orfani; io ero il più pic-
colo.
I più grandi mi dicevano che sarebbe venuta la
Befana, scendendo da un camino, ma di camini, in
quell’abitato, c’è n’erano diversi… comunque, sa-
rebbe venuta nella nostra comunità.
Era indispensabile, mi dicevano i grandi, non an-
dare di notte al bagno, perché la Befana, qualora fos-
se venuta proprio allora, non voleva essere ricono-
sciuta.
Questo fatto mi dava molta ansia perché ogni not-
te andavo a fare pipì nel bagno vicino ai lavandini,
accanto alla camerata. Dovevo resistere!
- 34 -
Dopo cena giocammo per un’ora a tombola e poi
don Sabatino ci accompagnò in camerata e ci diede
la buona notte.
Io mi sentivo molto agitato perché, mi dicevano i
grandi, quella notte dovevo sempre dormire, altri-
menti la Befana non sarebbe venuta. Strinsi, mi ve-
niva forte, strinsi ancora, non ne potetti più!! In u-
mido mi addormentai e attesi il mattino.
Svegliatomi, notai che tutti si erano già alzati e
lavati, attendendo che io uscissi dal letto. Aperti gli
occhi, cercai ai piedi del letto i miei pantaloncini, le
calze e le scarpe. Che strano! C’era solo una calza.
Sotto gli occhi di tutti, curiosi, mi ficcai sotto il letto
per trovare il mio calzino, cercai intorno al comodi-
no, niente. Mi misi il calzino e le scarpe sotto lo
sguardo sorridente di tutti.
“Palmuzzo, dove hai messo l’altro calzino?” Più
che prendermi in giro, scherzavano con me. Trava-
scio mi diceva: “Se non trovi il calzino, metti uno
dei miei; fa niente che è troppo grande per te.” Tutti
ridevano.
- 35 -
Io incomincia a piangere, non perché mi sentissi
deriso, ma perché non trovavo il mio calzino.
“Palmuzzo, vai a vedere sotto gli altri letti!” Ispe-
zionai ogni cosa, ma niente da fare.
Travascio mi disse:”Palmuzzo, vedi meglio sotto
il tuo lettino, forse non hai visto bene!”
Tornai di nuovo sotto il mio lettino, alzai gli oc-
chi e vidi, agganciato alla rete, il mio calzino pieno
che ciondolava. Diedi un sospiro di sollievo, lo
sganciai e sgusciai fuori. Tutti, contenti e sorridenti,
battettero le mani. Io infilai la mano nel calzino e ci
trovai tante castagne arrostite, diversi fichi secchi e,
in fondo, un carbone.
Questa fu la prima Befana della mia vita.
Bari, 7/9/2012
- 36 -
A DON SABATINO, NEL
TRENTESIMO ANNIVERSARIO DEL
SUO ARRIVO IN PARADISO
Don Sabatino Di Stefano nacque l’
1/4/1911 a Goriano Valli, contrada ricca
di verde e di fiori rossi e gialli. Secondo di
quattro figli, genitori contadini, amanti
della terra, all’età di quattro anni fu orfano
di guerra. Giovanissimo, avendo nove an-
ni appena, fu collocato nell’orfanotrofio di
Ofena. Qui, custodito e seguito da padre
G. Minozzi, coltivò e maturò la vocazione
al sacerdozio, arricchendo così il patrimo-
nio dei suoi sentimenti, dovuto al suo a-
more per gli orfani.
Ordinato sacerdote nel 1938, divenne un affluente
naturale della corrente rappresentata da padre Mi-
nozzi e da padre G. Semeria che nel 1919 avevano
fondato ” l’Opera Nazionale per il Mezzogiorno
d’Italia” e poi, nel 1931, la “Famiglia dei Discepoli”,
- 37 -
nella quale don Sabatino entrò ufficialmente il primo
aprile 1937.
Io ho conosciuto don Sabatino nell’ottobre del
1945, quando nonna Teresa e zia Lucia mi portarono
nell’orfanotrofio di Padula che allora era ubicato in
un edificio ai piedi del paese. Avevo compiuto cin-
que anni a marzo. Orfano di madre all’età di un me-
se, avevo vissuto la prima infanzia con i nonni ma-
terni.
Don Sabatino sapeva tutto questo e quando la
nonna e la zia, prima di ripartire, mi abbracciarono,
dicendomi che andavano a comprarmi il cavalluccio
a dondolo, mi prese per mano e amorevolmente mi
condusse tra gli altri orfani.
Allora eravamo circa una cinquantina, io ero il
più piccolo, tutti mi volevano bene e tutti ci voleva-
mo bene.
In seguito ci trasferimmo giù, nella Certosa, a oc-
cupare i locali posti a sinistra della facciata principa-
le. Dopo alcuni mesi, nel 1946, entrammo nella vera
- 38 -
e propria Certosa, più adatta ad accogliere gli orfani
il cui numero aumentava di giorno in giorno fino a
sfiorare i 400 nel 1948.
Quante preoccupazioni aveva quell’uomo per
mantenere una famiglia così numerosa! Senza dub-
bio gli davano forza l’amore per gli orfani e
l’impegno costante nel curare la loro crescita morale
e fisica.
Nel 1951, superato l’esame di ammissione soste-
nuto a Sala Consilina, don Sabatino ritenne opportu-
no trasferirmi nel Convitto “Principe di Piemonte” di
Potenza, dove potetti frequentare con successo le
scuole medie e il liceo scientifico.
Mi mancava la presenza fisica di don Sabatino
ma io ero nel suo cuore e nei suoi progetti; infatti,
nell’estate del 1953, accompagnato da suo nipote
Fabio Di Giulio, andai in treno a Goriano Valli per
trascorrere le vacanze con la sua bella famiglia, che
io ho sentito come mia, tanto che le sue nipotine
Giovanna e Silvana, quest’ultima nata l’anno dopo,
sono ora per me mie sorelle.
- 39 -
Nel 1957 i locali della Certosa furono richiesti
dallo Stato e poiché si prevedeva la chiusura
dell’orfanotrofio don Sabatino fu trasferito
nell’istituto “Principe di Piemonte”. Era proprio de-
stino! Era don Sabatino quella persona che mi a-
vrebbe guidato e protetto nel periodo più critico del-
la mia vita.
Stavo concludendo gli studi liceali e pensavo
sempre al mio incerto avvenire, visto che volevo i-
scrivermi all’Università per studiare Matematica, ma
non avevo le risorse economiche per realizzare que-
sto mio sogno. Don Sabatino intuiva queste mie pre-
occupazioni e, sempre il suo sorriso incoraggiante,
mi trasfondeva fiducia e coraggio.
Ricordo benissimo quando, nell’estate del 1959,
camminavamo per via Foria a Napoli, sotto il sole
cocente di luglio, alla ricerca di una sistemazione per
me. Passando davanti all’Università “Federico II”,
lungo il rettifilo, don Sabatino mi disse: “Questa è
l’Università dove ti laureerai.” E così fu. Infatti mi
affidò alla famiglia Rodriquez, che conoscevamo
- 40 -
sin dai tempi della Certosa, e che mi ospitò per il
primo anno di studi. colgo l’occasione per ricordare
con affetto e riconoscenza l’amore e la cordialità che
mi hanno donato. In seguito, grazie alla nomina di
supplente per un anno nelle scuole di avviamento di
Grassano, mio paese natio, e a successive supplenze
nelle scuole medie riuscii a sbarcare il lunario e a
laurearmi, coronando il mio sogno e realizzando
quello che la visione sicura di don Sabatino aveva
presagito.
Noi siamo stati ora bravi, ora monelli, ma
siamo sempre stati i tuoi orfanelli. Ogni
orfano, nella vita, ha avuto il suo destino,
ma il mio è stato plasmato da don Sabati-
no. Tu fosti sempre vigile, come un ange-
lo custode, e il Padre Eterno ti premia con
dieci e lode. Tu, che ora sei in Paradiso,
prega per noi e aiutaci con il tuo sorriso.
Bari, 23/9/2013