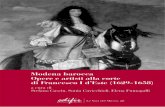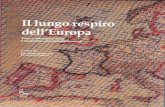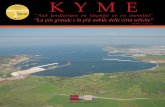Francesco Locatelli e il suo Libro universal: vita e cultura dell'età barocca nel diario di un...
Transcript of Francesco Locatelli e il suo Libro universal: vita e cultura dell'età barocca nel diario di un...
Izid knjige so omogočiliIL LIBRO È STATO PUBBLICATO CON IL CONTRIBUTOLIBRO È STATO PUBBLICATO CON IL CONTRIBUTO
7
11 Andrej Malnič, ravnatelj Goriškega muzeja, Nova GoricaUvodna beseda
13 Claudio Cressati, Assessore alla Cultura, GoriziaPrefazione
15 Ferdinand Šerbelj, LjubljanaUvodIntroduzione
19 France M. Dolinar, LjubljanaPrizadevanje za cerkvenoupravno ureditev habsburškega dela oglejskega patriarhata do jožefinskih reformL’organizzazione ecclesiastica nei territori asburgici del Patriarcato di Aquileia sino alle riforme giuseppine
27 Luigi Tavano, GoriziaLa vita socio-religiosa di Gorizia nel catapan parrocchiale del SeicentoDružbeno in versko življenje v Gorici v katapanu iz 17. stoletja
41 Donatella Porcedda, GoriziaCittadini e nobili a Gorizia nel SeicentoMeščani in plemiči v 17. stoletju v Gorici
47 Rudj Gorian, GoriziaL’informazione militare e politica nelle raccolte poetiche di Giovanni Maria Marusig (1641–1712)Vojaški in politični dogodki v pesniških zbirkah Giovannija Marie Marusiga (Gorica, 1641–1712)
57 Silvano Cavazza, Sagrado (GO)Politica e violenza nobiliare: il caso di Carlo Della TorrePolitika in nasilje v plemiških krogih: primer Carla Della Torre
67 Alessio Stasi, GoriziaFrancesco Locatelli e il suo Libro universal: vita e cultura dell’età barocca nel diario di un nobile cormoneseFrancesco Locatelli in njegov Libro universal: življenje in kultura baročnega obdobja v dnevniku krminskega plemiča
79 Lojze Kovačič, LjubljanaGoriški jezuiti v zrcalu svojih rektorjev od leta 1615 do 1773I gesuiti di Gorizia alla luce dei loro rettori negli anni 1615–1773
89 Lucia Pillon, GoriziaIl monastero di Sant’Orsola a Gorizia dalle origini al priorato di madre Maria Giovanna Lantieri (1672–1730)Uršulinski samostan v Gorici od začetkov do prednice Marie Giovanne Lanthieri, 1672–1730
99 Jernej Vidmar, SolkanGoriška črna vojska - černida v letih med 1690 in 1750L’esercito nero Goriziano – le cernide negli anni 1690–1750
115 Jernej Vidmar, SolkanDrobci iz zgodovine Solkana in solkanskega plemstva v 17. in 18. stoletjuFrammenti dalla storia di Salcano e della sua nobiltà nel Sei e Settecento
Kazalo / INDICE
Barok na Goriškem
8 129 Vincenc Rajšp, LjubljanaVloga jezika v cerkvi na prehodu iz baroka v jožefinski racionalizem. Jezikovne razmere na GoriškemIl ruolo della lingua nella Chiesa nel passaggio dal Barocco al Razionalismo giuseppineo: la situazione linguistica nel Goriziano
135 Metoda Kokole, LjubljanaOperne predstave v Gorici od odprtja gledališča do konca 18. stoletjaLe rappresentazioni operistiche a Gorizia dall’inaugurazione del teatro sino alla fine del Settecento
157 Inga Miklavčič Brezigar, Nova GoricaRobidišče – razvoj in življenje podeželja na nekdanji avstrijsko-beneški meji v barokuRobidišče: sviluppo e vita quotidiana nella campagna lungo il confine austro-veneziano nel periodo barocco
165 Aleksander Panjek, TrstO mejnosti Goriške grofije v baroku – gospodarski in družbeni pogledUn’area di transizione tra Europa Centrale e Mediterranea. La struttura agraria nella contea di Gorizia in età moderna
171 Paolo Iancis, Mossa (GO)La mobilità del lavoro manifatturiero a Gorizia nel SettecentoMobilnost delovne sile v 18. stoletju v Gorici
177 Loredana Panariti, San Pier d'Isonzo (GO)Le tessitrici di seta nel Goriziano del SettecentoTkalke svile v 18. stoletju na Goriškem
183 Igor Sapač, LjubljanaBaročna grajska arhitektura na GoriškemArchitettura barocca profana nel Goriziano
207 Pavla Jarc, Nova GoricaCerkev na Sveti gori - nastanek in njeno nasledstvoLa chiesa di Monte Santo: la sua fondazione e il suo seguito
221 Helena Seražin, LjubljanaVila Belvedere na Zemonu pri VipaviLa villa Belvedere a Zemono presso Vipacco
235 Metoda Kemperl, LjubljanaCerkev Marija Obršljan pri Komnu – kraška renesansa ali pozni barok?Il santuario della Vergine Maria a Obršljan presso Comeno: Rinascimento carsico o tardo Barocco?
247 Božidar Premrl, LjubljanaStavbarska delavnica družine Rojina v Brezovici v Brkinih v 17. stoletju in na začetku 18. stoletjaLa bottega edile dei Rojina di Brezovica dal Seicento e agli inizi del Settecento
267 Gabriele Angeli, Cormòns (GO)Un Sant’Antonio Abate e un San Valentino dalla chiesa della Beata Vergine del Soccorso sul Quarin (Cormòns)Sveti Anton Opat in Sv. Valentin iz cerkve Marije Pomočnice na Krminski gori nad Krminom
Il barocco nel Goriziano
9273 Nataša Polajnar Frelih, LjubljanaPrispevek Mihaela Kuše in Luke Misleja k razvoju ljubljanskih kamnoseških delavnic poznega 17. in zgodnjega 18. stoletjaIl contributo di Mihael Kuša e Luka Mislej allo sviluppo delle botteghe lapicide lubianesi tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento
281 Blaž Resman, LjubljanaPuttijeva kipa v KozaniDue statue di Angelo Putti a Kozana
289 Matej Klemenčič, LjubljanaGoriški in beneški delež pri Schoyevem velikem oltarju v graški stolnici: Pasquale Lazzarini in Giovanni MarchioriIL contributo dei goriziani e veneziani all'altare maggiore di Johann Jakob Schoy nel Duomo di Graz: Pasquale Lazzarini e Giovanni Marchiori
301 Massimo De Grassi, GradoIl ruolo degli scultori goriziani nell’area giuliana agli inizi del SettecentoVloga goriških kiparjev v Julijski krajini v začetku 18. stoletja
311 Verena Koršič Zorn, LjubljanaOprema jezuitske cerkve sv. Ignacija v Gorici v prvih desetletjih 17. stoletjaGli arredi sacri del collegio dei gesuiti a Gorizia nei primi decenni del suo sviluppo
319 Gabriella Brumat Dellasorte, Turriaco (GO)L’altare votivo di Sant’Antonio nella parrocchiale di TurriacoVotivni oltar sv. Antona Padovanskega v župnijski cerkvi v Turjaku
325 Serenella Ferrari Benedetti, GoriziaUna tela di Alessandro Magnasco nelle collezioni Coronini Cronberg di GoriziaSlika Alessandra Magnasca v goriški zbirki Coronini Cronberg
335 Maddalena Malni Pascoletti, GoriziaUn pittore in cucina: le “pentole” di Martin Dichtl nelle collezioni Coronini Cronberg di GoriziaSlikar v kuhinji: Kozíce Martina Dichtla v goriški zbirki Coronini Cronberg
345 Ana Lavrič, LjubljanaPrispevek k biografiji Giulia QuagliaContributo alla biografia di Giulio Quaglio
353 Luca Geroni, MonfalconeUn’opera dell’atelier della famiglia Litterini all’interno della collezione de Brandis di San Giovanni al NatisoneDelo iz delavnice družine Litterini v zbirki De Brandis v San Giovanniju al Natisone
361 Ferdinand Šerbelj, LjubljanaSlikar Antonio Dall'Agata o slikah Anne BorriniIl giudizio del pittore Antonio Dall'Agata sui dipinti di Anna Borrini
371 Igor Weigl, LjubljanaPortreti baronov Erbergov na Goriškem in v FurlanijiI ritratti dei baroni Erberg a Gorizia e nel Friuli
Barok na Goriškem
10 389 Alessandro Quinzi, GoricaDela Atonij Parolija in Janeza Mihaela ter Karla LichtenreitaInediti di Antonio Paroli, Johann Michael e Karl Lichtenreiter
395 Alessio Stasi, GoriziaUn San Giuseppe con Gesù Bambino di Johann Michael LichtenreitLichtenreitov Sveti Jožef z Detetom
401 Enrico Lucchese, TriesteNuove opere di Antonio Paroli e un appunto sulla decorazione della villa di Sigismondo d’AttemsNova dela Antonija Parolija in zapiski o okrasju v podgorski vili grofa Sigismunda Attemsa
411 Gabriele Angeli, Cormòns (GO)Un San Luigi Gonzaga di Giambettino Cignaroli a GoriziaCignarolijeva slika Svetega Alojzija Gonzage v Gorici
417 Lidia Da Lio, GoriziaFrancesco Pavona: note per l’aggiornamento del suo catalogoDodatek k seznamu del Francesca Pavone
431 Sergio Tavano, GoriziaSpunti per la pittura barocca nel GorizianoNekaj misli o baročnem slikarstvu na Goriškem
445 Barbara Murovec, LjubljanaBaročna poslikava župnijske cerkve sv. Štefana v VipaviLa decorazione pittorica barocca della parrocchiale di Santo Stefano a Vipacco
457 Ana Lavrič, LjubljanaLichtenreitovi sliki sv. Marije Magdalene in sv. Petra v ljubljanski stolniciI dipinti del Lichtenreiter di Santa Maria Maddalena e di San Pietro nel Duomo di Lubiana
465 Raffaella Sgubin, GoriziaAffreschi inediti a Palazzo Attems-PetzensteinNovoodkrite freske v goriški palači Attems-Petzenstein
475 Darija Mavrič, SolkanVedute kot možen vir za preučevanje baročnega vrtnega oblikovanja na GoriškemLe vedute come fonte per lo studio dell’architettura dei giardini del Goriziano nel Barocco
489 Marina Bellina, UdineMotivi decorativi nei tessuti e nei ricami del periodo barocco nel GorizianoOkrasni motivi na blagu in vezeninah v baročnem obdobju na Goriškem
499 Ferdinand Šerbelj, LjubljanaUkradena preteklostIl passato rubato
507 Avtorji / AUTORI
67
Verso la metà del Seicento il colonnello Locatello Locatelli, noto in tutto Impero per il valoroso servizio prestato nella Guerra dei Trent’Anni, rientrò nella natia Cormòns per godersi il meritato riposo. L’imperatore Ferdinando III lo ricompensò accordando alla sua famiglia il titolo baronale con i predicati di Eulenburg e Schönfeld, cui seguì la donazione di trecento campi da scorporarsi dai beni comunali di Cormòns, soluzione di compromesso dovuta alla proverbiale man-canza di fondi nella cassa imperiale.1 L’alienazione dei terreni comunali, sin dal Medioevo concessi in uso ad una comu-nità per lo sfruttamento dei pascoli e dei boschi, rappresentò uno dei problemi più gravi dell’economia agraria goriziana nel Seicento e Settecento. Nel caso particolare della donazione imperiale a Locatello Locatelli, l’alienazione dei terreni comunali destò animose reazioni tra nobili e popolani di Cormòns, rasentando la sommossa popolare. La scorporazione dei trecento campi e il relativo passaggio di proprietà a Locatello Locatelli si concluse solamente dopo più di dieci anni di dispute, proteste e vane misurazioni. Infine, il nuovo possedimento dei Locatelli comprese pressappoco tutta la località di Novali, situata tra Cormòns e Medana.2 Tra i vigneti, all’incrocio della strada che da Plessiva porta a Cormòns, i Locatelli costruirono una casa padronale. Per dare consistenza al recente titolo baronale, i trecento campi vennero chiamati Schön-feld, ossia “Belcampo”, mentre alla casa venne dato il nome alquanto pretenzioso di Eulenburg, “Castelcivetta”, riferito allo stemma di famiglia nel quale campeggiava una civetta.
Due secoli più tardi, nel 1861, il barone Antonio Locatelli risolse di vendere ciò che era rimasto del vecchio podere di Novali. Suo figlio era fuggito in Italia spinto dall’entusiasmo dell’irredentismo e il titolo di baroni di Eulenburg e Schön-feld era stato già da qualche tempo usurpato, con il beneplacito sovrano, da un altro ramo della famiglia, non titolato, che però poteva vantare ricchezza e provata fedeltà alla casa d’Austria. La tenuta di Novali fu così acquistata dal barone Giuseppe Formentini. L’antica casa di Eulenburg era allora poco più di una fattoria, nota nel circondario con il toponimo sloveno Čemajna, benché fosse abitata da una famiglia colonica friulana. In quel tempo il capofamiglia era Domenico Go-deas, famigliarmente detto Barba Meni.3 In quella vecchia casa erano rimaste alcune cose appartenute ai Locatelli, tra cui un mucchio di carte ingiallite. Il gioviale Barba Meni aveva tratto in salvo queste carte abbandonate dagli antichi padroni, pur non avendo saputo resistere alla tentazione di riempire alcuni fogli liberi, non ricoperti delle ispide scritture dei secoli passati, con le proprie annotazioni: una canzonetta in friulano, i punti delle partite a briscola, i conti della spesa e le dosi di zolfo per l’irrorazione delle viti. Il nuovo proprietario, Formentini, era invece un cultore di storia patria e riconobbe subito in quelle carte ciò che rimaneva dell’archivio dei baroni Locatelli, con documenti risalenti al Cinquecento e ai secoli successivi. Debitamente ordinate, le carte dei Locatelli formarono alcune cartelle di documenti che andarono ad arricchire l’archivio dei Formentini. Al di fuori della raccolta rimase un consistente quaderno di diversi fascicoli, dall’aspetto tut-t’altro che appariscente. In tempi lontani, quando trovare un pezzo di carta per scriverci sopra non era tanto facile, molte carte erano state ritagliate, il quaderno era stato in parte smembrato e privato dell’originaria rilegatura in pelle. Le prime pagine di questo quaderno presentano un sommario del contenuto in ordine alfabetico, mentre alla sesta carta si legge, dopo l’invocazione “Angelus et Joseph, Jesus et Maria nobiscum sint in omni via”, una sorta di introduzione narrativa al quaderno: “L’anno 1706 diedi principio a scriver in questo Libro chiamato universal, per aver notato per memoria assai
1 Il titolo baronale fu concesso ai fratelli Locatello e Antonio Locatelli dall’imperatore Ferdinando III con diploma datato Vienna, 20 maggio 1647 (Archivio Formentini, Fondo Locatelli, b. VII, fasc. 248), cui seguì immediatamente l’atto di donazione dei trecento campi, datato Graz, 8 giugno 1647 (Archivio Formentini, Fondo Locatelli, b. VII, fasc. 251).
2 La donazione imperiale ai Locatelli è stata sinora erroneamente identificata con la tenuta di Langoris, appartenente ad un altro ramo della famiglia. Il verbale della misurazione e assegnazione definitiva dei trecento campi, datato 23 settembre 1658, si trova in: Archivio Formentini, Fondo Locatelli, b. VII, fasc. 240, cc. 17v–18.
3 Domenico Godeas era il nonno materno del futuro poeta Alojz Gradnik: Marja BORŠNIK, Pogovori s pesnikom Gradnikom, Maribor 1954, p. 7. Ringrazio Vanda Gradnik di Cormòns che, oltre a fornirmi questa fonte, mi ha gentilmente aiutato a ricostruire le vicende della casa di Novali.
Alessio Stasi, Gorizia
Francesco Locatelli e il suo Libro universal: vita e cultura dell’età barocca nel diario di un nobile cormonese
Barok na Goriškem
68
cose, come anco l’aniventario di tutti li miei mobili di casa, di tempo in tempo fatti, ed altri miglioramenti come si vede destintamente”.4 Si tratta di un diario domestico del barone Francesco Locatelli, vissuto a Cormòns tra Sei e Settecento.
L’autore del Libro universal discendeva da una di quelle numerose famiglie di mercanti ed imprenditori appartenen-ti alla nobiltà minore di Bergamo che nel Cinquecento capitarono nel Goriziano, in cerca di nuovi sbocchi commerciali. I Locatelli furono senz’altro il gruppo famigliare più numeroso che, verso la metà del Cinquecento, si trasferì nel Goriziano.5 Il paese d’origine era Locatello nella Valle Imagna e le famiglie che ne portavano il nome avevano in comune lo stemma con un allocco posato su un monte di tre cime ed accompagnato da tre stelle. Si trattava evidentemente di un’arma parlante, rife-rita al cognome Locatelli, derivato dall’espressione dialettale bergamasca per allocco, “loc”. Stabilitisi in un primo periodo a Gradisca, i Locatelli si trasferirono poi a Cormòns. Abbandonato il commercio, molti della famiglia optarono piuttosto per la carriera militare, che era la via più sicura per ottenere buoni emolumenti e prestigio. È il caso del già menzionato colon-nello Locatello Locatelli che grazie alla sua straordinaria carriera militare aumentò il prestigio e il patrimonio di famiglia. Sebbene non equiparabile alle ricchezze delle principali famiglie di Cormòns, quali i Della Torre, i Neuhaus e i Delmestri, la posizione dei Locatelli era del tutto rispettabile. Il colonnello era rimasto celibe, cosicché il compito di portare avanti la famiglia spettava al fratello Antonio, che ancor prima che la sua famiglia fosse elevata al rango baronale ed aggregata agli Stati Provinciali di Gorizia fece un ottimo matrimonio, assicurandosi illustri parentele e una cospicua dote.6 La moglie, più
4 Il Libro universal è conservato nel Fondo Locatelli dell’archivio Formentini a San Floriano del Collio, senza alcuna numerazione o collocazione. Si presenta come un quaderno in folio di quattro fascicoli rilegati, mentre del quinto si conservano unicamente due carte. Sono numerate le carte, che attualmente comprendono un totale di 72, ma dal sommario risulta che originariamente le carte numerate erano almeno 89. Delle carte perse si sono conservate, riposte altrove ed ora reintegrate, le due carte 75 e 88. La carta presenta la marca filigranata di tre mezzelune. Nella citazione dei passi di questo come di altri documenti d’archivio si è cercato di portare il testo a una forma quanto più scorrevole, eliminando particolarità grafiche ed errori ortografici, rivedendo l’interpunzio-ne, ma conservando coerentemente tutte le particolarità linguistiche e sintattiche, per conservare la fragranza del modo di parlare dell’epoca in una forma grafica immediatamente comprensibile. Ringrazio l’amico Filippo Formentini che ha gentilmente messo a mia disposizione il proprio archivio di famiglia.
5 Notizie di prima mano sulla famiglia si trovano nel Fondo Locatelli dell’Archivio Formentini e, in sintesi, in alcuni testi a stampa: Rudolphus CORONINUS DE CRONBERG, Fastorum Goritiensium liber primus, Viennae 1769, pp. 100–103, e nel cenno redatto dal genealogista friulano Enrico del Torso in: Vittorio SPRETI et al. Enciclopedia storico-nobiliare italiana, Milano 1928–1936, 4, pp. 128–129.
6 L’aggregazione dei Locatelli agli Stati Provinciali di Gorizia risale al 28 febbraio 1659. Cf. Carlo MORELLI DI SCHöNFELD, Istoria della Contea di Gorizia, Gorizia 1855–56, 2, p. 117.
L’incipit del Libro universal di Francesco Locatelli (1706)
Il Barocco nel Goriziano
69
giovane di quattordici anni, era la baronessa Lisetta di Neuhaus, discendente dal ramo cormonese di quest’antica famiglia. Francesco Locatelli nacque da questo matrimonio il 15 aprile 1656, a Cormòns, terzultimo di quattordici figli.
Scarse sono le notizie sull’educazione ricevuta da Francesco. È verosimile che egli abbia studiato dapprima nel colle-gio dei gesuiti di Gorizia, per passare poi all’università di Padova, dove, a quanto pare, approfondì lo studio della matema-tica. Terminati gli studi, trascorse la giovinezza in stretto contatto con i fratelli, dei quali, oltre a lui, uno soltanto si sposò, lasciando però un’unica figlia. La prepotenza e la violenza, al tempo così diffuse tra nobili e popolani, infierirono anche nella famiglia Locatelli. Uno dei fratelli, Felice, nell’intento di salvaguardare l’onore della sorella Elisabetta, fu coinvolto in uno scontro con il barone Giovanni Antonio Delmestri e perse la vita in seguito a delle archibugiate, non ancora ventiquat-trenne. Un altro fratello, Giacomo, che in quell’occasione era scampato alla morte, fu ucciso dodici anni dopo dal fratello di Delmestri, il barone Stefano, che intendeva sparare al proprio fratello assassino e non a Locatelli, di cui era amico. Ma Francesco non aveva nulla del carattere litigioso e prepotente dei fratelli: le sue annotazioni rivelano piuttosto un carattere mite ed equanime. Qualche anno dopo l’assassinio del fratello si limitò ad annotare in questi termini la fine di Delmestri: “Questo malfattore andò poi disperato a servire un nobile veneziano sul Padovano, qual trovò da dire con altro uomo bravo di detto nobile e questo con una pistolata lo ammazzò e così pagò il tributo della sua infamità, che volendo ammazzar suo fratello, colpì due suoi amici, con risigo di cinque sei, per essere tutti in truppa che camminavamo un drio l’altro.”7
La narrazione del Libro universal si apre con la morte del padre, avvenuta quando Francesco aveva appena com-piuto il ventesimo anno di età: “Il signor mio padre rese l’anima al suo Creatore, che sia in cielo, l’anno 1676, l’ottava di Pasqua di Resurrezione, in età di anni 71, munito di tutti li santissimi Sacramenti, anzi, per maggior sicurezza dell’anima, prima di morire, sano andò a prender il perdono lo penultimo venerdì di quaresima alla veneranda chiesa della Subida, concesso dalli Sommi Pontefici come oggidì si pratica comunemente. Sicché, fatto la sua devozione, morse come dissi
7 Libro universal (nota 4), c. 4r.
Scorcio di Cormòns nel 1704, particolare da: Pietro Bainville, San Filippo Neri con la Madonna e il Bambino (Cormòns, Museo Parrocchiale)
Barok na Goriškem
70 sopra, perciocché buttatosi al letto l’istesso giorno della sua devozione, all’ottava di Pasqua andò al Creatore”.8 La morte del padre coincise per Francesco con le prime responsabilità e il graduale ingresso nell’età adulta.
Due erano le possibilità per un giovane nobiluomo di acquisire quell’esperienza di uomini e cose che gli sarebbe stata necessaria per il suo inserimento nella società. La prima e più prestigiosa era quella di intraprendere un lungo viag-gio di diporto in diversi paesi, che tuttavia era molto oneroso, la seconda era quella di partecipare attivamente a qualche campagna militare. La tradizione famigliare, lo spirito d’avventura, ma anche la malcelata avversione per lo “stare tutti a casa oziosi” spinsero Francesco ad arruolarsi nell’esercito imperiale.9 In un piccolo quaderno di appunti che portò con sé così narra la propria partenza: “Addì 15 aprile 1684 io Francesco Locatelli barone eccetera partii il suddetto giorno, mese ed anno alla guerra in Ongaria, giusto l’anno che fu liberata Vienna dell’assedio del turco. Il giorno suddetto ancora fornii anni ventotto della mia età. Partii dico con il signor barone Carlo Volchero de Dorinberg capitanio di corazze di Sua Maestà Cesarea nel Reggimento dell’Altezza prencipe Carlo di Neuburgo”.10 Locatelli registra puntualmente quanto portò con sé in viaggio, accompagnato dal servitore Gasparo Saiz e dalla cagnetta “Gemma, che fornirà due anni il primo di maggio prossimo”. La destinazione era l’accampamento militare situato sul confine ungherese, presso la cittadina di Szentgotthárd, e Locatelli lo raggiunse viaggiando attraverso la Carniola e la Stiria, fermandosi a Lubiana, dove acquistò tra l’altro un cavallo dal manto leardo e visitò il giardino del conte di Auersperg, e infine a Radgona, sosta in cui registra laconicamente un compenso dovuto a una non meglio specificata “donna di soldato”.
Rientrato dopo un anno, Locatelli avrebbe voluto ripartire per la guerra, ma la madre e i fratelli maggiori lo spinse-ro a prender moglie. Sposò la baronessa Anna Delmestri, più giovane di tredici anni, che gli diede otto figli e morì prema-turamente a ventinove anni. Nella società del tempo il matrimonio era un aspetto troppo importante della strategia sociale ed economica di una famiglia per essere lasciato alla decisione e alle preferenze del singolo individuo. Quello di Locatelli rientra in piena regola nell’ambito dei matrimoni combinati, per la decisione indotta dalla famiglia e in parte anche per la scelta della sposa. Ne è una prova il breve cenno riguardante la morte della “poverina”, come egli la chiama, scrivendo che lo “lasciò dopo undici anni di buona compagnia con quattro putti e una putta”.11 Qualche anno dopo, nell’occasione della morte della madre, Locatelli annotò nel Libro universal un ricordo ben più sentito e commosso. Tuttavia, la tendenza di chi considera al giorno d’oggi queste circostanze è quella di pensare a drammi famigliari legati a matrimoni e monaca-zioni forzate. In realtà queste decisioni venivano prese quasi sempre serenamente, in seno alla famiglia, poiché vi era un modo ben diverso di scegliere il proprio stato di vita da quello che è in uso oggi. Lo stato di vita, che sia il matrimonio, la vita religiosa o semplicemente una determinata professione, era scelto con il criterio della convenienza sociale: l’individuo si sentiva in dovere di adeguare le proprie doti ed aspirazioni alla scelta di un determinato ruolo sociale, in funzione alle esigenze e possibilità della famiglia, e in genere con senso di responsabilità nei confronti della comunità di cui faceva parte. È pertanto tendenzioso attribuire a queste scelte per così dire indotte dalla famiglia un senso negativo, partendo dal presupposto dell’individualismo che caratterizza la società attuale.
Dopo la scomparsa della madre, i figli si dimostrarono sempre più refrattari all’educazione. I maschi furono man-dati a Gorizia al ginnasio dei gesuiti. Abitavano assieme a un paggio in una casa presa in affitto, ritornando a casa una volta al mese, in groppa a un asinello ed accompagnati da un servitore. I primi due figli rientrarono a casa dopo qualche anno, come osservò il padre deluso, “per non aver voluto studiare”.12 Il secondogenito Carlo Antonio, dopo aver abbandonato gli studi, si lasciò andare ad una vita sregolata. Alla vigilia di Pentecoste del 1709 accadde un fatto che segnò per sempre la vita di questo figlio ribelle, allora diciassettenne. Rientrato da una caccia sul Monte di Medea, offrì il pranzo a tutta la compagnia nella casa di suo padre a Borgnano.13 Il giovane barone era già alticcio, quando, rientrato a Cormòns, si fermò
8 Libro universal (nota 4), c. 1r. 9 Libro universal (nota 4), c. 2r.10 Questa e le due citazioni successive sono tratte da: Archivio Formentini, Fondo Locatelli, fasc. sciolto 40.11 Libro universal (nota 4), c. 4r.12 Libro universal (nota 4), c. 59r.13 La tenuta dei Locatelli era situata a Villaorba presso Borgnano. Comprendeva la casa padronale con cappella, edifici rurali e ampi
terreni. Dalle mappe catastali e relativi elaborati del 1812 la tenuta, il cui nucleo era costituito dalla particella 1321, risulta ancora di proprietà dei baroni Locatelli, sebbene il complesso padronale fosse già da tempo in rovina (Archivio di Stato, Gorizia, Catasti
Il Barocco nel Goriziano
71a cena in casa dell’amico cacciatore Orazio Delmestri. L’ospite testimonierà in seguito che l’amico Locatelli “bevette pari-mente e d’avvantaggio, s’alterò col vino bevendo”.14 Rientrato a casa, ebbe uno scontro con un tale Giacomo Slizza che ferì mortalmente con una pistolettata. Dopo alcuni anni di carcere, rimesso in libertà, Carlo Antonio poté attuare la decisione che aveva maturato durante la detenzione. Dopo aver ottenuto la dispensa canonica dall’impedimento, intraprese gli studi di teologia e nel 1715 fu ordinato sacerdote. Successivamente divenne monaco agostiniano a Udine e morì in tarda età. Degli otto figli di Francesco solamente il primogenito Giorgio si sposò, due maschi e una femmina morirono nell’infanzia, mentre gli altri scelsero tutti la vita religiosa: Elisabetta divenne monaca domenicana, Carlo Antonio, come si è visto, agostiniano, Andrea e Giuseppe cappuccini. Dalle annotazioni del Libro universal traspare l’ambiente profondamente cri-stiano della famiglia di Francesco Locatelli, improntato a una serena e consapevole osservanza religiosa ma lontano dagli eccessi e superstizioni talvolta diffusi anche nelle classi più colte. Francesco Locatelli manteneva un cappellano domestico ed aveva legami molto stretti con il vicino convento dei cappuccini, più volte ricordati “con tanta carità ed affetto”.15
Oltre all’educazione dei figli, una delle maggiori preoccupazioni di Francesco era la gestione del patrimonio fa-migliare. Il fratello maggiore Giovanni Battista si era stabilito a Gorizia, mentre nel frattempo erano morti, oltre ai due fratelli assassinati, anche Andrea e Carlo, rimasti celibi.16 Così Francesco divenne l’unico proprietario del palazzo di fami-glia a Cormòns, situato non lontano dalla chiesa dei cappuccini.17 Il palazzo, più volte ingrandito nel corso del Seicento, presentava una pianta irregolare. La facciata rivolta sulla strada era caratterizzata da un arco, chiamato allora Portico dei Rivolt, dal nome della famiglia che vi abitava.18 Il tratto più rappresentativo del palazzo era caratterizzato da un por-ticato che guardava sul giardino interno e le cui pareti erano affrescate con stemmi e motivi decorativi. In questo tratto del palazzo, che diversi decenni fa è stato ridotto in un anonimo falansterio, erano situati gli appartamenti e la cappella, ultimata nel 1705 e dedicata all’Annunciazione. Il giardino interno era delimitato da tre lati dal palazzo e dall’altro dagli annessi rustici, in cui si apriva un portone in pietra bugnata, tuttora esistente, che immetteva nella corte con le stalle, gli orti, i frutteti e i vigneti retrostanti, la cosiddetta Braida Bancaria. I particolareggiati inventari del Libro universal rendono un’idea degli interni del palazzo, di cui si può intuire il caratteristico sussiego del barocco maturo.
Della decorazione pittorica del palazzo si era occupato un pittore goriziano, Santo Comiz, che aveva anche ese-guito diversi ritratti di famiglia. Locatelli annotò che il pittore “li toccò assai bene, che ne restai soddisfatto d’aver questa memoria in casa”.19 Nella cappella c’era una pala d’altare raffigurante l’Annunciazione, mentre ai lati erano dipinti San Francesco e Sant’Antonio. Alle pareti del corridoio erano appesi tre dipinti di soggetto biblico, Giobbe, la decollazione del Battista e Giuditta, e inoltre sei dipinti di carattere allegorico. Nel salone attiguo alla cappella erano appesi dodici ritratti di famiglia e diversi altri quadri, definiti “spirituali”. Gli altri dipinti erano perlopiù di soggetto sacro, storico, mitologico ed allegorico. Come esempio di cultura abitativa del tempo, conviene citare per esteso la descrizione della camera da letto di Francesco Locatelli: “Nell’altra camera contigua che ora dormo: il letto fornito di cavalletti sotto, con tre cantoni dorati, con friso attorno di seda con sua franza, il ciel sopra detto letto depinta l’Annunziata, con sei pezzi di coltrine attorno col sfriso di sopra e franza color verde di seda, un oratorio con cancelli, un armaro compagno con scancelli, due casse, un
secoli XIX–XX, Comune Censuario di Cormòns, Registro 20, p. 82). Oggi la villa è del tutto scomparsa, mentre si sono conservati alcuni rustici rimaneggiati.
14 Testimonianza del barone Orazio Delmestri, datata Cormòns 12 agosto 1709, in: Archivio Formentini, Fondo Locatelli, b. IV, f. 19.15 Libro universal (nota 4), c. 4v.16 Qualche anno prima della morte, avvenuta a distanza di pochi anni l’uno dall’altro, Andrea e Carlo Locatelli avevano sistemato una
delle due cappelle laterali del santuario della Castagnevizza, commissionando alla bottega degli scultori Pacassi l’altare e la lapide della tomba dove furono sepolti. La pietra porta inciso lo stemma baronale dei Locatelli e l’epitaffio: “ANDREAS ET CAROLVS FRATRES / LOCATELLI LI: BA: D’AILEMBVRG / ET SCHENFELD HOC SIBI / POSTERISQUE SVIS / POSVERE MONVMENTVM / ANNO DOMINI / M.DC.LXXXXII”.
17 Il palazzo dei baroni Locatelli è stato sinora erroneamente identificato con l’attuale municipio di Cormòns, appartenente in realtà al ramo che nel 1838 si fece riconoscere arbitrariamente il titolo baronale. Del palazzo di Francesco Locatelli si è invece conser-vata soltanto un’ala e alcuni fabbricati, contrassegnati dai numeri 4 e 6 di via Zorutti (il complesso si estendeva sulle particelle catastali 572–578, come risulta da: Archivio di Stato, Gorizia, Catasti secoli XIX–XX, Comune Censuario di Cormòns, Registro 20, p. 38). Ringrazio l’attuale proprietario Eraldo Sgubin che assieme alla moglie mi ha gentilmente informato sulle più recenti vicende dell’edificio.
18 L’attuale accesso a Via dei Pini.19 Libro universal (nota 4), c. 17r.
Barok na Goriškem
72
armaro incassato nel muro, depinta la facciata d’istorie della Sacra Scrittura, il muro della camera coperto di corri d’oro, cadreghe con intaglio sei, un sforzieretto, una cassetta quadra con cassettini dentro, due cavedali di fuogo sotto il camin col circolo, una pala e mollette, più un quadro requadrato dell’Annunziata Maria, uno del Redentor, uno di Lucrezia Romana, sopra le finestre, porte e armaro nel muro sei altri quadri requadrati, paesetti con indoratura, il quadro dell’An-nunziata a capo al letto, fornito da basso con una bella croce di manufattura con ostia papal in mezzo, sotto questa un Crocifisso intagliato nella medema croce, più sono altri fornimenti di medaglie che pendono sopra cordelle, crosette, brevi ed altro, più un specchio grando requadrato, un altro piccolo, una pettenera, mia spada d’argento, una sabla, un maioletto di cera col suo ferro come una forfice, una cassetta in cassinella per comodo, dentro le fenestre tre bandinelle di tela verde, fenestre di lastre con gli scuri di fuora, con tutti i suoi ferri che nulla manca, così la porta”.20
Situata ai margini dell’abitato di Cormòns, dove le ultime case segnavano il confine con l’aperta campagna, la dimo-ra dei Locatelli aveva il vantaggio di riunire in sé le caratteristiche del palazzo di città con quelle della casa di campagna come centro di attività agricole. La proprietà terriera rappresentò, nell’età barocca e ancor oltre, la risorsa economica primaria della maggior parte dei nobili. La terra possedeva, nella forma mentis del nobile dell’età barocca, una valenza pratica ed una simbolica. Da una parte infatti garantiva il sostentamento dignitoso della famiglia, dall’altra costituiva il fondamento dell’identità nobiliare, dell’immagine che il nobile voleva trasmettere di sé e della propria famiglia alla socie-tà che lo circondava. La terra, nella solidità che la caratterizza e di cui mancano le altre forme di ricchezza, ricollegava il nobile in maniera forte e inconfondibile al passato della propria patria e della propria famiglia. La proprietà terriera era per il nobile una sorta di blasone, che assieme alla genealogia rappresentava per lui e agli occhi degli altri un’iden-tità sicura e una garanzia di continuità. D’altra parte la proprietà terriera offriva al nobile una posizione di predominio nella vita locale, per il potere che egli aveva di intervenire nella vita dei propri fittavoli. Si trattava certo di un legame di
20 Libro universal (nota 4), c. 66.
Stemma dei baroni Locatelli sulla lapide sepolcrale nel santuario della Castagnavizza (1692)
Il Barocco nel Goriziano
73
tipo paternalistico, caratterizzato dall’assoggettamento del contadino al signore, ma fondato pur sempre su un rapporto di mutua lealtà. Ritornando al nostro caso particolare, le precise annotazioni del Libro universal sembrano riflettere un atteggiamento giusto ed equilibrato da parte di Locatelli nei confronti dei sudditi. Non a caso l’ultimo scritto conservatosi tra le sue carte è un ricorso contro l’erario a difesa dei propri coloni di Novali.
L’introito principale di casa Locatelli era rappresentato dalla vendita annuale del vino. Il centro dell’attività vinico-la era la tenuta di Novali con la casa padronale, già ricordata con il nome di Eulenburg, e i suoi annessi rustici.21 I vigneti di Novali, piantati in terreni fertili e riparati, garantivano un’eccellente produzione di vino. Nel Libro universal Francesco Locatelli trascrisse una dettagliatissima Nota della quantità delle ribolle e vini terrani che ogni anno ho fatto, in cui sono registrate puntualmente le caratteristiche di ogni annata dal 1688 sino al 1724.22 Per alcune annate è riportata anche la produzione di olio d’oliva. La coltivazione di viti ed alberi da frutto era infatti promiscua. Particolarmente interessante è una nota riportata per l’annata 1712: “Fu un anno così tempestoso, che rovinò tutto il paese, sì di uve come di sorghi e saracini, che non lasciò si puol dire niente, poiché tempestò tutta l’estate ogni luna e poi fornì di confiscar tutto li 18 ago-sto, a segno tale che a me conviense comprar del vino per il bisogno di casa mia. Sicché nessuno in Cormòns ebbe peggio di me, poiché non mi lasciò un albero né vite che non la disfece, e poi temporali di venti così terribili che mi fece danni immensi sopra li coperti delle case e tetti di paglia spiantati sino a terra. Nel mio bosco sradicati alberi e massimamente li castagnari, centinaia di piedi nel bosco sramazzati e restato il sol tronco, quali dovei farli spiantar affatto per non esser mai più buoni da niente. Ho fatto questa memoria veramente per esser una cosa insolita, né mai più a memoria di uomo
21 La casa di Eulenburg, situata sulla particella catastale 2830 del comune di Cormòns, al numero civico 12 di Novali, è stata più volte rimaneggiata negli ultimi decenni. Perfettamente conservata è la cantina sotterranea. Ringrazio gli attuali proprietari Franco e Renato Toros che mi hanno gentilmente ragguagliato sulle ultime vicende della casa, fornendomi l’immagine della tenuta prima dei rifacimenti, qui riprodotta.
22 Libro universal (nota 4), c. 46r–48r.
La casa di Eulenburg nei Novali (secolo XVII) nel 1965
Barok na Goriškem
74 s’ha sentito cotal strage. Castigo veramente dell’Onnipotente mano, in tempo che tutta l’Europa è in guerra: cristiani con cristiani, questi con luterani, quelli con questi, e tutto il mondo sottosopra. Che il Signore sia quello che ne liberi in avve-nire di tutte le suddette calamità per sua santa bontà e misericordia. Amen”.23
Molte delle annotazioni del Libro universal offrono un’immagine puntuale delle abitudini e soprattutto della cultura materiale del tempo. Alcuni appunti di Francesco Locatelli rivelano uno spiccato gusto per la buona cucina. La tavola di casa Locatelli, pur non essendo ricercata, offriva il meglio che potesse offrire la produzione domestica in fatto di carni, verdure e formaggi. Dalle annotazioni traspare anche una certa predilezione per il pesce, soprattutto quello d’acqua dolce. Locatelli fece costruire una peschiera nel giardino del palazzo di Cormòns ed un’altra nel podere di Nova-li. Nell’agosto del 1706 annotò con rammarico: “Feci sugar la peschiera nelli Novali e trovai poco pesse, rispetto che fu rubato senza saper chi, altramente si averia trovato un conzo di roba. Eppur non trovai altro che tenca d’un anno o due al più ed anguilla assai bella.”24
Francesco Locatelli nutrì una passione particolare per la caccia e le armi, come risulta dalla descrizione dell’ar-meria. Qui si trovavano ben quarantadue fucili e tredici paia di pistole, oltre ad altri ordigni, come ad esempio “un ferro da pigliar animali”. 25 Anche la scuderia di palazzo Locatelli era particolarmente ben fornita: si intuisce anzi una certa predilezione del padrone per i cavalli bai. Un ambito invece in cui Francesco Locatelli pare assoggettarsi ai gusti delle donne di famiglia è quello della moda e dell’abbigliamento. Alla moglie Anna regalò “un abito di broccato d’oro comprato a Venezia”, oltre a diversi gioielli, tra cui “sei fili di perle fine”.26 La figlia Elisabetta dovette invece accontentarsi di “un filo di perle grosse alla moda, false”.27
Il Libro universal e gli altri documenti dell’archivio Locatelli offrono interessanti indizi sulla dimensione culturale e linguistica nell’ambito nobiliare goriziano. Per quanto riguarda la lingua corrente tra la nobiltà goriziana in epoca baroc-ca, questa è senz’altro l’italiano, con le inflessioni tipiche della parlata locale, avendo resistito pure come lingua dotta ed ufficiale, nonostante i tentativi di imporre il tedesco come “Amtsprache”, ossia lingua d’ufficio. Tuttavia, nell’uso corrente tra i nobili, anche lo sloveno e il friulano rivestono una discreta importanza. Queste due lingue, pur nel loro diverso svi-luppo nella prassi letteraria, sono accomunate da un destino simile: una certa borghesia, nella smania di conferirsi sempre un tono, guarderà con malcelato disprezzo a queste due lingue, considerate troppo volgari per poter servire come mezzo di promozione sociale. Se si trae spunto da questo pregiudizio, si stenta a riconoscere nello sloveno o nel friulano una lingua che potesse essere usata correntemente dalla nobiltà. Nell’ambito della mentalità e degli usi nobiliari, soprattutto in epoca barocca, è invece necessario saper distinguere quella che era la lingua ufficiale, largamente presente nella vita pubblica come anche nella produzione letteraria, da quella che era la lingua di uso corrente. Questa lingua corrente, appresa sin dall’infanzia dalla balia, dal sacerdote, dalla servitù e dagli amici, risulta essere talvolta anche la lingua d’uso famigliare, pure nei rapporti più stretti tra coniugi, genitori e figli, com’è nel caso di un epistolario in lingua slovena intercorso verso la fine del Seicento tra due nobildonne triestine delle famiglie Brückenthal-Corraduzzi e Marenzi.28 A titolo di curiosità, sebbene si riferisca ad un’epoca posteriore, valga l’esempio dello storico goriziano Carlo Morelli, che in casa della contessa Clementina Coronini, nata Leiningen, conversava in sloveno con una contessa Auersperg.29
La lingua d’uso in casa Locatelli era invece il friulano, come appare anche da alcune particolarità lessicali del Libro universal. Tra le carte dei Locatelli si è conservata una quartina, che il colonnello Locatello trascrisse in apertura della pro-pria traduzione in italiano delle lettere scrittegli in tempo di guerra da noti condottieri come Montecuccoli, Piccolomini e Gonzaga. Si tratta di quattro esametri in una combinazione maccheronica di friulano e latino: “Te mea pena preiat solum
23 Libro universal (nota 4), c. 52r.24 Libro universal (nota 4), c. 15v.25 Libro universal (nota 4), c. 68r.26 Libro universal (nota 4), c. 2v.27 Libro universal (nota 4), c. 56r.28 Pavle MERKÙ, Slovenska plemiška pisma, Trst 1980. 29 Il dato è dedotto dal diario dello statista Karl von Zinzendorf, pubblicato in: Antonio TRAMPUS, Economia e stato delle riforme nel
Litorale austriaco, in: Archeografo Triestino, s. IV, L (1990), p. 81: “Avec Morelli chez Madame Clementina, sa fille parle le Cragnolin” (si intende la figlia del conte Auersperg precedentemente citato).
Il Barocco nel Goriziano
75sis lector attentus: / saltavit bizzarria mihi de scribere gnozzas / furlanas: gustum grande promitto provabis, / ridebis tantum, quod de legrezza vaibis”.30 È chiaro che questi versi riflettono una valenza comica spesso attribuita al friulano in veste letteraria, resta invece meno chiaro l’aspetto ridicolo attribuito ad una raccolta di lettere di contenuto strategico e militare. Un’altra testimonianza dell’uso del friulano tra i nobili appartiene all’ambito della famiglia d’origine della nuora di Francesco Locatelli, la contessa Marianna Coronini di San Pietro, seconda moglie del figlio Giorgio. Si tratta di una let-tera in friulano scritta alla nobildonna dal fratello Giuseppe, parroco del Duomo di Gorizia, che le si rivolge chiamandola “chiarissima sur” e si firma in calce: “affietuosissim fradi Seff Curunin”.31
Gli interessi culturali di Francesco Locatelli si possono ricostruire, almeno in parte, dalla Nota di tutti i libri che mi ritrovo avere trascritta nel Libro universal.32 Relativamente pochi sono i libri di carattere religioso e anche i classici latini sono scarsamente rappresentati. C’è un immancabile Cicerone, quasi d’obbligo nella biblioteca del gentiluomo per la funzione pedagogica che gli viene attribuita, in quanto fonte sicura per apprendere un latino limpido e per accostarsi ai modelli di virtù nobiliari. C’è poi un nucleo di libri evidentemente appartenuti allo zio colonnello: si tratta perlopiù di opere storiche e di arte militare. La biblioteca di Locatelli rivela interessi d’indirizzo prevalentemente pratico e scientifico. L’interesse per un’indagine di tipo cosmologico e astronomico si riflette in alcuni titoli, presenti nell’elenco dei libri di Locatelli: Teatro del mondo del Sacrobosco, Teatro del mondo di Abramo Otelio, La sfera del mondo, Anatomia celeste, ma anche in titoli di opere di geografia di carattere più divulgativo. Numerosi titoli e qualche accenno nel Libro universal riflettono un interesse specifico di Locatelli per la misurazione di quanto nella cosmologia aristotelica, ancora in voga nell’età barocca, era considerato stabile ed incorruttibile, la terra, i cieli, ma anche il tempo. A giudicare dal numero dei titoli l’interesse principale di Locatelli era la matematica, la geometria e la meccanica. Tra questi titoli compaiono due edizioni delle opere di Oronzio Fineo, matematico francese del Rinascimento, che si occupò tra l’altro anche di geografia, geometria e cartografia. Tra gli autori di opere di geometria, come il classico Euclide e Francesco Patrici, compare anche il nome di Jean Taisnier, matematico belga che si occupò anche di scienze occulte, come la divinazione, la chiromanzia, la fisionomia e l’astrologia. Dall’elenco non risulta nessun’opera di astrologia, o forse Locatelli ritenne di celare questo suo interesse per un settore che non era particolarmente benvisto all’autorità ecclesiastica. Una prova del suo interesse per l’astrologia è offerta dalle annotazioni riguardanti la nascita dei nipoti, per ciascuno dei quali Locatelli effettua un accurato calcolo astrologico sulla posizione degli astri al momento della nascita. Valga come esempio l’annotazione riguar-dante la nascita del nipote Francesco: “1723 a 8 luglio, la suddetta signora mia nora diede in luce altro bambino non senza qualche travaglio di dolore stravagante, in giorno di giovedì alle ore 7 ½ dopo mezzodì, giusto al tramontar del Sole, che si trovava in gradi 18 di Cancro, la Luna aveva giorni 6 e si trovava in segno di Cancro, Luna d’agosto”.33 D’altra parte in quest’epoca è difficile stabilire limiti ben definiti tra astronomia pratica ed astrologia. Nel settore dell’astronomia fu parti-colarmente attiva in Austria la Compagnia di Gesù: nella biblioteca di Locatelli non manca il nome del gesuita Christoph Clavius, famoso maestro di astronomia pratica. L’interesse principale di Locatelli, in cui aveva anche raggiunto una certa competenza tecnica, era invece la gnomonica, ossia la costruzione di meridiane, ma anche la fabbricazione di orologi ed altri strumenti scientifici. Diversi sono i manuali riguardanti la costruzione di orologi, presenti nell’elenco dei libri, e più di un’annotazione del Libro universal fa intuire che Locatelli fosse un accurato costruttore di orologi e meridiane, oltre che osservatore empirico della fenomenologia celeste. Così è registrato un acquisto effettuato nel 1692: “Comperai a Venezia una sfera d’ottone con tutti li circoli. Io ne feci una, prima che ebbi questa, quale mi serve d’orologio da sole universale e mi serve ancora da fabbricar orologi solari, instrumento da tenir conto poiché a comprarlo valarebbe assai”.34 Sulla fac-ciata laterale della casa di Novali esisteva una delle meridiane eseguite da Locatelli. Tra i suoi libri preferiti vanno infine menzionati quelli riguardanti l’agricoltura e la vita di campagna, come anche diversi manuali sulla caccia, l’equitazione, la
30 Archivio Formentini, Fondo Locatelli, b. VIII, f. 26.31 Archivio Formentini, Fondo Locatelli, b. VII, f. 265. In questo caso l’uso del friulano non può essere ricondotto ai luoghi d’origine
dei genitori: Marianna e Giuseppe Coronini erano figli di un Coronini di San Pietro e di una baronessa Waidmannsdorff, originaria della Carinzia.
32 Libro universal (nota 4), c. 75. L’elenco riporta 127 titoli, ma è privo dell’ultima parte.33 Libro universal (nota 4), c. 88v.34 Libro universal (nota 4), c. 32r.
Barok na Goriškem
76 pesca e alcuni volumi riguardanti aspetti particolari della ricreazione e dell’educazione nobiliare, come Duello, ma anche i più spiccioli Giuochi di fortuna e Virtù della cioccolata e té.
C’è infine un aspetto culturale della vita di Francesco Locatelli di cui non si sarebbe saputo nulla se non fosse stato tramandato da un cenno inserito in una raccolta di biografie del tardo Settecento. Egli viene presentato come compilatore di opere di gnomonica, geometria, matematica ed astronomia. Questo è infatti il profilo che ne traccia il biografo Pietro Antonio Codelli: “Francesco Benedetto nativo della terra di Cormòns, luogo poco distante da Gradisca, ebbe i suoi natali da nobili e comodi parenti verso la metà del secolo passato. Quest’uomo di gran lettura e di profonda penetrazione nell’età sua giovanile si diede intieramente allo studio più difficile, qual è quello delle matematiche, ed in questo ebbe campo di approfittarsi in Padova, laddove compì i suoi studi. Ritiratosi per accudir alle sue domestiche facende in patria, non lasciò inutili i suoi talenti: quindi approfittandosi del tempo diede mano a comporre un trattato degli orologi solari, opera molto comoda e vantaggiosa a’ meccanici: indi a non molto scrisse un trattato di geometria ed aritmetica, nel quale dimostra una gran cognizione delle matematiche, e ne dà un buon metodo e facile per apprender queste per altro astruse scienze. Avea principiato a scrivere qualche cosa circa l’astronomia; ma colto dalla morte l’anno 1682 lasciò imperfetto il suo lavoro. Questi mss. si conservano con gran gelosia nell’archivio di Giovanni-Giuseppe Coronini di S. Pietro conte di Cronberg.”35 Da una sommaria ricerca negli archivi locali non risulta conservata nessuna delle opere manoscritte di Locatelli. Nell’ar-chivio dei Coronini di San Pietro, dove i manoscritti erano giunti attraverso la nuora di Locatelli, che apparteneva a quella famiglia, c’è un unico accenno ad un manoscritto di Locatelli, registrato in un catalogo del 1775. Si tratta di un trattato di gnomonica con il titolo Fabbrica degli orologi solari, di cui tuttavia non c’è più traccia.36 Certo non si sarà trattato di opere innovative, tuttavia il loro rinvenimento getterebbe indubbiamente un po’ di luce sulla produzione scientifica a Gorizia nell’epoca barocca, tutto sommato non trascurabile ma ancora in attesa di un’adeguata presentazione.
Negli ultimi anni le annotazioni del Libro universal si fanno sempre più rade. Francesco Locatelli, ormai prossimo alla settantina, può dirsi soddisfatto: non ha aumentato di molto il patrimonio, ma l’ha saputo conservare in maniera redditizia, per garantire una vita dignitosa ai discendenti. Tuttavia, subito dopo la sua morte, il figlio Giorgio avrebbe tra-scinato la famiglia in una grave situazione economica, seguita dal degrado morale in cui la precipitò di lì a poco il nipote ed omonimo di Francesco. Una fonte del 1768 definisce quella dei baroni Locatelli “una famiglia nobile comoda assai per il passato ed ora decaduta in basse fortune, ridotta alla necessità quasi di mendicare”.37 Il nipote omonimo di Francesco, Franzil, come era noto tra gli amici, nell’impossibilità economica di sposarsi e mantenere una famiglia, scelse come aman-te la moglie di un servitore dello zio, parroco di Gorizia. Per assicurarsi una discendenza legittima, sposò, ormai avanti con gli anni, una giovane nobildonna, Marianna Vihtelič de Wichtenstein. Il figlio Antonio avrebbe venduto i beni di famiglia, tra cui il podere di Novali con la casa di Eulenburg, abbandonandovi le carte d’archivio e il Libro universal. Anche il figlio di Antonio si sarebbe chiamato Francesco, ma avrebbe troncato definitivamente con la tradizione di famiglia. Partecipò ai moti del Quarantotto e si appassionò per l’ideale irredentista, stabilendosi prima a Milano e poi a Udine. I suoi discendenti vivono tuttora a Pavia di Udine.
Ma Francesco Locatelli, che traspose la propria vita moderata e parsimoniosa nel suo Libro universal, ebbe la ven-tura di non vedere neppure l’inizio della decadenza della sua famiglia. La morte venne per lui improvvisamente, il mattino del 4 aprile 1725. Tra qualche giorno avrebbe compiuto sessantanove anni. L’indomani all’imbrunire, mentre tutte le chiese dei dintorni suonavano l’avemaria, il feretro fu accompagnato attraverso le vie di Cormòns, in un suggestivo corteo di fiaccole e candele accese, tra il salmodiare dei sacerdoti e il muto calpestio dei passi. Così si chiudeva l’ultimo atto di
35 Pietro Antonio Codelli, Gli scrittori friulano-austriaci degli ultimi due secoli, Gorizia 1792, pp. 144–145. Il profilo biografico contiene due imprecisioni. La prima è il secondo nome Benedetto, evidentemente un arbitrario scioglimento dell’abbreviazione per “barone”, che Locatelli anteponeva sempre al cognome. La seconda è la data di morte: il manoscritto di astronomia lasciato incompiuto nel 1682, poco prima della partenza di Locatelli per la guerra, deve aver indotto il compilatore della biografia a crederlo morto in quell’anno.
36 Archivio Coronini Cronberg di San Pietro, Gorizia, Catalogo delli libri del Signore, Signore di San Pietro Conte Giuseppe Coronini, Go-rizia 1775, senza collocazione, p. 57. Ringrazio Giovanni Battista e Giuliana Coronini Cronberg che hanno gentilmente messo a mia disposizione il proprio archivio di famiglia.
37 Supplica dei curatori del patrimonio Locatelli all’imperatrice Maria Teresa, Gorizia 26 settembre 1768, Archivio Formentini, b. Lanthieri, Mels, Locatelli, Granada, f. 11.
Il Barocco nel Goriziano
77una vita intesa come uno spettacolo barocco: ora Francesco Locatelli avrebbe trovato posto nei sotterranei del Duomo di Cormòns, accanto ai suoi avi.
Il figlio Giorgio prese allora in mano il Libro universal, diede una rapida scorsa alle pagine, riempite della fitta e re-golare scrittura del padre. Vi lesse ancora una volta le parole scritte su di uno dei fascicoli: “Del tutto lascio memoria ai miei discendenti, acciò in loro coscienza come eredi che saranno dopo di me Francesco barone Locatelli debbano pontualmente supplire come ho fatto io ogni anno, il tutto come vederanno annotato”.38 Il figlio cercò allora uno spazio vuoto e vi annotò: “1725, addì 4 aprile alle ore nove la mattina rendé l’anima al sommo Iddio il quondam illustrissimo signore mio padre e sep-pellito fu il giorno seguente la sera di notte, cioé all’Ave Maria nel nostro solito monumento”. Poi, avendo inavvertitamente dimenticato di annotare il nome del padre, aggiunse tra parentesi la seguente postilla: “(di nome Francesco)”.39
Così, tra queste due parentesi, pare concludersi la vicenda di Francesco Locatelli e del suo Libro universal. È la sto-ria ordinaria, fatta di minuzie quotidiane, di una vita modesta e discreta, spesa ad amministrare un patrimonio famigliare con grande meticolosità e cura. Eppure tutte le annotazioni di Francesco Locatelli, anche i più aridi elenchi di numeri, non fanno altro che rispecchiare quegli affetti semplici e quella serenità che lo animavano, saldamente radicati nella consapevolezza che la vita, pur essendo legata, come una grande opera teatrale, a convenzioni sociali e necessità materiali, ne oltrepassa decisamente i limiti. Questo era anche l’ethos, puramente barocco, di Francesco Locatelli, che aveva saputo affrontare con tenace semplicità le contraddizioni della sua vita, superando la frattura tra rivendicazione di status sociale, possibilità economica ed esigenze interiori e personali. Diversamente da molti dei suoi colleghi di ceto, egli preferì tenersi lontano dall’inesorabile concatenazione di grandezza e miseria della sua epoca. Nella quiete delle campagne, tra libri, astrolabi e cannocchiali, si accontentò di misurare con quanta più precisione poteva il tempo che scorreva ed esplorare da lontano, giorno dopo giorno, un piccolo segmento di cielo stellato, dove poter contemplare, con gli occhi della più fervida fantasia barocca, il grandioso spettacolo dell’esistenza universale.
38 Libro universal (nota 4), fascicolo inserito senza numerazione.39 Libro universal (nota 4), c. 8v. Alla fine ringrazio Martin Pintar, amico sempre arguto e cordiale, che ha percorso con me più di un
tratto di questo itinerario sui sentieri del passato.
Barok na Goriškem
78 Francesco Locatelli in njegov Libro universal: življenje in kultura baročnega obdobja v dnevniku krminskega plemiča
Med doslej neznanimi viri za zgodovino baročnega obdobja na Goriškem je hišni dnevnik krminskega plemiča Francesca Locatellija. Na podlagi dnevnika, ki se je ohranil kot rokopis v nekem zasebnem arhivu, si je mogoče ustvariti živo podobo o življenju in kulturi v baročnem obdobju na Goriškem. Baron Francesco Locatelli je bil rojen v Krminu leta 1656, kot potomec trgovske rodbine iz Bergama, ki se je v 16. stoletju naselila na Goriškem. Francescov stric Locatello se je kot poveljnik izkazal v tridestletni vojni in zaradi njegovih zaslug je rodbina prejela baronski naslov. Tudi Francesco se je sprva posvetil vojaški službi, nato se je vrnil domov in si z ženo, baronico Anno Delmestri, ustvaril družino. Iz tega časa izhaja njegova skrb za upravo družinskega imetja, pa tudi posvečanje svojim kulturnim zanimanjem. V hišni dnevnik, ki nosi naslov Libro universal (Vsesplošna knjiga), je zapisoval pomembnejše družinske dogodke, dohodke in stroške pri gospodarjenju, podroben opis palače v Krminu in drugih posestev, poročila o nakupih in druge drobne podatke. V zakonu se mu je rodilo osem otrok, od katerih so trije zgodaj pomrli. Kot je bilo v navadi v plemiških družinah, ki se niso mogle zanašati na veliko posest in dohodke, se je edino prvorojenec oženil, ostali štirje pa so postali redovniki.
Francesco Locatelli je veliko skrbi posvečal opremi svoje palače v Krminu, od katere se je do danes ohranilo le stransko krilo. Pomembno vlogo je za Locatellija kot za druge plemiče igrala zemljiška posest zaradi svojega praktičnega in simbolnega pomena. Po eni strani je zemlja predstavljala glavni in skorajda edini dohodek, po drugi strani pa je bila temelj plemiške identitete. Plemiču je zemljiška posest zagotavljala vodilno vlogo nad podložniki, neizpodbitno pa ga je povezovala s preteklostjo lastnega rodu in domovine. Locatelli je leto za letom podrobno vpisoval v svoj dnevnik količino in kakovost domačih pridelkov, zlasti vina. Posredno pa nudi Locatellijev Libro universal tudi vpogled v kulturno in duhovno razsežnost življenja goriškega plemiča v baročnem obdobju. Tudi iz ostalih ohranjenih listin izhaja, da se je pri Locatel-lijevih govorilo furlansko. Nekatere struje domačega zgodovinopisja so furlanščino kakor tudi slovenščino predstavljale kot izključno kmečki jezik, ki so ga govorili le podložniki. Na Goriškem je kot uradni jezik sicer obveljala italijanščina, furlanščina in slovenščina pa sta bili v številnih plemiških družinah domači jezik za sporazumevanje, pravzaprav prvi jezik, ki se ga je plemič naučil od dojilje, domačega duhovnika, prijateljev in podložnikov. Osebni zapisi in seznam knjig, ki jih je prebiral, nam Locatellija predstavljajo kot umirjenega, a vedoželjnega podeželskega plemiča, ki se je veliko zanimal za znanstvena vprašanja, predvsem za matematiko, geometrijo, astronomijo in naravoslovje ter je svoje življenje utemeljeval na trdnem duhovnem prepričanju. Iz njegovih zapisov veje tudi globoko doživeta verska zavest.
Locatelli je sestavil tudi več rokopisnih del o vedah, s katerimi se je najraje ukvarjal, na primer o gradnji sončnih ur, ki pa se, kot kaže, niso ohranila. Kljub njegovemu zglednemu gospodarjenju je po njegovi smrti Locatellijeva družina propadla in se nazadnje odselila. Francesco pa, ki je umrl v rodnem Krminu leta 1725, ni videl propada svojega rodu. Še do zadnjega je skrbno pisal svoj dnevnik, se posvečal merjenju časa in opazovanju nebesnih pojavov. Morda je prav opazovanje prostrane nebesne površine najbolje odgovarjalo na njegova osebna vprašanja in najbolj nagovarjalo domišljijo njegove baročno čuteče duše.

























![Storia dell'Arco 2 - [Brovelli] - Dispensa didattica Corso OPS Storico parte seconda- Archi dell'Età del ferro - VI sec.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63203b9100d668140c0ceeb9/storia-dellarco-2-brovelli-dispensa-didattica-corso-ops-storico-parte-seconda-.jpg)