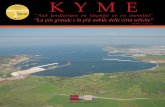Servizio Gestione Didattica - Didattica PoliTo - Politecnico di Torino
Un nobile cosentino al servizio dell’Impero: otia e negotia di Bernardino Martirano tra eredità...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Un nobile cosentino al servizio dell’Impero: otia e negotia di Bernardino Martirano tra eredità...
19,00
a cura di Donatella Gagliardi
Rubbettino
La cu
ltur
a ispanic
a nella C
alabria
del C
inq
ue-Seic
ento
Rubbettino
Si raccolgono in questa miscellanea i contributi che sedici specialisti di vari settori scientifico-disciplinari (storico, filologico-letterario, storico-artistico e architettonico) hanno presentato al convegno internazionale svoltosi presso l’Università della Calabria nella primavera del 2012, nell’ambito di un più ampio progetto di ricerca. Le strategie di gestione del potere (sia secolare che religioso) attuate dalla corte di Madrid nei territori calabresi; il rapporto controverso che nobiltà, funzionari, intellettuali e clero locali stabilirono sul piano politico e culturale con il governo centrale; l’influenza ispanica nella produzione filosofica, letteraria e artistica della Calabria cinque-seicentesca sono alcuni dei temi trattati in queste pagine, che ci restituiscono un’immagine della periferia calabrese dell’impero spagnolo ricca di nuove sfumature e di suggestioni finora inesplorate.
Donatella GaGliarDi insegna letteratura spagnola presso l’Università della Calabria. Tra le sue principali linee di ricerca si annoverano la trattatistica rinascimentale sull’educazione femminile, i romanzi cavallereschi, e la censura letteraria nel Siglo de Oro. Oltre a vari articoli e capitoli di libri, ha pubblicato una monografia su Beatriz Bernal, autrice del Cristalián de España (Zaragoza, 2010), e l’edizione bilingue della terza giornata del Ragionamento di Aretino (Roma, 2011). Sta ultimando l’edizione di una versione castigliana della Pietra del paragone politico, opera postuma di Traiano Boccalini.
In copertina: Palazzo Arnone (Cosenza), stemmi della volta dell’androne
La CuLtura iSpaniCa neLLa CaLabria DeL Cinque-SeiCento
Letteratura, Storia, arte
Do
natella G
agliar
di (a cura di)
Rubbettino
La cultura ispanicanella Calabria
del Cinque-SeicentoLetteratura, Storia, Arte
Rubbettino
a cura di
Donatella Gagliardi
Rubbettino
Tobia R. ToscanoUniversità di Napoli “Federico II”
Un nobile cosentino al servizio dell’Impero:otia e negotia di Bernardino Martirano tra eredità
pontaniana e sperimentalismo in volgare
La biografia di Bernardino Martirano1 evidenzia i tratti specifici di unatraiettoria comune a molti esponenti dell’umanesimo, che attraverso lo stu-dio del diritto ebbero accesso ai ranghi dell’amministrazione pubblica, fon-damento a sua volta dell’acquisizione di diritti feudali e quindi di uno sta-tus nobiliare. Nato a Cosenza intorno al 1490, Bernardino realizzò l’amplia-mento del patrimonio familiare, seguendo le orme del padre Giovan Batti-sta, elogiato nella Descrittione di tutta Italia di Leandro Alberti che lo ave-va conosciuto a Cosenza nel 1526, ricordandolo come «uomo di rado, et cu-rioso ingegno, che con le sue argute, et ornate rime volgari, a i mortali fa in-tendere l’altezza, sottilità et delicatezza della sua dottrina»2. Qualche annodopo Martirano padre dovette trasferirsi a Napoli in quanto risulta reggen-te della Vicaria negli anni 1529 e 1530. Inutile dire che delle «argute, et or-nate rime volgari» menzionate dal dotto domenicano non rimane traccia,ma gli si potrà credere sulla parola, giacché anche la produzione latina e vol-gare del figlio Bernardino, che fu certo abbondante, andò in buona parte di-spersa, non avendo egli avuto cura, mentre fu in vita, di pubblicare altro chela prefazione al commento di Aulo Giano Parrasio all’Ars poetica di Orazio(Napoli, Sultzbach, 1531), sette distici latini indirizzati a Giano Anisio, che
1 Ricostruibile a partire dalla monografia di POMETTI, 1896, che integrava le prime in-dagini di FIORENTINO, 1872, e successivamente arricchita di nuovi apporti dalle recensioni allavoro di Pometti rispettivamente di PÈRCOPO, 1898 e CROCE, 1953. In anni pù recenti credodi avere portato qualche nuova luce sui Martirano e le loro opere e tentato di definire in ma-niera meno approssimativa i contorni del loro circolo accademico a corredo dell’edizione cri-tica di uno dei due poemetti in volgare di Bernardino, Il pianto d’Aretusa: cfr. TOSCANO (a cu-ra di), 1993. Da ultimo si segnalano le documentate «voci» su Bernardino e Coriolano Mar-tirano firmate da VALERI, 2008 per il Dizionario biografico degli italiani. Onde evitare inutiliappesantimenti di note i fatti riferiti alla biografia dei fratelli Martirano sono riconducibili,tranne contrario avviso, ai titoli appena elencati.
2 La citazione è riportata da SPIRITI, 1750, p. 29, nota 1.
Rubbettino
li fece stampare nei suoi Variorum poematum (ibidem, 1536, c. 32r-v), e unaLugubris oratio […] in illustrissimi D. Iacobi Sabelli funere habita.
E proprio la lettura di questo rarissimo opuscolo3 in morte del condot-tiero Iacopo della nobile famiglia romana dei Savelli costringe a rimettere afuoco qualche tessera della biografia di Bernardino, dovendosi prendere at-to, come annota Elena Valeri, che
in età giovanile, molto probabilmente nel secondo decennio del secolo, il M.aveva composto un’orazione funebre in onore di uno dei suoi primi protettori, ilcondottiero Iacopo Savelli […], del cui figlio, Giovambattista, il M. era stato precet-tore, insieme con Lorenzo Palilio, nelle lettere latine e greche, secondo quanto rife-risce Benedetto Varchi.
Iacopo Savelli morì nel 15254 e abbastanza presto dovette subentrargliil figlio Giovambattista, annoverato da Guicciardini nella Storia d’Italia(1971, p. 1817) nel contesto dei condottieri impegnati nella difesa dello sta-to della Chiesa nelle vicende del 1527 che precedettero il sacco di Roma.
Quindi Bernardino era a Roma nel 1525 e pertanto va corretta l’afferma-zione degli antichi biografi secondo cui dall’autunno del 1523 si trovasse al se-guito del viceré di Napoli Charles de Lannoy, costretto a recarsi in Lombardiaper sedare contrasti sorti tra il papa e i capi dell’esercito imperiale. Il primo do-cumento che attesti la presenza di Bernardino a Milano nel seguito del ducaCarlo di Borbone è del 1° gennaio 1527 e quindi può essere più plausibile rite-nere che il passaggio dalla condizione di pedagogo, esercitata a Roma, a quel-la di consigliere-amministratore dell’esercito spagnolo, impegnato in Lombar-dia, vada collocata subito dopo la morte di Iacopo Savelli, che comportò il ve-nire meno della sua funzione, giacché il figlio di lui Giovambattista (nato nel1505) quasi subito dovette subentrare al padre nelle incombenze di guerra5.
Quasi sicuramente fu Aulo Giano Parrasio a introdurre Bernardino co-me precettore negli ambienti aristocratici di Roma6. È plausibile che, aven-dolo avuto tra i suoi allievi a Cosenza nel triennio 1511-147, dovette con-
3 Segnalato da TISANO, 1993.4 Tale data si legge sul sito www.condottieridiventura.it.5 Fatto che sembra implicito nella perorazione finale che a lui rivolge Bernardino nel
contesto dell’Oratio: «Tu vero ante alios Ioannes Baptista Sabelle adulescens ornatissime at-que eximiae spei age paternis avitisque vestigiis insiste teque ad paternas artes compone, utet laudem immortalem (amore cuius pater tuus tantopere flagravit) adipisci possis, quodquidem fore non despero […]», c. A5r.
6 La stampa dell’Oratio è dedicata a Giovan Battista dell’Anguillara, al quale Martiranosi rivolge in termini molto deferenti: «Vale, unicum presidium meum Bernardinumqueclientulum tibi ex animo dicatum atque fidissimum tuorum numero adiungere placeat».
7 Cfr. TRISTANO, 1988, pp. 11-12. Nella dedica a Benedetto Accolti, cardinale di Raven-na, della ricordata edizione del commento parrasiano all’Ars poetica di Orazio, così Bernar-
116 Tobia R. Toscano
Rubbettino
durlo con sé a Roma, dove papa Leone X aveva chiamato il fondatore del-l’Accademia Cosentina a ricoprire la cattedra di eloquenza nello Studium,colà lasciandolo bene introdotto dopo il ritorno in patria, che precedette dipoco la sua morte, avvenuta tra il 28 novembre e il 6 dicembre 15218. Par-rasio lasciò in eredità la sua preziosa biblioteca ad Antonio Seripando, chea sua volta la legò alla biblioteca della fondazione agostiniana di San Gio-vanni a Carbonara di Napoli, non senza aver subito qualche preventivo sac-cheggio, come pare si debba desumere da un passo della dedica di Bernar-dino che precede l’edizione del commento del maestro all’Ars poetica diOrazio:
[…] nam de tot laboribus, de tot luculentissimis lucubrationibus […] vix unumalterumque extat, ac lectitur. Quod non hercule negligentia vel improbitate perac-tum est, sed quadam potius (ut ita dicam) hominum tabe, qui alienae laudis ob in-vidiam impatientes […] omnes pene Parrhasii vigilias vix eo defuncto rapacissimisunguibus occuparunt. Et quum ipse a patria tunc abessem, nec tantam iniuriampulsare possem, actum profecto de iis esset, funditusque occidissent, ni AntoniusSeripandus, quam humanitate clarus, huic obviam pestis prodiisset. Hic nempe aParrhasio haeres factus librorum, incredibili fide sollertiaque, quasi Scyrones et Ca-cos expugnans, nonnullos e labyrinthi latebris eduxit9.
Insieme alla notizia della dispersione di alcuni scritti di Parrasio e diqualche prezioso cimelio, si rileva che al momento della morte del maestroMartirano si trovava lontano dalla citta natia (a patria abessem) e quindi sipuò ritenere che il suo soggiorno romano al servizio dei Savelli si sia pro-tratto fino al 1525, solo in seguito passando in Lombardia al servizio deglispagnoli, senza escludere un passaggio per Siena nello stesso anno, se nei«Tabelloni» dell’Accademia degli Intronati10, accanto al nome di ClaudioTolomei, il Sottile, si trova registrato un «Signor di Martinano [sic]» con ilsoprannome di Travagliato, che può essere il nostro Bernardino, la cui pre-senza fa da probabile contorno a una vera e propria «colonia» di napoleta-ni, di origine o di adozione, come Alfonso d’Avalos, marchese del Vasto (ilPomposo), Ferrante Sanseverino, principe di Salerno (l’Ostinato), AntonioMuscettola (l’Inquieto), Alfonso Piccolomini, duca di Amalfi (il Desiato) eun Maron Galeoto (il Delicato) che potrebbe essere Mario Galeota, diven-tato in anni successivi uno dei più convinti seguaci di Valdés.
117Un nobile cosentino al servizio dell’Impero: otia e negotia...
dino ne rievocherà il fecondo magistero: «A Parrhasio ita semper eruditus et dilectus sum,ut uni patri concederet soli […]. Sed tanta fuit magnitudo in me meritorum, ut mihi ipsinumquam satisfacio».
8 Ivi, pp. 14-15.9 Citato ivi, p. 16.10 Cfr. SBARAGLI, 1942, pp. 190-191.
Rubbettino
Subito dopo la morte del duca di Borbone nelle prime fasi del sacco diRoma, Martirano passò ai servizi di Filiberto di Châlons, principe d’Oran-ge, e nel suo seguito, nominato nel frattempo viceré di Napoli, fece ritornonel Regno al tempo dell’assedio di Lautrec. Il suo stretto rapporto con ilnuovo viceré è rievocato nel De bello neapolitano di Camillo Querno (Na-poli, Sultzbach, 1529), nel punto in cui l’autore, rivolgendosi al principed’Orange, gli ricorda
tecumque fidelisMartiranus adest, lateri coniunctus honoreet capiens secreta animi, nova gloriae linguaeromanae, Aonidum cultor, comes ire per omneisnil timet armorum casus variosque tumultus.Interdum fessas revocare ad carmina musasgestist et altisono nova fingere proelia versu (c. D3r-v).
La conclusione favorevole agli Spagnoli di quella campagna militare se-gna l’inizio dell’ascesa definitiva di Bernardino, già caratterizzato nella du-plice veste di uomo di armi e di lettere, a quella data prevalentemente latine,come pare confermato ancora nel 1533 dall’elogio di Giovanni Filocalo daTroia che lo ricorda insieme al fratello Coriolano come «gloria carminis la-tini»11. In un documento firmato dal viceré il 2 gennaio 1529 Bernardino ri-sulta già investito della carica di segretario del Regno, dopo aver ottenuto indono dall’imperatore i titoli feudali su Amendolea e San Lorenzo in Cala-bria, che si andavano ad aggiungere a quelli su Aieta e Tortora ricevuti pereredità paterna. All’ombra di Bernardino si sviluppa anche la carriera delfratello Coriolano, che subentrerà alla morte di lui nella carica di segretariodel Regno, firmando nel 1549 L’indulto delli eccettuati de li tumulti emanatoda don Pedro de Toledo (Napoli, Giovan Paolo Suganappo)12. Proprio du-rante il lungo viceregnato del Toledo (1532-1553) si consoliderà la posizio-ne dei fratelli Martirano, senza per questo venire mai meno da parte di Ber-nardino la partecipazione attiva ai circoli accademici napoletani, per i qualianzi divenne un essenziale patronus negli anni in cui per l’assenza di Vitto-ria Colonna e di Alfonso d’Avalos si andava esaurendo la vitalità di quellacorte che la storiografia letteraria ha battezzato come «cenacolo di Ischia».
La venuta di Carlo V a Napoli nel novembre del 1535 segna la consacra-zione definitiva del prestigio e del ruolo di preminenza conseguiti da Bernar-dino sia al cospetto dell’aristocrazia napoletana che nell’ambito della corte
11 Giovanni Filocalo (da Troia), Carmen nuptiale in Fabritii Maramauri [...] et PortiaeCantelmae [...] nuptiis [...] decantatum anno MDXXXIII, Sultzbach, Napoli, 1533, ristampa-to in DELLA ROCCA, 1988, pp. 109-120.
12 Cfr. MANZI, 1973, p. 34.
118 Tobia R. Toscano
Rubbettino
vicereale. L’Imperatore fu ospite per tre giorni nella villa di Martirano a Leu-copetra nei pressi di Portici, che divenne lo scenario fastoso in cui si incro-ciarono le nobiltà di Napoli e di Spagna, impegnate tra l’altro a definire com-plesse questioni di etichetta in vista dell’imminente trionfo di Carlo V.
Non sarà un caso che proprio tra il 1535 e il 1536 il nome di Bernardi-no compaia a più riprese nei libri stampati dalle tipografie napoletane e perla prima volta si hanno notizie di una sua attività letteraria ormai rivolta alvolgare dopo l’iniziale tirocinio latino. Nel Rimario di Benedetto di Falco(Napoli, Mattia Cancer, 1535, c. H6v) si loda infatti «una sua opera dottis-sima e florida in prosa oratione scritta ne la quale lepidamente e con un stildolce e grave narra gli amori d’Ismene e d’Ismenia», che, come ho avutomodo di ricostruire13 in margine all’edizione del Pianto d’Aretusa, va iden-tificata con un volgarizzamento al momento perduto di un romanzo del bi-zantino Eustazio (o Eumazio) Macrembolita, di cui farà ancora menzionequalche anno dopo unicamente Luigi Tansillo sia nelle Stanze a BernardinoMartirano che nel son. 226 Per l’onda ove nascesti e per l’arena14.
Nel 1536 Martirano appare tra i protagonisti del dibattito-accademia sultema della Fortuna svoltosi nella villa aragonese di Poggioreale in presenzadi Carlo V in occasione di un convito organizzato per festeggiare le nozzeimminenti di Margherita d’Austria con Alessandro de’ Medici. Il resocontodi tale performance è affidato a un raro opuscolo uscito dalla tipografia na-poletana di Mattia Cancer nel febbraio del 1536 dal titolo (e dalla lettura)alquanto macchinoso: Le cose volgare […] nelle quale si raggiona dell’una el’altra fortuna dovuto ad Agostino Landolfi (Landulfo)15. Ciò che appare in-teressante è l’annessione di Bernardino a una brigata di «alquanti segnalatiprincipi e signori, a sua Maiestà più cari» (c. B2r), in un contesto in cui nonsi fa cenno alcuno né al viceré né ad altri nobili spagnoli: siamo nei mesi incui l’aristocrazia regnicola tende anche attraverso la stampa ad enfatizzareil suo rapporto diretto con l’Imperatore e la presenza del Segretario, oltreche non essere sgradita, chiudeva un cerchio nel quale la presenza del Tole-do una volta tanto si poteva ritenere superflua.
Non saprei dire se sia una casualità il fatto che nello stesso 1536 l’uma-nista calabrese Niccolò Salerno dia alle stampe la sua raccolta di Sylvulae(Napoli, Sulztbach), il cui secondo libro è dedicato a Bernardino, del qualesi riepiloga la biografia proprio a partire da una riflessione sui rapporti traFortuna e destino degli uomini, manifestando la certezza che, diversamen-te da quanto pensa il volgo, la carriera di Martirano risponda a un precisoatto della volontà di Dio:
119Un nobile cosentino al servizio dell’Impero: otia e negotia...
13 Cfr. TOSCANO, 1993, pp. 9-17.14 TANSILLO, 2011, pp. 668-669.15 Per un’analisi dell’opera, cfr. GRIPPO - TOSCANO, 1994, pp. 279-307.
Rubbettino
Non Fortuna regit, non alti sidera coeliignea, sed nutum observant Iovis omnia summi.Mortales igitur cunctos qui prospicit actuset videt arcanos hominum sub pectore sensus,hic te magnorum ad fastigia vexit honorum.
Si delinea così una biografia eroica, del giovane Martirano intento soloa procacciarsi la gloria, seguendo come Ercole al bivio la parte più ardua esenza lasciarsi distrarre da lusinghe di donna («Herculei te pars bivii rapitardua, nec te | per planum tenerae abducunt promissa puellae»). La svolta èrappresentata dalla guerra franco-spagnola: è l’occasione in cui Bernardinomostrerà tutte le sue doti conquistando la fiducia dei superiori e arrivandoquindi al culmine degli onori:
[…] Bello interea fremit itala tellus,gallorum Hesperiam magno quatit agmine ductor.Invicti occurrunt aeratae Caesaris alae:itur ad insane non una mente duellum.Gallica dum plures nostratum signa sequuntur,alite felici tu ingressus castra fuisti,quae Iovis auratam gestant in bella volucrem.Non te turmalem parvo velut aere merentemaccepit legio, sed te facundia primumCaesareo generose duci quem causa dolorqueverterant in gallos, itum Caesari arma foventemconciliat. Parvo datur tibi tempore mentemarcanumque ducis pectus cognoscere et altaconsilia et sacri chirografa discere regis.Arcanis dignus praestare silentia rebusinventus variosque vigil tolerare laboreset saevi nunquam belli cessisse periclismox duce, quem flesti, capitur dum Roma, peremptosedulitate, fide, non est te carior alterductori, qui tunc castris successerat atquecura tibi est merito servati tradita regni.Publica non solus tu cuncta negocia tractascaesareique patent soli decreta senatus.Felix terque quater felix Cosentia septemcollibus et fluviis hinc illinc cincta duobusproduxit quae illustre iubar, quo laeta coruscatipsa quidem primum et, si fas est, iure superbitMamertina domus quanquam candore priorum etsanguine patritio per sese clara nitescit.
120 Tobia R. Toscano
Rubbettino
Praemia longaevo redduntur digna parenti,redditur et patrio merces pietatis amori,annua Parthenopes dum munera suscipit urbis.
La lunga citazione è come il condensato di una biografia «autorizzata»nella quale Bernardino poteva riconoscersi: la scelta senza ambagi della par-te imperiale, mentre altri seguivano gallica signa, l’arrivo nell’esercito delduca di Borbone e l’immediata fiducia conquistata tanto da essere messo aparte degli «alta | consilia et sacri chirografa discere regis»; fiducia conser-vata e accresciuta presso il successore del Borbone, Filiberto di Châlon, cheinfine gli affida la cura servati regni: un eccesso di enfasi per definire la ca-rica di segretario, su cui ricadono i publica negocia, donde l’elogio della pa-tria Cosenza che da tale figlio riceve lustro al pari della stirpe Mamertinache però già da prima sanguine patritio per sese clara nitescit. Pare ovvio chela parentesi romana non potesse trovare spazio in cornice così eroica, maaverne recuperato la memoria può essere utile perché ci riporta alla lunga egiovanile milizia umanistica del discepolo prediletto di Parrasio, la cui di-mora di Leucopetra sarà dal 1535 e fino alla morte luogo di ritrovo e diconforto per l’ultima generazione degli accademici pontaniani e per le nuo-ve leve della letteratura in volgare.
Lo stesso Bernardino si cimenterà nella nuova letteratura, mostrandouna spiccata propensione allo sperimentalismo linguistico, tanto che Di Fal-co nel Rimario produrrà una nutrita elencazione di innovazioni lessicali at-tingendole al perduto volgarizzamento del romanzo greco di Eustazio. È no-ta la serie di riserve linguistiche che Pietro Bembo avrebbe espresso in mar-gine al Polifemo, poemetto in ottava rima sul quale appare impegnato Ber-nardino negli ultimi anni di vita16; ma anche la testura più sostenuta delpoemetto epico-erotico del Pianto d’Aretusa, collocabile tra il 1535 e il 1540,non appare immune dal tentativo di annettere ai territori della lingua poe-tica voci formate sul latino o provenienti direttamente dal vernacolo17.
Tuttavia ai fini di una valutazione del ruolo svolto da Bernardino qualeelemento di aggregazione dei quadri intellettuali attivi a Napoli nel quindi-cennio circa che va dal 1535 al 1548, anno della sua morte, può valere comepunto di partenza la felice espressione formulata da Benedetto Croce (1953,p. 377), che indicò i fratelli Martirano quali «prosecutori nel Napoletano diquel movimento accademico, che dalla Pontaniana dà la mano all’Accade-mia di Cosenza». Meglio non si poteva dire per definire il proficuo otium delSegretario del Regno, che volle e seppe essere riferimento cordiale e munifi-co della generazione dei pontaniani orfana di Sannazaro e dei sodali cosen-
121Un nobile cosentino al servizio dell’Impero: otia e negotia...
16 Sulla questione rimangono fondamentali le pagine di TISANO, 1993.17 Per uno spoglio linguistico di queste voci, cfr. TOSCANO (a cura di), 1993, pp. 51-55.
Rubbettino
tini, formatisi alla scuola di Parrasio, che ebbero modo di trasferirsi nella ca-pitale. D’altra parte proprio l’iscrizione fatta apporre al ninfeo, al centro delquale si ammirava la statua di Aretusa, riassume un programma di vita, chesenza pretermettere gravosi negotia sembrava vagheggiare un futuro di piùtranquilli otia: «post labores honeste fortiterque susceptos, ex opere novoconcharum Nymphaeum hoc genio posuit et ocio liberali»18.
Si è discusso a lungo se la villa di Leucopetra sia stata sede di una verae propria accademia dopo che Minieri Riccio (1880, p. 143) ne aveva certi-ficato l’esistenza ricordando che intorno a Bernardino si riunivano «i più di-stinti letterati di quel tempo, suoi amici, e con essi intrattenevasi in eruditiragionamenti e recitando eleganti composizioni latine e volgari». Convalidòl’assunto Pometti, che addusse, oltre alle Leges geniales dettate da Coriola-no19, l’importante testimonianza sincrona di Girolamo Ruscelli, consegna-ta a una nota linguistica di corredo ai Fiori delle rime (Venezia 1558), don-de risulta l’autorevolezza in materia linguistica che si riconosceva a Bernar-dino. Riferendosi al sonetto Mal vidi, Amor, le non più viste e tante di Gio-vanni Guidiccioni (stampato a c. 318) Ruscelli annota (c. PP8v):
Questo sonetto del Guidiccione, in tante volte, che è stato stampato, così nei li-bri stessi, come nelle tavole si vede, che sempre nelle prime parole si è dalle stampefatto dir Mai vidi Amor. Onde io mi ricordo, che in casa della benedetta memoriadel Segretario Martirano in Napoli, un Poeta novello havendo in un suo sonetto po-sto la parola MAI negativa per sé sola, et avendogli detto il Segretario, che era erro-re, e che nella lingua nostra non si truova mai, che MAI sia voce negativa, se non viha seco nella costruttione della sentenza una delle parole NON, o NÉ, o NULLA, o NIEN-TE, o NESSUNO, o NIUNO.
Si tenga a mente che Ruscelli fu a Napoli tra il 1546 e il 1548/49 ed eb-be modo di tessere articolati rapporti con gli ambienti aristocratici e acca-demici20 e quindi la sua testimonianza è quella che in maniera più direttacoglie la vivacità della conversazione di villa Leucopetra.
Non è questo il luogo per riproporre la questione da me affrontata al-trove circa la supposta soppressione da parte di don Pedro de Toledo del-l’Accademia Pontaniana prima (1543) e delle accademie dei Sereni, degliArdenti e degli Incogniti poi (1547). Rinviando alle conclusioni a suo tem-po da me formulate21, credo di poter ribadire che, senza negare il prestigio
18 Si veda MORMILE, 1670, p. 74.19 Le Leges geniales si leggono in Coriolani Martirani Epistolae familiares, Neapoli, s. t.
[ma Giovanni Mario Simonetta], 1556, cc. 40r-41v, e sono state riproposte e commentate inTOSCANO (a cura di), 1993, pp. 42-44.
20 Sull’argomento rinvio a TOSCANO, 2012.21 TOSCANO, 1992, pp. 25-30.
122 Tobia R. Toscano
Rubbettino
di Scipione Capece, tutti i dati convergono a ribadire che villa Leucopetrafu l’ultimo asilo dei pontaniani e che difficilmente si troverebbe un docu-mento che meglio delle leges geniales scritte da Coriolano Martirano possasintetizzare quello spirito di faceta urbanitas posta da Gioviano Pontano afondamento della conversazione accademica, la quale non poteva fare a me-no di un comodo luogo d’incontro.
Quale che sia il valore documentale di queste Leges geniales, non man-cano altri elementi, insieme a quelli già addotti, che ribadiscono la centra-lità di Bernardino nel milieu accademico napoletano, ricordando anche cheil nome dei fratelli Martirano, oltre le citazioni che li riguardano diretta-mente, è quello che nel periodo 1531-1557 ricorre con maggiore frequenzanelle dediche di opere a stampa.
Leggendo le varie raccolte di versi latini di Giano e Cosimo Anisio – ve-ra e propria rete di collegamento tra i pontaniani – l’auctoritas esercitata daBernardino appare confermata da una lettera di Giano, che lo invita a rive-dere le proprie Epistolae de religione (Napoli, Sultzbach, 1538), correggendo-le se necessario e inviandole per una ulteriore ripulitura a Coriolano (c. D2r):
Si quid unquam cuiquam grati feciste, Martyrane, hanc mihi imovero omnibusbonis ipsique reipublicae Christianae operam imprende, relictis quaeso rebus om-nibus, Epistolas quas mitto gravissim[as] curato diligenter, eleganter, emendatequedescribendas, recognoscendas, examinandas perque omnis viros doctos circumfe-rendas […]. Et si postea videbitur Romam mitte, ut idem faciat Coriolanus […].
A Coriolano si era rivolto due anni prima licenziando la tragedia Proto-gonos (Napoli, Sultzbach, 1536): «Tu quem Phoebus amat cognosce laborem| et qua nota signandus est, edicito» (c. 56r).
Anzi è proprio Giano Anisio, ormai vecchio, che in altra lettera manife-sta l’intenzione di lasciare in custodia a Bernardino il corpus delle sue ope-re, commettendogli l’incombenza di allestire una selezionata antologia sal-vando gli scritti più meritevoli di memoria (Protogonos, c. 81v):
Tu, Martyrane suavissime, tu hunc postea facies delectum, fasciculumque sicutex floribus lectissimis trades delicatis lectoribus gestandum noctesque et dies nari-bus admovendum […]. De editionis impensa non ausim quicquam dicere: satisenim virtute tua maiorumque tuorum dives es, meaque causa vita ne dum opes telibenter profusurum saepe praedicasti.
Il vecchio Anisio non se la passava bene né dal punto di vista della sa-lute fisica e nemmeno del benessere economico, e se qui ricorda a Bernar-dino la promessa più volte reiterata di mettere a disposizione, se necessario,vita e ricchezza, si potrà convenire che egli abbia accettato di sostenere le
123Un nobile cosentino al servizio dell’Impero: otia e negotia...
Rubbettino
spese della stampa delle sue ultime opere, tanto che in altra opera sempredel 1536 dello stesso Anisio si leggono gli unici versi di Bernardino stampa-ti in vita (Variorum poematum, c. 32r-v):
Te sine nostra tuos moerens it Nympha per agrossqualida crudeles et vocat usque deos.
Te nostrae lauri, te nostra arbusta morantemet fagi et pinus et vocat omne nemus.
Quin Arethusa etiam curarum oblita suarumper te turbatis in mare currit aquis.
En ructato scopulos flammato Vesbius orecessantemque altis vocibus increpitat.
De me quid dicam, qui te noctesque diesqueafflictus lugens et voco et excrucior?
Quare age, Leucopetram longo post tempore Anysivisas et tecum gaudia cuncta feras.
Quodi si te morbus perget tristisque podagralaedere tristitiae non modus ullus erit.
Pure sotto la coltre delle reminiscenze e delle citazioni classiche, soprat-tutto di Virgilio bucolico, vibra una nota di affetto sincero per l’anzianoumanista, cui la vita longeva aveva riservato il privilegio e poi le angustie diessere spettatore del fulgore e dell’inesorabile esaurirsi dell’Accademia Pon-taniana, che in Leucopetra intorno a Bernardino Martirano poté officiare isuoi ultimi riti.
Ma se Bernardino venerò gli anziani maestri della stagione umanistica,non fu per questo meno amato dai più giovani sodali protagonisti della let-teratura in volgare. Egli si trovò anzi a svolgere una funzione di cerniera fratre generazioni: nato nel 1490, ebbe la ventura di essere mediatore tra la ge-nerazione precedente la sua (Anisio era nato intorno al 1470) e quella se-guente, nata nel primo decennio del XVI secolo. Tra le nuove leve un postodi rilievo riservano a Martirano due tra i maggiori poeti della pleiade napo-letana: Berardino Rota e Luigi Tansillo.
Oltre che dedicargli un lungo carme latino, Rota introduce Martiranosotto le sembianze del pescatore Crati («suo amicissimo e padrone di Pie-trabianca») nella VI e nella VII delle sue Egloghe pescatorie, che occupano ilcentro preciso della raccolta formata di 14 egloghe22. La prima è intitolataLeucopetra, la seconda Sebeto; entrambe sviluppano l’eziologia del sito diPietrabianca che Martirano aveva condensato in una sola ottava del Piantod’Aretusa, destinato a rimanere inedito. Quasi un ideale passaggio di testi-
22 Per il testo si fa riferimento a ROTA, 2005.
124 Tobia R. Toscano
Rubbettino
mone: il più giovane Rota fa raccontare a Crati ormai vecchio la metamorfo-si della ninfa Leucopetra, che per scampare alle brame dei focosi Vesevo eSebeto ottiene da Nettuno di essere trasformata in pietra, mentre la dispe-razione trasformerà poi gli amanti in vulcano e in fiume. Difficile datare conprecisione le singole pescatorie di Rota. Per la VI c’è un curioso riferimentotopografico introdotto da Crati nel rivelare a Melanto la causa della sua as-senza da Leucopetra durata «quattro giorni» (v. 2):
Più tosto io non potei: cotanto iratisoffiâro i venti e fûr l’onde inquïete.che sapendo qual fé dal mar s’attende,scioglier non volli da Pozzuolo il legno;né men venir potea scorto dal piede,fatto per gli anni grave in tutto e lento. (vv. 4-9)
Certo è il riferimento all’età avanzata, anche se a noi può sembrare stra-no che un ultracinquantenne si possa sentire e definire vecchio, a meno cheil «piede, | fatto per gli anni grave in tutto e lento» non sia un modo per in-dicare la tristis podagra di cui soffriva anche il vecchio Anisio, come sem-brerebbe autorizzare anche il ricordato son. 226 di Tansillo, che invoca Ve-nere perché faccia guarire l’amico malato:
Pon’ mente al duol che ‘l vago piè raffrena,ch’or vedea Gnido, or Elicona errante:priega, come poeta e come amante,Febo che ‘l tolga a così lunga pena23.
Tuttavia lo sconforto di Crati non sembra dovuto solo agli acciacchi fi-sici, ma è frutto di una crisi più generale che gli toglie persino il piacere di«pescar per queste arene» (v. 13), perché
passata è la stagion che le Sirene,che Teti e Proteo e Glauco e gli altri deisi stavan qui nel buon tempo felice. (vv. 16-18)
Un quadro cupo che ha turbato la serenità di Leucopetra, anche gli deihanno abbandonato il mare di Napoli: la bucolica come la pescatoria è unapoesia che si nutre di umbratili riferimenti alla cronaca storica. Ma qui nonsembrerà un azzardo immaginare che il più giovane Rota abbia voluto rievo-care ex post (le Pescatorie furono stampate nel 1560) l’afflizione di Crati alla
125Un nobile cosentino al servizio dell’Impero: otia e negotia...
23 TANSILLO, 2011, pp. 668-669.
Rubbettino
vigilia della morte, che lo colse mentre ancora non erano del tutto archiviatele conseguenze della rivolta cittadina contro il viceré reo di voler introdurrenel Regno l’inquisizione al modo di Spagna. Sicché anche l’iniziale riferimen-to a Pozzuoli potrebbe essere pregnante allusione a una sosta presso don Pe-dro, che a Pozzuoli, in località Campiglione, si era fatto costruire una villa do-po l’eruzione del 1538 e lì si era ritirato nelle fasi calde dei tumulti.
Alla poesia di Tansillo è affidata per converso la costruzione del ritrat-to più splendido e vitale del Segretario, il cui nome, come dedicatario o invari riferimenti, ricorre a più riprese: segno di una lunga e affettuosa con-suetudine maturata negli ambienti della corte vicereale dove il giovane poe-ta svolgeva mansioni di continuo. Il ritratto del bon vivant che conosce laperfetta misura di compensazione tra otia e negotia è delineato nel III deiCapitoli giocosi e satirici, diretto a Girolamo Albertini, impegnato anch’eglinei ranghi della pubblica amministrazione, cui si addita Bernardino comeesempio da seguire:
Non siate a voi medesimo avversario,riposate talor la mente stanca,prendete essempio dal buon Secretario,che quando può goder di Pietrabiancal’orto, la fonte, il mar, l’antro, la strada,non ha invidia al signor di Salamanca.Così le feste inanzi tempo badacome fanciullo che la scola abborre,e i dì d’opra gli è forza che vi vada.Sendo il dì festo a Pietrabianca corre,fugge ogni ira, ogni noia, ogni imbarazzoe si toglie il piacer quando il può torre24. (vv. 172-83)
In questa dimensione nascono anche le Stanze a Bernardino Martirano,e per Tansillo impegnato in molesti viaggi per mare con la flotta di donGarcía de Toledo, sempre Leucopetra è vagheggiata come diletto buen reti-ro nel quale rifugiarsi ogni volta che sia possibile. Nel corpus lirico di Tan-sillo si leggono sette sonetti indirizzati a Bernardino e uno a Coriolano. Ilcodice Casella consente di recuperare anche due sonetti di proposta di Ber-nardino25 che dovrebbero essere gli unici da lui composti e dai quali traspa-re l’affetto che lo lega al più giovane sodale afflitto da pene d’amore.
L’immagine del munifico patronus appare modellata sul topico riferi-mento a Mecenate alla cui lode Tansillo si sente inadeguato, sapendo di nonpoter competere con Orazio e Virgilio:
24 TANSILLO, 2010, pp. 132-133.25 Si possono leggere in TANSILLO, 2011, pp. 673 e 756-757.
126 Tobia R. Toscano
Rubbettino
Cosí Venosa e Mantoa d’intornogirsen dovean a Mecenate, quandoLiri e Vulturno et Aufido varcando,con lor presse d’Italia il minor corno.Cosí doveasi far breve ogni giorno,e piano ogni sentier, dolce cantando,e por gli affanni e i rei disagi in bandoe dal camino insieme e dal soggiorno.Deh, foss’io, Martirano, a’ tempi nostri,Marone o Flacco in una sola, comevoi sete in ogni parte Mecenate!Bench’uopo a voi non faccin gli altrui inchiostri,del mio sarei sì largo al vostro nome,che forse il gradiria Sibari e Crate26.
Nell’arco del ventennio 1528-1548 Bernardino Martirano seppe tessereuna rete di relazioni umane e letterarie che senza soluzione di continuità lovidero protagonista in proprio, ma soprattutto generoso e cordiale patrono,equamente dimidiato tra salvataggio della stagione dell’umanesimo post-aragonese e sostegno alle nuove leve della letteratura in volgare.
Bibliografia
CROCE, B., 1953, I fratelli Martirano [1897], in ID., Aneddoti di varia letteratura, La-terza, Bari, vol. I., pp. 377-386.
DELLA ROCCA, A., 1988, L’umanesimo napoletano del primo Cinquecento e il poetaGiovanni Filocalo, Liguori, Napoli.
FIORENTINO, F., 1872, Bernardino Telesio ossia studi storici su l’idea della natura nelRisorgimento italiano, Successori Le Monnier, Firenze, voll. 2.
GRIPPO, M., TOSCANO, T.R., 1994, Carlo V nelle delizie aragonesi di Poggio Reale.Un’“accademia” poetica di nobili napoletani in un raro opuscolo a stampa del1536, in «Critica letteraria», XXII, pp. 279-307.
GUICCIARDINI, F., 1971, Storia d’Italia, a cura di S. Seidel Menchi, Einaudi, Torino.MANZI, P., 1973, La tipografia napoletana nel ’500. Annali di Giovanni Paolo Suga-
nappo - Raimondo Amato - Giovanni de Boy - Giovanni Maria Scotto e tipogra-fi minori (1533-1570), Olschki, Firenze.
MINIERI RICCIO, C., 1880, Cenno storico delle Accademie fiorite nella città di Napoli,in «Archivio storico per le province napoletane», V, pp. 131-157.
MORMILE, G., 1670, Descrittione della città di Napoli e del suo amenissimo distretto,Paci, Napoli.
127Un nobile cosentino al servizio dell’Impero: otia e negotia...
26 È il sonetto 232: ivi, p. 677.
Rubbettino
128 Tobia R. Toscano
PÈRCOPO, E., 1898, recensione a POMETTI 1896 in «Rassegna critica della letteratu-ra italiana», III, pp. 68-72.
POMETTI, F., 1896, I Martirano, in «Memorie della Reale Accademia dei Lincei», s.V, vol. IV, pp. 58-186.
ROTA, B., 2005, Egloghe pescatorie, a cura di S. Bianchi, Carocci, Roma.SBARAGLI, L., 1942, I «tabelloni» degli Intronati, in «Bullettino Senese di Storia Pa-
tria», XLIX, f. III, pp. 177-213.SPIRITI, S., 1750, Memorie degli scrittori cosentini, nella stamperia de’ Muzj, Napoli.TANSILLO, L., 2010, Capitoli giocosi e satirici, a cura di C. Boccia e T.R. Toscano, Bul-
zoni, Roma («Europa delle Corti» 153).ID., 2011, Rime, introduzione e testo a cura di T.R. Toscano, commento di E. Mil-
burn e R. Pestarino, Bulzoni, Roma («Europa delle Corti» 154).TISANO, V., 1993, Formazione e scelte linguistiche di un corrispondente meridionale
del Bembo: Bernardino Martirano, in P. TROVATO (a cura di), Lingue e culturedell’Italia meridionale (1200-1600), Bonacci, Roma, pp. 327-344.
TOSCANO, T.R., 1992, Una postilla sulla soppressione delle accademie napoletane, inB. DI FALCO, Descrittione dei luoghi antichi di Napoli e del suo amenissimo di-stretto, coordinamento e introduzione a cura di T.R. Toscano, con un saggio diG. Toscano, testo critico a cura di M. Grippo, CUEN, Napoli, pp. 25-30.
ID., (a cura di), 1993, B. MARTIRANO, Il pianto d’Aretusa, Loffredo, Napoli.ID., 2012, Ruscelli e i lirici napoletani: tracce di antigrafi perduti nel transito da Na-
poli a Venezia, in P. MARINI e P. PROCACCIOLI (edd.), Girolamo Ruscelli. Dall’Ac-cademia alla corte alla tipografia, Atti del Convegno Internazionale di Studi(Viterbo, 6-8 ottobre 2011), Vecchiarelli, Manziana, vol. I, pp. 133-172.
TRISTANO, C., 1988, La biblioteca di un umanista calabrese: Aulo Giano Parrasio,Vecchiarelli, Manziana.
VALERI, E., 2008, Bernardino Martirano, in Dizionario biografico degli italiani, Isti-tuto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, vol. 71, pp. 336-341.
EAD., 2008, Coriolano Martirano, in Dizionario biografico degli italiani, Istituto del-l’Enciclopedia Italiana, Roma, vol. 71, pp. 341-344.
Rubbettino