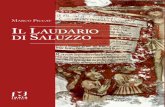-Onorio, cavaliere divino. Un episodio della fortuna di Stazio, Tebaide 6: il Panegirico per il IV...
-
Upload
liceocanova -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of -Onorio, cavaliere divino. Un episodio della fortuna di Stazio, Tebaide 6: il Panegirico per il IV...
1
ONORIO CAVALIERE DIVINO Un episodio della fortuna di Stazio, Tebaide 6:
il Panegirico per il IV Consolato di Onorio di Claudiano
Il primo testimone della fama della Tebaide è Stazio stesso nella sphraghís del poema, additato
come testo scolastico sul quale la Itala iuuentus si forma, e a lui fa eco Giovenale 7,82-87 che
ironizza sulla popolarità delle letture pubbliche che non garantisce però al poeta la tranquillità
economica1. Tuttavia il primo poeta per il quale si può parlare di influenza diretta da parte di Stazio
è, appena nel IV secolo, Claudiano2, che, servendosi della tradizione poetica a lui precedente,
sostanzia la sua produzione panegiristica con forma e tono epici. Con la Tebaide Claudiano non si
limita a condividere il gusto per i lunghi discorsi, le allegorie moralizzanti e le descrizioni; è
possibile comprendere più a fondo la natura di questo dialogo tra i due poeti anche studiando un
episodio molto circoscritto della fortuna del poema3.
In apertura il ritratto equestre di don Balthasar Carlos infante di Spagna dipinto da D. Velazquez tra il 1635-36, olio su
tela (209x173cm), Madrid Museo del Prado. 1 Cfr. Stat. Theb. 12,810-815 Durabisne procul dominoque legere superstes,/ o mihi bissenos multum uigilata per
annos/ Thebai? Iam certe praesens tibi Fama benignum/ strauit iter coepitque nouam monstrare futuris./ iam te
magnanimus dignatur noscere Caesar,/ Itala iam studio discit memoratque iuuentus; Iuu. 7,82-87 Curritur ad uocem
iucundam et carmen amicae/ Thebaidos, laetam cum fecit Statius urbem/ promisitque diem: tanta dulcedine captos/
adficit ille animos tantaque libidine uulgi/ auditur. sed cum fregit subsellia uersu/ esurit, intactam Paridi nisi uendit
Agauen. 2 Cfr. M. DEWAR, Statius and later European literature, in Statius, Thebaid 9 by M. Dewar, Oxford 1991, p. XXXVII:
«Certainly his influence does not clearly emerge until the end of fourth century, in the works of another professional
poet […]. Claudian’s poems are in essence a blend of traditional encomium and the matter and techniques of Silver
epic». 3 Non sono numerosi i contributi sulla fortuna della Tebaide nella letteratura latina tarda e medievale: L. VALMAGGI,
La fortuna di Stazio nella tradizione latina e bassolatina, «RFIC» 21, 1892, pp. 409-462; 481-554, lungo articolo più
attento a inserire Stazio all’interno di una storia del gusto letterario che a individuare gli effettivi rapporti con gli autori
successivi (al punto che poeti come Claudiano e Sidonio sono appena nominati). Concentrato solo sulla Tebaide e i suoi
rapporti con il Phoenix di Claudiano, Cassiodoro e l’anonimo Gesta Regis Berengarii, è puntuale e propositivo dal
punto di vista della citazione dei loci communes l’articolo di G. ARICÒ, Per il “Fortleben” di Stazio, «Vichiana» 12,
1983, pp. 36-43. Di più largo respiro, anche se attenti soprattutto al successo nelle letterature nazionali europee, sono
invece i lavori di Dewar e Pollmann compresi nelle introduzioni ai rispettivi commenti dei libri 9 e 12 del poema: cfr.
M. Dewar 1991, pp. XXXVII-XLVIII; K. F. L. POLLMANN, The Thebaid and later writers, pp. LVIII-LXI. Per i
2
La parte più cospicua (vv. 296-549) del sesto libro della Tebaide, che tratta dei ludi funebri in
onore del neonato Ofelte straziato da un gigantesco serpente, è costituita da una movimentata corsa
di quadrighe, più descritta che narrata. Il protagonista della gara è Arione, cavallo divino figlio di
Nettuno, guidato suo malgrado (il cavallo lo percepisce perché dotato di psicologia propria)
dall’inesperto auriga Polinice, il reietto figlio di Edipo. La gara è una grande metafora della guerra a
venire e i suoi personaggi assumono significative valenze simboliche4.
Si possono rinvenire tracce della reinterpretazione staziana del motivo epico della gara delle
quadrighe nel Panegirico per il quarto consolato di Onorio di Claudiano. Il confronto di quei passi
del panegirico che presentano eco lessicali o rielaborazioni di motivi del testo di Stazio consentirà
di mettere in luce l’originalità e la stretta aderenza all’intento encomiastico con le quali il poeta di
Alessandria si muove rispetto a uno tra i suoi modelli favoriti.
1. L’argomento del IV Consolato di Onorio Nel gennaio del 398, a soli 13 anni, Onorio, figlio di Teodosio e imperatore della pars
Occidentis, assunse per la quarta volta la dignità consolare. Spettò allora a Claudiano, celebrare
l’evento in un momento critico per l’impero e per Stilicone, patrono del poeta e tutore del principe:
il generale era infatti alle prese con la guerra gildonica ed era stato dichiarato dai ministri di
Arcadio hostis publicus. Si trattava attraverso il panegirico di rafforzare l’idea di legittimità e di
sacralità della figura imperiale5 e del suo entourage.
Già nel 396 Claudiano aveva scritto un panegirico per il terzo consolato dell’imperatore, nel
quale erano state celebrate soprattutto le lodi di Teodosio, morto all’inizio dell’anno precedente.
Trascorsi solo tre anni, il tredicenne Onorio offriva al panegirista come unico argomento il suo
titolo e la sua discendenza: si presentò dunque al poeta la doppia difficoltà di costruire un
panegirico senz’aver nulla di fatto da lodare, evitando l’indelicata ripresa degli argomenti trattati in
occasione del precedente consolato.
In assenza di un passato di Onorio da celebrare, il poeta doveva piuttosto fondare la sua lode sul
futuro, sulle aspettative riposte nell’Augusto. Con questo obiettivo6 il panegirico dedica, dopo il
proemio (vv. 1-18) in cui si descrive il processus consularis, un’ampia sezione alla celebrazione del
ghenos (vv. 18-121), che era stata invece trascurata in III Cons. Hon. Le gesta della stirpe
teodosiana discendente da Traiano sono l’esempio e la garanzia che rendono certa la futura gloria di
Onorio7. A conclusione di questa sezione è lodata la nascita di Onorio (vv. 122-158), presentata
come "porfirogenesi" (cioè nascita a corte del futuro imperatore), accompagnata dai migliori
presagi. Secondo lo schema del panegirico proposto da Menandro retore8, alla nascita segue la
celebrazione dell’anatrophé dell’infante imperiale (159-427). La sezione è di insolita lunghezza,
probabilmente perché la vita di Onorio non aveva ancora nessuna impresa da offrire al poeta.
Claudiano mette subito in luce la positività della nascita a corte che assicura al principe una precoce
familiarità con l’esercito e con i luoghi della politica. Ai vv. 214-418 Claudiano inserisce una sorta
rapporti tra Claudiano e Stazio sono molto utili le osservazioni che Al. CAMERON, Claudian. Poetry and Propaganda
at the Court of Honorius, Oxford 1970, fa trattando delle tecniche poetiche del poeta alessandrino (pp. 255, 263 n. 1,
272, 282, 315; cfr. DEWAR 1991, p. XXXVII n. 66). 4 Per l’interpretazione della gara delle quadrighe come preludio della guerra cfr. D. VESSEY, Statius and the Thebaid,
Oxford 1973, pp. 209 ss.; un’altra interpretazione più recente attenta invece anche agli aspetti metaletterari è quella di
H. LOVATT, Statius and epic games: sport, politics, and poetics in the Thebaid, Cambridge 2005, pp. 23-54. 5 Per il contesto storico, gli obiettivi politici e i delicati equilibri tra tradizione pagana e cristiana rispettati all’interno del
panegirico cfr. B. MORONI, Una rilettura del panegirico di Claudiano per il quarto consolato di Onorio: i rapporti della
corte milanese col senato e l’opposizione pagana dopo la battaglia del Frigido, «Arch. Stor. Lomb.» 119, 1993, pp. 11-
44. 6 Cfr. IV Cons. Hon. 1-4 Auspiciis iterum sese regalibus annus/ induit et nota fruitur iactantior aula,/ limina nec passi
circum priuata morari/ exultant reduces Augusto consule fasces, e W. BARR, Claudian’s Panegyric on the Fourth
Consulate of Honorius, Liverpool 1981, ad l. 7 Ibidem 120-123: Hinc amor, hinc ualidum deuoto milite robur./ Hinc natis mansura fides. Hoc nobilis ortu/ nasceris
aequaeua cum maiestate creatus/ nullaque priuatae passus contagia sortis, e BARR ad l. 8 Questa la struttura che Menandro individua per il basilikós logos: ghenos, ghenesis, anatrophé, praxeis, epilogos.
3
di discorso sul regno in cui Teodosio, in forma di allocuzione strettamente privata di tono
epicizzante, propone al figlio uno speculum principis9.
La sezione delle praxeis (428-618) risulta inaspettatamente lunga data la giovane età del
principe; il poeta infatti la costruisce in parte ricorrendo a un espediente che aveva già usato in III
Cons. Hon., l’attribuzione cioè delle imprese di un grande, in quel caso di Teodosio e in questo di
Stilicone, agli auspici di Onorio, e in parte sviluppando il tema della lode delle qualità fisiche di
Onorio e della sua abilità a cavallo.
La sezione termina con la grandiosa descrizione dell’aduentus di Onorio a Milano nel 394 in
occasione del suo secondo consolato. Nella parte conclusiva (619-656), l’epilogos, secondo un
espediente già sfruttato nella parte relativa alle praxeis, le vittorie ottenute da Teodosio durante il
terzo consolato del figlio sono invocate come fausto presagio per la magistratura appena assunta.
2. La metafora nautica nello Speculum Principis: vv. 419-427 e Stat. Theb. 316-325 e 450-
453
Parte consistente del panegirico (214-427) è occupata dal discorso di Teodosio al figlio Onorio:
non è di certo un discorso realmente pronunziato, ma un basilikós logos sui doveri e le virtù del
sovrano ideale simile a parte di quello che Sinesio scrisse per Arcadio probabilmente nel 39910
. Il
discorso segue la sezione dedicata alla formazione del giovane principe e la conclude con precetti di
natura filosofica e politica. Nel quadro dell’anatrophé di Onorio il fatto che sia il padre a farsi carico
dell’educazione politica del figlio fa pensare anche a un’investitura ufficiale in cui Teodosio,
attraverso i precetti desunti dalla sua esperienza e gli esempi della storia romana11
, legittima l’erede
all’esercizio del potere. L’idea principale del discorso è quella espressa ai vv. 261 s. tunc omnia
iure tenebis,/ cum poteris rex esse tui, l’abilitazione alla regalità inscindibile dalla capacità di
dominare se stessi: Onorio non sarà imperatore se prima non sarà re di se stesso.
Come sigillo, recapitulatio del lungo discorso e transizione alla sezione delle praxeis, il poeta
inserisce una similitudine (vv. 419-427) di ambito nautico in cui un vecchio marinaio in procinto di
ritirarsi affida al figlio la propria imbarcazione spiegandogli come condurla e come affrontare i
pericoli della navigazione. Naturalmente gli inlustranda sono Teodosio e Onorio e gli inlustrantia il
vecchio marinaio e suo figlio, mentre il tertium comparationis si può individuare nel tema del
passaggio delle consegne, un’investitura ereditaria quindi, accompagnato dalle raccomandazioni del
caso. Haec genitor praecepta dabat: uelut ille carinae
longaeuus rector, uariis quem saepe procellis
explorauit hiems, ponto iam fessus et annis
aequoreas alni nato commendat habenas
et casus artesque docet: quo dextra regatur
sidere; quo fluctus possit moderamine falli;
quae nota nimborum; quae fraus infida sereni ;
quid sol occiduus prodat; quo saucia uento
decolor iratos attollat Cynthia uultus.
Claudiano, per parlare della navigazione, che con ovvio traslato indica il governo dello stato, usa
un lessico metaforico tratto dall’arte di guidare il carro (cfr. v. 420 rector; v. 422 habenas). Non è
certo rara l’interscambiabilità lessicale tra l’arte del nocchiero e quella dell’auriga, entrambi tenuti a
governare un veicolo mantenendo un’andatura il più possibile costante12
, abilità che significa il
primato della ragione umana sulla forza della natura, ma quel che colpisce sono le reminiscenze
9 L’allocutio di Teodosio, non essendo inserita all’interno di una cerimonia, come accade in altri panegirici, è stata
spesso considerata un’anomalia nell’architettura dell’opera, cfr. MORONI 1993, pp. 34-40. 10
Per i rapporti tra le due opere cfr. CAMERON 1970, pp. 321 s. 11
Quest’ultima sezione (vv. 396-420) è un catalogo di personaggi e momenti paradigmatici della storia romana del
primo periodo della Repubblica gli exempla morali dei quali Onorio deve imitare, cfr. R. PERRELLI, I Proemi
Claudianei. Tra Epica ed Epidittica, Catania 1992, pp. 84-91. 12
I due ambiti sono sono spesso l’uno metafora dell’altro a partire da Cat. 64,9 ipsa leui fecit uolitantem flamine
currum; Verg. Aen. 6,1 classique immittit habenas e AUSTIN ad l.
4
letterarie evocate da tale slittamento semantico. È topico nelle gare dei carri un momento in cui il
padre dà al giovane auriga alla sua prima esperienza dei precetti di guida moderata tendente a
evitare ogni eccesso: la figura del pater-praeceptor è attestata fin dall’archetipo omerico della gara
curule. In Hom. Il. 23, 306-46 infatti Nestore avverte il figlio Antiloco (vv. 305; 307 s.) che la metis
dell’auriga è più determinante della foga dei cavalli (vv. 313 ss.; 319 ss.) e gli dà suggerimenti sul
percorso da tenere (vv. 326 ss.)13
. Questo accade anche prima di una corsa, che è al contempo un
capriccio infantile, ma anche un atto di legittimazione, la folle corsa di Fetonte in Ou. Met. 2,126-
141. Il Sole istruisce l’impaziente figlio naturale sulla moderazione indispensabile alla guida dei
suoi focosi cavalli e sulla necessità di tenere un percorso mediano nella volta celeste14
.
Su questa tradizione e soprattutto sul modello ovidiano s’innestano i consigli che Adrasto,
proprietario del cavallo Arione, dà al genero, ma anche erede del regno, Polinice prima della gara
dei carri in Stat. Theb. 6,316-325: Tunc rector genero Polynici indulget agendum
multa monens, ubi feruor equo, qua suetus ab arte
mulceri, ne saeua manus, ne liber habenis
impetus. "urge alios" inquit "stimulisque minisque;
ille ibit, minus ipse uoles". Sic ignea lora
cum daret et rapido Sol natum imponeret axi,
gaudentem lacrimans astra insidiosa docebat
nolentisque teri zonas mediamque polorum
temperiem: pius ille quidem et formidine cauta,
sed iuuenem durae prohibebant discere Parcae.
Anche Adrasto invita lo sfortunato Polinice alla moderazione, ma quel che più importa è il
commento di Stazio che completa e conclude il passo con una similitudine con i precetti che il Sole
diede a Fetonte. Polinice è quindi assimilato a Fetonte e il suo destino sarà a un di presso quello
dello sventurato figlio del Sole. Si riscontrano alcuni usi lessicali comuni: rector è in IV Cons. Hon.
420 il vecchio marinaio e in Theb. 6,316 Adrasto, la presenza del verbo tecnico doceo (IV Cons.
Hon. 424; Theb. 6,322), natus per indicare il figlio (IV Cons. Hon. 422, il figlio del marinaio; Theb.
6,321, Fetonte); e significative variazioni: il passaggio di consegne in IV Cons. Hon. 422 è espresso
dal verbo tecnico commendo15
, in Theb. 6,316 si ricorre alla perifrasi indulget agendum che
sottolinea la concessione di Adrasto; il nesso metaforico aequoreas habenas di IV Cons. Hon. 422 e
quello di segno opposto ignea lora di Theb. 6,320. Leggere la similitudine di Claudiano alla luce
della sua affinità con il motivo del pater-praeceptor induce a scorgere nell’allusione a Stazio
l’intenzione di inserire Onorio in questa tradizione di "investiture", con la differenza che Onorio,
come il giovane marinaio saprà guidare la nave, sarà in grado di governare il proprio stato.
La seconda parte della similitudine (vv. 423-427) presenta l’elenco dei pericoli nei quali il
giovane può incorrere e dei consigli su come evitarli. Il padre non insegna solo le artes ma anche i
casus, gli incidenti con i quali il nocchiero avrà a che fare. Anche in questo caso è utile richiamare
un passo del sesto libro della Tebaide di Stazio quando Arione ha completamente esautorato
Polinice che pieno di paura rinuncia alla guida, vv. 450-453: Sed nec lora regit nec uerbera pallidus audet
Labdacides: lassa ueluti ratione magister
13
Il luogo omerico è considerato l’archetipo di ogni poesia didascalica: cfr. M. CITRONI, Ovidio Ars 1,3-4 e Omero,
Iliade 23,315-318: l’analogia tra le artes e la fondazione del discorso didascalico, «Sileno» 10, 1984, pp. 157-167. 14
A. Barchiesi nel suo commento ad l. interpreta la lezione del Sole come un’esposizione dell’etica del giusto mezzo.
Molto simili, per le indicazioni topografiche e per la possibilità di lettura in chiave etico-pedagogica, sono i precetti che
Dedalo dà a Icaro prima del loro viaggio etereo fatto con un mezzo fuori dall’ordinario, cfr. Ou. Ars 2,51-64 e Met.
8,203-209. Sul mito di Icaro e le sue interpretazioni etiche e politiche: A. SHARROCK, Seduction and Repetition in
Ovid’s Ars Amatoria II, Oxford 1994, pp. 146-155; R. RONCALI, Ovidio, il mito di Dedalo e il tiranno, «Quad. di
Stor.» 23, 1997, pp. 43-58; A. LA PENNA, Tra Fetonte e Icaro: ardimento o amore della scienza? «Maia» 51, 2003, pp.
535-564; 15
Indica l’affidamento, anche ereditario, di un bene materiale a qualcuno, cfr. TLL III, 1841, 33 ss., ma soprattutto
Claud. III Cons. Hon. 83 Ille uetat rerumque tibi commendat habenas; de Nuptiis 307 s. dignus cui pignora tanti/
principis et rerum commendarentur habenae.
5
in fluctus, in saxa ruit nec iam amplius astra
respicit et uictam proiecit casibus artem.
Il binomio claudianeo casus artesque pare ricordare Theb. 6,453, in cui i casus sono qualcosa di
ignoto al nocchiero, prevedibile solo con l’esperienza, contro i quali anche l’ars, intesa come mera
capacità tecnica, è inutile. Quindi il praeceptor di Claudiano offrirebbe al suo pupillo uno strumento
di governo in più, l’esperienza che gli consente di prospettare al figlio un elenco particolareggiato di
"imprevisti". Si potrebbe scorgere nella similitudine di Claudiano un intento correttivo nei confronti
di quella di Stazio: l’insegnamento e quindi la prevedibilità dei casus è il segreto grazie al quale
l’ars del nocchiero-re non potrà mai essere vinta.
3. Onorio al gioco della guerra: vv. 539-553 e Stat. Theb. 389-403
Nella parte del panegirico dedicata alle praxeis trionfa il descrittivismo di cui Claudiano è
maestro: in assenza di imprese che testimonino la grandezza dell’imperatore, il compito di
trasmettere l’idea della straordinarietà della persona imperiale è affidato alle immagini. E infatti,
dopo la narrazione delle gesta di Stilicone auspicate da Onorio (vv. 428-487) e la lode delle doti
morali convenzionalmente attribuite all’imperatore (vv. 488-517), ai vv. 518-628 si susseguono una
serie di ekphraseis nelle quali l’infante imperiale appare dotato di bellezza divina e promettente in
ogni arte. Ci si concentrerà qui su tre piccoli quadri, utili a vedere come Claudiano rielabori alcuni
motivi e stilemi staziani.
La lode della forza fisica rappresenta anche la parte atletica della "Bildung" del principe, che
deve eccellere soprattutto nella vita attiva: se ne vantano a questo punto l’abilità nell’uso dell’arco e
la perizia nell’equitazione. A questo proposito Claudiano sembra abbandonare la sospensione
temporale che caratterizza l’infanzia eroica di Onorio e ricondurre il lettore a un evento ben definito
(vv. 539-543): Cum uectaris equo simulacraque Martia ludis,
quis mollis sinuare fugas, quis tendere contum
acrior aut subitos melior flexisse recursus?
Non te Massagetae, non gens exercita campo
Thessala, non ipsi poterunt aequare bimembres.
La scena iniziale del quadro fa riferimento non a una generica esercitazione a cavallo, ma
all’esecuzione dei simulacra belli, il carosello equestre che si svolgeva in occasione dei Ludi
consulares, che viene descritto con profusione di particolari in VI Cons. Hon. 521-53916
.
L’esibizione di queste manovre di cavalleria che seguivano rigorose coreografie non era solo uno
spettacolo, ma anche una vera e propria esercitazione bellica, con l’obiettivo di insegnare ai giovani
cavalieri a effettuare i movimenti utili in campo di battaglia e a conservare, anche nel pieno dello
scontro, l’assetto dello schieramento17
. L’aspetto militare dell’esercitazione, che passerebbe
comunque in secondo piano davanti alla spettacolarità dell’evento, è qui potentemente rievocato
dalla perifrasi ossimorica simulacra Martia ludis18
, perché è proprio questa connotazione a dare
gloria all’imperatore che, ancora adolescente, dimostra una stupefacente predisposizione all’arte
16
Cfr. VI Cons. Hon. 621-639. Nella parte iniziale e conclusiva di questo passo, in cui descrive le esercitazioni belliche,
il poeta ricorre a iuncturae ossimoriche (621 belligeros […] lusus; 622 armatos […] choros; 622 s. certa uagandi/ […]
lege; 623 inconfusosque recursus; 624 pulchras errorum artes; 638 laeta sub imagine pugnae; 639 armorum innocuos
[…] honores) per mettere in risalto la natura dell’esibizione, cioè quella di un gioco che imita la guerra, che in
apparenza ne produce il medesimo effetto di confusione, ma che in realtà è studiato e segue delle precise indicazioni di
regia. Per un commento puntuale cfr. M. DEWAR, Claudian Panegyricus de sexto Consulatu Honorii Augusti, Edited
with Introduction, Translation and Literary Commentary, Oxford 1996, ad ll. 17
Cfr. DEWAR 1996, pp. 408 ss. 18
L’espressione evoca il contrasto tra le dimensioni bellica e ludica e richiama molto da vicino VI Cons. Hon. 621
belligeros exercuit […] lusus (cfr. DEWAR ad l.). In entrambe è duplice il riferimento alla natura fittizia della guerra
grazie al verbo, che in questo caso richiama un contesto puramente ludico (lusit), nell’altro un contesto atletico
(exercuit), e al sostantivo che designa l’esibizione, simulacra e lusus, che associano un contesto spettacolare e uno
agonistico. Il nesso simulacra Martia è una variazione di belli simulacra usato in contesto simile in Verg. Aen. 5,674 a
proposito del Lusus Troiae (cfr. WILLIAMS ad l.). La iunctura deriva però da Lucr. 2,41 Feruere cum uideas belli
simulacra cientis e soprattutto 324 camporum complent simulacra belli cientes dove si parla di esercitazioni militari.
6
bellica19
. Questa iunctura ha l’effetto di rendere spontanea nella mente del lettore l’associazione
dell’imperatore con il giovane Ascanio, speranza dei Troiani e fondamento della futura gloria di
Roma, che guida uno dei drappelli coinvolti nel lusus Troiae in Verg. Aen. 5,674 Qua ludo indutus
belli simulacra ciebat.
Su Onorio quindi Claudiano riversa allusivamente la carica di ottimistica aspettativa di cui
Virgilio aveva dotato il figlio di Enea. Le abilità del giovane nel cavalcare con il giavellotto in resta
e nell’eseguire le figure di guerra sono enumerate attraverso una serie di interrogative (con la
ripetizione enfatica del pronome quis a inizio di verso e dopo cesura semisettenaria), alle quali è
data risposta nel distico successivo dove si sviluppa, attraverso la ripetizione anaforica della
negazione non, una serie in crescendo di tre comparazioni con i Massageti, i Tessali e i Centauri,
popolazioni la cui eccellenza nell’arte della guerra a cavallo è paradigmatica. La bravura di Onorio
risulta quindi superiore a quella di popoli abituati alla guerra a cavallo e, iperbolicamente, persino a
quella dei Centauri, che sono creature semiequine20
.
Dopo questo breve catalogo dal gusto esotico, il poeta insiste sullo stesso tema usando come
termine di paragone le schiere stesse di Onorio che non riescono a reggere il passo del loro principe.
Il tertium comparationis dei vv. 545 s. si specializza, non è più il generico aequare di v. 544, che
poteva riferirsi a tutti gli aspetti del combattimento a cavallo, ma diventa sequuntur, quindi la dote
di Onorio che quest’immagine raffigura e celebra è la straordinaria velocità che egli sa raggiungere
a cavallo: Vix comites alae, uix te suspensa sequuntur
agmina feruentesque tument post terga dracones.
La velocità di Onorio a cavallo è tale da mettere a dura prova gli altri drappelli coinvolti nelle
manovre di cavalleria e quindi da lasciar immaginare al lettore un principe protagonista assoluto al
di fuori dei ruoli imposti dal carosello. Sintomo della velocità di Onorio è la fatica dei compagni al
suo seguito espressa attraverso la ripetizione di uix in posizione d’enfasi accompagnato dalla
menzione delle alae e degli agmina. I due sostantivi richiamano naturalmente un ambito militare e
indicano delle parti dell’esercito sempre più grandi: il primo più specificamente le due ali di
cavalieri disposte dietro a Onorio21
e il secondo probabilmente tutti i drappelli coinvolti nella
parata. Onorio lascia quindi dietro di sé una folla sempre più numerosa e affannata.
Il nesso suspensa agmina, i cui membri sono iconicamente separati dal verbo allitterante
sequuntur e dall’enjambement (che insistono sull’idea espressa dal participio) è concettualmente
molto denso: il participio suspensus si riferisce infatti a una velocità iperbolica che tiene le schiere
"sollevate" da terra22
, si profila l’immagine eccezionale di un esercito in volo, ma potrebbe anche
far pensare all’idea della fatica fisica degli altri cavalli che stentano a sostenere il passo del destriero
di Onorio23
.
19
Per il precoce amore per le armi che sono i balocchi abituali di Onorio cfr. III Cons. Hon. 22-32 e IV Cons. Hon. 160-
164 (il paradigma mitico, anche esplicitato, è naturalmente Achille, cfr. PERRELLI, 1992, pp. 34 s.). L’amore per le
armi è la maggior prova di attitudine all’eroismo e di virilità in un ragazzo: cfr. Partenopeo in Stat. Theb. 4,265 ss.; e
Achille in Achil. 1,852-857. 20
L’accostamento ai Centauri dà al breve catalogo l’andamento di una climax, in quanto, soprattutto grazie all’epiteto
bimembres (poetico per i Centauri da Cornificio fr. 2 Courtney e Verg. Aen. 8,293; cfr. CASALI a Ou. H. 9,99), pare
che si realizzi una completa fusione tra il cavallo e il suo cavaliere. 21
Si potrebbe qui pensare a una disposizione simile a quella del Lusus Troiae in cui i tre giovani più nobili guidavano
tre diverse colonne di cavalieri: cfr. Verg. Aen. 5,560 s. Tres equitum numero turmae ternique uagantur/ ductores. 22
Per il motivo della sospensione in aria per la velocità si vedano anche le similitudini riferite a Camilla in Verg. Aen.
7,808-811 Illa uel intactae segetis per summa uolaret/ gramina nec teneras cursu laesisset aristas,/ uel mare per
medium fluctu suspensa tumenti/ ferret iter celeris nec tingeret aequore plantas e HORSFALL ad l. In questo caso
suspensa è detto di Camilla che “vola” tanto è veloce; cfr. anche Stat. Silu. 2,3,13 fuga suspensa per agros. Per questa
accezione del verbo cfr. OLD 1890, s. v. suspendo, 5a. 23
Il participio suspensa, che fisiologicamente esprime la tensione dei muscoli impegnati in un respiro affannoso (OLD
1890, s. v. suspendo, 4a), potrebbe ricordare l’immagine brachilogica di Theb. 6,473 et longi suspendunt ilia flatu, con
la quale Stazio descrive i cavalli spossati dalla fatica: il nesso longi flatus “raffigura” l’ansimare ripetuto e prolungato
dei cavalli sotto sforzo e il verbo suspendunt la tensione dei fianchi dell’animale.
7
L’immagine claudianea della folla che insegue Onorio acquista in originalità e in efficacia
descrittiva nell’elaborazione del motivo della velocità tale da far sì che il vento gonfi i vessilli. La
metonimia dracones, cioè i gonfaloni delle coorti con l’effigie del drago24
, anima le bandiere che
sembrano trasformarsi nell’animale mostruoso grazie al vento vivificante sollevato dalla velocità di
Onorio. Contribuiscono a questo effetto il participio feruentes, connesso con l’area semantica del
fuoco25
, e il verbo tument che sembra qui evocare anche il turgore muscolare di un animale sotto
sforzo26
, come in Stat. Theb. 6,418 colla crinita tument (dove si suggerisce l’immagine plastica di
una tensione muscolare smisurata: pare che nei cavalli in corsa i crini si trasformino in nervi tesi).
L’immagine offre dunque due livelli di lettura: uno realistico di Onorio che si staglia solitario
davanti alle truppe con i gonfaloni spiegati al vento, e l’altro fantastico, in cui dietro ai vessilli
sembra di scorgere mostruosi animali di fuoco, come quelli che si combattono nella corsa staziana
(cfr. Theb. 6,389-403), che questa volta non riescono a incalzare l’auriga protagonista che li supera
con la sua prodigiosa velocità.
4. Tuis … calcaribus
L’occasione dei Martia simulacra si trasforma sempre di più in pretesto per lodare l’imperatore
in un crescendo di precisione. Dall’evocazione dei drappelli in corsa affannosa con i vessilli
spiegati, si passa al ritratto ravvicinato del cavallo imperiale e quindi dell’Augusto stesso, ancora
più maestoso e bello in mezzo alle fatiche delle esercitazioni. I vv. 546-550 sembrano spiegare la
causa dell’eccezionale velocità di cui si parlava sopra, cioè il carisma imperiale: Vtque tuis primum sonipes calcaribus arsit,
ignescunt patulae nares, non sentit harenas
ungula discussaeque iubae sparguntur in armos;
turbantur phalerae, spumosis morsibus aurum
fumat, anhelantes exundant sanguine gemmae.
La descrizione dei sintomi del furor del cavallo in corsa rivela come modello quella dei cavalli alle
"griglie di partenza" in Stat. Theb. 6, 396-403: face lumina surgunt
Ora sonant morsu, spumisque et sanguine ferrum
uritur, impulsi nequeunt obsistere postes
claustraque, compressae transfumat anhelitus irae.
Stare adeo miserum est, pereunt uestigia mille
ante fugam, absentemque ferit grauis ungula campum.
Circumstant fidi, nexusque et torta iubarum
expediunt firmantque animos et plurima monstrant.
Tuttavia la differenza tra le due situazioni è grande: i cavalli di Stazio sono impazienti perché
fremono, animati da un intimo furor, nell’attesa della gara che per loro sarà come una battaglia; il
cavallo di Claudiano, invece, non si deve cimentare in una competizione, deve solamente sfilare, e
quindi la sua irrequietudine non avrebbe ragione d’essere in un contesto non agonistico27
. In questo
24
Draco è usato da poeti e prosatori tardi (cfr. TLL V 1, 2064, 19 ss.) per indicare le bandiere con il drago, emblema di
alcune coorti introdotto probabilmente all’epoca delle guerre daciche. Più volte usato da Claudiano: cfr. VI Cons. Hon.
566-568 quid fixa draconum/ ora uelint? uentis fluitent an uera minentur/ sibila suspensum rapturi faucibus hostem? e
DEWAR ad l. Topica l’allusione al realismo dei draghi dipinti: cfr. Claud. Ruf. 2,176 ss.; 364; Eutr. 193. 25
Cfr. R. MALTBY, A Lexikon of Ancient Latin Etymologies, F. Cairns 1991, s. v. feruor; TLL VI 1, 590. 26 Claudiano usa il verbo tumeo in relazione ai draghi delle bandiere anche in III Cons. Hon. 139 multusque tumet per
nubila serpens. Anche in questo passo si può notare l’ambiguità semantica di tumeo, che sia indica il corpo del serpente
teso nel movimento sia il vessillo gonfiato dal vento. 27
Il tema dell’impazienza dei cavalli era già stato accennato da Claudiano in Rapt. 1,276-288. Se effettivamente il
poema epico-mitologico risale al 396-7 (cfr. C. GRUZELIER, Claudian De Raptu Proserpinae, Oxford 1993, pp. XVII
s.), sarebbe questa la prima trattazione claudianea del motivo. Nel primo libro i quattro destrieri di Plutone sono colti
mentre smaniano di uscire dal regno dei morti, 1,287 s.: Stabant ante fores iuncti saeuumque fremebant/ crastina
uenturae spectantes gaudia praedae. Gruzelier ad l. cita in riferimento al passo, per il motivo del fremitus del cavallo,
Verg. Aen.11,607 fremitusque ardescit equorum e Ou. Met. 3,704 ut fremit acer equus. Tuttavia i cavalli di Claudiano
non smaniano per andare alla guerra come quelli descritti da Virgilio e Ovidio: l’immagine richiama pertanto dei
8
la ripresa del motivo della concitazione del cavallo è originale: il destriero non è agitato per la prova
che lo attende, ma è il contatto con il cavaliere a trasmettergli una sorta di energia trasfigurante.
Onorio possiede quindi la virtù di insinuare il furor nel cavallo solo incitandolo con gli speroni, un
motivo verosimilmente esterno alla tradizione epica: cioè è l’imperatore a possedere una forza
"demonica" che riesce a trasmettere al cavallo che domina.
Pare di poter osservare in relazione a questo passo un analogo processo di "ispirazione divina"
in Lucr. 5,1075 s.: Pinnigeri saeuit calcaribus ictus Amoris
et fremitum patulis sub naribus edit ad arma.
Al contatto con gli sproni di Amore, che rappresenta nella convenzionale forma divina il
principio aggregante al quale nessuno può sottrarsi, il giovane stallone si trasfigura fino a fremere,
ricordando un cavallo da guerra, e nitrire diversamente dal solito (cfr. Lucr. 5,1077 et cum sic alias
concussis artubus hinnit?). La memoria del passo lucreziano28
opera in modo tale da insistere sulla
natura divina di Onorio.
Onorio sa anche governare la straordinaria forza che genera e quindi implicitamente si crea una
comparazione con gli aurighi staziani, e Polinice soprattutto, che sono per lo più incapaci di
governare i loro cavalli. Nella gara staziana infatti i veri protagonisti sono i cavalli dotati di forza
prodigiosa, mentre gli aurighi sono figure pallide ed epigonali (sono per lo più figli di grandi eroi,
in alcuni casi anche degeneri) che cedono alla loro natura ferina oppure la domano solo con l’aiuto
di qualche divinità. Un tale risultato della presenza dell’imperatore in un contesto pacifico promette
bene per quando avrà a che fare con la guerra.
In Stat. Silu. 1,1, la descrizione della statua equestre di Domiziano, i fianchi sono tra le parti più
realistiche dell’opera d’arte, vv. 49 s.: Et tantis calcaribus ilia late/ suffectura patent. L’uso di
pateo e di late fa pensare a un completo e volontario abbandono del cavallo prima ancora di sentire
il contatto degli speroni del suo straordinario cavaliere (suffectura pare suggerire che solo l’idea di
ricevere Domiziano fa sì che il cavallo si disponga a essere cavalcato). Claudiano sembra quindi
essersi ricordato dell’idea di Stazio e di averle dato concretezza: l’imperatore non ha solo un
carisma impalpabile che condiziona il cavallo e il tocco dei suoi speroni sprigiona un’autentica
energia29
.
La descrizione di Claudiano prende avvio dalla rielaborazione di due passi poetici (Lucr.
corsieri scalpitanti dietro i cancelli, come fa ben capire fores, come quelli di Stat. Theb. 6,398 ed eccitati per qualcosa
che ha ancora da venire (cfr. Stat. Theb. 6,401 absentem… campum e nota ad l.) e non per un segnale che ha annunciato
l’inizio della battaglia. Nel secondo libro del Raptus, composto probabilmente negli anni tra il 400 e il 402, Claudiano
così descrive i cavalli di Plutone usciti dagli Inferi, ma riluttanti a proseguire verso Enna, 2,197-203: Mox ubi pulsato
senserunt uerbera tergo/ et solem didicere pati, torrentius amne/ hiberno tortaque ruunt pernicius hasta:/ quantum non
iaculum Parthi, non impetus Austri,/ non leue sollicitae mentis discurrit acumen (cfr. GRUZELIER ad l.). Le frustate
spronano i cavalli la cui velocità è espressa con una serie di cinque similitudini nella quale è evidente la presenza di
Stat. Theb. 6,405-409 (Quae tantum carbasa ponto,/ quae bello sic tela uolant, quae nubila caelo?/ amnibus hibernis
minor est, minor impetus igni,/ tardius astra cadunt, glomerantur tardius imbres./ Tardius e summo decurrunt flumina
monte). Alla straordinaria velocità si accompagnano alcuni segni che caratterizzano i cavalli come creature maledette
che ammorbano tutto quanto li circonda, cfr. Rapt. 2,202 s. (Sanguine frena calent; corrumpit spiritus auras/ letifer;
infectae spumis uitiantur harenae). Il sangue che scalda i freni ricorda Stat. Theb. 6,397 s. spumisque et sanguine
ferrum/ uritur; mentre la bava che cade a terra si rivela ancor più mostruosa di quella di Theb. 6,419 bibit albentis
humus arida nimbos (il modello è infatti Ou. Met. 3,76 Ore niger Stygio uitiatas inficit auras, detto del drago che
Cadmo deve affrontare). 28
Prova il rapporto tra i due passi il nesso patulae nares ripreso da Lucr. 5,1076 per indicare il primo effetto del
contatto con gli sproni divini. 29
All’interno del panegirico Onorio è più volte connotato come una divinità (per esempio cfr. 181-183 Nec Boreas
nimbos aut sol ardentior egit:/ imperii lux illa fuit; praesagus obibat/cuncta nitor risitque tuo natura sereno, ma anche
la menzione di omina e auspicia che accompagnano la nascita e l’incoronazione del fanciullo), fatto strano dopo la
battaglia del Frigido e l’assunzione del cristianesimo a religione di stato. MORONI 1993, pp. 15-17 lo spiega come un
modo per cattivarsi i consensi dell’aristocrazia pagana di Roma e di opporsi alla propaganda in chiave cristiana sfruttata
da Mascezel. Per il tema del carisma imperiale cfr. D. LASSANDRO, Sacratissimus Imperator. L’immagine del
princeps nell’oratoria tardo antica, Bari 2000, pp. 95-104.
9
5,1075-1077 e Verg. Georg. 3,83-8830
, le reazioni che contraddistinguono per il suo vigore il
giovane puledro destinato alla monta) ed è contaminata con la reminiscenza di quella staziana di
Theb. 6,389-403, che riguarda però più squadre di destrieri. Claudiano attribuisce questi sintomi a
un unico cavallo sul quale monta l’Augusto, dietro al quale tutti gli altri, uomini e animali,
scompaiono o sopravvivono come semplici comparse.
Claudiano opera contaminando il passo virgiliano e quello staziano e trascegliendone alcuni
motivi. Il poeta flavio costruisce una descrizione in cui la coordinazione asindetica dei vari
segmenti impone l’idea della frenetica attesa dei cavalli e ogni motivo è sviluppato nei particolari
con l’attenzione puntata sulla vanità esasperante del movimento31
. In Claudiano scompare la
frustrante negazione del moto che c’era in Stazio e rimane invece la connotazione del cavallo come
mostro di fuoco che sembra correre nell’aria. La descrizione comincia con una temporale, nella
quale arsit32
esprime la trasmissione dell’energia in forma di fuoco da Onorio al destriero attraverso
gli speroni33
, proprio come nel passo lucreziano, che sortiscono lo stesso effetto del clangore delle
armi in Verg. Georg. 3,83 e dell’eccitazione che precede la corsa in Stat. Theb. 6,396 ss. Segue
l’enumerazione asindetica degli altri motivi con il risultato di creare un quadro nel quale il poeta
rende con grande efficacia descrittiva l’idea della repentina metamorfosi dei cavalli e della loro
velocità.
Il passo ben si presta a studiare il comportamento di Claudiano nei confronti del modello
staziano. Il primo sintomo del furor dei cavalli al v. 547 ignescunt patulae nares rielabora Verg.
Georg. 3,85 collectumque premens uoluit sub naribus ignem e Stat. Theb. 6,399 compressae
transfumat anhelitus irae: si perde però qui il senso di compressione al centro delle descrizioni
virgiliana e soprattutto staziana, emblematico del movimento frustrato, ma soprattutto Claudiano va
oltre la metafora staziana del "fuoco dell’ira", facendo sì che il suo cavallo emetta dalle froge puro e
semplice fuoco, come il puledro virgiliano. L’incoativo ignesco evidenzia il rapporto di causalità tra
questa manifestazione di furor e Onorio che è montato a cavallo, e brachilogico risulta il recuperato
nesso lucreziano patulae nares, in quanto pare di vedere le froge che prima si dilatano a dismisura,
diventando incandescenti, e infine sputano fuoco. La successiva manifestazione dell’energia divina
è la velocità straordinaria che il cavallo raggiunge, vv. 547 s.: non sentit harenas/ ungula.
Claudiano riecheggia Theb. 6,399 absentemque ferit grauis ungula campum, procedendo però in
senso contrario a Stazio34
: mentre il poeta flavio insiste sulla pesantezza e sulla violenza del colpo
degli zoccoli di questi cavalli costretti a stare fermi, Claudiano invece rappresenta l’alata leggerezza
30
Verg. Georg. 3,83-88 tum, si qua sonum procul arma dedere/ stare loco nescit, micat auribus et tremit artus,/
collectumque premens uoluit sub naribus ignem./ Densa iuba, et dextro iactata recumbit in armo;/ at duplex agitur per
lumbos spina, cauatque/ tellurem et solido grauiter sonat ungula cornu. 31
Così si può suddividere Stat. Theb. 6,397-403: 397-398 l’attenzione è concentrata attorno alla bocca dei cavalli dalla
quale esce sangue misto a bava che corrode i finimenti; 398 s. la frenesia dei cavalli mette a dura prova i carceres e
l’impossibilità di abbatterli si traduce nell’ira che esce dalle froge in forma di fumo; 399-401 è il pezzo forte della
descrizione staziana, cioè il movimento dei cavalli vanificato dalla costrizione; 402 s. i garzoni di scuderia cercano di
placare gli animali pettinandone le criniere. 32
Non è frequente l’uso di ardeo in riferimento agli animali e ai cavalli in particolare (cfr. TLL VII 2, 485, 50 ss.): cfr.
Verg. Aen. 1,472 ardentisque auertit equos; ma soprattutto il verso di Stat. Theb. 6,427 iratusque oneri solito
truculentior ardet, che racchiude un gioco etimologico fondato su iratus che sembrerebbe suggerire la radice di pàr e
ardet (per la supposta etimologia di ira cfr. MALTBY, 1991, s.v. ira), detto proprio di Arione e glossato dal verso
successivo Inachidae credunt accensum laudibus. È interessante notare che l’ardere di Arione è determinato dall’ira e
dal disprezzo che in lui suscita Polinice, quello del cavallo imperiale invece dagli sproni del cavaliere. 33
A questo proposito si noti la ripetizione cellula fonica ca- in calcaribus e la scelta dell’epiteto sonipes che
suggeriscono i rumori della partenza del cavallo. L’emistichio è isometrico a Verg. Aen. 6,881 foderet calcaribus
armos cui forse la memoria involontaria del poeta allude. L’espressione di Claudiano è più vicina alla clausola staziana
calcaribus urgent (cfr. Theb. 11,452) che però supera in vigore e anima con l’idea del fuoco. 34
Nella nota al v. 547 Fargues (Cl. Claudiani, Panegyricus de Quarto Consulatu Honorii Augusti, Aix en Provence
1936) rinvia solo a Stat. Theb. 6,638 s. uix campus euntem/ sentit, la corsa di Partenopeo; pare invece utile sottolineare
come l’allusione avviene qui per contrasto, per dare risalto all’alata velocità del cavallo imperiale, dato che anche il
modello comune di Claudiano e Stazio, cioè Verg. Georg. 3,87 s., menziona l’attrito dello zoccolo impaziente con la
terra: cauatque/ tellurem et solido grauiter sonat ungula cornu.
10
del destriero di Onorio che è un corpo di fuoco volante35
.
Allontanandosi da Stazio Theb. 6,402 s. (nexusque et torta iubarum/ expediunt), che conclude la
descrizione dell’impazienza dei corsieri alla partenza, Claudiano riprende più da vicino Virgilio,
quando sviluppa il motivo dei crini al vento: il v. 548 discussaeque iubae sparguntur in armos
ricorda molto Verg. Georg. 3,86 densa iuba et dextro iactata recumbit in armo. La situazione è
opposta, perché in Claudiano i crini sono scompigliati dal vento della corsa, mentre in Stazio i
garzoni di scuderia stanno pettinando le criniere con un gesto che sembra riportare i cavalli a uno
stato di quiete. L’immagine è ben lontana anche dall’altro riferimento che Stazio fa alle criniere dei
suoi destrieri, Theb. 6,418 s. stantisque repectit/ aura iubas, in quanto nella descrizione di
Claudiano prevale l’immagine plastica di una criniera violentemente agitata dal vento36
, mentre in
Stazio si assiste a una sorta di orrida "pietrificazione" dei crini in corsa.
I vv. 549 s. sviluppano gli effetti della corsa sugli ornamenti del cavallo da parata estranei ai più
sobri cavalli da corsa staziani. Theb. 6,397 s. spumisque et sanguine ferrum/ uritur è amplificato per
ottenere un suggestivo effetto di contrasto tra il pregio dei materiali dei finimenti e la crudezza della
bava e del sangue del cavallo sotto sforzo. Claudiano glossa e sviluppa la concentrata espressione
staziana in spumosis morsibus aurum/ fumat, conservando nelle posizioni d’enfasi, separate
dall’enjambement, il nome del metallo e il verbo. L’effetto del liquido bianco, che sta a contatto
diretto con i freni, passa da uritur a fumat, visto che il fuoco era già stato assegnato dal poeta
alessandrino alle froge, che in Stazio erano solo fumanti, e inoltre il metallo dei freni non è il vile
ferrum, ma il nobile aurum più consono alla dignità del cavaliere (Claudiano vuole forse alludere
anche a una minore corruttibilità dell’oro e quindi all’effetto prodigioso della bava dei cavalli):
sembra quindi che l’oro dei freni a contatto con la bava del cavallo si fonda fumando.
L’immagine conclusiva rappresenta il culmine del colorismo e della crudezza della descrizione,
v. 550: anhelantes exundant sanguine gemmae, alle pietre preziose della bardatura, probabilmente i
finimenti dei freni37
, è attribuito per ipallage il participio anhelantes che dovrebbe invece riferirsi al
respiro affannoso del cavallo. Le gemme sembrano quindi animate, rese pulsanti, e l’esametro si
conclude con una clausola virgiliana che glossa l’ipallage38
. Claudiano trasferisce l’espressione
virgiliana da un contesto bellico, dove il sangue straripa dai fossati a indicare la violenza inaudita
della battaglia, alla descrizione dei monili del cavallo imperiale con il risultato di conferirle una
dignità più guerresca. Una prima esegesi del passo potrebbe essere che il freno fa sgorgare dalla
bocca del cavallo un fiotto di sangue che irrora le gemme: sembra cioè che il profluvio di sangue
affoghi le pietre in un rosso rubino. L’accostamento in clausola sanguine gemmae ancora una volta
metterebbe in risalto il contrasto barocco tra il pregio delle pietre preziose, i carbonchi, e la natura
ripugnante del sangue, e arricchirebbe la descrizione di una violenta notazione cromatica. Tuttavia
l’anhelantes sembra riferirsi piuttosto a un moto, una pulsione interna delle stesse pietre preziose
che prendono vita nella corsa. È preferibile allora intendere che le pietre preziose traboccano
35
È suggestivo a questo proposito rimarcare l’uso di non sentit in Claudiano (547) e di absentem in Stazio (401): il
primo sembra spiegare paraetimologicamente il secondo (a sensibus, come praesens sarebbe prae sensibus, cfr.
MALTBY 1991, s.v. praesens), anche se il significato è poi opposto: infatti il cavallo di Onorio è così veloce da non
sfiorare neppure la terra (e quindi è anch’egli privo di campo di gara), l’immobilità invece rende così furiosi i cavalli di
Stazio da farli colpire con violenza un campo di gara che verrà, ma che ancora non c’è. 36
Discussae fa pensare alla criniera del cavallo quasi divisa in due, ripartita da una parte e dall’altra del collo. La
iunctura è ripresa con senso diverso da Verg. Aen. 9,808-810 dove si descrive Turno in fuga con l’elmo dal quale si
staccano i pennacchi per i colpi: strepit adsiduo caua tempora circum/ tinnitu galea et saxis solida aera fatiscunt/
discussaeque iubae. Cfr. Claud. Epigr. 18,10 spargit et excussis colla superba iubis! 37
Cfr. Claud. Epigr. 21,8-9 uirides spumis perfunde smaragdos./ Luxurient tumido gemmata monilia collo. Anche in
Epigr. 18 che descrive i doni inviati da Serena ad Arcadio il morso del cavallo è di pietre preziose. 38
Per il nesso exundant sanguine cfr. Verg. Aen. 10,24=11,382 inundant sanguine fossae (poi Sen. Ag. 222 et alto
exundans sanguine solum), costruito sulla formula omerica ∙še d' a‡mati ga‹a, cfr. G. CONTE, Virgilio: l’epica del
sentimento, Torino 2002, pp. 139-145.
11
(exundant), cioè fanno sgorgare, del sangue, il fulgido nucleo di colore rosso, che racchiudono al
loro interno39
.
All’affanno del cavallo sconvolto si contrappone la bellezza di Onorio, efebo dalla chioma
scarmigliata, accresciuta, secondo un topos tradizionale40
, dalla fatica e dalla polvere della corsa,
vv. 551-553: Ipse labor puluisque decet confusaque motu
caesaries; uestis radiato murice solem
combibit, ingesto crispatur purpura uento.
Il quadro si conclude con l’epifania del suo protagonista assoluto, Onorio, in mezzo a un trionfo
di luce e colore. L’imperatore appare con il manto purpureo, che, colpito dai raggi del sole, li
assorbe avidamente41
per trasformarli nello splendore che la figura imperiale irradia, e le cui pieghe
sono modellate dal vento della corsa. Insieme con tale potenza immaginifica il lessico svela un
deciso intento encomiastico: i verbi combibo e ingero appartengono alla terminologia alimentare e
sono usati qui in senso metaforico per indicare una completa presa di possesso degli elementi da
parte dell’imperatore, come sottolinea anche il valore risultativo dei preverbi. Ne consegue che
Onorio con il suo manto "beve il sole" e "mangia il vento", impadronendosi così con il proprio
corpo della natura che assorbe in se stesso.
5. Il catalogo dei cavalli mitologici: vv. 554-564 e Stat. Theb. 301-350 Si dominus legeretur equis, tua posceret ultro
555 uerbera Nereidum stabulis nutritus Arion
seruiretque tuis contempto Castore frenis
Cyllarus et flauum Xanthus spreuisset Achillem.
ipse tibi famulas praeberet Pegasus alas
portaretque libens melioraque pondera passus
560 Bellerophonteas indignaretur habenas.
Quin etiam uelox Aurorae nuntius Aethon,
qui fugat hinnitu stellas roseoque domatur
Lucifero, quotiens equitem te cernit ab astris,
inuidet inque tuis mauult spumare lupatis.
Un catalogo di cavalli mitologici conclude in modo inaspettato la sezione relativa alle praxeis di
Onorio, visto che, trovandosi in un contesto di esibizioni equestri, la presentazione degli animali in
genere è posta all’inizio42
. Tuttavia la funzione di stabilire un confronto, in questo caso tra gli
aurighi dei cavalli mitici e il principe, come si nota dalla movenza introduttiva si legeretur, induce a
mettere in relazione il catalogo di Claudiano con il catalogo di cavalli mitici di Verg. Georg. 3,89-
94, introdotto per comparare il giovane anonimo puledro con dei referenti paradigmatici:
39
È questa una delle virtù proprie della famiglia dei carbonchi, pietra dura di un rosso acceso, e in particolare del
sandastro, come testimonia Plin. N.H. 37,100: Commendatio summa quod ueluti in tralucido ignis optentus stellantibus
fulget intus aureis guttis, semper in corpore, numquam in cute. L’idea che all’interno di una pietra sia imprigionato un
liquido che riesce ad animarla con una luce particolare è sviluppata da Claudiano negli epigrammi De crystallo cui aqua
inerat (Epigr. 4-12): cfr. per esempio 8,3 s. nonne uides, propriis ut spumet gemma lacunis,/ et refluos ducant pocula
uiua sinus. 40
Il modello diretto di Claudiano è qui Ou. H. 4,77 s. Te tuus iste rigor positique sine arte capilli/ et leuis egregio
puluis in ore decet, la severa bellezza di Ippolito impegnato a domare i cavalli o a esercitarsi con l’asta, che tanto
affascina Fedra. Per la bellezza di Onorio cfr. anche vv. 518 s. Quantus in ore pater radiat! quam torua uoluptas/
frontis et augusti maiestas grata pudoris! 41
L’immagine è molto preziosa: il poeta infatti usa combibit, che suggerisce la penetrazione di un liquido in un corpo
solido, di un processo di assorbimento, in relazione ai raggi solari, che sono l’opposto del liquido, in quanto la loro virtù
è quella di asciugare. Tuttavia murex ricorda la materia di cui è fatto il manto e l’idea suggerita diventa quella di una
seconda colorazione, dove è il sole con l’oro dei suoi raggi a impregnare la stoffa esaltandone il primitivo colore
purpureo. Combibo è usato con una metafora simile in Plin. N.H. 17,80 ut solem pluuiasque combibant; Stat. Theb.
10,674 s. Fulminis haut citius radiis afflata cupressus/ combibit infestas et stirpe et uertice flammas, e WILLIAMS ad
l.; Mart. 10,12,7 cute combibe soles. Ingero dà l’idea di una "ingestione" del vento da parte del mantello (cfr. TLL VII
1, 1549, 15 ss.). 42
Anche nel Lusus Troiae virgiliano i cavalli sono descritti in apertura insieme con i tre giovinetti che guidano le
turmae, Aen. 5,565-570.
12
Talis Amyclaei domitus Pollucis habenis
Cyllarus et, quorum Grai meminere poetae,
Martis equi biiuges et magni currus Achilli.
Talis et ipse iubam ceruice effundit equina
coniugis aduentu pernix Saturnus, et altum
Pelion hinnitu fugiens impleuit acuto.
Il catalogo di Claudiano non riguarda il cavallo del principe né tanto meno, come quello di
Stazio, gli altri cavalli coinvolti nelle manovre, ma è un’iperbole per assicurare un gran finale alla
lode delle abilità equestri, e non solo, di Onorio. Il panegirista dice infatti che, se gli straordinari
cavalli mitologici dei più celebri eroi potessero scegliersi un cavaliere, questo sarebbe Onorio, ed
esplicita così un motivo adombrato nell’epica omerica e successivamente sviluppato, cioè quello del
cavallo che si sceglie il proprio cavaliere dichiarandone quindi la superiorità rispetto a qualcun
altro43
. Il cavallo, animale dal temperamento incostante si presta a fungere da metafora del potere
difficile da gestire, nei panegirici imperiali, dove il riferimento ai cavalli mitici è usato come prova
della grandezza del sovrano44
. La coppia paradigmatica Cillaro e Arione non deriva dal catalogo
virgiliano, ma piuttosto da Stat. Silu. 1,1,52-55, descrizione del colosso equestre di Domiziano,
dove mostra chiaramente la sua funzione encomiastica45
: Hunc et Adrasteus uisum extimuisset Arion,
et pauet aspiciens Ledaeus ab aede propinqua
Cyllarus: hic domini numquam mutabit habenas
perpetuus frenis atque uni seruiet astro.
Stazio usa Arione, il cavallo di Adrasto, bizzoso protagonista della gara delle quadrighe nei ludi
funebri in memoria di Ofelte-Archemoro in Theb. 6, come paradigma di cavallo terrificante per
esaltare il timore reverenziale che suscita il cavallo di Domiziano trionfante che calpesta i Daci e i
Catti46
. Dopo aver immaginato un’inverosimile paura di Arione, con un audace sottinteso che
presuppone la conoscenza della storia del cavallo (visto che di Arione qui si menziona la paura e
non la volubilità o i vari passaggi di proprietà), Stazio loda la costanza del cavallo di Domiziano che
rimarrà in eterno fedele al proprio divino cavaliere. La lode scaturisce dal fatto che è il cavallo a
desiderare di sottomettersi a un così straordinario cavaliere.
L’associazione paradigmatica Arione-Cillaro si ritrova anche nella letteratura panegiristica, per
esempio nell’anonimo Paneg. Lat. 7,8,5 a Costantino: Quis enim te Cyllarus aut Arion posset
eripere quem sequebatur imperium: illa, inquam, illa maiestas quae Iouis sublata nutu nec Iridi
deum nuntiae sed pinnis commissa Victoriae tam facile te conlata est quam cito ad terras caelo
missa perueniunt? Si sta qui celebrando la modestia dell’imperatore, che ancora esita ad assumere
43
Il primo spunto per lo sviluppo del tema si avrebbe in Hom. Il. 10,530 të d' oÙk ¢škonte petšsqhn, quando Diomede
parte al galoppo con i cavalli rubati a Reso. La litote lascerebbe pensare per lo meno a un atteggiamento non ostile dei
nuovi cavalli verso Diomede (Ou. Am. 1,9,24 Et dominum capti deseruistis equi, dove l’apostrofe e il verbo desero
fanno pensare all’intenzionalità del gesto dei cavalli; e MCKEOWN ad l.). Il passo che tuttavia non lascia dubbi sulla
consapevolezza della scelta del cavallo è Val. Fl. 6,203-216: Castore desidera, per il candore straordinario del loro
manto, una coppia di cavalli montati da due fratelli e si avventa contro uno dei due, Gela, che riesce a uccidere.
S’impadronisce del suo cavallo e l’altro fratello, Medores, prega gli dei che il cavallo del fratello morto possa morire
perché, empio, ha tradito il compito affidatogli dal padre (cfr. 213-216 "Hunc, age, uel caeso comitem me reddite fratri/
primus at hic nostra sonipes cadet impius hasta/ credita qui misero non rettulit arma parenti/ meque uenit contra
captiuaque terga ministrat" e WIJSMAN ad l.). Medores attribuisce intenzionalità al cavallo, che ha abbandonato Gela,
optando per il più nobile e forte Castore. Si ricorda anche Sil. 10,458-460, dove però il cavallo catturato riconosce
l’antico cavaliere moribondo e, disarcionato il cavaliere usurpatore, si china per aiutarlo (Agnouit sonipes arrectisque
auribus acrem/ hinnitum effundens sternit tellure Bagesum,/ quem tum captiuo portabat in agmine dorso). Cfr. anche in
Stat. Theb. 7,632-639, il sonipes male fidus di Pterelao che toglie il controllo al suo cavaliere portandolo incontro alla
morte. 44 Il motivo sembra avere origine in Sen. Phaed. 809-811 Si dorso libeat cornipedis uehi,/ frenis Castorea mobilior
manu/ spartanum poteris flectere Cyllaron. All’interno di un elenco degli sport nei quali Ippolito eccelle il riferimento a
Cillaro comprova la straordinaria abilità di cavallerizzo del giovane ateniese. 45
In Stat. Silu. 1,1 l’associazione è dovuta a un fattore topografico, perché che il cavallo di Castore era effigiato nel
tempio dei Dioscuri nel Foro vicino al colosso di Domiziano. 46
Cfr. J. W. GEYSSEN, Statius and the tradition of Imperial panegyric: a literary commentary on Siluae 1,1, Durham
1992, p. 95.
13
l’imperium che gli spetta per natura (sequebatur): tale è la legittimità di questo vincolo tra
imperatore e imperium che neppure i due cavalli Arione e Cillaro (qui menzionati come paradigma
di velocità) potrebbero sottrarlo alle acclamazioni dell’esercito che lo intimidiscono47
.
È significativo anche il caso di Grat. Act. 18, in cui Ausonio conclude il suo discorso di
ringraziamento all’imperatore Graziano, di cui era stato precettore e che l’aveva creato console per
l’anno 379, celebrandone la velocità negli spostamenti (Graziano, che non riuscì a presenziare alla
cerimonia di apertura del consolato di Ausonio, ha attraversato l’impero per presiedere alla
cerimonia di chiusura del suo anno di carica). A questo punto il poeta ricorre a un catalogo di
cavalli mitologici celebri per i loro viaggi al termine del quale, introdotto dal tu, spicca Graziano
capace in un solo breve viaggio di attraversare tutto l’enorme impero: Quae enim umquam memoria
transcursum tantae celeritatis uel in audacibus Graecorum fabulis commenta est? Pegasus uolucer
actus a Lycia non ultra Ciliciam permeauit. Cyllarus atque Arion inter Argos Nemeamque
senuerunt. Ipsi Castorum equi, quod longissimum iter est, non nisi mutato uectore transcurrunt. Tu,
Gratiane, tot Romani imperii limites, […] euoluis […]. In un catalogo, la cui ricchezza si avvicina a
quella di Claudiano, l’imperatore stesso supera i cavalli per la velocità dei suoi spostamenti, che
vanno da un capo all’altro dell’immenso impero.
Se l’enumerazione di cavalli mitici è un espediente attestato nei panegirici per lodare la mobilità
del principe, la novità di Claudiano sta nel fatto che gli animali, famosi anche per l’eroismo dei loro
cavalieri, mostrando la loro preferenza per l’imperatore, ne dichiarano la superiorità assoluta anche
nei confronti dei più celebri personaggi del mito.
Nella loro valenza di simbolo del potere, Cillaro e Arione sono usati da Claudiano, con una
lieve variazione, anche in Epigr. 19, breve componimento ecfrastico in distici elegiaci nel quale il
poeta loda un balteo ricamato e donato da Serena, sposa di Stilicone, al cugino Arcadio, imperatore
d’Oriente, vv. 5-6: Hoc latus astringi uelox optaret Arion,
hoc proprium uellet cingere Castor equum.
Tale è la bellezza del finimento che Arione, cavallo dotato di volontà e intelligenza umane e
insofferente a costrizioni d’ogni tipo, desidererebbe vedersene adorno, e così anche Castore lo
chiederebbe per il proprio cavallo Cillaro. Fuor di metafora, così prestigioso è l’imperium di
Arcadio che i cavalli offrono spontaneamente la loro sottomissione al nuovo rector.
Nel suo catalogo Claudiano combina due valenze dei cavalli mitici, quella di paradigma di
velocità e quella di simbolo di un potere arduo da mantenere che si offre spontaneamente a un
sovrano. Integra così il motivo staziano di Silu. 1,1,52-55: sembra infatti che la virtù di Onorio sia
quella di rendere mansueti i cavalli più indocili (secondo un topos dell’encomiastica imperiale, che
celebra la funzione pacificatrice del sovrano), al punto che essi stessi desiderano l’Augusto come
cavaliere, mentre Stazio descriveva in realtà l’armonia tra ferocia del cavallo e ferocia del
cavaliere48
. Dà inoltre al passo una collocazione che, attraverso il contesto e un sistema di richiami
intertestuali, pone il testo, il cui modello acclarato è il catalogo dei cavalli mitici in Verg. Georg.
3,89-9449
, in relazione allusiva anche con il catalogo dei cavalli partecipanti alla corsa delle
quadrighe di Stat. Theb. 6,301-350.
Si può ora procedere a una disamina analitica delle varie sezioni del breve catalogo claudianeo a
confronto con quelle del più lungo catalogo staziano, che, secondo la convenzione epica, apre la
gara delle quadrighe con una particolareggiata descrizione dei sette equipaggi concorrenti. Il
47 L’imperatore per una sorta di pudore adolescenziale (topica dichiarazione di modestia) esita ad accettare il potere,
7,8,4: Diceris etiam, imperator inuicte, ardorem illum te deposcentis exercitus fugere conatus equum calcaribus
incitasse. Quod quidem, ut uerum audias, adulescentiae errore faciebas. Sic modestiam tuam atque pietatem et
differendi imperii conatus ostendit et reipublicae felicitas uicit. 48
Cfr. GEYSSEN 1992, p. 96: «Horse and rider, we can be sure, are perfectly suites to each other». 49
Nel catalogo virgiliano compaiono Cillaro, detto cavallo di Polluce, i cavalli di Marte, di Achille e infine Saturno
trasformatosi in cavallo per sottrarre se stesso e l’amata Filira alla vista della sposa legittima Rhea (cfr. MYNORS a
Georg. 3,93-95). Anche in Virgilio l’ultimo cavallo è descritto con particolare attenzione e con un riferimento al suo
verso: cfr. Georg. 3,95 hinnitu fugiens e Claud. IV Cons. Hon. 562 fugat hinnitu.
14
catalogo di Claudiano è svolto in forma di apostrofe all’imperatore con un costante appello alla sua
persona attraverso la ripetizione, con valore enfatico, del pronome di seconda persona (vv. 558 tibi;
564 te) e soprattutto dell’aggettivo possessivo tuus (vv. 554 s. tua/ uerbera; 556 tuis […] frenis;
564 tuis…lupatis), che arieggia il du-Stil del linguaggio religioso.
Ai vv. 554 s. il primo cavallo è naturalmente Arione, del quale Claudiano ricorda la tenera età
trascorsa nelle stalle delle Nereidi, ripresa sintetica e variata della "Bildung" descritta più
compiutamente da Stazio, ma quel che colpisce è la natura del tutto diversa che il destriero sembra
avere: infatti Arione si dimostra qui ben disposto ad avere un cavaliere (v. 554 ultro) e soprattutto -
al lettore che ha in mente Stazio pare un adynaton- chiede i uerbera, mentre in Theb. 6,304 s. si
ricorda che Nettuno aveva cresciuto il cavallo quasi senza l’uso dello staffile: primus teneris laesisse lupatis
ora et litoreo domitasse in puluere fertur,
uerberibus parcens;
I uerbera in Stazio costituiscono il termine di paragone per giudicare la qualità del cavaliere:
Nettuno, padre del cavallo, li usava con parsimonia, Polinice terrorizzato non solo evita di usare la
frusta, ma neppure osa riprendere il cavallo a voce50
. Nel caso di Onorio, è addirittura lo stesso
cavallo a richiedere i uerbera, tale sarebbe la sua volontà di assoggettarsi all’autorità dell’augusto
cavaliere. Implicitamente si è stabilito un confronto tra Onorio e i cavalieri di Arione, dal quale
l’imperatore risulta vincitore, non tanto in virtù di una straordinaria valentía nell’arte equestre,
quanto del carisma che la sua persona emana.
Il secondo cavallo del catalogo è Cillaro, il destriero di Castore, vv. 556 s. Il riferimento al
catalogo dei cavalli staziani è qui indiretto, visto che alla gara delle quadrighe non partecipava
Cillaro, ma un suo figlio. Claudiano trasferisce a Cillaro l’azione che era propria del suo cavaliere,
cioè una sorta di abbandono che era avvenuto quando Castore aveva deciso di imbarcarsi sulla nave
Argo, Theb. 6,327-329: tua furto lapsa propago,
Cyllare, dum Scythici diuersus ad ostia Ponti
Castor Amyclaeas remo permutat habenas.
Nel catalogo di Claudiano è invece il cavallo a rifiutare il suo tradizionale cavaliere per poter
servire Onorio. Lo stesso schema è applicato a un altro fedelissimo cavallo del mito, assente nel
catalogo staziano, ma presente in quello virgiliano e nel panegirico di Ausonio, Xanto che
rifiuterebbe Achille pur di essere cavalcato dall’imperatore.
Ai due ultimi destrieri, anche questi indirettamente collegati alla rassegna di Stat. Theb. 6, sono
dedicate delle sezioni più lunghe e complete. Il primo è Pegaso il cavallo alato di Bellerofonte nato
dal collo di Medusa (vv. 558-560) con il quale si concludeva la rassegna virgiliana: Ipse tibi famulas praeberet Pegasus alas
portaretque libens melioraque pondera passus
Bellerophonteas indignaretur habenas.
Anche Pegaso è assente dal catalogo dei cavalli partecipanti alla corsa delle quadrighe, ma in Stat.
Theb. 6,337-339 si parla delle cavalle di Admeto di origine incerta che sono paragonate alla stirpe
di quella mandria portata al pascolo da Apollo: credi nec degener illo
de grege, Castaliae stupuit qui sibila cannae
laetus et audito contempsit Apolline pasci.
Nella sua nota Lattanzio Placido dice che queste sarebbero le cavalle del gregge di Pegaso51
. Quindi
in questo passo Claudiano sarebbe intervenuto sul testo staziano similmente a come ha fatto per
Cillaro: per costruire il suo catalogo, sarebbe andato indietro di una generazione rispetto al modello
staziano, sdegnando gli epigoni e ritornando ai capostipiti delle stirpi equine, in quanto garanti di
maggiore nobiltà.
50 Cfr. Stat. Theb. 6,467 s. Solus Echionides errante silentia curru/ Maesta tenet trepidaque timet se uoce fateri. 51
Lattanzio Placido ad l.: de Pegasi grege, qui fontem Hippocrenen Apollini et Musis dicatum ungula sua scalpsit .
Neptunus enim pater quorundam equorum fertur: Pegasi ex Medusa, Arionis ex Cerere. Ergo equae Admeti Pegaso
concolores fuerunt.
15
Al v. 558 l’uso di ipse in posizione enfatica testimonia il prestigio del cavallo, l’unico alato, del
quale sono messe in risalto la spontaneità con cui si offrirebbe a Onorio (vv. 558 praeberet; 560
libens) e l’inferiorità del suo tradizionale cavaliere espressa attraverso il disprezzo da parte del
cavallo (v. 560 indignaretur). Insieme con questi due motivi ricorrenti anche per gli altri animali del
catalogo è qui introdotto quello nuovo del peso, che richiama e contrario il Fetonte ovidiano di Met.
2,162 (solitaque iugum grauitate carebat), dove i cavalli stupiscono per l’assenza del consueto peso
divino, perché Fetonte è un ragazzo, ma anche Stat. Silu. 1,1,20 magnoque superbit pondere detto
del cavallo bistonio cavalcato da Marte. Attraverso tale sistema di riferimenti in questa sezione, che
è l’unica a presentare un cavaliere mortale, a Onorio è attribuito un peso che lo mette
implicitamente al pari degli dei (meliora pondera), pur essendo un giovane. È notevole l’insistenza
sui verbi che indicano il rifiuto (vv. 556 contempto; 557 spreuisset) che fa pensare
all’inadeguatezza dei cavalli, che pur sono di origine divina e hanno portato grandi eroi e semidei,
al nuovo cavaliere, l’imperatore. La consapevolezza superba della propria stirpe e del proprio valore
erano già caratteristiche di Arione, che aveva accettato un cavaliere umano, e sono espresse in Stat.
Theb. 6,314 s. con un verbo simile52
: Mox diuum dono regis dignatus Adrasti
imperia.
La rassegna si conclude con la sezione più lunga e descrittiva dedicata ad Aethon, il cavallo di
Lucifero, stella del mattino, che nel nome porta il fuoco del sole, vv. 561-564. Il quadro è vivace
per la presenza di notazioni acustiche (hinnitu) e cromatiche (vv. 561 il nome stesso del cavallo
Aethon; 562 s. roseoque […]/ Lucifero) e raffigura il cavallo, diversamente dagli altri, intento nella
sua attività quotidiana di mettere in fuga le stelle e portare la luce dell’alba. Il suo nome è tipico dei
cavalli solari: così si chiamava un cavallo della quadriga di Fetonte in Ou. Met. 2,154, ma anche
uno dei cavalli di Euneo in Stat. Theb. 6,46453
. Segue lo sviluppo del motivo consueto della volontà
del cavallo di offrirsi a Onorio (v. 564 inuidet; mauult).
Occorre ora cercare di capire quale sia il criterio che il poeta ha seguito nella costruzione del
catalogo e come se ne sia servito al fine di lodare il destinatario del panegirico54
. Tutti e cinque i
cavalli citati sono di origine divina o appartenuti a dei ed eroi, e sembrerebbero quindi dei pari
grado, ma è opportuno considerare a questo proposito le proporzioni tra le parti della rassegna. Si
osserva una struttura del tipo: 2 vv. (Arione)+ 2 vv. (Cillaro e Xanto)+ 3 vv. (Pegaso)+ 4 vv.
(Aethon), quindi si riscontra un crescendo di attenzione verso i due ultimi cavalli. Claudiano vuole
ricordare il primo come cavallo marino (v. 555 Nereidum stabulis nutritus Arion), Cillaro e Xanto
sono cavalli terrestri, Pegaso ha le ali e vola nel cielo, Aethon infine è cavallo celeste. Sembra di
poter individuare un criterio ascensionale nella presentazione di questi cavalli (si ricordi invece la
decadenza "araldica", ma soprattutto morale che si realizzava nel catalogo dei cavalieri di Arione in
Stat. Theb. 6,301-325: Arione infatti passa dalle mani del padre Nettuno, un dio, a quelle di Ercole,
un eroe, a quelle di Adrasto, re pio ma mortale, e infine in quelle di Polinice, rinnegato dal padre e
cacciato dal suo regno) e una volontà di coinvolgere tutti i mondi e tutti gli elementi55
. Il numero
dei cavalli supera il numero fortemente simbolico dei quattro componenti della quadriga
suggerendo forse un iperbolico e mai visto tiro di cinque inarrivabili destrieri creatosi solo per
glorificare Onorio. La spontaneità inoltre della sottomissione di quei destrieri non certo docili e
52
Cfr. anche Stat. Theb. 6,333-5 Centaurica dicunt/ semina: credo, adeo sexum indignantur, et omnis/ in uiris adducta
Venus. 53
Aethon è anche cavallo di Ettore in Hom. Il. 8,185; di Pallante in Verg. Aen. 11,89; di Plutone in Claud. Rapt. 1,282. 54
J. LEHNER, Poesie und Politik in Claudians Panegyrikus auf das vierte Consulat des Kaisers Honorius, Königstein
1984, 99 si limita a definirlo "catalogo della migliore offerta" strutturato secondo una non meglio precisata climax. 55
Secondo questa interpretazione Arione rappresenterebbe l’acqua, la coppia Cillaro, Xanto la terra, Pegaso l’aria e
Aithon (nome parlante) il fuoco. Sul simbolismo del numero quattro legato alla tetrarchia (4 elementi, alle 4 parti del
mondo, alle quattro stagioni, ai 4 anni completi del lustrum, ai quattro cavalli del Sole, al quartetto delle luci celesti e
infine ai quattro evangelisti) cfr. M. WHITBY, The Propaganda of Power. The Role of Panegyric in Late Antiquity,
Leiden-Boston-Köln 1998, p. 46 e anche S. MACCORMACK, Arte e cerimoniale nell’antichità, trad. it. F. PIVIOTTI
INGHILLIERI, Torino 1995, p. 260. Tutti questi parallelismi identificano l’impero al mondo e i suoi sovrani agli
elementi regolatori della natura.
16
abituati a cavalieri di rango almeno semidivino sembra inverare l’assunto del trattatello sulla
regalità enunciato nella parte centrale del panegirico, cioè che chi domina la propria anima è allora
in grado di regnare sul mondo56
.
La grandezza di Onorio, che a cavallo "beveva" il sole e "mangiava" il vento, è quindi tale che
non solo il mare e la terra lo lodano e lo desiderano, ma soprattutto i cieli: infatti ai vv. 563 s., con
un ribaltamento di quanto ci si aspetterebbe (cioè che fossero i terrestri a invidiare il cielo) Aethon,
quando scorge l’imperatore dal firmamento, prova invidia nei suoi confronti (v. 564 inuidet),
vorrebbe cioè che l’Augusto fosse suo cavaliere.
In conclusione, rispetto a Stazio è qui fondamentale l’istanza encomiastica che assume
dimensioni cosmiche: anche attraverso i cavalli si deve celebrare la grandezza dell’imperatore e la
sua superiorità ai modelli divini e mitici57
.
Alberto Pavan
Università di Udine
56
Per lo sviluppo del topos della continentia nella letteratura panegiristica cfr. WHITBY 1998, pp. 325 s.; pp. 340 s. e
passim. 57
Cfr. P. JAMES, Taceat superata Vetustas: Living Legenda in Claudian’s In Rufinum 1, in WHITBY 1998, p. 170:
«Claudian makes the lofty comparisons only to undercut them immediately. There is a self-consciousness about these
allusions, which suggests that the poet is exploiting them as clichés: hence the key statement, borrowed for article’s
title, taceat superata uetustas». Claudiano nei suoi encomi mostra quindi come i tradizionali paradigmi mitologici sono
stati superati e propone dei nuovi miti, l’imperatore Onorio e il suo generale Stilicone.