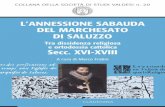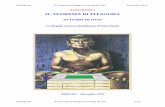Il Laudario di Saluzzo
Transcript of Il Laudario di Saluzzo
MARCO PICCAT
IL LAUDARIODI SALUZZO
ILLA
UDAR
IODIS
ALUZ
ZOMARCO PICCAT, professore eminente, ex Direttore del Di-partimento di Filosofia, Lingue e Letterature Stranieredella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Trieste. Si occupa dell’edizione di testi in lingua volgare, privile-giando l’area nord-italiana, francese, provenzale ed iberica,(con interessi per le tradizioni agiografiche, le canzoni digesta, i trattati di falconeria, le ‘enciclopedie’ popolari, il tea-tro sacro e le leggende apocrife, le narrazioni apocalittichee i viaggi nell’Oltretomba, il genere odeporico, gli antichitesti piemontesi e la cultura letteraria del Marchesato di Sa-luzzo) e dell’interpretazione iconografica dei cicli ad affre-sco del Quattrocento europeo. Ha pubblicato, nel 2008, LeLivre du Chevalier Errant di Tommaso III di Saluzzo, ArabaFenice, Boves; in collaborazione con L. Ramello Le Mystèrede Griseldis, Cuneo, 2011; con C. Pugliese e P. Arribas Brio-nes Vida y muerte de dos peregrinos picaros y conversos, Ca-strojeriz, 2013; con A. Cifani, F. Monetti, C. Venegoni Lacappella di Santa Maria di Missione di Villafranca Piemonte.Un capolavoro del gotico internazionale italiano (Allemandi,Torino 2014); ha curato, nel 2008, con R. Comba, gli Attidel Convegno Immagini e miti nello “Chevalier Errant” diTommaso III di Saluzzo, e La cultura a Saluzzo fra Medioevoe Rinascimento. Nuove ricerche, Società per gli Studi Storici,Cuneo, e con L. Ramello, G. Gasca Queirazza, Il canzoniereprovenzale To e altri saggi filologici, (1962-2009), e Mementomori. Il genere macabro in Europa dal Medioevo a oggi, (Ales-sandria, Edizioni dell’Orso, 2014).
Il Laudario della Confraternita dei Battuti ècontenuto in un manoscritto della fine del XVsecolo, conservato nell’Archivio della stessa, inSaluzzo. Si compone di un trentina di laudi “pre-ghiere cantate in onore di Cristo, della Vergineo dei Santi”, scritte in una lingua letteraria so-vraregionale con tracce del dialetto ligure e dellaparlata piemontese locale. Apparteneva allaConfraternita saluzzese dei Battuti ed era uti-lizzato nelle funzioni liturgiche e durante i ritiprocessionali. La Compagnia, composta da laici, perseguival’obbietivo di soccorrere il prossimo, aiutando ipoveri e curando i malati della Città, meditavasulla Passione di Cristo cui si immedesimavacon la pratica della flagellazione, e cantava inuna lingua venuta da lontano – e che andavaadattando al mutare dei tempi – la propria sin-cera fede religiosa. Il laudario di Saluzzo, per laprima volta edito integralmente, è attualmenteil più antico tra quelli conservati in Piemonte esebbene appartenga all’ultimo periodo di diffu-sione manoscritta del genere, risulta di particolareinteresse storico-culturale e linguistico perchéoffre l’opportunità di entrare nella religiosità po-polare di un’epoca che aspirava alla pace e albenessere della Comunità saluzzese, lavorando,cantando e pregando il Cielo di farsi terra.
MAR
COPI
CCAT
€ 23,00
Un unicum della poesia religiosa in volgare,
tra metà e fine Quattrocento, in Piemonte...
copertina laudario ok_Layout 1 18/03/15 11:40 Pagina 1
269
INDICE
Presentazione ...................................................................................................................................... pag. 5
I Disciplinati a Saluzzo nei secoli XIV-XV....................................................................... » 9Il manoscritto......................................................................................................................................... » 19La tradizione ligure-piemontese ............................................................................................... » 29Il laudario di Saluzzo........................................................................................................................ » 39
Incipiunt laude que dicitur secumdum ordinem jnfrascritumsecumdum beneplacitis rectoris Domus Discipline Saluciarum
I Ogno homo cum devocione / S’alegre in questo sancto Avento ............... » 59II Or è nato l’agnelo / Christo Nostre Segnore ..................................................... » 64
III Cerchemo lo Salvatore / Cum li rey in compagnia........................................ » 69IV Bon Yhesu, y’ me lamento / E piamzo cum dolore ......................................... » 74V Or unda porrà-lo scampare / Lo dolento peccatore........................................ » 79
VI Oy stella matutina, / Doza Vergen Maria ....................................................... » 86VII E’ te prego, alta croxe, / Che tu debi inclinare ................................................. » 91
VIII Piamzemo cum dolore / Tuti li nostri peccay ................................................... » 98IX Quando i’ te viste ferire / A lo core cum la lanza ........................................... » 103X Venite a la croxe / A vedere lo me' amore............................................................ » 109
XI Voy quy amay Jhesu d’amore / Veniti a pianzer la passione ..................... » 116XII Maria pianze a la croxe / Lo so Figlol chi moria .......................................... » 122
XIII Done e segnori cum gli cor pianzenti ................................................................... » 128XIV Or é venuto lo tempo de Jhesu salvatore ............................................................. » 132XV Or pianzemo, dura zente, / La morte de Christe omnipotente................ » 136
XVI Voy qui pianzì cum dolore / Lo bon Yhesu crucifixo ..................................... » 146XVII Quando tu te alegrij, homo de granda altura .................................................. » 152
XVIII Dè ve salve Sancta Croxe, / Albor d’amore piantao..................................... » 159XIX Or chi à sì duro lo core / Che no pianza de dolore.......................................... » 166XX Oy Vergen gloriosa / Sempre sia laudata............................................................ » 171
XXI Laudato sì Criste e la Vergen Maria.................................................................... » 176XXII Chi cristiano se chiama / Viva cum grande temeranza .............................. » 181
XXIII Spirito Sancto in noy desenda, / Oy nostro dolze consolatore ................. » 189XXIV Qui no servirà voluntera / Con devocion a lo Segnore .............................. » 194
XXV Mare de Dio Nostro Segnore, / Pregay lo vostro Figlo cum dolze amore » 199XXVI Cum noy pianze Magdalena / Cum noy pianzeti compagnia................ » 203
XXVII ... ......................................................................................................................................... » 207XXVIII Laudato sia Cristo / E la Vergen Maria............................................................ » 208
XXIX A li vostri grandi honori / Dolza Vergem Maria ......................................... » 214XXX Madona sancta Maria / Mare de lo Salvator ................................................ » 220
XXXI Salve regina, / Sore li angeli exaltata,................................................................ » 224XXXII ... ......................................................................................................................................... » 231
XXXIII Laudemo cum amore / La majestà divina ....................................................... » 232XXXIV Ty Pregamo, corpo sancto, per tuti li peccatori................................................. » 236XXXV Que faran ly peccadori se ly voi abandonare .................................................... » 240
XXXVI Socorrì, o Vergen Maria / La anima di questo nostro fradello ................ » 244XXXVII Noi te preguemo, Yhesu Christe / Trai quelle anime de pena................... » 248
XXXVIII Sanctissima croce preciosa, / Unde Yhesu Cristo fu jodà ............................. » 252
Antroponimi........................................................................................................................................... » 255Toponimi ................................................................................................................................................ » 255Repertorio lessicale............................................................................................................................. » 255Bibliografia .............................................................................................................................................. » 263
270 (copia parziale)
9
I DISCIPLINATI A SALUZZO NEI SECOLI XIV-XV
In Italia, alcuni movimenti e confraternite di laici1, scossi dalla nuova sensibilità religiosa che a partire dagli inizi del Duecento2 stava scuotendo l’intera penisola3, si fecero portavoci di diverse iniziative di pietà popolare4 e, insieme, di una innovazione liturgica che avrebbe presto impressionato ed interessato tutte le comunità religiose: la flagellazione pubblica unita alla recita e il canto di “Laudes”, preghiere musicate, in versi latini e volgari5. Tali “... canti che il popolo intonava in chiesa e in occasione di processioni che frequentemente si facevano per implorare il perdono di Dio e di Maria”, sull’esempio dagli antichi inni e sequenze in latino, vennero nel decorrere del tempo affidati allo scritto e registrati in raccolte chiamate “laudari”. Questo particolare ge-nere di poesia religiosa, con i primi centri di creazione in Umbria e in Toscana, si estese in seguito in un ben più vasto territorio, tanto che ancora oggi il numero dal numero di manoscritti redatti in diverse vesti linguistiche e rimasti a testimonianza della notevole fortuna popolare supera ampiamente i duecento6.
1 R. Rusconi, Dalla fine del XII agli inizi del XV secolo: tra movimenti religiosi e confraternite in Italia, in Storia vissuta del popolo cristiano, a cura di J. Delumeau, F. Bolgiani, Torino1985, pp. 331-347.Cfr. G. Angelozzi, Le confraternite laicali. Un’esperienza cristiana tra medioevo e età moderna, Brescia 1978; Cfr. G. G. Meersseman, G. P. Pacini, Le confraternite laicali in Italia dal Quattrocento al Seicento, in Problemi di storia della chiesa nei secoli XV-XVII, Napoli 1979, pp. 109-136; R. Rusconi, I laici devoti e le loro associazioni, La vita religiosa nel tardo Medioevo: fra istituzione e devozione, in Chiesa, chiese, movimenti religiosi, a c. di G. M. Cantarella, V. Polono, R. Rusconi, Bari 2001, pp. 214-219.
2 Cfr. G. G. Meersseman, Disciplinati e penitenti nel Duecento, in AAVV, Il movimento dei Disciplinati nel settimo centenario dal suo inizio (Perugia 1260), Perugia 1962, pp. 43-72.
3 Cfr. P.L. Meloni, Topografia, diffusione e aspetti delle Confraternite dei Disciplinati, in AAVV, Risultati e prospettive della ricerca sul movimento dei Disciplinati, Perugia 1972, pp. 15-98.
4 A. Vauchez, La piété populaire au Moyen Age, in Religion et société dans l’Occident Médiéval, Torino 1980, pp. 321-336.
5 Cfr. P. Canettieri, La poesia dell’estasi, in Cognitive Philology, n. 3 (2010). 6 Cfr. tra le ultimi edizioni, Laude cortonesi dal secolo XIII al XV, G. Varanini et alii, Firenze
1981-1895, vol 4; Laude di Borgo San Sepolcro, a c. di E. Cappelletti, Firenze 1986; Il laudario Frondini dei Disciplinati di Assisi (sec. XIV), a c. di F. Mancini, Firenze 1990; Il Laudario della Compagnia di San Gilio, a c. di C. Del Popolo, Firenze 1990, voll. 2; Laudario orvietano, a c. di G. Scentoni, Spoleto 1994; Il laudario dei Battuti di Modena, a c. di M. Salem Elsheick, Bologna 2001; Il laudario dei Disciplinati. Preghiere, invocazioni e laude dei confratelli modenesi nei secoli XV-XVI, a c. di M. Al Kalak-M. Lucchi, Modena 2005.
1 0
In Piemonte, le laudi godettero di particolare vitalità, grazie alle Confraternite che, due secoli dopo, continuavano ad utilizzarne il re-pertorio: il più antico e completo laudario tra quelli oggi conservati7, compilato in latino e in volgare, è in realtà uno degli ultimi redatti su manoscritto. È relativo al gruppo dei Disciplinati8 della città9 di Saluzzo.
“Col consiglio e sotto la direzione dei domenicani dovette costituirsi la casa dei ‘reccomandati’della B. Vergine presso la loro chiesa di S. Gio-vanni...”: così nel 191110 lo storico C.F. Savio iniziava a presentare la storia della fondazione e le prime vicende della localizzazione11 della Confraternita12 cui dobbiamo la compilazione, conservazione e cura del manoscritto con, al suo interno, la raccolta delle laudi da cantare. I sa-luzzesi aderenti al gruppo13 promotore compaiono citati nei primi do-cumenti come “Raccomandati della Beata Vergine”14, a volte con il nome di “crosati” per via della croce per metà bianca e per metà rossa con cui fregiavano il loro camice, o ancora di “disciplinati” o “battuti”,
7 Cfr. G. G. Meersseman, Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel Medioevo, in collaborazione con G.P. Pacini, Roma 1977; Le confraternite tra Medioevo e Rinascimento. Atti della tavola rotonda (Vicenza, 3-4 novembre 1979), in Ricerche di storia sociale e religiosa, n.s. 17-18, Roma 1980; L. Pamato, Le confraternite medievali. Studi e tendenze storiografiche, in Il buon fedele. Le confraternite tra Medioevo e prima età moderna, Quaderni di storia religiosa, V (1998), pp. 9-51.
8 Cfr. I. Baldelli, La lauda e i disciplinati, in Medioevo volgare da Montecassino all’Umbria, Bari 1971, pp. 323-363; G. De Sandre Gasparini, Movimento dei disciplinati, confraternite e ordini mendicanti, in AAVV, I Frati Minori e il terzo ordine. Problemi e discussioni storiografiche, Atti del convegno, Todi 17-20 ottobre 1982, Todi 1985, pp. 79-114.
9 Cfr. M. Gazzini, Confraternite e società cittadina nel medioevo italiano, Bologna 2006, pp. 3-57. Ringrazio don Giovanni Gisolo, canonico archivista della Diocesi di Saluzzo, per la gentilezza con cui ha seguito lo svolgersi della ricerca e per aver facilitato la consultazione del manoscritto.
10 Per segnalazioni precedenti, cfr. F.A. Della Chiesa, Descrizione del Piemonte, II, ms. originale in Biblioteca Reale, Torino, Storia Patria, 173/ II.
11 Cfr. R. Comba, Dai monaci cistercensi ai frati Predicatori: alle origini del convento di san Domenico a Saluzzo, in San Giovanni di Saluzzo. Settecento anni di storia, a c. di R. Comba, Relazioni al Convegno: Saluzzo, 21-22 Aprile 2007, Cuneo 2009, pp. 11-27.
12 R. Rusconi, Confraternite, compagnie e devozioni, in Storia d’Italia, a c. di G. Chittolini - G. Miccoli, Torino 1986, 23, pp. 490 e sgg.
13 L’adesione al gruppo fu esclusivamente riservata, fino agli ultimi anni del XV secolo, agli uomini. Per la presenza femminile cfr. A. Esposito, Donne e confraternite, in Studi confraternali. Orientamenti, problemi, testimonianze, a c. di M. Gazzini, Firenze 2009, pp. 53-78.
14 Condizione per l’ammissione alla Confraternita dei disciplinati, era a Saluzzo, come a Cuneo e a Bra, l’appartenenza alla Compagnia dei Raccomandati. Cfr. P. Camilla, recensione a G. Gasca Queirazza, Documenti di antico volgare in Piemonte. I: Le”Recomendaciones” del Laudario di Saluzzo, II: Gli “Ordinamenti” dei Disciplinati e dei Raccomandati di Dronero, in Bollettino della Società per gli studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, 55 (1966), pp. 162-165. Cfr. anche L. Kern, Notes sur la fondation de la Confrérie des Recommandés à la Vierge et ses rapports avec les Flagellants, in AAVV, Il movimento dei Disciplinati op. cit., pp. 253-256.
fratres dicte domus, que alio nomine domus discipline vocatur, credimus pro- mosinam ut supra exhibendam pauperibus Christi, ac etiam quia rectores con-
1 3
bos viros et idoneos ac fideles Deo et nobis et pauperibus Christi ad predic-tam elemosinam dispensandam...”28, segno evidente di un riconoscimento attribuito per le varie iniziative assistenzali intraprese29. Anche il luogo dell’atto, la cappella intitolata al santo martire dell’Ordine, è di per sé significativo dell’importanza assoluta del documento: essa costituiva infatti il “sancta sanctorum”, il nucleo e il fulcro della spiritualità domenicana nel territorio del marchesato di Saluzzo30.
Gli edifici di proprietà o in uso alla Confraternita, come attestano gli inventari relativi, andarono presto ad allestirsi e a funzionare, già nei primi anni del Quattrocento, come luoghi di aiuto e ricovero per i po-veri e i bisognosi.31
Della crescente collaborazione, anche di natura economica, instau-ratasi allora tra Disciplinati e frati Predicatori è sicura traccia nella no-tevole documentazione conservatasi fino ad oggi, che vede la citazione congiunta e paritetica delle due istituzioni tanto in disposizioni testa-mentarie di privati, come in importanti donazioni nobiliari e di membri della famiglia marchionale32.
28 Cfr. E. Dao, La Chiesa nel Saluzzese, op.cit., pp. 137-138. 29 Cfr. E. Bressan, L’'hospitale” e i poveri. La storiografia dell’assistenza, L'Italia e il 'caso
lombardo”, Milano 1981. 30 Cfr. sulla popolarità delle immagini di san Pietro Martire, D. Russo, Des saints et des stigmates: à propos
de saint François d’Assise et de saint Pierre de Verone, martyr iconographie et project de chretienté au XIIIéme siécle,in AAVV, Stigmates, Paris 2001; F. Bisogni, Gli inizi dell’iconografia domenicana, in Domenico da Calaruega e la nascita dell’Ordine dei frati Predicatori, Todi, 10-12 ottobre 2004; R. Rusconi,'Trasse la storia per farne la tavola” immagini di predicatori degli ordini medianti nei secoli XIII e XIV, in AAVV, La predicazione dei frati della metà del 200 alla fine del ’300, Atti del XXII Congresso Internazionale, Assisi, 13-15 ottobre 1994, Spoleto 1995, pp. 405-450; D. Russo, L’Ordre des Prêcheurs et son histoire en France méridionale, in Cahiers de Fanjeaux, 36 (2001); e, in particolare per il rapporto con Saluzzo, F. Saporiti, L’immagine spezzata. A partire da san Pietro martire: ricerche sull’iconografia dei santi domenicani nell’Italia nord-occidentale, in AAVV, San Giovanni di Saluzzo, op, cit., pp. 259-277. Per il contesto storico delle confraternire di san Pietro Martire, cfr. G. G. Meersseman, Études sur les anciennes confréries dominicaines; I. Les confréries de S. Dominique; II. Les confréries de S. Pierre Martyr; III. Les congrégations de la Vierge; IV. Les milices de Jesus Christ, in Archivum Fratrum Praedicatorum XX (1950), pp. 5-113; XXI (1951), pp. 51196; XXII (1952), pp. 5-176; XXIII (1953), pp. 275-308.
31 Cfr. C.F. Savio, Saluzzo e i suoi Vescovi, op. cit. p. 11, “Più tardi, sotto l’amministrazione della confraternita dei disciplinanti o del Gonfalone, che in origine dicevasi dei reccomandati della Beata Vergine, sorse un altro ospedale nella loro propria casa, sulle pareti della quale, in via Della Chiesa, si legge ancora, in lettere gotiche “Hospitale Saluciarum”; G. Gasca Queirazza, Cose e parole di ieri e di oggi: agli inventari quattrocenteschi della 'Crusà” di Dronero, in Bollettino per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, 62 (1970), pp. 5 e sgg.
32 Cfr., tra le altre quella del 1399, da parte di Azzone Saluzzo, richiamata in M. Gattullo, La comunità del convento saluzzese dei frati Predicatori, in San Giovanni di Saluzzo, op.cit., pp. 3146. Per una disamina della documentazione ritrovata, cfr. R. Olivero, I frati Predicatori e i Disciplinati , op.cit., pp. 85-93. Cfr. anche Le carte dei frati Predicatori, op.cit, pp. 42 e sgg.
(copia parziale)
1 4
Il legame con quest’ultima e, insieme, con i rappresentanti ufficiali della comunità saluzzese, è, nella raccolta in esame, ripetutamente il-lustrato. Infatti il manoscritto presenta anche la serie delle “Recomen-daciones”33, formule di preghiera in volgare di tradizione eucologica della più alta antichità e larghissima diffusione nel medioevo europeo34; i confratelli, che erano tenuti a recitarne i testi, al termine dell’Ufficio giornaliero di ogni domenica, venerdì e sabato, ne ricordavano puntualmente l’aiuto e la protezione.
Per il Marchese, l’intenzione di preghiera è espressa sia al n. II, in collegamento alle alte autorità religiose e civili, “Ancor se tornerema... qu'el debia illuminer lo cor de Meser lo Papa e di gli Segnor Cardenagl e di rey e di princi... e specialment de Meser lo Marchix de Saluce, chi àn a reçer e vier lo povol cristian”, e ancora al n. XIII, in modo esplicito, “Anchor preerema... per Meser lo Marchis de Saluce, che lo dea gracia de fer tal overe de que la soa anima sea salva...”.
Per i consiglieri, citati come rappresentanti della “comunità de Saluce” il riferimento è al n. XIV, “Anchor farema una special preera... per nostre... consogler de la comunità de Saluce... tant che la dicta comunità possa cresser e multiplicher”35. L’augurio di prosperità cittadina ritornava, riportato al-l’interno del mondo cristiano, anche nella lauda XXXV, in cui si invitava Cristo a:
La santa giesa fay unire, e la tua payze mandare, Que ogni dy puissam servire lo to nome e laudare. Ly cristiani debiay gardare e far ogni dy multiplicare, Contra lu turco traditore, de li cristiani persecutore.
Il ringraziamento per gli stessi, come per tutti gli altri possibili be-nefattori, spirituali e temporali della confraternita, e per tutte le persone
33 Cfr. G.P. Clivio, Le Recomendaciones di Saluzzo e gli Ordinamenti di Dronero, in Profilo di storia della letteratura in piemontese, Torino 2002, pp. 83-89.
34 J.A. Jungmann, Missarum sollemnia, Torino 1953, pp. 385-393 per la “oratio fidelium”. 35 Lo stesso invito compariva, indirizzato però questa volta al gruppo dei confratelli, tra le
preghiere latine contenute nell’‘Oficium diei dominice’: “..ut fraternitatem istam crescere et multiplicare digeneris...”. Cfr. c. 3 v.
(copia parziale)
1 6
assegnatari del ruolo speciale di “protettori della città”40 .Si spiega così nella sequenza delle invocazioni la serie:
“... sancte Laurencij/ sancte Vincenti/ sancte Fabiane/ sancte Sebastiane/ sancte Blaxij/ sancte Costancij/ sancte Zafrede/ sancti Johannes et Paule/ sancti Cosme et Damiane...”41.
Nell’ambito di uno specifico e rinnovato impegno catechetico42, iconfratelli iniziarono dunque a trovarsi, dalle prime decadi del Quat-trocento, nella cappella-chiesa dedicata a Sebastiano43, santo verso cui i Saluzzesi mostravano una particolare devozione, situata all’inizio della via dei Portici Scuri, nella parte bassa della città e dentro le antiche mura, per la celebrazione di funzioni e riti aperti anche alla partecipazione popolare. Sulla facciata decisero di rappresentare come segno visibile l’immagine dei confratelli in adorazione di Cristo crocifisso44, in uno spazio scandito dai cartigli con le strofe della laude “Bon Yhesu y'me lamento / E piamzo cum dolore...”, una delle più significative ed espressive del repertorio45. È in uno degli armadi della cappella che venne conservato, per secoli, il nostro codice. Durante l’assedio francese del 1487, il luogo venne individuato dai canonici come sede deputata
40 Cfr. H.C. Peyer, Città e santi patroni nell’Italia medievale, a c. di A. Benvenuti, Firenze 1998; R. Rusconi, La religione cittadina e il culto dei santi, in Chiesa, chiese, op.cit., pp. 228-236.
41 Cfr. c. 2 v., ‘Oficium diei dominice’, del manoscritto della compagnia saluzzese. 42 Cfr. R. Rusconi, Tra movimenti religiosi e confraternite, op.cit., p. 345 “Se la componente
solidaristica, di mutua assistenza, che è anpiamente connaturata al fenomeno confraternale ci rimanda alla funzione che queste associazioni di laici devoti svolgevano nel complesso di una società cittadina dell’Italia tardomedioevale...non bisogna dimenticare che la finalità primaria ed esplicita di queste confraternite rimaneva, ad ogni modo, una ordinata istruzione religiosa ed un inquadramento delle devozioni del laicato ortodosso...”.
43 Utili e complete informazioni sulla costruzione e l’indagine archeologica relativa, si possono ora trovare in L. Maffeis, Gli scavi in San Giovanni ed altri interventi di archeologia medievale a Saluzzo, in San Giovanni di Saluzzo, op.cit., pp. 169-182.
44 Cfr. A. Prandi, Intorno all’iconografia dei Disciplinati, in AAVV, Il movimento dei Disciplinati op. cit., pp. 253-256; idem, Arte figurativa per le confraternite dei Disciplinati, in Risultati e prospettive op.cit., pp. 266-290.
45 Per l’inserimento dei testi delle laude in raffigurazioni parietali, cfr. E. Ragozza, Laudari in affreschi del sec. XV e la tradizione di preghiere valsesiane, in Novarien, Associazione di Storia Ecclesiastica Novarese, 7 (1975-76), pp. 68-71.
1 7
per lo svolgimento dei riti religiosi.46 Infine, al momento dell’erezione della chiesa collegiata di Santa Maria, (inizi XVI secolo), gli appartenenti alla Compagnia dei Disciplinati contribuirono, con tutto il loro impegno, all’esecuzione di opere necessarie, come pure assicurarono il loro sostegno durante i successivi lavori di trasformazione della stessa in sede per l’abitazione del Vescovo47 .
L’Archivio della Confraternita, testimone della lunga storia48 della Compagnia che è rimasta in attività e servizio sino all’inizio dello scorso secolo49, mentre ha perduto il codice, in volgare, degli Statuti50, ha for-tunatamente conservato sino ad oggi quello proprio dell’uso liturgico, oggetto del nostro saggio51. La sua compilazione rimanda agli anni del governo di Saluzzo del marchese Ludovico I (1416-1475)52. È infatti proprio dalla metà del Quattrocento infatti che i suoi rapporti con i re-ligiosi del convento di san Domenico, presso cui si era costituito il primo nucleo dei Raccomandati della Beata Vergine Maria e in seguito quello dei Disciplinati saluzzesi, si erano strettamente intrecciati al punto che il luogo deputato per “trattare gli affari di sommo rilievo” era divenuto proprio il “... capitul(us) conventus sancti Dominici ordinis predicatoum Saluciarum”53, cioè la sala del capitolo del medesimo. Verso il 1466 Lu-dovico I promuoveva la costruzione del chiostro quadrato, antistante la medesima sala, e pochi anni dopo l’ampliamento della chiesa e l’edifi-cazione della cappella del Santo Sepolcro per luogo di sepoltura della famiglia marchionale. Le preghiere che i Disciplinati gli rivolgevano, dalle pagine del Laudario, costituivano il loro ringraziamento per la costante protezione ed il sostegno economico alle iniziative di pietà verso i poveri, gli ammalati e i derelitti della Città.
46 Cfr. E. Dao, La Chiesa nel Saluzzese, op.cit., pp. 137-138. 47 Cfr. D. Chiattone, La costruzione della Cattedrale di Saluzzo, Saluzzo 1902, pp. 22, 32 e sgg. 48 Per le attività della Confraternita nell’Ottocento, cfr. D. Muletti, Descrizione dello stato
presente, op.cit., pp. 116 e sgg. 49 Cfr. G. Casagrande, Il movimento dei Disciplinati: i motivi di un successo, in Sacre
rappresentazioni, arte, op.cit., pp. 67-82. 50 Cfr. C. F. Savio, Saluzzo e i suoi Vescovi, op.cit. p. 85, nota 3. 51 Tra gli altri documenti conservati possiamo citare in particolare, le serie relative a due particolari
impegni assunti nel tempo: quello di suonare “ogni anno, alle cinque italiane, dell’antivigilia della festa della Concezione, la baudetta”, in ricordo della diffusione della peste. La tradizione era iniziata nel 1361 a motivo del contagio che l’anno precedente si era diffusa nel marchesato. Cfr. D. Muletti, Descrizione dello stato presente, op.cit., p.117. Ancora, andò anche a consolidarsi nel tempo e tra le altre, una nuova regola, quella dell’elargizione di una dote ad una ragazza povera, consuetudine continuata fino alla scioglimento finale della compagnia.
52 Cfr. D. Muletti, Storia di Saluzzo e de’ suoi marchesi con documenti, vol. V, Saluzzo, MDCCCXXXI, p. 1-161.
53 Come nell’accordo tra il Comune di Saluzzo e quello di Cervignasco il 5 aprile del 1451, ibid. pp. 109 e sgg.
(copia parziale)
1 9
IL MANOSCRITTO
Il manoscritto di cui ci occupiamo è documento importante del-l’utilizzo che il gruppo dei Disciplinati promosse, in Piemonte e non solo, del patrimonio laudistico di origine umbra e toscana, secoli dopo la sua costituzione. Per questo motivo i testi del laudario di Saluzzo, la cui compilazione, nella veste attuale, risale alla metà del Quattrocento, con alcune aggiunte posteriori54, hanno perso molto della musicalità e del ritmo originari e propri del genere. La raccolta riporta la sequenza delle consuetudini fatte proprie dal gruppo dei flagellanti, sulla base di un’esperienza giunta da lontano e cresciuta in Saluzzo nei decenni pre-cedenti, ed alterna, al suo interno, diverse occasioni di raccoglimento, penitenza e preghiera corale previste dal regolamento confraternale, se-guendo l’ordine:
cc. 1r. - 5v. Oficium diei dominice cc. 6r. - 12v. Officium diei veneris cc. 13r. - 17r. Officium diei sabbati cc. 17r. - 21 v. Recomendaciones cc. 22r. - 29r. Officium quod fieri debet omni die domenica ultima men- sis in domo discipline Saluciarum videlicet pro animabus omnium defon-torum dicte domus’ cc. 29r. - 29v. Lauda in festo mortuorum cc. 29v. - 61 v. Laude que dicitur secundum ordinem infrascriptum secun-dum beneplacitis rectoris domus discipline Saluciarum cc. 62r. - 64r. Sequenze in latino cc. 64v. - 69v. Gaude flore virginali con altre laude in latino e in volgare aggiunte più tardi55
54 Il codice, pergamenaceo, misura cm. 26,5 per 20. La grafia è gotica libresca, di consueto uso nel XV secolo.La numerazione salta in una sola occasione (tra 49 e 52 vi è una sola carta); ogni carta è scritta con 2 righe; sono cadute, in antico, le carte 54 e 59. Oggi le carte sono 81. I titoli dei testi sono rubricati, i segni di paragrafo rossi e azzurro alternati. I due disegni colorati, alle c.6r e c.13r, ad illustrazione dell’‘Ufficium diei veneris’(crocifissione) e dell’“Ufficium diei sabbati” (la Vergine col Bambino in trono), rappresentano il nodo delle devozioni fondamentali. Sulla carta di guardia anteriore si legge il n.31, originario dell’Archivio della Confraternita. La legatura è moderna, in cuoio, con assi, le borchie e ilfermaglio in metallo. Per la sua completa ed accurata descrizione, cfr. G. Gasca Queirazza, Documenti, op.cit., pp. 12 e sgg.
55 Tra le prime, “Stabat mater dolorosa”, “Virgo dulcis virgo pia”, “Quando corpus morietur”...; per le seconde “In festo sancti Josephi, Or te preghemo degno confessore...”, “Padre nostro del ciel signore...”, ...
(copia parziale)
2 3
Nonostante inoltre la diversità dei testi raccolti, l’insieme mantiene un carattere fortemente unitario, al di là della lingua utilizzata (latino-volgare) e della sezione specifica, in quanto ideato nel tentativo di co-stituire il “liber” ufficiale delle attività di preghiera, penitenza e medi-tazione comunitaria della Compagnia. Le tematiche toccate con il sentire poetico proprio del laudario66 possono ritrovarsi infatti, sia pure con una diversa anche se complementare impostazione, tanto negli “Officia”, nella sezione relativa alle “Recomendaciones”, come ancora in quella latina delle formule di accoglimento dei nuovi membri.
Questo intreccio comune è di evidente richiamo: tra le preghiere in latino contenute nell’“Oficium die dominice” si recitavano quelle per i benefattori, “... ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona retri-buas...” e “... ut animas nostras fratrum, propinquorum et benefactorum no-strorum, ab eterna dapnacione eripias...”67. A questo proposito, nella laude n. XXXVII, leggiamo “Oy dolze Christe gloriosso,/ Chi moristi per noisalvare,/ Fora de pena le vogli traer/ E en to regno le mena”.
La seconda delle “Recomendaciones” riguarda invece il recupero della Terra Santa: “Ancor se tornerema... per tal manera que sea los e gloria de Dee e salvament e acressamen del povol cristian e recrovament de quella sancta terra de otramar...”. La laude XXXV, a questo proposito, recita:
“Defensore de la città grande de Ierusalem e ogni terra Ty prega questa... que deffendi aquesta terra De tutta crudella guerra, Segnor de lo celo e dela terra, Odine per tuo amore, tu sey lo nostro Redemptore”.
La III “Recomendacione” richiama la pace universale e particolare della località: “Ancor se tornarema con humilità e cum devocion... che el gli piaça de mander de la soa pax de cel en terra de ça de mar e de là de mar, e per tute le terre e ville e citae ond à verra e tribulacion, e specialment en quest pays e en questa villa...”.
Tra le invocazioni latine dell’“Oficium die dominice” sono previste quelle: “... ut regibus et principibus cristianis pacem et veram concordiam do-nare digneris,” e “... ut tucto populo cristiano unitatem et pacem largiri di-gneris...”,68 mentre la laude VI recita: “Preay, doza Vergen Maria,/ Reyna de misericordia,/ Per le citaee per li casteli,/ Unda è verra et discordia,/ Che
66 Cfr. per le diverse tipologie di laudari, A.M. Terruggia, In quale momento i Disciplinati hanno dato origine al loro teatro?, in Il movimento dei Disciplinati, op.cit., pp. 436 e sgg.
67 Cfr. c. 4 v. 68 Cfr. c. 3 v.
2 4
Dee gli mande paxe/ Tosto et bona concordia,/ Unda è pax et bona voluntà/ Conferme tutavia”.
La “Recomendacione” VIII è poi indirizzata per i viaggiatori, pellegrini o mercanti, “Anchor preerema... per tute quelle persone che son im pe-regrinage e per tuit gli marchand de mar e de terra, che el lor dea fer tal ro-meage e ensì dignament e iustament convier lor marchandie...”.
La lauda n. VI, in modo affine, legge: “Preay per li navegamti/ Che per voy y seen salvay,/ Day conseglo a li mercanti,/ Li poveri aytoriay,/ Pe-legrin et via andanti/ Per voy sean salvay,...”.
La X “Recomendacione” riguarda la preghiera per la tutela dei frutti della terra: “Anchor preerema... per lo fruyt de la terra, che per la soa misericordia e pietà lo vard de tempesta e de mal ivern e de vast de ree gent e lo trameta a bona recoglison...”. La laude XXXV, a questo proposito, recita:
“E de tutta aura freyda tu vey le nostre necessitae, De tempesta tanta orribla gardane per tua bontae...”.
La dodicesima è attinente piuttosto alla tutela da morbi e epidemia: “Anchor preerema... che per la intercesion del glorios martir Meser Sanct Se-bastiam vogla defender e varder tuta la fidella cristianità de morb e de epi-dimia, specialment quest pays, questa villa e questa fraternita e conpagnia...”.
Il tema è specifico argomento della lauda n. XXXIV, “O Santo Sebastiano, cavalere glorioso, Deffendi ly Cristiani del morbo contagioso... Prega Dio omnipotente e la Verçene Maria Que garde aquesta gente de tuta enpedimia”.
L’ultima “Recomendacione” interessa la preghiera per la salvezza di tutto il genere umano: “Noy se tornerema humelment e devotament a la glo-riosa Vergena Maria, fontana de gracia... che el gli piaça de preer el Nostre Segnor Yhesu Crist per salvacion de tuta la humana generacion...”. Allo stesso modo, nella lauda XX ritroviamo: “Intercede a Jhesu Christe/ Per tuta la humana generacione”69, e così via.
Il manoscritto saluzzese è stato compilato da un’unica mano e in uno stesso tempo, a parte, come anticipato, alcune aggiunte70. I testi che con-serva si rivelano elementi di una raccolta eterogenea e dalla differente antichità: oltre ai canti in latino (XIII secolo), anche la lauda XI riprende
69 G. Gasca Queirazza, Documenti, op.cit., p.19. 70 Cfr. le carte 82 r. - 84 r.
(copia parziale)
I
Avento: la lauda è il canto di una stagione di attesa e di gioia, l’Adventu- Avento, (R3, 1,5, 2,1), tempo dell’intrecciarsi del futuro, ... Christe... ven a salvare, (1, 7-8); ferà la doza paxe, (2, 7-8); ven lo to Segnore, (5, 3-4); ...è presso, (R3); s’aprossima, (2,1); lo mondo... vederà, (3, 4-6) con il passato Dè Pare n’à tramisso, (2,5); è il tempo del rallegrarsi proprio dei giorni che precedono il Natale, e s’alegre, (R2), alegreça, (1,6), alerança, (4,2), t’alegra, (5,1) sono le espressioni ripetute e comuni per la festa; il nascere del Signore, tema emergente della composizione, rey de paradisso/ si dey nascer de una vergen, (2,2-3), per ti vol naser cum povertae/ de una povera fantina, (5,5-6), a recever Christe omnipossente,/ quando Elo serà nao, (6, 3-4) è insistente nel procedere delle strofe, in abbinamento a quello dell’urgenza della conversione, e no gli torne zamay/ per amor del Salvatore, (4,6-7), no romagna alcun peccao/ in la nostra consciencia, (6, 4-6); il mondo tenebroso, (3,5), sta per scoprire luxe et claritae, (3,7): la venuta dell’agnelo sanza peccao, (3,3), il Figlor glorioso, (3,2), di Dè Pare (2,5) è prossima: per ogni devoto confratello, è il momento proprio del “pentimento”.
59
PRIMA DOMINICA, ET QUALIBET DOMINICADE ADVENTU, DICATUR ISTA2: IN NOMINE DOMINI NOSTRI YHESU CHRISTI. AMEN
* L’asterisco indica la variante presente in altri laudari, come in questo caso, ToRV devotamente
* ToMC penitentia
* LI se aproxima
* C, ToRV alegranza
* C christo chi è de o. d.
* LG era stao promisso, LI erainproximo
* LG inter dee e li p., * ToRV in cor de lo peccaurore
Ogno homo cum devocione* S’alegre in questo sancto Avento: Or è presso3 lo (1) tempo Che el dey naser lo Salvatore. //
c.30r. 1. Ogno homo cum devoci(o)ne S’alegre en questo sancto Avento; Chi è stato peccatore Si vegna a pentimento*: Or s’aproxima* lo tempo De grandissima alegreça*, Christe pin4 de ogni5 dozeza* Ven a salvare lo peccatore. 2. Or s’aprossima lo tempo Che lo rey de paradisso Si dey nascer de una vergen Como n’ era empromisso6*; Dè7 Pare8 n’à tramisso9
Lo so Figlor veraxe Chi ferà la doza paxe Inter10* li peccatore*.
2 LG ‘De la primera domenega de lo Avento fin alla Nativitai de Criste’, C ‘In dominicis de Adventu’, P ‘Incipit Lauda ab Adventu usque ad Na- tivitatem’; LI ‘In Adventu usque ad Nativitatem’
3 ‘vicino’ 4 ‘colmo’ 5 ‘tutte le’ 6 ‘profetizzato’ 7 ‘Dio’ 8 ‘Padre’, come a 3,1... 9 ‘inviato’, come a 3,1... 10 ‘con’
60
* C g. seguranza, LG, ToMC, ToRV, LI alegreza
* LG ogni peccaor , LI A t. * LG se parta
* C per amare lo S., LG per amor de lo Segnor;
* ToRV or con o miniata come ad indicazione d’inizio strofa
* LG lassa zomai le p.
* ToMC piccolina, LI caxa
3. Dè Payre n’à tramisso Lo so Figlor glorioso (2), L’agnelo sanza peccao, Ihesu Christe pietoso. Lo mondo tenebroso Et pin de oscuritae Vederà (3) luxe et claritae11
Quando nascerà lo (4) Creatore. 4. Mondo chi eri sença luxe, Or abi granda alerança12*! Lo doze Christe si t’aduxe13
Gracia et perdonanza. Tuti peccaor* cum gran speranza Se parten14 *da li peccay, E no gli torne zamay Per amor del Salvatore*. 5. Or* t’alegra, peccatore, E laxa* li peccae, A ti ven lo to Segnore cum grande humilitae; /
c.30v. Per ti vol naser cum povertae De una povera fantina15
In una caseta peçenina16* Scenza richeza ni honore.
11 ‘chiarore’ 12 ‘gioia’ 13 ‘reca’ 14 ‘allontanino’ 15 ‘ragazza’ 16 ‘piccola’
61
* LI s. stia
* C, LG, ToRV omnipotente, LI Iesu C. omnipotente
* LI in la sua
* LG creatore amen
6. Ogno homo devotamenti Si sea* apareglao A recever Christe omnipossente*, Quando Elo serà nao. No romagna alcun peccao In la nostra* consciencia Chi sea contra la reverencia De lo nostre Creatore*.
Hic [e]splicit lauda ista. Deo gracias.
(1) ms. dittografia di te (2) ms. glorioso con la seconda o add. in alto in inchiostro rosso (3) ms. de vera (4) ms. lo add. in alto in inchiostro rosso
R + 6 ABABBCCX, (R + 7 in LG, ToRV)17
Edizione: la correzione vederà (3,7) si impone grazie al confronto degli esiti degli altri codici (ToMC, LI de vera); la versione di LG e ToRV è composta da ben sette strofe (l’ultima evidente parafrasi della precedente):
“Lo nostro doce Segnore Dee naxer poveramente De Maria benita (LG M. fior) Chi l’à portà in lo ventre. Ogn’omo devotamente Si se debia aparegare E la soa anima mondare Per recever lo Segnore” (LG r. lo sarvao)
17 Cfr. A. Feist, Mitteilungen aus älteren Sammlungen italienischer geistlicher Lieder, in Zeitschrift für Romanische Philologie, XIII (1889), pp. 115-185, n. 858; A. Tenneroni, Inizii di antiche poesie italiane religiose e morali conprospetto die codici che le contengono e introduzione alle laude spirituali, Fi- renze 1909, p. 180.
62
II
nato l’agnelo: “la nascita di Cristo” è il tema conduttore della lauda, contenuto tra le strofe iniziale e quella finale, entrambe espressioni della preghiera personale del confratello saluzzese, lasemo li peccae/ e seamo obbedienti..., (1, 5-6), or amemo dozamenti/ questo nostro rey novello..., (7, 1-2). Il testo riprende la memoria del parto de Maria, (2,2), che semper stagando vergen/ ela è apartoria (2, 3-4), e recupera il modo della nascita con l’immagine del presepio, (6,2): ela no ave roba/ ni drapo ni richeza, (3, 5-6), lo bo e l’axenello/ si gli faxeen honore, (7, 7-8), collocando l’evento nel quadro della Storia del popolo ebreo con le voci dei sancti profecte, (4,3) e in quella del mondo cristiano con i canti angelici, (5,2), e la chiamata dei pastori, (6, 1-2).
63
DE NATIVITATE DOMINI USQUE AD EPIPHANIAMDICATUR ISTA LAUDA18
* LG, ToRV C. pin de dozeza
* LG, ToRV c. amore
* LI a retenire* C dato novelamente
* LG c. e. si è lo n. redentore, ToRV de lo nostro s., LI che ha fato il n. s.
* ToMC ancoi è compito lo z.
* LI e ley aparturirà nato
* LG pregem’ora
Or è nato l’agnelo Christo Nostre Segnore*: Ogni homo s’aparegle19
A rezeverlo cum honore*.
1. Ogno homo s’aparegle Monto20 devotamente A rezever* lo doze Christe Nato novellamenti21*; Lasemo li peccae E seamo obedienti Ali soy comandamenti Ch’ el è Nostre Segnore*.
2. Or sum cumpì22 li jorni* De lo parto de Maria, Semper stagando vergen Ela è apartoria23* Un doze fantineto24
Chi lo mondo à in baylia25: (1) // c.31 r. Pregemelo tuta via*
Per ogni peccatore.
18 In LG ‘Della Nativitai de lo Nostro Segnor Jexu Criste’, in C ‘A Nativi- tate usque ad Epiphaniam’, in P ‘In festo Nativitatis Domini Nostri Jhesu Christi dicatur infrascripta lauda’; in ToMC ‘Dominica de Adventu, in LI ‘In festo Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi dicuntur intro- scripta’
19 ‘si prepari’ 20 ‘molto’ 21 ‘da poco’ 22 ‘venuto il tempo’ 23 ‘ha partorito’ 24 ‘bambino’ 25 ‘in suo potere’
64
* C avia, LG aveiva, LI havea * C avia, LG aveiva, LI havea * ToRV, LG a. trapi (drapi) * LG, ToRV n. robe de richeza
* LG, ToRV tempo * C c. tanto desiramo
* ToRV agli sancti p.
* ToRV l’a. commendao
* LG, ToRV a. si an cantato
* LG, LI g. alegreza * ToMC anuntiano li angeli
* ToMC e in terra a li homini * LG, ToRV i. t. paxe
anonciando, ToMC che sono di bona voluntade
* ToMC li p. vigilavano/goardando lo lor grege/ e in bethlem intendeno/ esser nato lo s.
3. La Vergen gloriosa Pina de ogni beleza Vardando26 a lo so figlo Ave* granda alegreza; Ela no ave* roba27 * Ni drapo28 ni richeza*, De povera robeta29
Faxava lo Creatore. 4. Ancoy è conpì30 lo jorno* Chi è tamto dexirao31* E li sancti profecte* L’aveam anunciao*: “Lo dozo Jhesu Christe En Beleem è nao”; Li angeli van cantamdo* Canti de gran dozore. 5. “Gloria a Dè in cel” Li angeli van camtando* E la bona gente in terra* Paxe van anunciando*; Li pastori veglaven* Lor bestie vardamdo, Et Christo van cerchando Chi è nato lo Salvatore.
26 ‘badando’ 27 ‘mezzi’ 28 ‘stoffa ricercata’ 29 ‘tessuto’ 30 ‘venuto’ 31 ‘desiderato’
65
* C troverono * ToRV jasiva
* LG l’angero glorioso; ToMC in mezo lo bove e l’asino/ li magi cum gran fervore/ veneno da oriente/ adorar cristo nel presepio/ ch’era tuto relucente
* ToRV m. da dee pare* LG c. li peccai p.
* ToRV quello r. novello
* ToRV ello n’era
* C ge fasem, LG ge fan grande h., LI faceano, ToMC si erano al suo servitio.
6. Li pastor trovan* Christe Chi en un presepio32 jaxe*, L’agnelo inmaculao* Mandao da Dé veraxe*, Chi a li peccaor perdona* E a lo mondo dà paxe, Li nostri cor abraxe De lo so doze amore.
7. Or amemo dozamenti Questo nostro rey novello* Chi per noy è nato in terra Como un poverelo; / (1)
c.31 v. Ello non à* richeza Ni servo né donzelo33, Lo bo e l’axenello Si gli faxeen honore*.
Explicit lauda ista. Deo gracias. Amen
(1) ms. pregemelo add. nel margine inferiore della carta per indicazione all’inquadernatore.
R + 7 ABCBDBBX34
32 ‘mangiatoia’ 33 ‘domestico’ 34 Cfr. A. Feist, Mitteilungen... op.cit., n. 949; A. Tenneroni, Inizii di antiche
poesie... op.cit., p. 195.
66 (copia parziale)