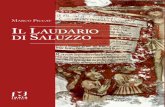Il codice francescano. L'invenzione di un'identità
Transcript of Il codice francescano. L'invenzione di un'identità
Questo mio intervento ha bisogno di una necessaria pre-messa, che ne costituisce in realtà una parte sostanziale, anzil’ossatura di fondo. Il tema della fisionomia del codice france-scano non è solo, in generale, un tema forte, anzi portante del-la codicologia francescana, ma sub specie personae, della miain particolare, rappresenta un vasto mare che come piccolo ve-liero ho frequentemente solcato. Non è stata sempre una navi-gazione facile: talora le acque sono state agitate, talora, so-prattutto, mi sono incontrata quando non scontrata con gli ice-berg rappresentati da ingombranti eppure consolidati miti sto-riografici, come la sin troppo dibattuta questione dell’ideologiafrancescana del libro, dalla quale mi sono tenuta a distanza disicurezza 1.
1 Sul ruolo del libro e della cultura scritta presso i Minori, più in generalepresso i Mendicanti, si ricordino almeno le ricostruzioni di G. SEVERINO POLICA,Libro, lettura, “lezione” negli Studia degli ordini mendicanti (sec. XIII), in Lescuole degli ordini mendicanti (secoli XIII-XIV). Atti del XVII Convegno inter-nazionale di studi (Todi, 11-14 ottobre 1976), Todi, 1978, pp. 375-413, e di chiscrive su I protagonisti del libro: gli ordini mendicanti, in Calligrafia di Dio. Laminiatura celebra la Parola (Abbazia di Praglia, 17 aprile - 17 luglio 1999), Ca-talogo a cura di G. CANOVA MARIANI - P. FERRARO VETTORE, Modena, 1999, pp. 51-57, oltre al riassuntivo intervento di A. BARTOLI LANGELI, I libri dei frati. La cul-tura scritta dell’Ordine dei Minori, in M. P. ALBERZONI - A. BARTOLI LANGELI - G.CASAGRANDE et alii, Francesco d’Assisi e il primo secolo di storia francescana, To-
NICOLETTA GIOVÈ MARCHIOLI378
In un gioco di hysteron-proteron dirò subito quello che inrealtà dovrebbe essere il punto d’approdo della mia nave, equesto perché l’idea forte che ha guidato la mia navigazionel’avevo ben chiara prima di cominciare, l’avevo ben chiaraquando ho elaborato il titolo del mio intervento, l’avevo sem-pre più chiara alla fine della mia ricerca. Non si tratta solo diuna scelta retorica. Si tratta anche di un déjà-vu. Otto anni fa,con Stefano Zamponi, trattavo di un tema assai simile 2. Par-lavamo anche allora di codici francescani: l’arco cronologicoera lo stesso, ma la discriminante era la lingua, dato che i co-dici di cui ci occupammo in quella occasione erano esclusiva-mente in volgare, mentre quelli studiati per questa occasionesono stati raccolti senza fare distinzioni linguistiche. Tale cir-costanza ha fatto sì che si allargasse a dismisura il corpus deipossibili testimoni, limitato solo dalle mie forze 3. Rispetto ad
rino, 1997, pp. 283-305, a quello, ancora più recente, di P. MARANESI, NescientesLitteras. L’ammonizione della Regola Francescana e la questione degli studinell’Ordine (secc. XIII-XVI), Roma, 2000, e a un altro contributo di chi scrive,molto più circoscritto, su Circolazione libraria e cultura francescana nella Pa-dova del Due e Trecento, in Predicazione e Società nel Medioevo: riflessione eti-ca, valori e modelli di comportamento. Atti del XII Medieval Sermon StudiesSymposium (Padova, 14-18 luglio 2000), a cura di L. GAFFURI - R. QUINTO, Pado-va, 2002, pp. 131-141.
2 Mi riferisco naturalmente alla relazione di N. GIOVÈ - S. ZAMPONI, Mano-scritti in volgare nei conventi dei frati Minori: testi, tipologie librarie, scritture(secoli XIII-XIV), in Francescanesimo in volgare (secoli XIII-XIV). Atti del XXIVConvegno internazionale (Assisi, 17-19 ottobre 1996), Spoleto, 1997, pp. 303-336.
3 La ricerca di manoscritti da censire si può indirizzare verso talmente tan-te direzioni, alcune delle quali sicuramente inaspettate e imprevedibili, che ri-chiede necessariamente delle bussole per orientarsi, dato il dedalo delle stradepercorribili. In tal senso certamente risultano non di poco aiuto cataloghi specialicosì come specifici studi su autori e testi minoritici, che hanno già provveduto auna selezione preventiva dei codici francescani potenzialmente interessanti. Citoalmeno, oltre alle due poderose opere di C. CENCI, Manoscritti francescani della Bi-blioteca Nazionale di Napoli, I-II, Grottaferrata, 1971 e Bibliotheca manuscriptaad Sacrum Conventum Assisiensem, I-II, Assisi, 1981, G. ABATE - G. LUISETTO, Codi-
IL CODICE FRANCESCANO 379
allora, inoltre, interviene un elemento nuovo. In quegli stessianni infatti si è aperta una straordinaria stagione nella cata-
ci e manoscritti della Biblioteca Antoniana, col catalogo delle miniature a cura diF. AVRIL - F. D’ARCAIS - G. MARIANI CANOVA, I-II, Vicenza, 1975, M. BIGARONI, Cata-logo dei manoscritti della Biblioteca storico-francescana di Chiesa nuova di As-sisi, in Atti dell’Accademia Properziana del Subasio di Assisi, ser. 6a, I (1978),pp. 9-43 e il recente anche se piuttosto parziale repertorio di G. J. ETZKORN, IterVaticanum Franciscanum. A description of some one hundred manuscripts ofthe Vaticanus Latinus collection, Leiden - New York - Köln, 1996, oltre alle uti-lissime ricognizioni di A. LÓPEZ, Descriptio Codicum Franciscanorum Bibliothe-cae Riccardianae Florentinae, in Archivum Franciscanum Historicum, I (1908),pp. 116-125, 433-442; II (1909), pp. 123-130, 319-324, 480-484; III (1910), pp.333-340, 551-558, 739-748; IV (1911), pp. 360-365, 748-754; V (1912), pp. 352-359; VI (1913), pp. 156-167, 328-337, 748-757 e di S. TOSTI, Descriptio CodicumFranciscanorum Bibliothecae Riccardianae Florentinae, ibid., VIII (1915), pp.226-273, 618-657; IX (1916), pp. 395-442; XIII (1920), pp. 587-603; XIV (1921),pp. 243-258; XV (1922), pp. 155-170, 508-524; XVI (1923), pp. 545-556. Per unampio elenco dei manoscritti testimoni del laudario iacoponico si veda L. LEO-NARDI, Per il problema ecdotico del Laudario di Jacopone: il manoscritto di Na-poli, in Studi di filologia italiana, XLVI (1988), pp. 13-85. Sulla tradizione delleopere poetiche di Ugo Panziera si vedano gli interventi di V. DI BENEDETTO, Perun’edizione delle Laudi del B. Ugo Panziera, O. Min. (c. † 1330), in MiscellaneaFrancescana, LVI (1956), pp. 262-281, e Nota filologica alla nuova edizione(1962) delle Laudi del b. Ugo Panziera, O. Min. († c. 1330), ibid., LXII (1962),pp. 414-444. Sulla tradizione manoscritta delle due versioni, latina e volgare,della Scala Paradisi si veda R. G. MUSTO, Angelo Clareno O.F.M.: Fourteenth-Century Translator of the Greek Fathers. An Introduction and a Checklist ofManuscripts and Printings of his Scala Paradisi, in Archivum FranciscanumHistoricum, LXXVI (1983), pp. 215-238 e 589-645. I testimoni delle opere diPietro di Giovanni Olivi si recuperano grazie ad A. CICERI, Petri Iohannis Oliviopera. Censimento dei manoscritti, Roma, 1999. Infine, per individuare i codicidei Fioretti si rivelano indispensabili le indicazioni di G. PETROCCHI, Inchiestasulla tradizione manoscritta dei “Fioretti di San Francesco”, in Filologia ro-manza, IV (1957), pp. 311-325. Non solo. Devo anche alla disponibilità di alcuniamici – fra cui Leonardo Granata, Martina Pantarotto, Adriana Paolini e Ric-cardo Quinto, che qui ringrazio –, i quali mi hanno messo a disposizione i mate-riali, ancora inediti, su cui stanno lavorando, la possibilità di avere avuto con-tezza della fisionomia dei preziosi fondi manoscritti conservati in importanti bi-blioteche – di Trento, Brescia, Venezia, Belluno, per citarne solo alcune –, spes-so poco esplorate se non del tutto sconosciute.
NICOLETTA GIOVÈ MARCHIOLI380
lografia italiana, che in pochissimo tempo ha arricchito un pa-norama sino ad allora asfittico e desolato, grazie alla pubblica-zione a ritmi serrati di una ricca serie di cataloghi sia generaliche speciali, che hanno squarciato con la luce di una granmesse di dati il buio che oscurava i fondi manoscritti medieva-li di intere regioni, fra le quali il Veneto, la Toscana, la Sicilia,e che mi hanno messo a disposizione una importante raccoltadi informazioni normalizzate su codici utili ai fini della mia ri-cognizione, codici tutti di origine italiana, soprattutto centro-italiana 4.
4 Mi riferisco nello specifico alle due collane Biblioteche e Archivi e Mano-scritti datati d’Italia, che comprendono l’una cataloghi generali di codici medie-vali, l’altra cataloghi speciali di codici datati, e all’interno delle quali sono uscitirispettivamente i volumi Manoscritti medievali del Veneto. 1. I manoscritti del-la Biblioteca del Seminario vescovile di Padova, a cura di A. DONELLO - G. M.FLORIO - N. GIOVÈ et alii, [Venezia] - Firenze, 1998, Manoscritti medievali dellaToscana. 1. I manoscritti medievali della provincia di Pistoia, a cura di G. MU-RANO - G. SAVINO - S. ZAMPONI, Firenze, 1998; Manoscritti medievali della Tosca-na. 2. I manoscritti medievali della provincia di Prato, a cura di S. BIANCHI - F.GALLORI - G. MURANO et alii, Firenze, 1999; Manoscritti medievali del Veneto. 2. Imanoscritti medievali di Padova e provincia (Padova, Accademia Galileiana,Archivio di Stato, Biblioteca Civica, Biblioteca dell’Orto Botanico, Biblioteca diSanta Giustina, Biblioteca Pinali; Monselice, Biblioteca Comunale; Teolo, Bi-blioteca di Santa Maria di Praglia), a cura di L. GRANATA - A. DONELLO - G. M.FLORIO et alii, con la collaborazione di N. GIOVÈ - G. MARIANI CANOVA - S. ZAMPONI,Venezia - Firenze, 2002; Manoscritti medievali della Toscana. 3. I manoscrittimedievali delle province di Grosseto, Livorno e Massa Carrara, a cura di S. BER-TELLI - E. CALDELLI - G. DE FRANCESCO et alii, Firenze, 2002; Manoscritti medievalidella Toscana. 4. I manoscritti medievali della Biblioteca Città di Arezzo, a curadi G. LAZZI - L. MELANI - G. POMARO et alii, Firenze, 2003 e I manoscritti datatidella provincia di Trento, a cura di M. A. CASAGRANDE MAZZOLI - L. DAL POZ - D.FRIOLI et alii, Firenze, 1996; I manoscritti datati della Biblioteca Riccardiana diFirenze. I. Mss. 1-1000, a cura di T. DE ROBERTIS - R. MIRIELLO, Firenze, 1997; Imanoscritti datati della Biblioteca Riccardiana di Firenze. II. Mss. 1001-1400, acura di T. DE ROBERTIS - R. MIRIELLO, Firenze, 1999; I manoscritti datati dellaprovincia di Vicenza e della Biblioteca Antoniana di Padova, a cura di C. CAS-SANDRO - N. GIOVÈ MARCHIOLI - P. MASSALIN - S. ZAMPONI, Firenze, 2000; I mano-scritti datati del Fondo Conventi Soppressi della Biblioteca Nazionale Centrale
IL CODICE FRANCESCANO 381
Ribadirei ancora quello che osservammo allora. Ma in qual-che modo quelle stesse osservazioni si allargano, si arricchisco-no, si complicano, come se, fissate alcune acquisizioni, l’evi-denza stessa delle fonti, quasi necessariamente, o involonta-riamente, mi spingesse a fare una serie continua di distinguo,di precisazioni, di deviazioni. Ecco cosa potrebbe essere il codi-ce francescano: una norma, e poi, subito dopo, tantissime ecce-zioni alla norma stessa. Insomma, nel rincorrersi di precisa-zioni e di ridefinizioni per mettere meglio a fuoco l’oggetto inanalisi, a un certo punto la verità appare nel suo innegabile,incontrovertibile, forse inatteso aspetto. Questo: a mio parerenon esiste un codice francescano con un’identità certa e asso-luta, o comunque non esiste un modello dominante, quantopiuttosto esiste una costellazione di modelli simili ma tutti de-vianti o deviati, quasi fossero una rifrazione, una scomposizio-ne all’infinito di un’immagine e dunque di una realtà solo ini-zialmente o astrattamente nitide e poi sempre più complesse.L’esuberanza delle fonti disponibili ha aiutato e nel contempoin qualche modo complicato la mia ricerca, il cui limite crono-logico alla soglia del XV secolo, pur da me rigorosamente ri-spettato, si rivela in qualche modo forzato e artificiale, inquanto, almeno per quel che concerne la prassi di produzionedel libro, stabilisce una scansione che nella realtà delle cosenon esiste.
di Firenze, a cura di S. BIANCHI - A. DI DOMENICO - R. DI LORETO et alii, Firenze,2002; I manoscritti datati della Biblioteca Civica Angelo Mai e delle altre biblio-teche di Bergamo, a cura di F. LO MONACO, Firenze, 2003; I manoscritti datati diPadova (Accademia Galileiana di Scienze, Lettere e Arti - Archivio Papafava .
Archivio di Stato . Biblioteca civica . Biblioteca del Seminario vescovile), a curadi A. MAZZON - A. DONELLO - G. M. FLORIO et alii, Firenze, 2003; I manoscritti da-tati della Sicilia, a cura di M. M. MILAZZO - M. PALMA - G. SINAGRA - S. ZAMPONI,Firenze, 2003, I manoscritti datati del Fondo Palatino della Biblioteca Naziona-le Centrale di Firenze, a cura di S. BIANCHI, Firenze, 2003 ed infine I manoscrittidatati della Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, a cura di M. L. GROSSI
TURCHETTI, Firenze, 2004.
NICOLETTA GIOVÈ MARCHIOLI382
Ma che cosa è un codice francescano? Secondo una consoli-data tradizione, che possiamo riassumere in una celebre e ci-tatissima ricostruzione di Marino Bigaroni,
« i frati di questi piccoli eremi cominciarono a procurarsidei libri, ma con parsimonia. Anzi non essendo in grado diprocurarsene molti, né volendolo, in ossequio alla povertà rac-colsero in pochi miscellanei compilazioni da opere intere, tra-scrivendo per economia le pagine più belle o più interessantiper loro o per la comunità, senza curarsi troppo né della “bonalittera” né dell’ornato, memori di quanto il loro fondatore ave-va raccomandato: “in libris testimonium querere Domini nonprecium, hedificationem non pulchritudinem edocebat”.
Da qui quel carattere di compilazione che hanno gran par-te dei codici francescani più antichi, soprattutto di origine pri-vata, ed il tipo di “littera” piuttosto rozza ed incerta. Si feceeccezione naturalmente per i libri liturgici che, considerati “or-namenta” del culto divino e dovendo essere trascritti tali equali, ed essendo destinati ad un uso collettivo, venivano com-messi a frati e monache esperte dell’arte » 5.
La mitologia del codice francescano è tutta qui, soprattuttoper quanto concerne le sue strutture formali. Cercando inveceun’altra prospettiva, potremmo allargare la definizione di ma-noscritto francescano quasi fosse una rete le cui maglie in que-sto modo potrebbero pescare di più. Un manoscritto può averela qualifica di francescano per uno o più motivi: a seconda cioèse si può attribuire alla mano di un francescano; se contienel’opera di un autore francescano; se appartenne a un insedia-mento francescano. Circoscrivere il concetto di manoscritto
5 Cfr. BIGARONI, Catalogo dei manoscritti cit., pp. 10-11. Ricordiamo anche leriflessioni sparse nell’intervento di G. ABATE, Manoscritti e biblioteche france-scane del Medio Evo, in Il libro e le biblioteche. Atti del primo congresso biblio-logico francescano internazionale (20-27 febbraio 1949), II. Conferenze di carat-tere particolare, Roma 1950, pp. 77-126.
IL CODICE FRANCESCANO 383
francescano, insomma, già di per sé non si rivela impresa faci-le. Esiste una tipologia ideale, quella cioè di un libro progetta-to per ricevere un testo di un autore minoritico, prodotto dafrati Minori o per commissione di frati Minori o anche destina-to a una biblioteca di Minori. Ma come già osservavamo annifa con Zamponi, a fronte di una costruzione teorica, di un mo-dello astratto, nella prassi diverse sono le ragioni per cui unmanoscritto si può identificare come francescano, e la verificasulla concreta realtà della tradizione manoscritta dimostra che
« questo modello di codice francescano non è attestato difrequente, viene piuttosto a delinearsi a posteriori dalla ricom-posizione di elementi diversi, che in varia combinazione (e soloin pochi casi tutti insieme) si ritrovano nei codici che con qual-che generosità possono definirsi francescani » 6.
Di fatto possiamo attribuire l’appellativo di francescano aun manoscritto solo in base ai testi che contiene, riconducibiliall’ambito culturale minoritico, o in base ad antiche note diconfezione o di possesso, che testimoniano una originaria pro-duzione o conservazione all’interno di un centro francescano.Attraverso attestazioni di ordine testuale e storico si indivi-duano così manoscritti con aspetti comuni, che nel loro ricorre-re ne rendono plausibile e ribadiscono l’origine in ambito fran-cescano. Solo sovrapponendo gli elementi che individualmenteconnotano questi manoscritti si potrà tentare di proporre, conun’operazione in parte astratta, una sorta di modello generale,costruito attraverso una sovrapposizione continua dei requisitiideali. Per quanto mi riguarda, intendo come manoscritto fran-cescano soprattutto quello con testi francescani, che tenterò dicollegare a una sede di produzione, uso e conservazione fran-cescana, tramite un esame diretto, attraverso il quale ho rile-vato elementi strutturali, impaginazione, scrittura, decorazio-
6 Cfr. GIOVÈ - ZAMPONI, Manoscritti in volgare cit., p. 312.
NICOLETTA GIOVÈ MARCHIOLI384
ne, testi, storia. L’osservazione dei caratteri formali dovrebbeconsentire di individuare delle connotazioni codicologiche uni-formanti, quasi una sorta di “moda francescana” che si defini-sce, rimane e si impone al di sopra degli usi dei singoli scripto-ria o dei singoli scriptores, siano essi stati attivi all’interno deiloci francescani oppure esterni a essi.
In quest’ultimo caso supponiamo che i copisti abbiano se-guito due modalità di comportamento entrambe possibili maopposte. Abbiano cioè imposto le strutture formali da loro co-munemente rispettate, oppure, al contrario, abbiano sentitocome immanente l’obbligo di uniformarsi alla volontà e ai cri-teri di confezione seguiti, oppure desiderati dalla committenza,e dunque diffusi in ambito francescano 7.
Ma allora, ponendoci nuovamente la medesima domanda,esiste il codice francescano, che cosa è un codice francescano?Ve ne faccio alcuni esempi, in qualche modo cattivi esempi,che attingono tutti in varia maniera all’eidos della Francisca-nitas, e che nel contempo corrono nella direzione opposta, ne-gando nei fatti quanto invece dovrebbero asseverare. Certa-mente francescane, tanto che per antonomasia così vengonodefinite, sono le bibbie di Cesena e di Trento, cioè i mss. Cese-na, Biblioteca Malatestiana, D.XXI.1, 2, 3, 4 e Trento, Castellodel Buonconsiglio, Monumenti e collezioni provinciali, 1597 8,sontuosi e anomali esemplari di libri il cui rapporto con l’am-
7 Sulla questione della committenza francescana nell’ambito più generaledella produzione artistica medievale e delle scelte iconografiche si veda la re-centissima sintesi di L. BOURDUA, The Franciscans and Art Patronage in LateMedieval Italy, Cambridge, 2004.
8 Belle riproduzioni, accurate descrizioni e puntuale storia di questi codicirispettivamente in “Scritte dal dito di Dio”. Testi biblici e liturgici manoscritti ea stampa della Biblioteca Malatestiana (Cesena, Biblioteca Malatestiana, 13aprile - 30 giugno 2002), a cura di P. ERRANI - F. LOLLINI, Cesena, 2002, pp. 76-85nr. 5-8 e in Calligrafia di Dio. La miniatura celebra la parola (Abbazia di Pra-glia, 17 aprile - 17 luglio 1999), catalogo a cura di G. CANOVA MARIANI - P. FERRA-RO VETTORE, Modena, 1999, pp. 135-138 nr. 22.
IL CODICE FRANCESCANO 385
biente minorita è quasi elemento sovrastrutturale calato inuna struttura formale fortemente connotata ed evoluta. I codi-ci, perfettamente coevi, risalendo agli anni fra il 1265 e il1270, sono ambedue in una textualis rotunda centro-italiana, epresentano una decorazione che nel caso cesenate è riconduci-bile alla zona romagnola e in particolare al “Maestro di Ba-gnacavallo”, mentre per la bibbia trentina si fa risalire piutto-sto a un’officina bolognese. Differiscono tuttavia fortementeper il loro formato: anacronisticamente atlantico quello dei vo-lumi cesenati (che può arrivare a 450 mm. di altezza e oltre300 di larghezza), medio (mm. 241 × 173) quello del libro tren-tino. Il richiamo al mondo dei Minori (forse committenti, piùprobabilmente destinatari, comunque possessori) è dato dallaperaltro ricca e magistrale ornamentazione, in cui compaiono,incastonati in contesti significativi, Francesco e santi e fratifrancescani. Da queste bibbie non promana alcuna idea di po-vertà, di modestia, di basso profilo.
Innegabilmente francescane (e come quelle di Cesena lo so-no anche per la continuità del loro luogo di conservazione), manon certo nel loro impressionante aspetto, né tanto meno perla loro origine, sono le celeberrime bibbie glossate dell’Anto-niana e del Sacro Convento 9. Bibbie la cui bellezza è frazio-nata, anzi, per meglio dire, moltiplicata nei tanti volumi, dun-que nei tanti libri in cui è diviso il testo, e che si devono al ge-neroso intervento di importanti benefattori, anche stranieri,ad esempio del re di Francia, san Luigi IX: si vuole attribuireinfatti alla sua devota generosità l’arrivo, oltre che dei tre libriliturgici del tesoro, anche dell’importante Bibbia glossata ese-guita certamente a Parigi, attualmente conservata fra Assisi ela Biblioteca Apostolica Vaticana. Prodotti librari di altissimo
9 Si tratta rispettivamente degli attuali mss. Padova, Biblioteca Antoniana,267, 274, 276, 277, 280, 283, 284, 285, 289, 309, 310, 313, 316, 342 e Assisi, Bi-blioteca del Sacro Convento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, e Città delVaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ross. 299, 300, 613 e 616.
NICOLETTA GIOVÈ MARCHIOLI386
livello, ambedue bibbie parigine e coeve, in quanto realizzate,pure in centri diversi – spesso in atelier celebri, come quello dimagister Alexander, che intervenne nella realizzazione dellabibbia padovana – entro la metà del Duecento, con datazioniche vanno dal secondo quarto alla piena metà del secolo, inorigine erano rispettivamente in venticinque e in diciassettevolumi, e vennero donate l’una da un magister Uguccio, cano-nico della cattedrale di Padova intorno al 1240, l’altra appuntodal re di Francia, san Luigi IX, dopo il 1255-1256.
Francescano, indubitabilmente, è infine il codice Pavia, Bi-blioteca Universitaria, Aldini 336 (cfr. Tavola I), strepitosoesempio di fattura maestosa, di decorazione superba, di libro-strumento raffinato, il tutto per un testo di diritto canonico, laSumma collectionum pro confessionibus audiendis, del mae-stro francescano Durando Campano. Risale a una mano chescrive con buona probabilità nel primo quarto del XIV secolo,ma non italiana, piuttosto inglese, che stride con la decorazio-ne arcaicizzante, sicuramente italiana, di impronta bolognese.Ed è proprio la decorazione, anzi solo la decorazione, che san-cisce pur inesorabilmente il rapporto con l’ordine minoritico,caratterizzata dall’iniziale caleidoscopica del prologo che rag-giunge il suo apice, anche metaforicamente, con l’immagine sufondo dorato di Antonio che tiene in mano un libro chiuso.
Questi forse non sono dei codici francescani perfetti. Unperfetto codice francescano è quello prodotto in un mondo per-fettamente francescano. Il mondo perfetto è quello di un cen-tro minoritico in cui i libri si concepiscono, si scrivono, si leg-gono, si usano, si prestano, si conservano, si ereditano, e nonsi disperdono mai. Questo mondo perfetto in qualche modo èesistito, ed è rappresentato dal Sacro Convento di Assisi con lasua biblioteca: istituzione religiosa, centro spirituale, ma an-che sede di uno Studium conventuale, e dunque primariamen-te luogo di uso, di conservazione, e probabilmente anche diproduzione dei libri che servono alla formazione spirituale eculturale dei frati, e che non solo furono acquistati per il con-vento, ma sicuramente furono realizzati nel Sacro Convento,
IL CODICE FRANCESCANO 387
che, insomma, non sarebbe potuto di fatto non divenire ancheun attivo e organizzato centro scrittorio. La Biblioteca del Sa-cro Convento ci è nota in tutte le sue pieghe: risale al 1381 ilsuo accurato inventario, esito di uno straordinario lavoro di si-stemazione da parte del suo bibliotecario, Giovanni di Iolo, chedi ogni volume fece una breve descrizione, apponendovi unasegnatura, per ricollocarlo seguendo un ordine ben preciso, eche non mancò di creare codici fattizi, unendo sezioni erraticheprovenienti da manoscritti smembrati, o di rilegare libri con lecoperte danneggiate 10. A testimonianza di questa poderosa im-presa rimangono i cartigli con le segnature collocati sulla copertae, apposta all’interno di ciascuno dei quaterni, cioè dei fascicoli diogni volume, la cosiddetta signatura Assisiensis, ossia l’indicazio-ne di volta in volta del numero del fascicolo stesso 11.
L’osservazione dei meccanismi e delle dinamiche di acquisi-zione, di produzione, di conservazione del materiale librario deveandare di pari passo con l’acquisizione della consapevolezza delfatto che la biblioteca di S. Francesco seguì dei percorsi intricatie diversi di accumulo di libri, anche in virtù del fatto che molticodici non solo furono acquistati per il convento, ma sicuramentefurono realizzati nel convento. Eppure mancano testimonianzeesplicite dell’esistenza di uno scriptorium conventuale, ed è piut-
10 L’inventario del 1381, che certamente è stato preceduto da altre impresecatalografiche, di cui peraltro non si sono conservate tracce, già edito da L.ALESSANDRI, Inventario dell’antica biblioteca del Sacro Convento di S. Francescoin Assisi compilato nel 1381, Assisi, 1906, è alla base dello studio sulla Bibliote-ca del Sacro Convento di CENCI, Bibliotheca manuscripta cit.
11 Non conviene insistere oltre sull’ordinamento di questa biblioteca, sulla qua-le, e non poteva essere altrimenti, sono intervenute molte delle relazioni presenta-te nel corso del convegno. Sullo specifico della collezione libraria del Sacro Conven-to si vedano inoltre le tante indicazioni nella sezione Codici e biblioteche, a cura diE. MENESTÒ, del volume Francesco d’Assisi. Documenti e Archivi. Codici e Bibliote-che. Miniature, Milano, 1982, pp. 89-153, accanto a M. G. CIARDI DUPRÈ DAL POGGET-TO - M. ASSIRELLI - M. BERNABÒ - G. BIGALLI LULLA, La Biblioteca del Sacro Conventodi Assisi, I. I libri miniati di età romanica e gotica, Assisi, 1988, seguito da M. G.CIARDI DUPRÈ DAL POGGETTO - M. ASSIRELLI - E. SESTI, La Biblioteca del Sacro Conventodi Assisi, II. I Libri miniati del XIII e del XIV secolo, Assisi, 1990.
NICOLETTA GIOVÈ MARCHIOLI388
tosto attraverso attestazioni di ordine testuale e storico che si so-no individuati prodotti librari con aspetti comuni di confezione,che rendono plausibile collocarne l’origine in ambito francescano,nello specifico nell’ambito del Sacro Convento. La presenza incer-ta di un centro di copia non esclude comunque la presenza certadi frati attivi come scriptores, accanto a copisti esterni, cui si po-terono commissionare in maniera sempre più consistente operedi trascrizione.
E a proposito dei frati-copisti, non pochi sono stati quelliche in Assisi si sono dedicati all’attività di copiatura dei codici,in particolare molti dei primi socii di Francesco, soprattuttofrate Leone e frate Elia, ma anche altri appartenenti alle suc-cessive generazioni francescane, come frate Elemosina: allamano di ciascuno si riconducono libri che legittimamente sipossono indicare come francescani nella forma e nella sostan-za. Alla prolifica attività di copista di frate Leone forse si de-ve, ad esempio, il minuscolo e suggestivo codicetto con scrittidi Chiara d’Assisi ora conservato dalle clarisse del monasterodi Montervergine di Messina 12. Per quanto concerne invecefrate Elemosina, vissuto nella prima metà del Trecento, passa-to dal convento di Gualdo Tadino ad Assisi, attivo tanto comecronachista quanto come copista, sappiamo che copiò più ma-noscritti con testi agiografici e storici. In particolare, usandouna textualis semplificata e corsiveggiante, da se stesso redas-se e produsse due stesure, quasi due work in progress, di unacronaca ab origine mundi, testimoniata ad esempio dal ms.Assisi, Biblioteca del Sacro Convento, 341 13.
12 Dirimenti per attribuire certa paternità leonina al codice sono state le ar-gomentazioni proposte da A. BARTOLI LANGELI, Gli autografi di frate Francesco edi frate Leone, Turnhout, 2000, che ne fa una lunga disamina alle pp. 104-130.
13 Cfr. I. HEULLANT-DONAT, Livres et écrits de mémoire du premier XIVe siècle:le cas des autographes de fra Elemosina, in Libro, scrittura, documento della ci-viltà monastica e conventuale nel basso medioevo (secoli XIII-XV). Atti del Con-vegno di studio (Fermo, 17-19 settembre 1997), a cura di G. AVARUCCI - R. M.BORRACCINI VERDUCCI - G. BORRI, Spoleto, 1999, pp. 239-262.
IL CODICE FRANCESCANO 389
Ritorno alla questione dello scriptorium, perché propriol’individuazione di caratteri comuni a tanti manoscritti due-trecenteschi conservati talora ab antiquo nella biblioteca diAssisi – caratteri che possono altresì delineare più in generalela fisionomia plausibile di un possibile libro francescano – haindotto in particolare Cenci a teorizzare l’esistenza appunto diun atelier grafico interno al Sacro Convento 14. Il più eclatantee il più ricorrente di questi elementi sarebbe la scrittura 15.
14 Cfr. in particolare CENCI, Bibliotheca manuscripta, I, pp. 23-24. Segue l’i-potesi di Cenci, fra gli altri, E. SESTI, La biblioteca del Sacro Convento di Assisi:ipotesi per uno “scriptorium”, in CIARDI DUPRÈ DAL POGGETTO - ASSIRELLI - SESTI, LaBiblioteca del Sacro Convento di Assisi, II cit., pp. 63-70. Non solo. La presenzafra alcuni codici di caratteri affini che distinguono scrittura, decorazione e miseen page ha spinto alcuni a intravedervi le tracce dell’attività all’inizio del Tre-cento di quello che potrebbe essere stato un piccolo atelier marginale rispetto algrande centro scrittorio conventuale. Si tratta nello specifico di tre manoscritti,tutti latamente ‘francescani’ per quel che concerne il loro contenuto (dalla Le-genda antiqua alle Revelationes beatae Angelae de Fulgineo e alle Collationes diIsacco di Ninive, testo della patristica orientale che circolava nell’entourage de-gli Spirituali: nell’ordine sono i mss. Perugia, Biblioteca Comunale Augusta1046 e Assisi, Biblioteca del Sacro Convento 342 e 572) e che rappresentanoprobabilmente le spie, o meglio i resti fossili di un’attività scrittoria svolta a la-tere di quella ufficiale dello scriptorium conventuale, in forme, ma soprattuttorispondendo a motivazioni che, lo confesso apertamente, non riesco a immagi-nare. Sui caratteri comuni di questi codici si consideri l’analisi di A. BARTOLI
LANGELI, Il codice di Assisi, ovvero il Liber sororis Lelle, in Angèle de Foligno. Ledossier, a cura di G. BARONE - J. DALARUN, Roma, 1999, pp. 7-27.
15 In realtà anche comuni scelte decorative e illustrative testimoniano, se-condo alcuni, l’esistenza di un centro di produzione attivo presso il Sacro Con-vento:
« i manoscritti miniati di scuola umbra presenti nella biblioteca del conven-to costituiscono infatti un nucleo troppo considerevole per essere consideratoestemporaneo e quindi sembra evidente che siano stati prodotti da un unicocentro miniatorio ad Assisi. E, data l’osservanza ai dettami della regola france-scana, tutto fa supporre che proprio all’interno del convento risiedesse lo scrip-torium vero e proprio.
Innanzi tutto le principali caratteristiche comuni sono la scrittura, l’omoge-nea decorazione a penna di stampo vegetale, la semplice decorazione a pennello
NICOLETTA GIOVÈ MARCHIOLI390
Osservando in sequenza diacronica molti codici si è voluta co-gliere la presenza, in una sorta di linea di continuità, di unascrittura libraria caratterizzata, la cosiddetta littera Assisien-sis, una textualis attestata in codici collocabili fra la secondametà del Duecento e la fine del Trecento, e che ci appare ro-tunda nel suo impianto, di impronta centro-italiana, di moduloampio, piuttosto pesante, tracciata con inchiostro di un brunointenso. La scrittura, per intenderci, con cui si è redatto l’in-ventario della sacrestia del 1338, che è stata utilizzata da Gio-vanni di Iolo per la sua ricognizione del 1381, ma soprattuttola scrittura con cui è stato scritto fra la metà e la seconda me-tà del XIII secolo il ms. Assisi, Biblioteca del Sacro Convento338, la pietra di fondazione delle fonti francescane, codice rite-nuto in qualche modo l’edizione ufficiale delle opere di France-sco. Non indugio ulteriormente su questo manoscritto, distilla-to, quintessenza, materializzazione del libro francescano parexcellence, su cui recentemente è intervenuto direi in modo de-finitivo Luigi Pellegrini 16. Mi limito tuttavia a esprimere lemie perplessità rispetto all’esistenza stessa oltre che alla pos-sibile persistenza di questa scrittura che, dato il lungo arcocronologico del suo impiego, dovrebbe essere stata iper-staticaed estremamente stilizzata già a partire da epoche assai alte.
Se da una parte abbiamo l’evidenza materiale dei codici, dal-l’altra sono anche le pur poche testimonianze sugli scriptores op-pure lasciate dagli scriptores a permetterci di pensare a un’attivi-
in cui prevale l’elemento vegetale sul figurativo e dove il linguaggio per imma-gini, tipico della cultura francescana ed in particolare dell’officina di Assisi coni grandi cicli illustrativi della vita di Gesù e della vita del santo, ha qui la suapiù piena concretazione ».
Cfr. E. SESTI, La miniatura ad Assisi tra Duecento e Trecento, in Assisi anno1300, a cura di S. BRUFANI - E. MENESTÒ, Assisi, 2002, pp. 435-454, alla p. 439.
16 Cfr. L. PELLEGRINI, La raccolta di testi francescani del codice assisano 338.Un manoscritto composito e miscellaneo, in Revirescunt chartae, codices, docu-menta, textus. Miscellanea in honorem fr. Caesaris Cenci ofm, a cura di A. CAC-CIOTTI - P. SELLA, I, Roma, 2002, pp. 289-340.
IL CODICE FRANCESCANO 391
tà di copia svolta in maniera continuativa presso il Sacro Con-vento. Sono infatti purtroppo rari i colophon al cui interno i fratisi sottoscrivono, ricordando il loro nome e menzionando esplicita-mente la loro appartenenza all’ordine, ma naturalmente nonmancano membri di altri ordini, domenicani ed eremitani in pri-mis, che copiano testi di autori francescani. Il frater Nycolaus dePolonia, studens in Padua, che il 17 ottobre 1353 termina la tra-scrizione di una Postilla in evangelia dominicalia dello scotistaLandolfo Caracciolo, non solo è uno straniero, ma anche unestraneo, nel senso che è un agostiniano, e il codice in questione,il ms. Padova, Biblioteca Universitaria 1462, appartenne a unsuo confratello che alla sua morte lo lasciò, solo un anno dopo, al-la biblioteca del convento eremitano padovano dei SS. Filippo eGiacomo. Osservo per inciso che l’esempio citato attesta un feno-meno diffuso anche fra i Minori, e cioè la presenza all’interno de-gli scriptoria conventuali di frati stranieri, che fra XIII e XIV se-colo sono piuttosto inglesi o francesi, e che in particolare nel cor-so del Quattrocento, provenienti invece prevalentemente dall’a-rea germanica o dai Paesi Bassi, domineranno la produzione li-braria usando un repertorio grafico inevitabilmente lontano daquello italiano 17.
Il mondo ideale non si sovrappone perfettamente al mondoreale. In quasi tutti gli altri casi i percorsi di costruzione del-l’identità del libro francescano si svolgono in circuiti spessosconosciuti, eccentrici, imprevedibili. Solo per il Santo e l’Anto-niana di Padova – e naturalmente anche per Firenze e SantaCroce, di cui purtroppo non riesco a occuparmi in questa sedeneppure in modo cursorio 18 – possiamo seguire la stessa stra-
17 Sul tema si vedano almeno i cenni offerti da chi scrive in Scriptus per me.Copisti, sottoscrizioni e scritture nei manoscritti della Biblioteca Antoniana, inMiscellanea di studi in onore di padre Giovanni Luisetto OFMConv, Padova,2003, [= Il Santo, XLIII (2003)], pp. 671-690.
18 La biblioteca del convento fiorentino di Santa Croce – molti codici dellaquale sono entrati ad esempio nel fondo Conventi Soppressi della BibliotecaNazionale Centrale di Firenze e in cui spicca la notevole presenza di classici la-
NICOLETTA GIOVÈ MARCHIOLI392
da, rimanendo all’interno di un circolo virtuoso di produzione,fruizione e conservazione di manoscritti che sono francescanida ogni punto di vista. Come in uno specchio ritroviamo rifles-sa nelle vicende del Santo la medesima storia del Sacro Con-vento: sontuosa biblioteca che fa da perno su cui poggiano atti-vità pastorale e vita dello Studium, ad alimentare le qualiopera certamente e da epoca verosimilmente precoce, dalla fi-ne del Duecento almeno, secondo molte ricostruzioni, unoscriptorium conventuale, dove teneatur continue unus scriptor,qui scribat libros necessarios et pro armario opportunos 19. In-ventari, sottoscrizioni dei copisti, note di possesso ci permetto-no di identificare alcuni codici francescani padovani, ma nondi delinearne una fisionomia unitaria. Impresa questa dispera-ta e disperante, e sostanzialmente vana, perché nei prodotti li-brari pure certamente padovani riconosciamo influenze, anchepesanti, di aree e di pratiche grafiche diverse, in particolarequelle del libro universitario bolognese o dell’ornamentazionepadana, che entrano recta via anche nei manufatti dichiarata-mente prodotti nell’ambito conventuale ma nel contempo coe-
tini e di grandi esponenti del volgare – nasce sostanzialmente addensando pro-gressivamente i libri intorno al fondo lasciato da Tedaldo della Casa nel 1406.Sulla raccolta libraria fiorentina si vedano almeno le ricostruzioni di F. MATTE-SINI, La biblioteca francescana di S. Croce e Fra Tedaldo Della Casa, in StudiFrancescani, LVII (1960), pp. 254-316, C. T. DAVIS, The Early Collection of Books ofS. Croce in Florence, in Proceedings of the American Philosophical Society, CVII(1963), pp. 399-414 e R. MANSELLI, Firenze nel Trecento: S. Croce e la culturafrancescana, in Clio, IX (1973), pp. 325-342 e Due biblioteche di “Studia” mino-ritici: Santa Croce di Firenze e il Santo di Padova, in Le scuole degli ordinimendicanti cit., pp. 355-371.
19 Citiamo il dettato di una costituzione decretata dal capitolo provinciale diTreviso del 1290, ricordata da A. G. LITTLE, Statuta provincialia ProvinciaeFranciae et Marchiae Tervisinae (sec. XIII), in Archivum Franciscanum Histori-cum, VII (1914), pp. 447-465, alla p. 456. Per ricostruire la straordinaria storiadell’Antoniana rimandiamo in particolare alla sintesi di C. CASSANDRO, Il fondomanoscritto, in I manoscritti datati della provincia di Vicenza e della BibliotecaAntoniana di Padova cit., pp. 53-57, con ulteriore bibliografia.
IL CODICE FRANCESCANO 393
renti con i modelli trainanti tardomedioevali, specie con quellidel codice universitario padovano. Allora come classificare, semai avesse senso farlo, un libro di un autore minoritico e ap-partenente a una biblioteca minoritica, ma certamente di pro-duzione non conventuale come il codice Padova, Biblioteca An-toniana 336, con la Postilla super Matthaeum di Pietro di Gio-vanni Olivi, lussuoso libro membranaceo di non piccolo forma-to (mm. 312 × 235), terminato nel novembre del 1344 e donato,con molti altri, il 26 settembre 1352 ai frati padovani dal ve-scovo di Padova Ildebrandino Conti? Colpisce nella sottoscri-zione del copista, che usa una rotunda, l’invocazione, peraltronon infrequente, in cui si citano il dulcissimus Ihesus, l’humil-lima mater eius e il beatissimus Franciscus 20.
Se ora usciamo da questi universi conclusi ed entriamo invecenella irregolare realtà, confusa e aggrovigliata, dei manoscritticlassificabili come francescani, incontriamo situazioni assai diffe-renti, in alcuni casi segnate da un denominatore comune, in altrirefrattarie a qualsiasi tentativo di assimilazione.
I libri liturgici, come le bibbie d’altra parte, sono troppo au-tonomamente connotati per pensare di poterli modificare an-che solo superficialmente, nel tentativo di adattarli al luogo diproduzione o alla committenza. Proprio la loro precocissimapresenza negli insediamenti dei Minori, prima ancora che nel-le loro biblioteche, rese inevitabile l’imitazione ricercata o l’as-similazione più o meno consapevole dei modelli codicologicicontemporanei, senza una loro originale rielaborazione. Bre-viari e messali redatti per la liturgia francescana secondo l’usodella Curia romana, e indispensabili per l’attività dei frati Mi-nori, come prevedeva la Regula bullata, già nel 1227, nel Ca-pitolo generale di Assisi, vennero fatti circolare quali exempla-ria nelle province francescane, e precoci testimoni del brevia-
20 Cfr. I manoscritti datati della provincia di Vicenza e della Biblioteca Anto-niana di Padova cit., pp. 72-73 nr. 64.
NICOLETTA GIOVÈ MARCHIOLI394
rium ordinis fratrum Minorum secundum consuetudinem sanc-tae Romanae Ecclesiae sono stati riconosciuti ad esempio neimss. Assisi, Biblioteca del Sacro Convento 693, 694 e 696, al-meno in alcune parti proprio degli inizi del XIII secolo, in cuihanno operato le medesime mani 21. Valutando i caratteristrutturali elaborati per i libri liturgici, emerge che coesistonoalmeno due tipologie librarie differenti e rispondenti a diffe-renti necessità, entrambe concepite e realizzate per la vitaconventuale e per l’attività pastorale. Così da un lato il libroliturgico francescano assume l’aspetto di un codice di grandidimensioni, di elevato livello grafico e codicologico, spesso conampi cicli decorativi figurati e con sezioni musicali, destinatoa un uso collettivo; dall’altro si hanno breviari che spesso sonodi modesto formato, portatili, da tasca, da bisaccia, adatti adaccompagnare i singoli frati nel loro cammino e nel loro opera-to. Fra i tanti testimoni di breviari francescani ricordo il cosid-detto “breviario di san Francesco” 22. Si tratta, e non sarà per
21 Entrare nel merito di questi tre codici, tutti in connessione fra di loro, dal-le dimensioni talmente oscillanti che non ha neppure senso parlare di formato“medio”, che ben poco condividono oltre allo schema di rigatura a due colonne,tanto meno la decorazione (talora solo in rosso, talora in rosso e azzurro), chevanno studiati come un unicum e nel complesso come un cantiere aperto, nonsolo è inutilmente rischioso, ma sostanzialmente inutile, soprattutto dati glispazi necessariamente ridotti di questa sede. La ricostruzione dei modi, deitempi, delle fasi secondo cui si sono stratificati gli interventi delle tante mani,sempre le medesime, che sono passate da un codice all’altro, tutte di ridottissi-mo modulo, tutte duecentesche ma non sempre proto-duecentesche, librarie opiuttosto corsiveggianti o cancelleresche, italiane ma anche non italiane, piut-tosto francesi, richiederebbe tempi più distesi e riflessioni ben articolate. Ci li-mitiamo pertanto a rimandare alle pure accurate ricostruzioni di G. ABATE, Ilprimitivo breviario francescano (1224-1227), in Miscellanea Francescana, LX(1960), pp. 47-240, in attesa di poter prima o poi ritornare sul tema.
22 Il codice, di piccole dimensioni, conservato nella cappella del Crocifissodella chiesa di S. Chiara ad Assisi, è stato descritto e studiato con attenzione inparticolare da S. VAN DIJK, The breviary of saint Francis, in Franciscan Studies,IX (1949), pp. 13-40 e da BARTOLI LANGELI, Autografi di frate Francesco e di frateLeone cit., pp. 82-89, oltre che, in tempi assai recenti, soprattutto secondo pro-
IL CODICE FRANCESCANO 395
noi una novità, di un codice composito e miscellaneo, di piccoledimensioni (mm. 170 × 120) ma con un cospicuo numero di fo-gli (oltre trecento), che raccoglie più sezioni, fra cui un brevia-rio, un salterio e un vangelo, che è l’esito di mani collocabilitutte agli inizi del XIII secolo, di comune provenienza italiana,meglio ancora centro-italiana e che sappiamo aver costituitoda subito uno dei tesori librari in dotazione al monastero cla-riano. Acquistato da Francesco per i socii Leone e Angelo, se-condo quanto racconta una scritta memoriale e dedicatoria alf. Iv di mano di Leone, da quest’ultimo completato e assembla-to nell’attuale composizione, secondo molti e concordi pareriesso venne donato forse fra il 1257 e il 1258 proprio da Leonee Angelo alla badessa di S. Chiara, Benedetta, quando le cla-risse si trasferirono da S. Damiano nel nuovo monastero. For-se più reliquia da custodire che libro-strumento da utilizzareconcretamente, fu tuttavia effettivamente impiegato, almenoper qualche tempo e in qualche occasione.
Sul fronte opposto, e non solo da un punto di vista tempo-rale, dobbiamo collocare il ms. Siena, Biblioteca Comunale de-gli Intronati, F.VII.3, databile fra la fine del XIV e gli inizi delXV secolo, appartenuto all’Opera del Duomo, breviario france-scano d’apparato, dal formato medio-grande (mm. 290 × 210),notevole soprattutto per l’ornamentazione, che si snoda fra ini-
spettive liturgiche e testuali, da P. MESSA, Un testimone dell’evoluzione liturgicadella fraternitas francescana primitiva: il Breviarium sancti Francisci, in Revi-rescunt chartae, codices, documenta, textus cit., I, pp. 5-141 e A. CICERI, HocEvangelistare fecit scribi, ibid., II, pp. 707-854. Fra i tanti testimoni di breviarifrancescani, si deve almeno ricordare quello che, tradizionalmente, si ritieneappartenuto a santa Chiara, codice certamente prodotto nell’area assisana.Conservato presso S. Damiano, databile al secondo quarto del secolo XIII, se-condo una tradizione oramai smentita si riteneva copiato anch’esso da Leoneper le clarisse di Assisi, mentre è più probabile che il codice sia appartenuto aifrati di S. Damiano e alle clarisse sia stato donato prima del loro trasferimentoin città. Cfr. S. VAN DIJK, The breviary of saint Clare, in Franciscan Studies, VIII(1948), pp. 25-46 e 351-387 e The breviary of saint Clare. A correction, ibid., IX(1949), pp. 10-12.
NICOLETTA GIOVÈ MARCHIOLI396
ziali istoriate e figurate con oro. Una descrizione, questa, chesi attaglia perfettamente anche a un altro breviario francesca-no, il ms. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Strozzi 12,ancora più interessante e importante del precedente, se voglia-mo, perché rappresenta, da un punto di vista cronologico, unideale momento di avvio della produzione dei breviari: dellaseconda metà del Duecento, in una bellissima rotunda, decisa-mente più piccolo del precedente (mm. 213 × 158, che tuttavianon sono certo le dimensioni originali, essendo stato il codicemolto rifilato), è un elegante libro solo relativamente portatile,dati i quasi seicento fogli della sua compagine. Al medesimomomento temporale appartiene anche un breviario bello e im-portante, di poco più grande (misura mm. 255 × 190), il ms.Brescia, Biblioteca Queriniana A-V-24, in rotunda centro-ita-liana, miscellaneo e composito, che si pone anch’esso come mo-dello non solo in assoluto per la decorazione dei breviari, manello specifico per la sottolineatura iconografica dell’apparte-nenza francescana del libro, costellato com’è di raffigurazionitanto dei santi dell’ordine, quanto dei suo membri 23. La ric-chezza decorativa che promana anche da libri non di grandeformato è attestata in moltissimi casi per tutto il Trecento: si-gnificativo e non unico esempio possibile è il ms. Assisi, Biblio-teca del Sacro Convento 265, notevole breviario di mm. 296 ×203, un tempo conservato nella sacrestia della basilica, scrittoin rotunda nel 1322 – come attesta la sottoscrizione del copi-sta al f. 171r -, nel cui apparato decorativo, di area umbra, ric-chissimo e articolato, pieno di oro e di colori ma purtroppo inparte asportato, appare Francesco. Di segno contrario, più pic-colo, più sobrio, insomma idealmente più consono allo spirito
23 Sul quale va segnalato lo specifico studio di R. SEMIZZI, Un breviario fran-cescano miniato tardodugentesco alla Biblioteca Queriniana di Brescia: presen-tazione iconografica del ms. A-V-24, in Il codice miniato. Rapporti tra codice, te-sto e figurazione. Atti del III Congresso di storia della miniatura, a cura di M.CECCANTI - M. C. CASTELLI, Firenze, 1992, pp. 129-145.
IL CODICE FRANCESCANO 397
francescano, il messale Siena, Biblioteca Comunale degli In-tronati, F.XI.8, della prima metà del Trecento, un tempo con-servato nel convento senese degli Osservanti di S. Bernardinodella Capriola, partito in due colonne, in cui l’ornamentazionesi limita alle iniziali filigranate e alle rubriche in rosso e allemaiuscole rilevate anch’esse di rosso.
Per dare una qualche coerenza a questa ricognizione all’in-terno dei libri francescani, è opportuno dirigersi là dove le te-stimonianze si fanno più fitte, consentendoci di indicare lineedi tendenza e di ricostruire modi e tempi secondo cui si sonoprodotti i libri dei primi due secoli del Francescanesimo. Nellafase iniziale di questa ricerca, quando indagammo sui codicidel volgare, avevamo raggruppato i manoscritti censiti per ti-pologie testuali, identificando alcuni nuclei tematici forti e in-dividuandone gli aspetti di confezione di maggiore rilievo. Ol-tre ai laudari, in particolare alle raccolte delle laude di tradi-zione iacoponica, ci eravamo orientati verso i volgarizzamentidella Scala Paradisi e i Fioretti: ho allargato il campione, os-servando i codici con testi di Giovanni Climaco anche nellaversione in latino e i sermonari. Confermano poi il loro rilievospecifico tanto i manoscritti concepiti come raccolta di più te-sti, quanto i compositi, che raccolgono anche ab antiquo piùsezioni autonome. Non solo. Nel medesimo libro possiamo tro-vare contaminazioni e intersecazioni di queste macrocategorie,di queste divisioni forzate. Così, ad esempio, in moltissimi casile opere indagate sono conservate in contenitori testuali comemiscellanee e compositi, che in qualche modo amplificano emoltiplicano le caratteristiche formali osservate. Nella somma-ria esemplificazione in cui va ricondotta questa variegata real-tà si confermano molte delle osservazioni cui eravamo giuntianni fa e che non hanno perso il loro valore di fondo: i lorocontorni sono però divenuti un po’ più sfumati e complicati.
Un gruppo di codici in cui alla tipologia contenutistica cor-risponde in linea diretta una caratterizzazione formale piutto-sto tipizzata è dato dai testimoni della Scala Paradisi di Gio-
NICOLETTA GIOVÈ MARCHIOLI398
vanni Climaco, sia nella versione latina di Angelo Clareno, sianel volgarizzamento di Gentile da Foligno. Abbiamo registratoun’occorrenza assai alta di copie della Scala Paradisi all’inter-no dei manoscritti censiti, e la loro confezione sostanzialmenteomogenea potrebbe far supporre che la loro origine sia solo osoprattutto francescana. Testimoni tutti sincroni, collocabilinella seconda metà del Trecento, membranacei ma anche car-tacei, sono di formato medio: formato certo non proprio di unlibro da tasca, ma di un volume comunque maneggevole, di li-vello grafico medio, alla cui base sta un progetto complessiva-mente piuttosto semplice, che contempla l’utilizzo di scritturetanto usuali quanto, soprattutto, librarie, anche di mani pro-fessionali, ma sempre più o meno semplificate, e un apparatodecorativo che si riassume nelle sole iniziali semplici in rosso.Eccezione in negativo a questa vischiosa tendenza può essereil ms. Pistoia, Biblioteca Comunale Forteguerriana, D. 304,della seconda metà del Trecento, appartenuto al convento pi-stoiese di San Francesco a Giaccherino: libretto membranaceodi dimensioni davvero ridotte (appena mm. 146 × 100), coniu-ga innegabili leggibilità e maneggevolezza con una scritturacorsiveggiante e un assetto complessivo essenziale; sono rigatesolo la prima e l’ultima rettrice e la mise-en-texte è colorata inesclusivo dal rosso delle iniziali semplici, delle rubriche, deisegni di paragrafo e dei tocchi di colore sulle maiuscole 24.Spesso si tratta di codici confezionati con materiali che si po-trebbero definire “di recupero”, secondo un’abitudine che si ri-trova anche in altri libri francescani. Nel caso del ms. Firenze,Biblioteca Riccardiana 1351, miscellaneo, siamo ad esempio difronte a un codice tutto palinsesto, con i fascicoli composti dafogli che arrivano da registri notarili due-trecenteschi e damanoscritti di epoche diverse. Si tratta di una miscellanea in
24 Il ms. contiene la Scala Paradisi con le glosse e i testi introduttivi e con-clusivi che tradizionalmente accompagnano l’opera in questione. Cfr. I mano-scritti medievali della provincia di Pistoia cit., p. 104 nr. 221.
IL CODICE FRANCESCANO 399
cui accanto al volgarizzamento di Gentile da Foligno si trova-no anche brevi testi di Domenico Cavalca. L’assetto complessi-vo del libro sembra aspirare a una qualche eleganza formaleche non raggiungerà: il formato è medio (mm. 255 × 187), mal’ornamentazione, tutta in rosso (dalle iniziali semplici alle ru-briche, ai titoli correnti, sino ai segni di paragrafo, alle mani-culae e alle maiuscole toccate di colore), si deve all’interventodi un decoratore incerto, e neppure la scrittura riesce a offrireun contributo positivo. È infatti una libraria chiara ma sem-plificata e irregolare quella con cui, nel 1397, termina l’operadi trascrizione non un semplice scriptor bensì verosimilmentel’autore – “gran peccatore”, come lui stesso dice di sé – di unodei componimenti presenti nel codice, che di fatto è anche unautografo 25. Infine il ms. Lucca, Biblioteca Statale 1282, dellametà del sec. XIV, che contiene il volgarizzamento di Gentileda Foligno, cartaceo, di medio formato (mm. 223 × 144), rubri-cato, ci attira in un tranello. Ha tutta l’apparenza di un codicefrancescano e in effetti proviene dal già menzionato conventosenese di S. Bernardino, nel quale tuttavia entrò solo un seco-lo dopo la sua confezione, dono della vedova di un maniscalco,un tale Antonio di Stirpi, come attesta una nota al f. 175v:Questo libro chiamato Climacho è ad uso di frati di sanctoFranciescho detti della Capriuola fuori di Siena il quale ci dèper l’amore di Dio la donna che fu d’Antonio di Stirpi mani-scalco per l’anima di detto Antonio et con conditione che ’l det-to libro non si dovesse partire di detto luogho. Nell’anno del Si-gnore 1447.
Fra i testimoni dell’opera di Giovanni Climaco non ci sonoclamorose note dissonanti. A un autore e a un testo corrispon-de una mise-en-page coerentemente e diligentemente ripetuta.Questa perfetta compatibilità o interconnessione grafico-codi-cologico-testuale non vale tuttavia in altri casi. Non vale in
25 Cfr. I manoscritti datati della Biblioteca Riccardiana di Firenze. II cit.,pp. 36-37 nr. 66.
NICOLETTA GIOVÈ MARCHIOLI400
particolare per Bonaventura da Bagnoregio. La ricchezza e lapoliedricità tematica delle opere del doctor Seraphicus si rivol-gono evidentemente a tipologie di lettori molto distanti, a se-conda che si tratti dei suoi testi squisitamente teologici o piut-tosto di quelli in cui predomina l’intento dottrinale e di conso-lidamento anche istituzionale dell’ordine. Così i codici bona-venturiani non sentono di dover rispettare alcun vincolo idealecon il mondo francescano, e sfuggono alla panìa di schemi pre-figurati per adattarsi più opportunamente alle relative, singolestrutture di riferimento elaborate in quegli stessi anni digrande fervore editoriale per le diverse tipologie contenutisti-che e dunque librarie. Il ms. Livorno, Biblioteca dei Cappucci-ni, Ar. 8. 6, del secondo quarto del XIV secolo, con la Legendamaior accompagnata dalla Legenda sanctae Clarae, è un per-fetto esempio di codice pensato certamente per essere essen-ziale, leggibile, trasportabile, senza pretese, a due colonne coniniziali filigranate e rubriche, scritto in una bella rotunda 26. Ilms. Padova, Biblioteca Antoniana 112 rappresenta una decli-nazione alta, se non ancora eccelsa, della medesima opera, digran livello comunque, quasi una copia ufficiale da esibire enon usare, e comunque certo non molto usata. Di grande for-mato (misura infatti mm. 390 × 281), in una strepitosa textua-lis, veramente vel picta quam scripta (e proprio per questa suaeccezionalità esecutiva difficile da datare con certezza), pre-senta d’altro canto alcuni elementi, anomali, di semplicità (co-me una decorazione in rosso e azzurro) e una pergamena nonmolto lavorata. E infine arriviamo al massimo, al ms. Roma,Biblioteca Nazionale Centrale, Vitt. Em. 411, della prima me-tà del ’300, in cui si fondono in un prodotto spettacolare unatextualis estremamente canonizzata, un assetto codicologico diottimo livello e soprattutto un apparato decorativo di impres-sionante bellezza e di forte impatto, di area forse romagnola,
26 Cfr. I manoscritti medievali delle province di Grosseto, Livorno e MassaCarrara cit., p. 63 nr. 52.
IL CODICE FRANCESCANO 401
forse più precisamente riminese, che prevede, all’inizio di ognicapitolo dell’opera, un fregio vegetale con iniziale con oro euna miniatura che illustra gli episodi della vita del santo, sufondo dorato. Ricordo per inciso che la raffigurazione di Fran-cesco al f. 32r è accompagnata da un riquadro più piccolo, incui compare l’immagine di una donna in ginocchio a manigiunte, che potrebbe essere la committente del codice 27. Se poidal latino passiamo al volgare, cioè al volgarizzamento dellastessa Legenda maior, possiamo passare rapidamente a un ti-po di libro per molto tempo ancorato ai testi di lingua, come cimostra il ms. Firenze, Biblioteca Riccardiana 1287, cartaceo,in-folio, senza rigatura, o meglio con solo le righe di giustifica-zione tracciate, con una decorazione in rosso 28. C’è un proble-ma ulteriore. È uno dei tanti codici, che abbiamo incontrato,che cambia fisionomia e si può leggere in modo diverso, taloraopposto, a seconda della prospettiva, dell’approccio che si sce-glie. Si tratta tra l’altro di una miscellanea: accanto a Bona-ventura troviamo un’opera di Agnolo Torrini e una di Simonedi Dino Brunaccini. E proprio a lui, lanaiolo fiorentino del po-polo di Sancto Romeo, morto nel 1408, che fu anche ambascia-tore a Bologna tra il 1386 e il 1387, si deve la trascrizione delcodice, che sottoscrive il 10 febbraio 1394, copiandolo per sé eper le sue erede del libro nello armario dello studio del chon-vento di frati Minori di Firenze. Abbiamo dunque a che farecon un exemplar francescano per uno scriptor laico, devoto malaico, colto, dai molteplici interessi 29, che dunque con disinvol-
27 Cfr. I santi patroni. Modelli di santità, culti e patronati in Occidente, a cu-ra di C. LEONARDI - A. DEGL’INNOCENTI, [Roma], 1999, pp. 262-263 nr. 67.
28 Cfr. I manoscritti datati della Biblioteca Riccardiana di Firenze. II cit., p.29 nr. 50.
29 Tanto che nei medesimi anni – oltre al ms. Firenze, Biblioteca Riccardia-na 1650, che contiene fra l’altro il volgarizzamento di Sallustio ad opera di Bar-tolomeo di San Concordio – copia in una textualis semplificata, ancora una vol-ta per sé e per le sue erede, la Commedia dantesca accompagnata da più com-menti. Si tratta dell’attuale ms. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana,
NICOLETTA GIOVÈ MARCHIOLI402
tura legge e scrive opere genericamente edificanti ma di evi-dente diverso spessore letterario e che usa una singolare, rigi-da, verticalizzata libraria frutto di contaminazioni fra la te-stuale e la cancelleresca, e che pure in contatto con l’ambientefrancescano opera assolutamente sganciato da una committen-za o un’utenza francescana. Soprattutto nel volgare troviamo
« una capillare produzione privata di testi [...] di argomentomorale, ascetico, parenetico, nei quali ricorrono con frequenzavolgarizzamenti anche di testi [... francescani]. La presenza diautori francescani, o di testi comunque diffusi nei conventi deiMinori, presso copisti per passione che scrivono in volgare as-sume ovviamente cospicuo rilievo per coloro che intendano in-vestigare la pietà popolare, la storia della predicazione e dellacura di anime, ma non individua certo una produzione di libridi interesse francescano intrinseca all’Ordine: in tutti questivolumi si deve riconoscere l’influenza di un più generale e dif-fuso modello di manoscritto in volgare » 30.
A questa produzione, così riconoscibile e non marginale,possiamo ascrivere, per fare un altro esempio, di segno diversoe di livello meno colto, il ms. Firenze, Biblioteca NazionaleCentrale, Palatino 144, miscellanea interamente francescanain cui spiccano i Fioretti, e che sembra esibire i caratteri do-minanti di questi libri, dal formato ridotto (in-8°) al supportocartaceo, alla mancanza di righe tracciate e di decorazione, al-la scrittura – una rigida mercantesca estremamente verticaliz-zata –, allo scriptor, Amaretto, che scrive nel 1396 e scandisce
Strozzi 161, che presenta, pur nella totale diversità testuale, forti analogie for-mali con il codice Riccardiano, dalla scelta del supporto cartaceo, alle dimensio-ni molto simili (mm. 275 × 196 rispetto a 278 × 214), alla mancanza di rigatura,all’uso della decorazione in rosso. Cfr. M. BOSCHI ROTIROTI, Codicologia trecente-sca della Commedia. Entro e oltre l’antica vulgata, Roma, 2004, p. 123 nr. 111.
30 Cfr. GIOVÈ - ZAMPONI, Manoscritti in volgare cit., pp. 314-316.
IL CODICE FRANCESCANO 403
lo scorrere del tempo indicando il santo che ricorreva in un da-to giorno, ma che tentenna fortemente con l’ortografia 31.
Il gioco di accostamenti binari, o addirittura di più scelte di-varicate per lo stesso autore, ma anche per la stessa opera, puòcontinuare. Il ms. Padova, Biblioteca Universitaria 1098, con l’Inprimum Sententiarum è un tipico libro universitario trecentescoitaliano in testuale, di grande formato (mm. 307 × 210), membra-naceo, a due colonne, con un ricco e complesso sistema decorativoche contempla anche l’oro. Un tipico libro universitario che è pe-rò anche un libro francescano, e che a un convento francescanoappartenne, anzi a due: ai Conventuali di Belluno e prima alconvento padovano di S. Francesco Grande. E tutti libri di stu-dio, libri seriali, perfettamente sovrapponibili nella loro ligia ade-renza ai modelli inflessibili e ben rodati del codice universitario,con qualche lieve scarto dovuto solo alla variazione delle mani, avolte non italiane, e della mise-en-page che, pur sempre a due co-lonne, organizza o meno lo spazio marginale per le eventualiglosse ma anche per i titoli correnti, cronologicamente tutti collo-cabili fra l’ultimo quarto del XIII e il primo del XIV secolo sono itanti manoscritti che contengono il commento di Bonaventura al-le Sentenze. Mi riferisco ad esempio ai mss. Padova, BibliotecaAntoniana 120 (cfr. Tavola II), 123, 124, 125 con l’In primum, 121con l’In secundum, 119 e 129 con l’In tertium e infine 130 e 131con l’In quartum. Si tratta di libri talmente simili che aderisconotutti alla descrizione dell’item con cui si registrano questi testinell’inventario della biblioteca padovana del 1396/7, tanto da nonconsentire un’identificazione sicura, ma tutti certamente tra XIVe XV secolo entrarono al Santo, come attestano note di possesso e
31 Cfr. I manoscritti datati del Fondo Palatino cit., p. 27 nr. 38. Amaretto,anzi Amaretto Mannelli, per completezza, non è proprio un Carneade, e si pos-sono ricostruire tanto la sua attività grafica che i suoi interessi culturali: cfr. A.PETRUCCI, Storia e geografia delle culture scritte (dal secolo XI al secolo XVIII),in Letteratura italiana, a c. di A. ASOR ROSA, Storia e geografia, II/2. L’età mo-derna, Torino, 1988, pp. 1195-1292, alla p. 1235.
NICOLETTA GIOVÈ MARCHIOLI404
di lettura. E potrebbe essere scambiato per uno dei codici sopraricordati il ms. Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv.Soppr. C.VI.209, commento dell’In primum che un copista cheusa una minuta testuale – ma non per il colophon, per il qualeimpiega invece una cancelleresca – termina il 24 settembre1285 e che è citato nell’inventario quattrocentesco della biblio-teca fiorentina di Santa Croce 32. Faccio ancora un ultimoesempio, di un caso del tutto antitetico, quello del ms. Trento,Biblioteca Comunale 1788, composito ab antiquo, con due se-zioni coeve della seconda metà del XIV secolo 33. Nella secondasezione troviamo il Lignum Vitae, accompagnato dal Canti-cum. Lo scenario è cambiato rapidamente: abbiamo un libro dimedio formato, in cui accanto alla decorazione in rosso trovia-mo una pagina illustrata a penna raffigurante il Lignum Vi-tae, scritto per manus Iohannis de Monte, il quale usa unafluida corsiva non italiana. Muta il testo, muta il pubblico,muta il libro 34.
Arrivo ai sermonari, una tipologia testuale, e dunque libraria,che assai frequentemente compare nelle raccolte francescane, eche altrettanto legittimamente può servire da cartina di tornaso-le per rilevare la varietà di esiti del libro francescano. Si tratta di
32 Cfr. I manoscritti datati del Fondo Conventi Soppressi cit., pp. 74-75 nr. 59.33 Cfr. I manoscritti datati della provincia di Trento cit., pp. 69-70 nr. 75.34 Ho purtroppo trascurato la disamina dei modi in cui si organizzano altri
testi bonaventuriani, come, ad esempio, l’Arbor crucis o il Breviloquium. Se lipossiamo osservare individualmente è altrettanto interessante osservarli quan-do li troviamo accostati, come avviene nel caso del ms. Assisi, Biblioteca del Sa-cro Convento 95, composito, con una prima sezione che contiene i Dialogi diGregorio Magno, mentre nella seconda si succedono appunto le due opere sopracitate. Si tratta di un bel libro, di mm. 303 x 215, dalla pergamena sottile e benlavorata, in cui si stempera la differenza fra lato carne e lato pelo, in una nitidaBononiensis di piccolo modulo, ove spicca il rapporto fra bianco e nero, date lacompattezza dello specchio, l’ampiezza dei margini e la bianchezza della perga-mena. L’analisi della miniatura lo identifica come un prodotto di scuola umbra,databile agli anni intorno al 1280-1290.
IL CODICE FRANCESCANO 405
un filone testuale in cui predomina, anzi domina il latino, essen-do la predicazione volgare francescana due-trecentesca ben pocoattestata nelle fonti manoscritte coeve. Non posso d’altra partenon fare mie alcune conclusioni cui è giunta Letizia Pellegrininel suo studio sui manoscritti dei predicatori, in particolarequando parla
« di una gamma di possibilità di resa grafica e codicologica deisermonari, che comprend[e] esiti diametralmente opposti. Dalpunto di vista estrinseco, infatti, si rilevano due estremi tipologi-ci dei sermonari: da un lato codici redatti da unica mano, in buo-na lictera textualis, su due colonne, con iniziale miniata, segni diparagrafo alternati in rosso e azzurro, rubriche in rosso, maiu-scole toccate di giallo [...], vergati su pergamena di buona fattura[...]; dall’altro codici ‘in bianco e nero’, privi di rubriche e di qual-siasi forma costante di organizzazione interna dello scritto sullapagina, [...] redatti in scritture tendenzialmente corsive » 35.
Quello dei sermonari francescani è tuttavia un intreccio diesperienze non completamente speculari a quelle domenicane,molto ben conosciute e accuratamente ricostruite. Esperienzeperaltro complesse, e, in questo caso sì, fortemente legate agliinsediamenti minoritici, essendo le raccolte di sermoni più chemai funzionali alla concreta, quotidiana attività di predicazio-ne dei frati. I sondaggi effettuati all’interno di un materialecosì ricco e mosso, segnato in qualche modo da una gradationella sua elaborazione e nel contempo da una mancanza, o dauna difficoltà, di una sua riconoscibilità immediata, danno re-pentinamente il senso di una varietà di esiti formali, che nonsono connessi con l’autore, i temi delle raccolte o la loro impor-tanza, ma che forse subordinano la raffinatezza esecutiva alla
35 Cfr. L. PELLEGRINI, I manoscritti dei Predicatori. I Domenicani dell’Italiamediana e i codici della loro predicazione (secc. XIII-XV), Roma, 1999, pp.226-227.
NICOLETTA GIOVÈ MARCHIOLI406
leggibilità della pagina e alla maneggevolezza del libro. Nédobbiamo dimenticare che sulla redazione materiale dei ser-monari influisce certamente la prospettiva, o la valutazione,della futura diffusione di quel testo, di volta in volta limitato aun uso tutto e solo individuale e privato o destinato piuttostoa una circolazione ampia e a una consultazione sistematica.Se, innegabilmente, abbiamo spesso a che fare con prodotti dilivello medio, quando non proprio basso (ed è questo invece untratto fortemente unificante), i sermonari francescani non rie-scono a sovrapporsi indistintamente, differenti come sono perle loro dimensioni e per le loro scritture, e nel contempo rias-sumono molti dei caratteri che, il più delle volte singolarmen-te, si contraddistinguono o si interpretano come francescani.
Sfogliamo i sermoni di s. Antonio, a partire dal ms. Pado-va, Biblioteca Antoniana 720, il cosiddetto codice del tesoro 36.Il formato notevole (quasi 330 × 240 mm.) lo identifica comeun codice evidentemente destinato alla consultazione in loco, enel contempo nato dal tentativo di dare consistenza alle volati-li parole del santo, di rispondere alla volontà non tanto di co-struire un monumento, quanto di fissare definitivamente e ra-pidamente il ricordo, di testimoniare concretamente il messag-gio di Antonio, e questo ne spiega i caratteri. Ci appare comeun libro solido, funzionale, mai elegante, che una tradizionevuole essere stato utilizzato e annotato dal santo stesso e chepiù di ogni altro caso mi sembra plausibile definire conventua-le, nel senso che si tratta del risultato di un interessante e ben
36 Per una descrizione del codice e per l’edizione della cosiddetta “Miscella-nea”, cioè dei trentotto sermoni extravagantes e dei tanti brani frammentaricontenuti ai ff. 182rA-205vB, cioè negli ultimi tre fascicoli del codice, si veda lamonografia di L. FRASSON - L. GAFFURI - C. PASSARIN, In nome di Antonio: la “Mi-scellanea” del codice del Tesoro (XIII in.) della Biblioteca Antoniana di Padova.Studio ed edizione critica, Padova, 1996. I sermoni domenicali e festivi conser-vati nei primi ventitre fascicoli del manoscritto sono stati editi in S. Antonii Pa-tavini Sermones dominicales et festivi, a cura di B. COSTA - L. FRASSON - G. LUI-SETTO - P. MARANGON, I-III, Padova, 1979.
IL CODICE FRANCESCANO 407
rodato lavoro collettivo, in cui probabilmente cooperarono copi-sti diversi, che copiarono, con mani competenti, porzioni di te-sto in una successione non chiaramente regolata. Se questaipotesi di un lavoro collettivo non si può applicare alla raccoltadi Sermones dominicales di Luca da Bitonto conservata nelms. Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Conv. Soppr.C.VII.236, elegante codice membranaceo di medio formato de-gli inizi del Trecento, che si deve alla ancor più elegante te-stuale di un magister Fortis, che appartenne da subito a SantaCroce – come attestano le note di possesso, oltre che l’inventa-rio quattrocentesco della biblioteca francescana fiorentina – eche rappresenta la versione raffinata di questo genere testua-le 37, le medesime considerazioni fatte per il codice del tesorosi possono riproporre invece anche per altri due testimoni deisermoni antoniani, i mss. Padova, Biblioteca del Seminario ve-scovile di Padova 1120 e 1122, databili entrambi alla metà delsec. XIII 38. Non parlo del secondo, che contiene i Sermones do-minicales e festivi, e che apparteneva all’armarium del con-vento bellunese di S. Pietro, mentre del primo sottolineo cheabbiamo ancora a che fare con un composito, in cui le quattrosezioni in cui si alternano i Sermones domenicales e quelli dediversis presentano analogia nelle dimensioni (che non supera-no i 208 × 150 mm.) e nella mise-en-page, ma scelte autonomenella decorazione – che prevede iniziali filigranate o piuttostosemplici – e soprattutto nelle mani, mai troppo vicine al cano-ne più rigido della libraria, orientate talora verso la cancelle-resca e che a volte tradiscono un’origine non italiana. Questemodalità costruttive, peculiari e cronologicamente trasversali,nelle quali mi sembra davvero di vedere un forte nesso conun’attività scrittoria tutta interna agli insediamenti conven-
37 Cfr. I manoscritti datati del Fondo Conventi Soppressi cit., pp. 128-129nr. 160.
38 Cfr. I manoscritti della Biblioteca del Seminario vescovile di Padova cit.,rispettivamente p. 102 nr. 222 e p. 103 nr. 224.
NICOLETTA GIOVÈ MARCHIOLI408
tuali, si ritrovano regolarmente in molti altri sermonari con-servati presso la Biblioteca Antoniana: nella serie dei sermonidi Bonaventura d’Iseo, gli attuali mss. 445 (cfr. Tavola III), 446,447, del primo quarto del Trecento con ridotte dimensioni edecorazione essenziale, soprattutto segnati dall’affastellarsi dimani anche non italiane e di fasi compositive, oppure nel com-plesso codice 527, composito ab antiquo con sermoni festivi,fra cui spiccano quelli dedicati a s. Antonio, che letteralmentesi intersecano per una complessa successione delle singole se-zioni, profondamente differenti ma della medesima mano, unamossa e rotondeggiante testuale nord-italiana di pieno Trecen-to. Insomma, l’intrecciarsi di mani e i caratteri dell’assetto de-corativo, che muta, si semplifica, si riduce sino a scomparire,sembrano caratterizzare la produzione, anzi meglio una cospi-cua parte della produzione dei sermonari francescani, che ri-propongono, quasi fossero degli stilemi significativi, questi ele-menti, accanto a quello delle dimensioni sempre piuttosto ri-dotte, ed è l’evidenza delle fonti stesse a convincerci della bon-tà di questa ricostruzione. I sondaggi effettuati ripropongonoinfatti con convincente frequenza l’immagine di un sermonarioquale il ms. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana,Vat. lat. 9821, con i sermoni domenicali e de diversis di s. An-tonio, della prima metà del Duecento, di mm. 184 × 131, in cuia una minutissima libraria nord-italiana (nella quale si sento-no, consapevole elemento di ricercatezza voluta, echi cancelle-reschi) segue una mano simile, solo un po’ più pesante e dal-l’inchiostro più chiaro e non bruno brillante, e in cui la rodataornamentazione in rosso e azzurro progressivamente viene amancare. Le due mani hanno collaborato alla confezione di unprodotto certamente unitario, ma la loro scansione è segnataanche fisicamente, dato che il passaggio da una raccolta te-stuale all’altra è una vera e propria cesura materiale segnala-ta da un foglio bianco e dal passaggio a un fascicolo nuovo.
Molti dei codici esaminati sono anche delle miscellanee. Al-l’interno del materiale censito si conferma in modo imperioso e
IL CODICE FRANCESCANO 409
del tutto trasversale rispetto alla lingua dei testi la presenzadi libri miscellanei, come anche di compositi, talora ab anti-quo. Si tratta di manoscritti che mescolano con disinvolturatesti in latino e in volgare, spesso assolutamente incoerenti fradi loro, di lunghezza diseguale, non sempre riferibili all’espe-rienza francescana: per esempio Bernardo, ma anche Bonaven-tura e Guglielmo di Saint-Thierry occupano, accanto ad altriautori, anche anonimi, il ms. Perugia, Biblioteca ComunaleAugusta 280, codice membranaceo terminato il 21 aprile 1301,appartenuto al convento perugino di S. Francesco del Monte,di formato medio e caratteri modesti, in parte stemperati dallaraffigurazione della Crocifissione, a piena pagina e arricchitadalla presenza dell’oro 39.
All’interno del nostro corpus la presenza di codici con unapluralità di testi è piuttosto netta, tanto da non doversi adde-bitare ai casi della conservazione. Infinite sono le sfumaturedel panorama codicologico, e non è possibile fissare con unacaratterizzazione univoca i caratteri formali e gli aspetti con-tenutistici delle miscellanee di origine francescana: all’idea dielaborare un’immagine cristallizzata e statica osta la percezio-ne precisa del ricorrere di una varietà di soluzioni che dise-gnano una realtà complicata. L’elemento più importante, chenel contempo è forse l’unico realmente unificante, sta nel livel-lo generalmente medio-basso delle miscellanee francescane. Dinorma sono codici in cui si susseguono mani che spesso tradi-scono una buona competenza grafica, ma che non raggiungonomai un alto livello di stilizzazione. In moltissimi casi si alter-nano corsive, spesso anche cancelleresche o librarie semplifica-te, mai la littera textualis canonizzata. A scritture di non altolivello corrisponde sempre, in un parallelismo non inconsueto,
39 Cfr. Catalogo dei manoscritti in scrittura latina datati o databili per indi-cazione di anno, di luogo o di copista, III. Perugia: Biblioteca Comunale Augu-sta - Archivio Storico di S. Pietro - Biblioteca Dominicini, Testo, a cura di M. G.BISTONI GRILLI CICILIONI, Padova, 1994, pp. 38-39.
NICOLETTA GIOVÈ MARCHIOLI410
un assetto decorativo che ha la funzione primaria, se nonesclusiva, di scandire le singole sezioni del testo. Dunque laconfezione del codice è in generale piuttosto semplice, con per-gamena spesso di modesta qualità.
Ho insistito sui cambi di mano: la coesistenza di testi di-versi può corrispondere anche a una coesistenza di mani, sen-za che sia perspicua la correlazione fra le variazioni dellascrittura e il succedersi delle opere. È difficile individuare uncriterio di qualunque genere che sottenda alla presenza di piùmani, e la regoli o la spieghi, in quanto la casistica è fra le piùvarie: in alcuni casi a una mano principale si alternano altremani che scrivono brani di dimensioni ridotte, in altri le diver-se sezioni testuali corrispondono a scriventi diversi.
Per quanto riguarda i contenuti di questi libri, nuovamentesi deve constatare una grande varietà di situazioni: il libro mi-scellaneo francescano raccoglie talora testi molto lontani fra diloro, anche se forse è possibile individuare qualche macrogrup-po testuale. Una tipologia molto diffusa è quella della raccoltapoetica, che mette insieme laude soprattutto di Iacopone, mala poesia si trova anche in combinazioni testuali molto menoomogenee, mescolata a testi in prosa. In alcuni casi il contenu-to francamente francescano, anzi tutto francescano, della mi-scellanea è chiarissimo, in altri questo senso mi sembra vengameno.
Se ricerchiamo la funzionalità pratica di queste raccolte,mi sembra che la motivazione più plausibile, e forse la più ba-nale e strumentale, debba partire dalla considerazione che ilcodice miscellaneo costituisce una piccola biblioteca con le ope-re indispensabili tanto per lo studio quanto per la predicazio-ne: si pensi soprattutto alle raccolte di strumenti utili per lacomposizione di sermoni, o all’assortita unione di sermoni in-teri, schemi o parti di sermoni. Alla prima esigenza sembrapossa rispondere il ms. Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana268, databile fra XIV e XV secolo, raccolta di estratti, sermonie trattatelli religiosi, tra cui spiccano excerpta di Alessandro diHales, Riccardo di Mediavilla e Bonaventura. Cartaceo, dalla
IL CODICE FRANCESCANO 411
fascicolazione irregolare, di più mani coeve, rispetta il consoli-dato repertorio di una decorazione non elaborata ma sicura-mente funzionale alla lettura: iniziale maggiore filigranata einiziali minori semplici in rosso e azzurro, come i segni di pa-ragrafo, e poi titoli, sottolineature, note marginali in rosso eancora maiuscole toccate in rosso.
Alcuni casi tuttavia impediscono un’interpretazione sicura,o perlomeno univoca. Così mi sembra quasi impossibile capirela ratio che ha guidato l’organizzazione di un’antologia comequella conservata nel ms. Cortona, Biblioteca comunale 211,dell’ultimo quarto del XIII secolo, che è difficile riassumere inbreve: accanto a versioni compendiate delle Vite dei Santi Pa-dri o dei Dialogi di Gregorio Magno, troviamo il Lignum vitaedi Bonaventura. Il legame di questo libro con il mondo dei Mi-nori, dove forse può essere stato prodotto, è certo storicamenteaccertato, dato che appartenne almeno dal XV secolo al con-vento di S. Margherita di Cortona, ma potrebbe essere indiret-tamente confermato anche dalla struttura materiale del libro,cartaceo, di piccole dimensioni, senza alcuna decorazione senon quella autarchica delle iniziali semplici a inchiostro.
Solo una considerazione riassuntiva sui compositi, per iquali esistono forti diversità rispetto alle modalità, se non aitempi, della loro confezione. In molti casi si rivela uno sforzoinutile immaginare quando le singole, autonome parti sianostate raccordate in un volume unitario, mentre in altri si puòragionevolmente dedurre che l’opera di ricomposizione sia sta-ta attuata in un’epoca comunque di molto posteriore al mo-mento della fattura delle singole sezioni. Non mancano peròcompositi che nascono dalla ricomposizione delle sezioni scritteseparatamente in un momento immediatamente successivo aquello della loro confezione.
Arrivo finalmente a un approdo, per tentare una qualcheschematizzazione conclusiva. Nelle diverse declinazioni e nel-l’intreccio, anzi nell’incastro di scrittura, decorazione, tipologiatestuale, mise-en-page e mise-en-texte ricostruiamo tante iden-
NICOLETTA GIOVÈ MARCHIOLI412
tità diverse del libro francescano, che rispondono a motivazio-ni contingenti, ma che dipendono naturalmente dall’ambitomateriale di produzione e probabilmente, almeno in parte, dal-l’influenza esercitata dalla committenza francescana stessa.
L’intero complesso delle tradizioni grafiche tardomedievali,dal filone testuale a quello corsivo, è presente all’interno deicodici francescani, che tradiscono la maggiore o minore compe-tenza grafica degli scriventi. Spesso sono i miscellanei a offrirel’esibizione di una mescidanza di mani a volte divaricate fraloro, a volte invece assimilabili, in una alternanza di personeabituate a scrivere solo per sé e di persone che lavorano pergli altri. Ben attestate sono le scritture di base corsiva, in al-cuni casi risistemate per ricercare volutamente una funzionelibraria, in altri invece orientate verso la cancelleresca, maprevalgono decisamente le scritture di tipo testuale.
Dall’assetto grafico passiamo a quello decorativo. Descrivere oriassumere l’ornamentazione dei codici francescani non è possibi-le senza la contestuale verifica delle corrispondenze con le scrit-ture e il testo, e senza considerare quanto essa abbia potuto co-stituire uno strumento espressivo, educativo, formativo, usatoconsapevolmente o meno, ispirato, indirizzato, controllato dallacommittenza francescana, che mescola o sovrappone funzione di-dattica e funzione decorativa dell’apparato iconografico 40. Sebbe-
40 Si tratta di una interazione di notevolissima importanza ed estremamen-te diversificata nelle sue realizzazioni. Proprio per questo motivo altrettantoampia è la bibliografia di riferimento, rispetto alla quale mi limito a richiamaregli interventi di G. MARIANI CANOVA, La miniatura degli ordini mendicanti nel-l’arco adriatico all’inizio del Trecento, in Arte e spiritualità negli ordini mendi-canti. Gli Agostiniani e il Cappellone di S. Nicola a Tolentino. Atti del convegno(Tolentino, 1992), Tolentino, 1992, pp. 165-183, S. MADDALO, Immagini del libro,immagini nel libro, in Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e con-ventuale cit., pp. 165-182, e di F. TONIOLO, L’iconografia francescana nei codiciminiati della Biblioteca Antoniana, in Cultura, arte e committenza nella Basili-ca di S. Antonio di Padova nel Trecento. Atti del Convegno internazionale distudi (Padova, 24-26 maggio 2001), a cura di L. BAGGIO - M. BENETAZZO, Padova,2003 [= Il Santo, XLII (2002)], pp. 59-75. Necessarie, anche per un’introduzione
IL CODICE FRANCESCANO 413
ne non emerga con forza una linea di tendenza coerente e unica,di norma i codici in littera textualis sono notevolmente decorati,anche con uso dell’oro. Ma al di là dei casi di apparato, molto piùnumerosi sono i libri con ornamentazione modesta, in cui tutti glielementi distintivi, dalle iniziali ai segni di paragrafo e ai titoli,sono assai semplici, in rosso o con l’alternanza cromatica di rosso eazzurro. Vi sono però alcuni casi di iniziali istoriate o di pagine or-nate in cui i personaggi raffigurati sono s. Francesco, Iacopone ocomunque frati minori. Di norma l’immagine è coerente con il te-sto, e si può collocare nel filone del ritratto dell’autore inserito nel-l’iniziale con cui si apre il codice, in particolare un libro di studio ilcui autore è raffigurato mentre compone o esibisce la sua opera.Monaldo da Capodistria compare, a mezzo busto oppure seduto,con il saio e con un libro, all’inizio della sua Summa de iure cano-nico in molti codici appartenuti ab antiquo, almeno dal 1449, allaBiblioteca Antoniana: oltre al 51, che un Bonaventura Veronensisconsumavit a Bologna il 25 giugno 1293 usando una textualis piut-tosto pesante 41, e al 52 (cfr. Tavola IV), di un secolo posteriore, inuna perfetta Bononiensis, soprattutto il ms. 38 (cfr. Tavola V), del-la prima metà del Trecento e caratterizzato anch’esso dall’uso diuna inequivocabile Bononiensis. In quest’ultimo codice sopra l’ini-ziale è presente una vignetta in cui ritorna Monaldo, nell’atto ditenere una lezione a studenti confratelli. Ma se passiamo a costru-zioni più articolate, in cui la decorazione svolge evidentemente unruolo importante, fungendo in qualche modo da collante materialee visibile fra testo, pubblico e ideologia, dobbiamo sfogliare allorail ms. Padova, Biblioteca Antoniana 74 (cfr. Tavola VI), leggenda-rio complesso e importante, in cui si realizza visivamente il saldo
generale al tema, sono soprattutto le riflessioni proposte da M. G. CIARDI DUPRÈ
DAL POGGETTO, La miniatura e l’Ordine francescano nel secolo XIII, La miniaturanei libri francescani e infine La miniatura francescana dalle origini alla mortedi san Bonaventura, in Francesco d’Assisi cit., rispettivamente alle pp. 295-297,323-327 e 331-332.
41 Cfr. I manoscritti datati della provincia di Vicenza e della Biblioteca Anto-niana di Padova cit., pp. 64-65 nr. 49.
NICOLETTA GIOVÈ MARCHIOLI414
sodalizio fra i tradizionali santi patroni padovani Prosdocimo eGiustina e i nuovi e amatissimi santi francescani Francesco, Chia-ra e naturalmente Antonio. Mi riferisco in particolare a una seriedi ritratti dei singoli santi che costituiscono le iniziali figurate concui si apre la narrazione delle loro rispettive vite. Il codice in que-stione, peraltro, è un libro polimorfico, che si può leggere secondoprospettive diverse: in una nitida Bononiensis, con una decorazio-ne di impronta padovana che asseconda la datazione del libro alsecondo quarto del Trecento, citato già nel primo inventario anto-niano, è un libro liturgico, ma anche un composito ab antiquo, ol-tre che una miscellanea 42.
Proprio i libri liturgici spesso costituiscono una bella e pre-vedibile antologia dell’iconografia francescana, come attestanoindiscutibilmente la serie degli Antifonari e dei Graduali del-l’Antoniana, eseguiti per il e forse al Santo fra il secondo quar-to e il settimo decennio del Trecento, che bene rappresentanol’elemento di sintesi fra funzione, committenza, destinatari eillustrazione, e in cui operarono più miniatori, alcuni dei quali
42 Come efficacemente sottolinea D. GALLO, Cultura e identità della comunitàfrancescana del Santo nel Trecento, in Cultura, arte e committenza cit., pp. 137-145 alla p. 143:
« Il codice materializza nelle sue sezioni, per così dire, la stratificazione del-la doppia identità del Santo [...]. Troviamo un blocco francescano con la Legen-da maior [... e] un blocco antoniano [...]. La sezione francescana continua consanta Chiara, con san Ludovico vescovo, con san Ludovico re di Francia [...].Non manca un blocco di testi agiografici relativi al santorale padovano, testimo-nianza appunto della duplicità identità di cui partecipa anche la comunità delSanto. I santi padovani rappresentati sono la protomartire Giustina e il proto-vescovo Prosdocimo [... :] segnale molto importante, appunto, della memoria sulpiano liturgico e cultuale, che esprime le due anime, quella francescana e quel-la che potrebbe essere detta padovana e cittadina ».
Il codice, sulla base del suo contenuto, è stato datato agli anni post 1317 –ante 1346. Per una sua puntuale descrizione accompagnata da aggiornata bi-bliografia cfr. A. MAZZON, Manoscritti agiografici latini conservati a Padova. Bi-blioteche Antoniana, Civica e Universitaria, Firenze, 2003, pp. 4-5 nr. 2.
IL CODICE FRANCESCANO 415
di grande spessore e di scuola bolognese 43. Chiunque sia statoa volere l’allestimento di questo sontuoso ciclo liturgico ha te-nuto ben presente e ha rispettato l’esigenza di ricordare chequesti stessi libri avevano una funzione importante nella vitae nella pratica religiosa quotidiana dell’ordine, e ha costante-mente sottolineato questo legame fra libri e lettori, costellandoin particolare gli antifonari di santi francescani e di semplicifrati, non solo spettatori ma anche attori del gesto liturgico. Inquesto modo si è attribuita a questi stessi libri una funzionedidascalica, realizzando un sistema di comunicazione non piùo non solo verbale, ma precipuamente iconica, che riflette eanzi amplifica l’apoteosi dell’ordine, dei suoi santi, dei suoimaestri, ma esalta anche i suoi appartenenti più semplici.
Non mancano infine casi anomali, in cui nel ciclo illustratoche accompagna il testo compaiono, quasi a rendere visiva-mente l’immanenza francescana, immagini di minori o di santiminoritici, anche se assolutamente sganciate dalle indicazionitestuali. Insomma, in una serie di gradazioni originali e co-munque di volta in volta diverse, assistiamo a un passaggiodal previsto al prevedibile, all’imprevisto.
Anche per quel che concerne la coeva tradizione codicologicadi riferimento dobbiamo parlare di scelte a volte divaricate. In-fatti è indubbiamente vero che tra le più ricorrenti caratteristi-che di molti manoscritti francescani troviamo una certa semplici-
43 Ne sopravvivono attualmente quattordici e dieci volumi, e sono segnati ri-spettivamente con delle lettere e con dei numeri romani: A, B, C, D, F, G, H, K, L,M, O, P, Q, S e II, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV. Sull’apparato decorativodi questi codici liturgici – per la cui sommaria descrizione si vedano almeno tantoABATE - LUISETTO, Codici e manoscritti cit., II, pp. 679-711 quanto F. FLORES D’ARCAIS,I Corali, in S. Antonio 1231-1981. Il suo tempo, il suo culto e la sua città, Sala dellaRagione, Sala dei Chiostri del Santo, giugno-novembre 1981, catalogo a cura diGiovanni Gorini, Padova, 1981, pp. 94-99 e schede nr. 67-71 – è intervenuta fra glialtri ad esempio F. TONIOLO, L’iconografia francescana nei codici miniati della Bi-blioteca Antoniana, in Cultura, arte e committenza cit., pp. 59-75, per fare solo unadelle più recenti fra le tante citazioni possibili.
NICOLETTA GIOVÈ MARCHIOLI416
tà strutturale, determinata ad esempio dall’uso di un supportonon particolarmente lavorato, visto che è frequente l’utilizzo, ol-tre che della poco pregiata carta – mi verrebbe di dire materialeumile per libri e lettori umili –, anche di pergamene palinseste, origate per una mise-en-page diversa da quella poi effettivamenteseguita, o in cui risalta vistosamente la differenza fra lato carnee lato pelo. Ma è altrettanto vero che per altri libri francescani,come i codici liturgici antoniani, per i quali l’aggettivazione dimaestosi non serve soltanto a esaltarne la bellezza quanto anchea renderne concettualmente la monumentalità (misurano infattisino a mm. 700 × oltre 450), si sceglie un supporto di qualità ec-cellente e assai costoso.
Insomma, la produzione manoscritta di ambito francescano èrispettosa dei modelli codicologici comuni, né propone o sceglie al-cuna innovazione strutturale. Si possono osservare attestazioni diuna prassi omogenea nella produzione del libro, non necessaria-mente dominante, che potremo connotare come francescana, eche, in una sorta di aderenza ideale alle motivazioni portanti del-l’ideologia dell’ordine, si esprime in un livello esecutivo medio-bas-so, e in un uso contenuto della decorazione. Un possibile modello,o prototipo, o manifesto, o riassunto, o esemplificazione, o forse ba-nalizzazione del codice francescano è il libro evidentemente e pre-minentemente di studio, di lavoro, improntato all’essenzialità,quasi che istintivamente e inconsciamente, o al contrario consape-volmente, ci si orientasse, nella lussureggiante varietà delle possi-bilità codicologiche del basso Medioevo, verso le forme che anche osoprattutto esteriormente corrispondessero all’habitus dell’ordine.Questa situazione funziona precipuamente con i testi del france-scanesimo in volgare, che scelgono appunto forme di libro dalla fi-sionomia semplice sopra prospettata, e che è poi quella prevalentepiù in generale del libro volgare. Libro volgare che, al di là dellerealizzazioni ben limitate di livello molto alto, si mantiene forte-mente statico e destrutturato nel suo assetto. Ma si tratta di unascelta non esclusiva né esaustiva, soggetta a cambiamenti e co-munque non prioritaria: in altri casi è la decorazione magari a im-primere a un manoscritto, fortemente e diversamente connotatostrutturalmente, il suggello della francescanità.
IL CODICE FRANCESCANO 417
Quando osserviamo la morphè del codice, anzi dei codicifrancescani, ci accorgiamo insomma che si è realizzata unadoppia costruzione della loro identità, una sorta di doppia in-venzione a priori e a posteriori: allora, da parte di produttori efruitori dei libri francescani, che hanno voluto adottare, elabo-rare, selezionare, propagandare modelli grafico-codicologiciben precisi ma per assurdo molto diversi, e soprattutto ora, daparte della storiografia, che ha cercato, agognato, ricostruito epropagandato l’esistenza di un modello unitario. I due percorsisi incontrano, a un certo punto. Ma il trait-d’-union fra espe-rienze e analisi delle esperienze, rappresentato dall’ipotesi,scarna ed essenziale, che il manoscritto francescano dovesseessere scarno ed essenziale, in realtà mortifica (o perlomenonon ne dà conto a pieno) quel poliedrico ventaglio di tentativi,di possibilità, di scelte, di appropriazioni indebite, di imitazio-ni formali che spero di essere riuscita almeno a farvi scorgerein lontananza e che non si possono riassumere se non imbri-gliandole a forza. Assorbito inconsapevolmente, imitato inevi-tabilmente, declinato o rielaborato in forme inaspettatamenteoriginali, introdotto scientemente da scriventi e committentifrancescani e non francescani, il mondo esterno entra all’inter-no del mondo minoritico, con tutto il suo complesso bagaglio disperimentazioni librarie, contribuendo a frantumare l’idea diun codice francescano monolitico, e ponendo invece le basi peruna ridefinizione, una re-invenzione della sua identità.
Il codice francescano, anzi, i codici francescani nascono e sidefiniscono in modo dinamico attraverso mutuazioni e osmosicontinue con l’ampio spettro di possibilità, canonizzate o comun-que fortemente connotate, attinte dall’universo dei libri tardome-dioevali: il libro liturgico d’apparato, il libro universitario, il librotascabile. Forse, in un parallelismo plausibile e magari anchenon originale, questa pluralità di aspetti riflette la pluralità dianime, di caratteri, di orientamenti del Francescanesimo due-tre-centesco, in cui si mescolano élan culturale e conseguente forteradicamento nella realtà urbana di grandi centri universitari, evocazione o spinta al pauperismo assoluto e isolamento. Orienta-
NICOLETTA GIOVÈ MARCHIOLI418
menti che scelgono di esprimersi attraverso diversi codici di co-municazione, cui corrispondono codici formali spesso rigidamentestandardizzati, e probabilmente capacità interpretative divarica-te da parte di lettori diversi. Solo quando ci si allontana dai mo-delli forti come quelli appena ricordati, e si producono libri peraltre esigenze, ben specifiche, come quelle della predicazione, al-lora aumenta la possibilità di giungere a esiti formali fortementedifferenziati, a volte ben riconoscibili e nel contempo sganciati danorme vincolanti.
Non posso concludere senza riconoscere che c’è un tema di fon-do da cui mi sono volutamente tenuta distante. Ho parlato quasisempre solo dei libri, dunque dei prodotti scritti e quasi mai, e co-munque incidentalmente, degli scriventi che quei libri hanno con-fezionato. Un’indagine che voglia affrontare in modo compiuto for-me e modi di produzione dei libri francescani deve nel contemporicostruire le fisionomie di tutti quegli scriptores, certamente mol-te volte laici, e altrettante invece interni all’ordine, secondo rap-porti di forza e proporzioni che ancora non riesco a immaginare,che stanno dietro ai libri, e che hanno operato evidentemente incontesti e situazioni opposte, dall’officina laica allo scriptoriumconventuale, scrivendo magari faticosamente per sé, oppure ri-spondendo alle richieste di una committenza che non necessaria-mente era francescana ma che richiedeva un prodotto in qualchemodo francescano, per i suoi contenuti, magari, o per i suoi desti-natari. La mia ricerca ha idealmente percorso la metà di un mon-do, quello dei libri, che già anni fa abbiamo cominciato a conosce-re. Il prossimo percorso potrebbe essere in un’altra, nuova direzio-ne, verso l’altra metà dello stesso mondo, quello delle persone chequei libri scrivono.
Ringrazio il Direttore della Biblioteca Antoniana di Padova e laDirezione della Biblioteca Universitaria di Pavia per avere autorizza-to la riproduzione e la pubblicazione delle tavole. È vietata ogni ulte-riore duplicazione con qualsiasi mezzo.