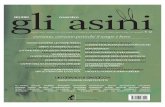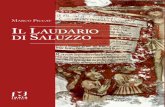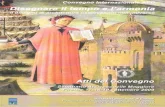Il deflazionismo. Tempo di bilanci?
Transcript of Il deflazionismo. Tempo di bilanci?
RIVISTA DI FILOSOFIA / vol. CIII, n. 2, agosto 2012
RICCARDO BRUNI
Il deflazionismo Tempo di bilanci?
I. La soluzione data da Alfred Tarski al problema di definire la verità per un dato linguaggio formale, delineata nel celebre articolo Il concetto di verità per i linguaggi formalizzati1, presenta due peculiarità. La pri-ma ha un carattere positivo. Supponiamo di aver spe-cificato un certo linguaggio formale e di averne fissata un’interpretazione. Supponiamo, in particolare, di aver assegnato un riferimento ai suoi termini ed un signifi-cato ai suoi simboli di relazione. Si dimostra allora che esiste (ed è unica) una proprietà che si applica a tutte e sole le formule vere del linguaggio. Dunque, la nozione di «essere vero» rispetto all’interpretazione prescelta, è definibile. In particolare, tale definizione è possibile in un opportuno metalinguaggio, laddove il linguaggio dato è il linguaggio oggetto. La seconda peculiarità della sco-perta tarskiana, quella negativa, è che non esiste nessuna
1 La prima versione del lavoro, in polacco, viene pubblicata nel 1933 dalla rivista della Società Scientifica di Varsavia sulla base di materiale che Tarski aveva già reso noto alla comunità dei matematici approfittando tra l’altro di una missione di ricerca a Vienna nel 1930. La prima versione in-glese del lavoro è del 1956, pubblicata in occasione della raccolta di saggi Logics, Semantics and Metamathematics (Oxford, Clarendon) che avrà una seconda edizione nel 1983 (Indianapolis, Hackett). Nel frattempo, data l’importanza acquisita dalla propria proposta, a Tarski erano pervenute ri-chieste di traduzione del lavoro in altre lingue, che videro la luce in tede-sco, nel 1935, successivamente nel 1976 in francese e nel 1984 in italiano. – L’autore desidera esprimere la propria riconoscenza a Andrea Cantini, Elena Castellani e Arnaldo Bruni che hanno letto e commentato una ver-sione precedente di questo articolo. Tutto ciò che è rimasto di poco chia-ro nel testo, è il risultato della personale incapacità di mettere a frutto in modo adeguato i loro suggerimenti.
Riccardo Bruni306
formula del linguaggio oggetto che è vera per tutte e sole le formule per le quali vale la proprietà suddetta. In al-tre parole, l’estensione al metalinguaggio è significativa e necessaria. Significativa, perché il metalinguaggio risulta maggiormente espressivo del linguaggio oggetto. Neces-saria, perché il fine stesso della ricerca di Tarski richie-de il passaggio a questo linguaggio esteso per la propria realizzazione. Tarski intende infatti risolvere il problema della definizione del concetto di verità in modo da ren-derla «adeguata» a uno sfondo filosofico di tipo corri-spondentista, ossia adeguata all’idea che la verità di un enunciato consiste nel realizzarsi dello stato di cose che esso enuncia. L’elaborazione formale di questa idea da parte di Tarski prende, com’è noto, il nome di conven-zione T.
Ormai da diversi anni la posizione individuata con il nome di deflazionismo costituisce un punto di riferi-mento costante del dibattito nel campo delle teorie della verità. Anche contributi recentissimi sul tema contengo-no ricche trattazioni al riguardo2. L’essenza del punto di vista deflazionista consiste, per così dire, nel liberare la soluzione di Tarski da alcune assunzioni di carattere me-tafisico che la renderebbero filosoficamente discutibile. Il presupposto, che può essere fatto risalire ad un’illu-stre tradizione filosofica ispirata da Quine3, è che il ri-corso al predicato di verità nel quotidiano sia pressoché inessenziale tranne che per qualche eccezione. Nella let-teratura al riguardo, la declinazione di questo punto di vista, che deflaziona la verità in quanto la riduce a ciò che di essa contribuisce alle capacità espressive del lin-guaggio, ha assunto forme diverse.
2 Si vedano, al proposito, i seguenti volumi: A.G. Burgess – J.P. Bur-gess, Truth, Princeton, Princeton University Press, 2011; L. Horsten, The Tarskian turn. Deflationism and axiomatic truth, Cambridge (MA), The MIT Press, 2011; V. Halbach, Axiomatic theories of truth, Cambridge, Cambrid-ge University Press, 2011.
3 Cfr. W.V.O. Quine, Philosophy of logic, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1970.
Il deflazionismo. Tempo di bilanci? 307
In primo luogo, si è identificato con la posizione che valga un’assoluta interscambiabilità tra l’espressione «φ è vero» e «φ», tranne che nei casi notevoli segnalati. A ciò si è aggiunta l’idea, apparentemente più elaborata, che la verità sia una proprietà «non sostanziale». In par-te, quest’ultimo aspetto della posizione deflazionista si riconduce a quanto appena detto: la verità è una pro-prietà non sostanziale perché non aggiunge nulla al pro-ferimento dell’enunciato del quale essa si predica. Tale posizione ha preso in aggiunta la forma di una critica della soluzione tarskiana, in particolare per quanto con-cerne la necessità di distinguere il linguaggio oggetto dal metalinguaggio e il conseguente impegno con l’ontologia di riferimento di quest’ultimo.
Ciò conduce però a un quadro complessivo apparen-temente incoerente. Sulla base della suddetta interscam-biabilità tra l’enunciato «φ è vero» e «φ», il deflazionista accetta in qualche modo la convenzione T, o quantome-no l’idea che ne sta alla base, quale criterio di adegua-tezza della propria teoria della verità. Dall’altro lato, in base all’assunto filosofico che la verità è «inconsisten-te», egli rifiuta la necessità di presupporre un ulterio-re (meta-)livello linguistico che pure consente, come ha mostrato Tarski, di ottenere una definizione corretta del-la verità (che evita, quindi, i paradossi) e adeguata nel senso della convenzione T medesima. A ben guardare, una parte significativa delle difficoltà di questo punto di vista possono essere ricondotte al tentativo di conciliare questi due aspetti contrastanti. Appare comunque chiaro il rifiuto da parte del deflazionista della distinzione tra il momento sintattico e il momento semantico. L’idea pro-posta sembra quella di un linguaggio oggetto che risul-ta essere autosufficiente per ciò che concerne la propria nozione di verità. Come si cercherà di mostrare, questo fatto costituisce già di per sé lo spunto per una serie di riflessioni in campo logico.
La discussione circa la nozione deflazionista di veri-tà ha poi assunto contorni più definiti grazie ad alcuni commentatori che hanno suggerito che dall’assunto re-
Riccardo Bruni308
lativo alla «leggerezza» della verità segue che una teo-ria (assiomatica) che aspiri ad incarnare lo spirito di questa proposta non debba risultare «creativa» rispetto alla teoria o all’insieme di conoscenze che essa estende. Quest’idea corrisponde a proprietà dei sistemi formali di assiomi che sono note ai logici. Con l’introduzione di questa tematica diventa possibile precisare ulteriormente gli assunti della posizione deflazionista, nonché tentarne una verifica più puntuale.
II. Una prima questione che conviene affrontare è la seguente: il deflazionismo è in qualche modo impegnato a caratterizzare la verità per via assiomatica? E, in caso di risposta affermativa: quale forma assume, o dovrebbe assumere, una teoria assiomatica della verità di stampo deflazionista?
La questione è naturalmente concepita per legare le istanze filosofiche deflazioniste e le indagini logico-for-mali che si sono sviluppate a partire da esse. Dunque, può servire a spiegare come sia accaduto che i logici di professione abbiano ‘invaso’ l’ambito di ricerca proprio del filosofo del linguaggio.
La prima parte del problema, ovvero se sia corretto guardare al deflazionismo come a un approccio volto a caratterizzare per via assiomatica la verità, potrebbe es-sere risolta sottolineando come in questa direzione si siano mossi, in modo più o meno esplicito, alcuni tra i sostenitori più noti del deflazionismo4. A prescindere da ciò, sembra comunque inevitabile giungere a questa con-clusione affermativa anche procedendo all’analisi della posizione in questione.
Il deflazionista rifiuta la distinzione tarskiana tra lin-guaggio oggetto e metalinguaggio. Ciò significa rifiutare in particolare il fatto che la verità, o meglio la possibili-
4 Si vedano, ad esempio, P. Horwich, Truth, Oxford, Oxford Uni-versity Press, 19982; H. Field, Deflationist views of meaning and content, «Mind», CIII, 1994, pp. 247-85; Id., Deflating the conservativeness argu-ment, «The Jorunal of Philosophy», XCVI, 1999, pp. 533-40.
Il deflazionismo. Tempo di bilanci? 309
tà di definire il predicato «essere vero» per un dato lin-guaggio, dipenda dalla specificazione di una semantica «alla Tarski» e quindi risulti relativa a un certo modello privilegiato, o persino alla nozione generale di modello. Al contrario, il deflazionista intende proporre una teo-ria assoluta della verità. Di più: si rifiuta l’idea che tale teoria possa dipendere da strumenti che eccedano le ca-pacità espressive del linguaggio al quale la verità si rife-risce. La verità è una nozione primitiva, e come tale è parte del linguaggio di riferimento. Il che comporta la necessità di interrogarsi su quale sia il «raggio d’azione» del predicato in questione e, in particolare, di doman-darsi se sia lecito che esso si applichi agli enunciati di tutto il linguaggio (inclusi quelli che contengono occor-renze del predicato di verità), o se invece lo si debba li-mitare al solo linguaggio di base. Di questo, però, ci oc-cuperemo con maggiore dovizia di dettagli nel seguito.
Quanto detto sembra intanto sufficiente per giustifica-re la necessità di assumere alcuni principi regolativi del predicato in questione. Essi non possono dare luogo a una definizione soddisfacente: per il risultato negativo di Tarski non ci si può aspettare di fissare in questo modo l’estensione del predicato di verità in modo adeguato ri-spetto alla convenzione T, cara agli stessi deflazionisti. Sembra quindi naturale guardare a questi principi come ad assiomi che riflettano le intuizioni relative al predica-to di verità.
Si apre così il problema della scelta di un’assioma-tizzazione appropriata. Senza voler entrare troppo nel-lo specifico, può essere d’aiuto riferirsi nuovamente alla convenzione T. In particolare, all’idea che essa veicola circa l’equivalenza (logica) tra l’attribuzione della verità agli enunciati e il loro proferimento. Sembra legittimo cioè su questa base stabilire il seguente criterio minimale di adeguatezza per un’assiomatizzazione della concezione deflazionista della verità: dato un linguaggio formale che comprenda un predicato di verità, una teoria assiomati-ca è adeguata alla concezione deflazionista se, fissato un certo insieme A di formule del linguaggio, la teoria di-
Riccardo Bruni310
mostra le istanze delle equivalenze della forma «φ è vero se e solo se φ» (quello che da qui in avanti chiameremo lo schema (T)), per ogni formula φ di A, fatta salva la consistenza della teoria stessa.
In presenza della logica classica (e per teorie che estendano una base aritmetica sufficientemente espressi-va), il teorema di indefinibilità di Tarski impone che A sia un sottoinsieme proprio dell’insieme delle proposi-zioni del linguaggio di riferimento. Stabilito ciò, restano comunque sul tavolo diverse soluzioni alternative.
In prima approssimazione si può dire che le scelte disponibili si dividono in due gruppi. Del primo fanno parte le teorie assiomatiche che prendono alla lettera il criterio di adeguatezza descritto in precedenza. Ovvero, che identificano come assiomi proprio una certa classe di equivalenze logiche tra la verità di un enunciato e l’enunciato medesimo. Queste soluzioni individuano però criteri diversi per giungere, per questa via, a una teoria complessivamente consistente e perciò evitare i parados-si. È nota ad esempio la proposta, contemplata dallo stesso Tarski, di scegliere come assiomi tutte le istanze dello schema (T) ottenute da enunciati, cioè da formule prive di variabili libere, che non contengano occorrenze del predicato stesso di verità. Al fine di comprendere il senso di quest’idea può essere utile notare che la restri-zione si applica in particolare all’enunciato «del menti-tore», il quale, come si è soliti dire, «dice di sé stesso di essere falso» e dunque contiene un riferimento alla verità. Ciò significa che la condizione scelta permette in effetti di bloccare la contraddizione che ne deriva.
Al fine di ottenere un grado superiore di generalità, si è proposto di estendere la collezione degli assiomi mediante equivalenze dello stesso tipo, applicate però a formule aperte, ovvero a quelle espressioni del linguag-gio che corrispondono all’attribuzione di proprietà di base a individui o che sono ottenute da queste per com-binazioni logiche, purché, di nuovo, non contengano oc-correnze del predicato di verità. Per estensione naturale della convenzione T, si stabilisce negli assiomi che ogni
Il deflazionismo. Tempo di bilanci? 311
formula siffatta è vera in ogni sua istanza possibile, se e solo se detta istanza si verifica.
Le due soluzioni descritte sono accomunate dalla scel-ta di restringere la convenzione T, o meglio la sua tra-duzione formale, alle sole formule del linguaggio di base che, come si è detto, non contengono occorrenze del predicato di verità. Cerchiamo di essere più precisi al riguardo. Una teoria assiomatica della verità è riconduci-bile, in ultima analisi, a un insieme di assiomi che altro non sono se non formule di un linguaggio che contie-ne un predicato di verità. Supponiamo di indicare con LT questo linguaggio esteso. Nella situazione più sempli-ce possibile, questo linguaggio è ottenuto per aggiunta del predicato in questione ad un linguaggio L di base. Nei casi menzionati questi assiomi coincidono con una collezione di formule che possiedono tutte la medesima forma logica, quella di equivalenze del tipo suddetto. In assenza di restrizioni ulteriori la presenza del predicato di verità consente di considerare istanze ammissibili de-gli assiomi della teoria tutte le formule della forma «φ è vero se e solo se φ», per ogni enunciato φ di LT
5. In particolare sarebbero ammissibili formule di quel genere per enunciati che contengano occorrenze del predicato di verità stesso. Dunque, supponendo di indicare con l l’enunciato del mentitore, ad esempio nella forma «Que-sto enunciato è falso», l’espressione «l è vero se e solo se l» sarebbe un assioma della teoria con conseguenze facilmente immaginabili. L’alternativa consiste nell’asse-gnare al predicato di verità un tipo di formule al quale esso può legittimamente applicarsi. Nella sua forma più estrema, già menzionata, tale restrizione può riguardare tutte le formule del linguaggio esteso LT. Il predicato di verità finisce in questo caso per applicarsi negli assiomi
5 Per ragioni di semplicità, si è deciso di evitare ogni riferimento alla questione relativa alla presenza nel linguaggio di nomi per gli enunciati e alle sottigliezze tecniche a ciò legate. Pur costituendo un problema impor-tante, per certi versi cruciale, una sua trattazione esaustiva finirebbe per portarci molto al di là degli obiettivi del presente lavoro.
Riccardo Bruni312
ai soli enunciati del linguaggio L di partenza, dunque a enunciati che non ne presentano occorrenze. La teoria risultante viene detta di conseguenza tipata.
Più recentemente, è stata avanzata una soluzione, da parte di Volker Halbach6, che fa parte del novero delle teorie della verità che possiedono come assiomi istanze formalizzate della convenzione T, ma che rompe allo stesso tempo la consuetudine di ricorrere alla «tipizza-zione estrema» per garantire la consistenza della teoria. L’idea consiste nell’aggiungere agli assiomi descritti in precedenza istanze derivanti dall’applicazione del predi-cato di verità a una parte delle formule del linguaggio esteso, in particolare alle formule che siano tali da con-tenere solo occorrenze positive del predicato di verità, cioè occorrenze alle quali siano applicate un numero pari di negazioni7. Formule di questo tipo vengono dette T-positive. Basti qui osservare che ciò consente di evitare i rischi legati alla possibilità di costruire il para-dosso del mentitore. L’enunciato l citato in preceden-za, infatti, è (logicamente equivalente a) un enunciato che non è T-positivo (dato che un enunciato è «fal-so» se è «non vero»). Ciò significa che la formula «l è vero se e solo se l» non fa parte degli assiomi della teoria proposta da Halbach. Dunque, non è possibile ottenere, per logica, alcuna contraddizione al riguardo. Anzi, la teoria non dimostra alcuna contraddizione: il sistema d’assiomi di Halbach è infatti consistente. In
6 Cfr. V. Halbach, Reducing compositional to disquotational truth, «The Review of Symbolic Logic», II, 2009, pp. 786-98; Id., Axiomatic theories of truth, cit., pp. 274-86.
7 A dire il vero, l’identificazione tra occorrenze positive del predicato di verità con quelle formule nelle quali ad esso risultano applicate nega-zioni in numero pari, richiede, perché sia corretta, che il linguaggio for-male prescelto non contenga il connettivo logico di implicazione. È noto, infatti, come in logica classica un enunciato della forma «se A, allora B» è logicamente equivalente a «non A o B». Dunque, esso contiene un’occor-renza «mascherata» della negazione applicata all’antecedente. D’altra parte, lo stesso risultato di equivalenza logica consente di fare a meno del con-nettivo «se… allora…» in un linguaggio formale che contenga negazione e disgiunzione, senza perdita di capacità espressiva.
Il deflazionismo. Tempo di bilanci? 313
più, esso possiede qualche vantaggio espressivo rispetto alle teorie tipate. Un altro enunciato noto agli studiosi del settore, il «portatore di verità» τ che «dice di sé stesso di essere vero», istanzia infatti un assioma della teoria. Il sistema di Halbach dimostra quindi che «τ è vero se e solo se τ», che oltre ad apparire come una conclusione del tutto innocua e legittima, non risulta dimostrabile nelle teorie precedentemente menzionate a causa della restrizione sulle istanze ammesse dello sche-ma (T).
Come si diceva, però, la scelta di scrivere gli assiomi per il predicato di verità direttamente nella forma logi-ca che la convenzione T acquisisce, se formalizzata, non è l’unica possibile. In particolare, mantenendo ferma la restrizione secondo la quale è legittimo applicare il pre-dicato di verità alle sole formule che non ne contengono occorrenze, è possibile in alternativa definirne assiomati-camente le proprietà in modo composizionale. In questo caso si sfrutta la struttura sintattica dei linguaggi forma-li: si stabilisce cioè che un enunciato atomico è vero se e solo se la relazione che esso esprime sussiste effetti-vamente tra i termini coinvolti (o meglio tra gli oggetti a cui i termini si riferiscono, in un’interpretazione pre-scelta del linguaggio); si stabilisce che un enunciato ne-gato è vero se è falsa la corrispettiva formula positiva; che una congiunzione è vera se risultano veri entrambi i congiunti, e così via per le rimanenti operazioni di con-nessione logica e di quantificazione. Si dimostra poi che il sistema assiomatico che si ottiene per questa via sod-disfa il criterio di adeguatezza fissato, in quanto annove-ra tra i suoi teoremi, ad esempio, gli assiomi dei sistemi tipati descritti in precedenza.
Riassumendo, il tentativo di dare una veste formale agli assunti deflazionisti conduce a più di una soluzione possibile. Ciò sembra dovuto al fatto che la posizione fi-losofica originaria non è sufficientemente specificata. In particolare, l’essenza del deflazionismo non può conside-rarsi esaurita dal solo criterio minimale di adeguatezza, né dall’importanza riservata da parte del deflazionista
Riccardo Bruni314
alla convenzione T che di quel criterio costituisce il fon-damento principale.
Appare naturale, quindi, la necessità di approfondire la questione, prendendo in considerazione altri aspetti che caratterizzano la posizione in oggetto.
III. Si è detto che per il deflazionista vi è una sostan-ziale interscambiabilità tra l’enunciato mediante il quale si attribuisce verità a una frase del linguaggio e il pro-nunciamento della frase in questione. Un’interscambiabi-lità sostanziale, ma non assoluta. Si riscontrano in parti-colare due eccezioni significative: il caso delle generaliz-zazioni e quello delle cosiddette sottoscrizioni cieche.
Un esempio dell’uso del predicato di verità nel primo senso è quello della frase: «Gli assiomi dell’aritmetica di Peano sono veri». Che tale uso sia essenziale, in questo caso, discende dal fatto che ciò che la frase significa è che tutte le istanze degli assiomi aritmetici sono vere. Poiché, come è noto, tra essi figura anche il principio di induzione completa, che è uno schema d’assioma e che possiede quindi infinite istanze, la frase originaria impe-gna dunque alla verità di un numero infinito di enuncia-ti. In tal senso, essa non è sostituibile in pratica da una frase della forma «L’Assioma 1 dell’aritmetica di Peano è vero e l’Assioma 2 dell’Aritmetica di Peano è vero e...», che ne sarebbe il corrispettivo.
Il secondo caso si ha invece in situazioni in cui si ri-corre al predicato di verità per assentire ad affermazioni altrui, come in una frase del tipo: «Ciò che Aristotele disse il 4 aprile del 360 a.C. alle 10.40 del mattino è vero». L’elemento significativo consiste nel fatto che chi pronuncia la frase potrebbe essere del tutto ignaro di cosa effettivamente Aristotele abbia detto in quell’occa-sione. Ciò nondimeno, egli è in grado di esprimere il proprio assenso mediante il ricorso al predicato di verità e non altrimenti. Quest’ultimo fatto diviene evidente da un’analisi dell’enunciato che rivela come anch’esso non sia altro che una congiunzione infinita della forma: «Se
Il deflazionismo. Tempo di bilanci? 315
il 4 aprile del 360 a.C. alle 10.40 del mattino Aristote-le disse “Socrate è stato il più grande filosofo di tutti i tempi”, allora Socrate è stato il più grande filosofo di tutti i tempi, e se il 4 aprile del 360 a.C. alle 10.40 del mattino Aristotele disse “Atene è la città-stato dell’At-tica”, allora Atene è la città-stato dell’Attica,...» (e così via, per tutti gli enunciati possibili del linguaggio).
L’uso del predicato di verità è dunque inessenziale, tranne che in casi nei quali esso ha la funzione di espri-mere congiunzioni infinite. Ci si può chiedere allora se questa conclusione possa aiutare ad operare un discri-mine tra le teorie che si propongono di «incarnare» la concezione deflazionista. In altri termini, se esiste, tra le teorie che risultano adeguate al deflazionismo nell’ac-cezione precedente, un sistema d’assiomi che rifletta il fatto che la verità ha un ruolo essenziale nell’esprime-re congiunzioni infinite. La risposta è negativa, se per «esprimere congiunzioni infinite» si intende dimostrare l’enunciato che, diciamo così, le traduce a livello formale.
Un semplice esercizio di formalizzazione, infatti, ren-de chiaro come le congiunzioni infinite alle quali si è fatto riferimento siano enunciati universali del tipo: «Per ogni elemento x della collezione B di enunciati, x è vero». Se si fa riferimento in particolare alle collezio-ni di enunciati che siano definibili nel linguaggio scelto (dunque, collezioni i cui elementi siano tutti e soli gli individui che godono di proprietà espresse da formu-le di tale linguaggio), è possibile concludere, estenden-do una tecnica dimostrativa escogitata da Halbach8, che nessuna delle teorie che soddisfano il criterio di adegua-tezza al deflazionismo è in grado di esprimere una con-giunzione infinita.
Tuttavia, il deflazionista potrebbe legittimamente op-porsi all’idea che con «esprimere una congiunzione in-finita» si intenda «dimostrare formalmente l’enunciato che la traduce». In fin dei conti, ciò che si riconosce al
8 V. Halbach, Disquotationalism and infinite conjunctions, «Mind», CVIII, 1999, p. 10.
Riccardo Bruni316
predicato di verità è la capacità di estendere l’espres-sività di un linguaggio rispetto a sistemi di enunciati che non sarebbero esprimibili altrimenti. In alternati-va all’interpretazione precedente sarebbe allora meglio dire che una teoria assiomatica esprime una congiunzio-ne infinita se essa dimostra tutte le conseguenze logiche dell’enunciato che la traduce a livello formale, eccezion fatta, dato il risultato citato, per l’enunciato medesimo. In particolare, si tratta di verificare che l’aggiunta della congiunzione infinita agli assiomi della teoria non sorti-sce alcun effetto sulla capacità dimostrativa della teoria assiomatica di partenza. Ciò comporta verificare in pri-mo luogo che una teoria dimostri tutti i congiunti di una congiunzione infinita.
Ebbene, è possibile concludere allora che tutte le te-orie adeguate al deflazionismo nel senso del criterio mini-male esprimono congiunzioni infinite in quest’accezione9.
IV. La conclusione del precedente paragrafo può ap-parire favorevole al deflazionismo. Tutte le teorie che possono candidarsi a rappresentarne le istanze sono in grado di riflettere l’idea che il predicato di verità abbia un ruolo essenziale nell’espressione di congiunzioni infi-nite. Tuttavia, il fatto che tutte le teorie minimalmente adeguate al deflazionismo possiedano questa capacità è di scarsa utilità rispetto al problema di cercare elementi discriminanti tra le teorie in questione. Volendo perse-guire nell’intento, si può allora partire dall’osservazione di alcuni commentatori che hanno cercato di caratteriz-zare meglio l’idea che la verità sia un concetto non so-stanziale10.
9 V. Halbach, Disquotationalism and infinite conjunctions, cit. pp. 13-14.
10 Si vedano: L. Horsten, The semantical paradoxes, the neutrality of truth and the neutrality of the minimalist theory of truth, in The many pro-blems of realism, a cura di P. Cortois, Tilburg, Tilburg University Press, 1995, pp. 173-87; S. Shapiro, Proof and truth: through thick and thin, «The
Il deflazionismo. Tempo di bilanci? 317
Stando a una formulazione un po’ schematica si può dire che una teoria assiomatica della verità è composta da tre parti: una parte logica, che fissa l’orizzonte logi-co della teoria (classico, intuizionista, ecc.); una parte specifica, che contiene assunzioni relative al «dominio teorico» di riferimento (ad esempio, gli assiomi usuali dell’aritmetica per una teoria dei numeri); una parte ale-tica, che contiene le assunzioni sul predicato di verità. Supponiamo di riferirci a queste tre parti con L, S e V rispettivamente.
L’idea generale, allora, è che gli assiomi di una teoria di base, ovvero la sua parte logica e la sua parte speci-fica, e le loro conseguenze, rappresentino tutto ciò che si è disposti ad accettare. Una teoria assiomatica del-la verità viene concepita come un’estensione che rende esplicita tale accettazione, nella forma di assunzioni cir-ca la veridicità di certe espressioni del linguaggio. Sem-bra legittimo richiedere che la teoria che si ottiene per aggiunta di V a L e S non sia creativa, ovvero non con-senta di dimostrare, tra le formule che non contengono occorrenze del predicato di verità, niente che non sia già dimostrabile a partire da L e S stessi: se vi fosse una formula siffatta che risultasse dimostrabile solo dopo l’aggiunta della parte aletica, la sua negazione potrebbe essere aggiunta in modo consistente a L e S; dunque potrebbe essere considerata come un’assunzione che do-vrebbe o potrebbe accettare chiunque accetti L e S, no-nostante essa non sia stata fatta in modo esplicito o non la si voglia fare per altre ragioni. La verità sarebbe in questo senso sostanziale, in quanto decisiva per influen-zare l’impegno nei confronti di conoscenze che, in un certo senso, prescindono da essa. A livello metalogico ciò significa richiedere che la teoria che si ottiene da L e S, per aggiunta degli assiomi V, debba essere conservativa sulla teoria costituita dai soli L e S.
Journal of Philosophy», XCV, 1998, pp. 493-521; J. Ketland, Deflationism and Tarski’s paradise, «Mind», CVIII, 1999, pp. 69-94.
Riccardo Bruni318
Si noti innanzitutto che la spiegazione data si presta all’interpretazione radicale per cui, se un individuo è di-sposto ad accettare i soli assiomi logici, una teoria de-flazionista dovrebbe risultare parimenti conservativa sul solo insieme L di enunciati. Ebbene, è possibile dimo-strare che nessuna teoria della verità adeguata al deflazio-nismo è conservativa sulla logica11. Si consideri infatti un sistema d’assiomi che abbia come parte aletica una qua-lunque estensione della collezione dello schema (T), ri-stretto agli enunciati che non presentano occorrenze del predicato di verità, e che contenga tra gli assiomi la teo-ria dell’identità. Ebbene, entro questo quadro assiomati-co si dimostra che esistono almeno due individui (ovve-ro, che esistono due termini del linguaggio s e t che la teoria dimostra essere l’uno diverso dall’altro).
Detto altrimenti, (i) nessuna teoria deflazionista è conservativa sui soli assiomi logici e (ii) ogni teoria ade-guata al deflazionismo consente di concludere che esisto-no almeno due individui, contro l’assunto che la verità sia una proprietà ontologicamente neutra, in quanto non sostanziale. È chiaro, a questo punto, che il deflazioni-sta che volesse ancora cercare sostegno mediante la pro-prietà di conservatività dovrebbe sostenere la radicalità dell’accezione smentita dal risultato precedente. Egli do-vrebbe perciò sottolineare l’importanza di una dimostra-zione di conservatività su una teoria di base che estenda significativamente l’insieme degli assunti logici (che sia cioè costituita da L e da un certo S non vuoto).
In questo caso, la letteratura offre al deflazionista un panorama più variegato. Ad esempio, la stessa teoria la cui parte aletica consiste dello schema (T) ristretto agli enunciati nei quali non occorre il predicato di verità (così come la sua variante «uniforme», con lo schema esteso alle formule aperte), è conservativa in questo sen-so sulla teoria di base, se S coincide con gli assiomi del-la teoria dei numeri. Invece, la teoria che abbiamo de-
11 V. Halbach, How innocent is deflationism?, «Synthese», CXXVI, 2001, pp. 178-79.
Il deflazionismo. Tempo di bilanci? 319
scritto come «composizionale» non è conservativa sulla teoria dei numeri (almeno nella sua forma più genera-le, che consente cioè alle formule nelle quali occorre il predicato di verità di istanziare il principio di induzio-ne completa), così come non lo è la versione uniforme della teoria che consente, in V, istanze dello schema (T) per formule T-positive12.
Il punto, tuttavia, è se tale varietà di risultati si tradu-ca in una possibilità effettiva da parte del deflazionista di argomentare a favore o contro qualcuna delle teorie assiomatiche menzionate. Una valutazione più attenta di questo fatto è ciò che ci si propone di fare nel seguito.
V. Da quanto detto sembra naturale concludere che l’esame dei requisiti proposti offre al deflazionista una scelta tra più teorie assiomatiche della verità. Ma si ren-de necessaria qualche altra considerazione.
Innanzitutto si impone una riflessione sul criterio di adeguatezza minimale per le teorie candidate a rappre-sentare la proposta deflazionistica. Ci si potrebbe chie-dere, ad esempio, se non si tratti forse di un criterio troppo banale. La domanda è una naturale conseguenza di un risultato dovuto a Vann McGee: data una teoria della verità che estenda, ad esempio, il sistema di assio-mi dell’aritmetica, per ogni enunciato del linguaggio esi-ste un’istanza dello schema (T) logicamente equivalente ad esso13. La conseguenza immediata, è che ogni teoria assiomatica formale della verità che estenda una teoria di base del genere può acquisire la «forma» di una te-oria che rispetti il criterio di adeguatezza fissato. Ma lo stesso risultato ha un’altra conseguenza ancora: questo criterio non può essere «massimizzato», e quindi non
12 Si rimanda il lettore interessato ai dettagli dei risultati citati qui sommariamente, e per altri risultati dello stesso tipo, alla lettura del testo di V. Halbach, Axiomatic theories of truth, cit.
13 Si veda V. McGee, Maximal Consistent Sets of Instances of Tarski’s Schema (T), «Journal of Philosophical Logic», XXI, 1992, pp. 235-41.
Riccardo Bruni320
consente, da solo, di individuare una teoria della veri-tà in particolare. La ragione è semplice. Si consideri un enunciato indecidibile nella teoria aritmetica di base. Si tratta di quelle proposizioni aritmetiche che Gödel ha dimostrato esistere con i suoi celeberrimi teoremi, ov-vero formule del linguaggio della teoria dei numeri che risultano essere tanto indimostrabili, quanto irrefutabili rispetto al sistema d’assiomi dell’aritmetica. Ebbene, dal risultato di McGee segue che ogni enunciato di questo tipo dà vita ad un’estensione consistente di una data te-oria della verità che rispetta il criterio di adeguatezza. È un fatto noto che esiste un’infinità più che numerabile di completamenti consistenti massimali dell’aritmetica (cioè, estensioni della teoria dei numeri che non sono ulteriormente estendibili, pena la perdita della proprie-tà di consistenza). Dunque, esiste un’infinità più che nu-merabile di teorie consistenti che estendono l’aritmetica e che soddisfano il criterio di adeguatezza al deflazionismo. In che senso ciò è rilevante? Certamente nella misura in cui si potrebbe pensare di ovviare alle difficoltà segna-late, indicando come teoria prescelta l’insieme più gran-de di enunciati che soddisfano il criterio di adeguatezza, e che non danno vita ad una contraddizione14. Ebbene, il punto è che non esiste un insieme siffatto. O alme-no, non ne esiste uno solo: ne esistono infiniti, addirit-tura più di quanti se ne possano contare utilizzando i soli numeri naturali. Detto questo sembra inevitabile concludere che la soddisfazione del criterio di adegua-tezza, che pure appare come una naturale conseguenza delle posizioni deflazioniste, possa aiutare poco nel mi-gliore dei casi: anzi, nel peggiore, alimentare ulteriori rilievi critici al deflazionismo stesso (tacciabile di essere intrinsecamente vago).
Un’altra considerazione obbligata concerne la diffe-renza tra teorie che non consentono al predicato di ve-rità di applicarsi a formule che ne contengano occorren-
14 Cfr. P. Horwich, Truth, cit.
Il deflazionismo. Tempo di bilanci? 321
ze (le teorie tipate, come si è detto), e teorie che non prevedono simili restrizioni. Si potrebbe notare, in real-tà, che la critica alla distinzione tarskiana tra linguaggio oggetto e metalinguaggio fa venire meno la necessità di proporre una teoria tipata della verità. Sembra infatti piuttosto naturale che il deflazionista propenda per una teoria dove il predicato di verità convive con gli altri elementi sintattici del linguaggio senza recitare un ruolo privilegiato. Dunque, senza essere soggetto a restrizioni che appaiono giustificate solo dall’obiettivo di dare vita a teorie consistenti. Il problema, in questo caso, sorge dal fatto che, come si ricordava al termine del paragrafo precedente, per la teoria con le istanze T-positive dello schema (T) in versione uniforme viene meno il requisi-to di conservatività sulla teoria di base (quando questa coincide con la teoria dei numeri). Occorre analizzare più da vicino quest’ultimo requisito, poiché sembra co-stituire l’unico discrimine possibile tra le proposte con-siderate.
In primo luogo si potrebbe notare come la richie-sta che una teoria della verità sia conservativa sul siste-ma di assiomi di base faccia riferimento alla proprietà di conservatività sintattica, che è formulata rispetto alla dimostrabilità di una formula in una teoria assiomatica. Esiste, come è noto, un corrispettivo semantico di tale nozione. Più precisamente, si dice di un’estensione as-siomatica T2 di una teoria T1 che è semanticamente con-servativa su quest’ultima, se ogni interpretazione di T1 può essere estesa a un’interpretazione di T2. Nel caso delle nostre teorie della verità, ciò significa che deve essere possibile, nel dominio di riferimento della teo-ria di base, trovare un insieme di individui (di numeri, ad esempio, volendo continuare a parlare di teorie che estendono l’aritmetica) che possa essere interpretato come l’insieme delle formule vere, tale, quindi, da ren-dere validi gli assiomi relativi al predicato di verità. Il fatto è che le due nozioni, la conservatività sintattica e quella semantica, non coincidono. Esistono casi, an-che tra le teorie della verità menzionate, in cui sistemi
Riccardo Bruni322
d’assiomi che sono sintatticamente conservativi su una teoria di base non risultano essere tali da un punto di vista semantico, rispetto alla medesima teoria di parten-za. D’altra parte, la scelta di riferirsi all’una piuttosto che all’altra proprietà metalogica sembra essere frutto di un arbitrio. La conservatività semantica sembra al-trettanto in grado di esprimere l’idea della non sostan-zialità della verità, nel senso che la sua interpretazione è il frutto di un’«elaborazione» dell’interpretazione del linguaggio di base. Ciò significa che, al fine di acquisire significato, la verità non ha bisogno di risorse «esterne» a quelle necessarie al fine di dotare di senso il linguag-gio di partenza. Dunque, il deflazionista potrebbe con-testare in toto il ricorso a certe proprietà metateoriche per operare una selezione di assunti che si vogliono motivare filosoficamente, soprattutto quando le proprie-tà in questione risultano essere scelte sulla base di una restrizione, arbitraria appunto, dell’orizzonte possibile.
C’è un ulteriore elemento che sembra favorire una si-mile mossa nel caso specifico della conservatività sintatti-ca: anch’essa non può essere massimizzata, e dunque non conduce, nella sua versione più radicale, all’individua-zione di un sistema assiomatico. L’osservazione discende da un risultato di Cezary Cieslinski: esiste un’infinità più che numerabile di estensioni conservative massimali della teoria che ha come assiomi lo schema (T) ristretto agli enunciati del linguaggio di base15. Dunque esiste un’infi-nità più che numerabile di teorie che (i) rispettano il cri-terio di adeguatezza, (ii) sono sintatticamente conservati-ve sull’aritmetica, e (iii) non possono essere ulteriormen-te estese, pena la perdita del requisito di consistenza.
Queste osservazioni possono essere utilizzate per muovere una critica a coloro che hanno ritenuto che tale proprietà potesse costituire un’appropriata interpre-tazione dell’idea che la verità sia un concetto non so-
15 C. Cieslinski, Deflationism, conservativity and maximality, «Journal of Philosophical Logic», XXXVI, 2007, pp. 695-705.
Il deflazionismo. Tempo di bilanci? 323
stanziale. Tuttavia, sembra inevitabile presentare il conto dell’indagine logica anche al deflazionista.
VI. Il deflazionista, a questo punto, ha di fronte a sé due opzioni. Egli può ritenere il lavoro dei logici un fraintendimento della propria proposta, oppure, pur ri-conoscendo in esso un legittimo sviluppo della propria impostazione, può ritenere i risultati finali dell’indagine logico-formale del tutto irrilevanti per lo sfondo concet-tuale di partenza. A mio avviso, la prima posizione sa-rebbe sbagliata, la seconda del tutto insensata.
L’elemento di maggiore interesse dell’intera «questio-ne deflazionista» consiste proprio nel fatto che il dibatti-to, nato in seno a un approccio legato alla filosofia della logica e del linguaggio, ha finito per creare un ponte tra analisi concettuale e indagine formale. Decidere, in ma-niera più o meno aprioristica, di non tenere conto dei risultati di quest’ultima, sarebbe come disconoscere la ricchezza del dibattito che ne è stato il presupposto.
Se invece il deflazionista accettasse il ricorso agli stru-menti dell’indagine logica come una naturale prosecuzio-ne della propria opera di analisi concettuale, non si com-prenderebbe, se non come un estremo tentativo di sal-vaguardia delle proprie posizioni originarie, la decisione di ignorarne gli esiti. La situazione generale si può rias-sumere nel modo seguente. Si è partiti dal proposito di svelare l’essenza della verità in modo coerente con il suo uso nel linguaggio ordinario. Il passaggio alla considera-zione dei linguaggi formali si rende necessario per alcu-ne problematiche intrinseche alla struttura dei linguaggi naturali da un lato, e per la ricerca di maggior rigore complessivo dall’altro. La logica consente a questo pun-to di effettuare alcuni «test» sulla teoria proposta, il cui risultato va però interpretato alla luce del percorso fatto. È possibile che qualcosa vada irreparabilmente perduto nel passaggio ai linguaggi formali. Ma è anche possibile che qualcosa non andasse già nelle istanze di partenza, e che queste vadano rivedute alla luce dell’indagine logica.
In effetti le cose sembrano cambiare, diversifican-do il quadro concettuale di riferimento. Si è detto
Riccardo Bruni324
dell’idea, suggerita dall’analisi di Quine, del predicato di verità come un mezzo per esprimere congiunzio-ni infinite. Si aggiunga a ciò, l’assunto che la verità è essenzialmente uno strumento di de-citazione, dunque uno strumento che permette di passare dalla menzio-ne di un enunciato al suo uso. Secondo quest’approc-cio, tutto ciò che occorre sapere sulla verità è rac-chiuso nello schema (T). Occorre certo appurare che ciò sia sufficiente a restituire l’idea relativa alla mag-giore espressività del linguaggio derivante dal ricorso al predicato di verità. Tuttavia, sembra lecito fare del solo criterio minimale di adeguatezza la cifra di que-sta posizione da un punto di vista assiomatico. In par-ticolare, risulta adeguata a questo approccio una teoria assiomatica la cui parte aletica V coincida con la col-lezione delle istanze dello schema (T) per ogni elemen-to di un insieme fissato di enunciati A del linguaggio (fatta salva la consistenza). Supponiamo di indicare questa posizione con il termine decitazionismo (dall’in-glese disquotationalism) cui solitamente ricorre la let-teratura. Il decitazionista condivide con il deflazionista l’idea che il predicato di verità contribuisca all’espres-sività del linguaggio limitatamente alle generalizzazioni e alle sottoscrizioni cieche. A parte ciò, egli tuttavia non gli riconosce altro ruolo se non quello di veico-lare il passaggio dalla menzione degli enunciati al loro uso. In questo senso, il decitazionista condivide con il deflazionista anche l’opinione sulla non sostanzialità del predicato di verità. Tuttavia, egli lo fa in modo chia-ro, senza impegnarsi in alcun modo relativamente alla sua «neutralità metafisica». Ci sia consentito perciò di guardare al decitazionismo come a una forma debole di deflazionismo. A livello assiomatico, l’indebolimen-to del quadro filosofico sembra rendere il decitazioni-sta maggiormente in grado di individuare un sistema d’assiomi che sia un’interpretazione esatta delle proprie istanze filosofiche. Il § 3 sembra risolvere tutto ciò che potrebbe destare preoccupazione, cioè la verifica che la scelta degli assiomi evidenzino il ruolo del predicato di
Il deflazionismo. Tempo di bilanci? 325
verità rispetto all’espressione di congiunzioni infinite. Il decitazionista, dunque, ha a disposizione una scelta tra varie teorie adeguate nel senso suddetto, considerando anche che, come per il deflazionista, gli assunti filosofi-ci sembrano renderlo libero di scegliere anche una teo-ria non tipata come una corretta interpretazione assio-matica della propria posizione.
Come si diceva, la situazione è diversa per il defla-zionismo. In particolare, continua a risultare problema-tica la trasposizione di un’idea di verità che non abbia un impatto ontologico o conoscitivo significativo. Ma il «caso decitazionista» insegna quantomeno che il tenta-tivo di coniugare l’urgenza filosofica con il rigore della logica non è senza speranza.
A ben vedere, in effetti, gli stessi risultati qui consi-derati, se sommati a quanto si è appena ricordato rela-tivamente al decitazionismo, suggeriscono un possibile spunto di riflessione dal quale far ripartire il dibattito. Una volta esclusa la conservatività dal novero dei criteri utili alla disamina, il deflazionista potrebbe notare che la pluralità di proposte assiomatiche discende dal grado di libertà che si ha nel fissare l’insieme A di enunciati che consente il rispetto del criterio di adeguatezza. La scel-ta tra esse si riconduce, in fin dei conti, alla condizio-ne che fissa tale insieme di enunciati. Si potrebbe allora argomentare che ciò che manca al deflazionismo è una giustificazione più efficace di una scelta in questo senso. È possibile immaginare come formulare una simile giu-stificazione? È possibile, ad esempio, che il deflazionista possa trovare una giustificazione concettuale profonda per la restrizione dello schema (T) a tutte e sole le for-mule T-positive? Oppure si tratta di un approccio trop-po riduttivo al problema?
In alternativa, e in modo più radicale, il deflazionista potrebbe decidere di rivedere seriamente i propri assun-ti di partenza. Ad esempio, alla luce dei risultati dell’in-dagine logica egli potrebbe concludere che dopotutto la verità è un concetto sostanziale, o almeno risulta tale in una misura superiore alle attese: per il fatto di incidere,
Riccardo Bruni326
poniamo, sulle assunzioni ontologiche legate alla scelta di un dato linguaggio.
Com’è ovvio, sciogliere il dilemma è un compito che spetta in primo luogo ai sostenitori della teoria deflazio-nista. Sembra inevitabile, tuttavia, che si debba passare dalla considerazione di simili problematiche per rilancia-re un dibattito che si è finora rivelato assai ricco e sti-molante.
Summary. Deflationism. Time for a Balance?
This paper considers issues that connect the philosophical discussion about the nature of truth with logical investigations over the outcoming truth theories. In particular, we focus on topics related to the evaluation of defla-tionism, which is possibly the most popular and debated view in the field at the moment. Beside the general discussion on the axiomatic approach to the problem (as opposed to others, such as the semantical one), we explain how the (philosophical) ideas of truth contributing to the expressivity of langua-ges, and truth being insubstantial have been interpreted at the formal level. Finally, this is used for supporting the opinion according to which deflatio-nism still lacks some conceptual analysis that could make it more definite as a viable way to truth.
Keywords: Deflationism, Theories of Truth, Conservativeness.