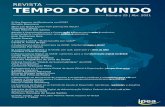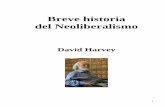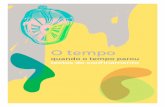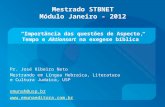corriamo, corriamo perocché il tempo è breve - Gli Asini
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of corriamo, corriamo perocché il tempo è breve - Gli Asini
corriamo, corriamo perocché il tempo è breve
MENSILE - ANNO X - NOVEMBRE 2019 - POSTE ITALIANE SPA SPEDIZIONE IN A.P. D.L.353/03(CONV IN L.27/02/2004 N°46)ART.1 COMMA 1 AUT C/RM/04/2013 € 12
SABINO CASSESE: UN PAESE FERMOGIOVANI ECOLOGISTI A VENEZIA
GRETA THUNBERG ALL’ONULE CAUSE DELLE CRISI INDUSTRIALI
LOTTARE PER LA GIUSTIZIA AMBIENTALEROMA, LA CITTÀ DEGLI ALTRI
GIUSEPPE DE RITA:DISCONTINUITÀ E CONTINUISMO
AMITAV GOSH NELL’ISOLA DEI FUCILILE ELEZIONI IN ISRAELE
AFGHANISTAN, TRA GUERRA E DEMOCRAZIACAPIRE MEGLIO LE MIGRAZIONI AFRICANE
UN DOCUMENTO SU ADULTERIO E ABORTO IN MAROCCO
SALVATORE MANNUZZU TRA LETTERATURA E POLITICA
TUTTO IL PEGGIO DELLA SCUOLAL’OSSESIONE BUROCRATICA E LA FORMAZIONE LE CONTRADDIZIONI DEL SOSTEGNODOPO BASAGLIAPERICOLO ROM O ROM IN PERICOLO?LE ULTIME POESIE DI JOHN ASHBERYPIERO SCARAMUCCI, GIORNALISTALE RADIO LIBERE DEGLI ANNI SETTANTAALEX GIBNEY E L’ARTE DEL DOCUMENTARIOI MARGINALI NEL CINEMA DI ANGIUSVERGOGNARSI GUARDANDO TARANTINOLE PAROLE INTRADUCIBILI DI CRISTINA ALI FARAHSULL’ARTE DEL ROMANZO:R.L. STEVENSON CONTRO HENRY JAMESI RICCHI E I POVERI DI ARMIN GREDER
UN GRANO DI SAGGEZZASABINO CASSESE, GIUSEPPE DE RITA
ALI FARAH | ANGIUS | ASHBERY | BANDIERA | BATTISTON | BATTOCLETTI | BETTIN | BRAZZODURO | CALLEDDA CASSESE | COSSU | DE RITA | “FUORIMERCATO” | GAGLIARDI | GARIBALDO | GHOSH | GIACCHÈ | GIANOLA | GIBNEY GOBETTI | GRAZIANI | GREDER | D. LERNER | G. LERNER | MCKEON | MONTEROSSO | MORREALE | NADOTTI PECORARO | PETACCIA | PIVETTA | STEVENSON | THUNBERG | VELOTTI | UN MANIFESTO DAL MAROCCO
ISBN 978-88-6357-302-2
9 788863 573022 >
69 | 2019 novembre
Tra bianco, nero e colore, Davide Reviati con ritmo incessante e un segno materico, visionario e realista, dipinge con empatia e tensione il gioco di un bambino e la violenza della guerra in uno dei più intensi racconti del maestro dell’horror Ambrose Gwinnett Bierce
EELS
L’INNOCENZA DEL GIOCO DI UN BAMBINO SI TRASFORMA NELLA PIÙ CRUDA REALTÀ DELLA GUERRA
La citazione che dà il titolo a questo numero viene, anche se pochi saprebbero indovinarlo, da una sollecitazione più volte ripetuta da santa Caterina da Siena alle sue consorelle. Apriamo questo numero con una breve intervista a un maestro della nostra più rigorosa e concreta cultura italiana, Sabino Cassese, che risponde alla redazione sullo stato delle nostre istituzioni. Gianfranco Bettin ragiona su cosa è cambiato con il crollo (che si spera definitivo) del salvinismo, Lorenzo Velotti enuncia da Venezia alcune novità sul fronte dell’ecologia, e abbiamo voluto riportare perché non vengano dimenticate le dichiarazioni di Greta Thunberg all’Onu. Francesco Garibaldo ci parla di stato dell’economia, italiana ed europea, mentre il gruppo di Fuorimercato invita a lottare per la giustizia ambientale e sociale. Francesco Pecoraro, autore di Lo stradone, un libro che abbiamo molto amato, ci parla di una Roma reale, di una capitale poco attendibile. Chiudiamo questa sezione con la lunga conversazione condotta da Piergiorgio Giacchè, con un altro grande personaggio della nostra cultura, Giuseppe De Rita del Censis, sul nostro presente italiano e sulla nostra storia politica. Da altrove, Amitav Ghosh, grande scrittore e grande amico, affronta il tema cruciale delle migrazioni di ieri e di oggi nel suo nuovo libro, L’isola dei fucili, rispondendo alle domande di Anna Nadotti e Norman Gobetti; David e Gad Lerner, figlio e padre, analizzano il recente voto israeliano e la situazione politica del paese; Giuliano Battiston ci aggiorna sulla situazione afghana; Nora McKeon spiega come le organizzazioni contadine dell’Africa occidentale vedono le migrazioni verso l’Europa. Chiudiamo questa sezione riportando l’autodenuncia di donne e uomini del Marocco sulla questione cruciale della legislazione sull’adulterio e sull’aborto. Per “Educazione e intervento sociale” ancora Giacchè commenta un importante saggio di Galli della Loggia sullo stato della scuola pubblica in Italia. Parlano di educazione anche Stefania Petaccia (le “scienze della formazione”, e a Bologna, ohibò) e Roberta Bandiera e Giovanni Monterosso sui corsi di formazione per insegnanti di sostegno. Amedeo Gagliardi apprezza lo studio sul dopo Basaglia di P.A. Rovatti e infine Marco Brazzoduro esamina le leggi che riguardano i rom. Passando alle arti, ecco alcune poesie del grande John Ashbery a cura di Damiano Abeni e Moira Egan, mentre Oreste Pivetta ricorda il nostro comune amico Piero Scaramucci, grande giornalista del ’68 e oltre, e animatore di Radio Popolare a Milano. Alex Gibney, grande documentarista, risponde alle domande di Cristina Battocletti; Costantino Cossu ha intervistato Bonifacio Angius, regista di film e documentari che hanno al centro figure di emarginati, mentre Emiliano Morreale si vergogna di aver visto il film di Tarantino, dei suoi fan e dei critici cinematografi suoi colleghi. Michela Calledda e Federica Graziani ricordano Salvatore Mannuzzu, scrittore, giurista, politico, nostro amico e collaboratore recentemente scomparso. Per le “Storie”, Rinaldo Gianola ricorda, pensando a Scaramucci, la bella storia delle radio libere degli anni Settanta e Cristina Ali Farah, parte dalla sua esperienza di immigrata tra immigrati e nelle scuole di italiano che ha conosciuto, per elencare e affrontare tante “parole intraducibili”. Per “I doveri dell’ospitalità” abbiamo ripescato dal fondo dei nostri scaffali la bella risposta di R.L. Stevenson alle opinioni del raffinatissimo Henry James sull’arte del romanzo: una divergenza tra grandi da confrontare con le sciocche diatribe tra i letterati di oggi. Illustrano questo numero le immagini forti e provocatorie di Armin Greder che mettono a confronto le infanzie dei poveri e quelle dei benestanti.
Mensile · anno X · n. 69, novembre 2019viale Carlo Felice 89 – 00185 Romatel. [email protected] www.gliasinirivista.orgwww.asinoedizioni.it
Edizioni dell’asinoDistribuzione Messaggerie libri
Redazione: Goffredo Fofi (dir. resp.), Sara Honegger, Federica Lucchesini, Luigi Monti, Mimmo Perrotta, Nicola Villa, Gabriele Vitellocon Sara Giannessi, Giorgio Laurenti, Davide Minotti e Ilaria Pittiglioe con Damiano Abeni, Fulvia Antonelli, Mirella Armiero, Livia Apa, Simona Argentieri, Maria Baiocchi, Cristina Battocletti, Mau-ro Boarelli, Giacomo Borella, Maurizio Braucci, Marisa Bulgheroni, Valentina Calderone, Michela Calledda, Vinicio Capossela, Roberta Carlotto, Franco Carnevale, Simone Caputo, Marco Carsetti, Matteo Cesaro, Domenico Chirico, Francesco Ciafaloni, Giacomo D’Alessandro, Emanuele Dattilo, Gemma de Chirico, Nicola De Cilia, Gianluca D’Errico, Enzo Ferrara, Giancarlo Gaeta, Marina Galati, Marco Gatto, Andrea Gava, Piergiorgio Giacchè, Vittorio Giacopini, Rinaldo Gianola, Alex Giuzio, Stefano Guer-riero, Grazia Honegger Fresco, Andrea Inzerillo, Stefano Laffi, Nicola Lagioia, Luca Lambertini, Franco Lorenzoni, Luigi Manconi, Pietro Marcello, Giulio Marcon, Roberta Mazzanti, Taddeo Mecozzi, Paolo Mereghetti, Bruno Montesano, Giuseppe Montesano, Giorgio Morbello, Emiliano Morreale, Jan Mozetic, Maria Nadotti, Fabian Negrin, Lea Nocera, mons. Raffaele Nogaro, Sara Nunzi, Fausta Orecchio, Claudio Paravati, Damiano Pergolis, Oreste Pivetta, Giacomo Pontremoli, Savino Reggente, Alberto Rocchi, Alice Rohrwacher, Nicola Ruganti, Rodolfo Sacchettini, Iacopo Scaramuzzi, Antonella Soldo, Paola Splendore, Nadia Terranova, Alessio Trabacchini, Marco Triches, Manuela Trinci, Sandro Triulzi, Emilio Varrà, Lorenzo Velotti, Stefano Velotti, Serena Vitale, Dario Zonta e Giovanni Zoppoli.
Collaboratori: Gemma Adesso, Giorgia Alazraki, don Vinicio Albanesi, Nicola Alfiero, Anna Antonelli, Andrea Baranes, Cecilia Bartoli, Giuliano Battiston, Marcello Benfante, Stefano Benni, Ginevra Bompiani, Vando Borghi, Beatrice Borri, Giulia Bussotti, Silvia Calamandrei, Giulia Caminito, Rosa Carnevale, Simona Cappellini, Cecilia Cardito, Roberto Carro, Roberto Catani, Serena Chiodo, Francesco Codello, Nunzia Coppedé, Costantino Cossu, Dario Dell’Aquila, Gigi De Luca, Giorgio De Marchis, Carlo De Maria, Stefano De Matteis, Lorenzo Donati, Gianluca Farinelli, Nicola Galli Laforest, Guido Gattinara, Roberto Keller, Alessia Lanunziata, Giacomo Manconi, Fabiano Mari, Marcello Mariuzzo, Emanuele Maspoli, Valerio Mastandrea, Lorenzo Mattotti, Ni-cola Missaglia, Niccolò de Mojana, Giorgio Morbello, Grazia Naletto, Mimmo Paladino, don Giacomo Panizza, Roberta Passoni, Lorenzo Pavolini, Andrea Petrucci, Giordana Piccinini, Fabio Piccoli, Carla Pollastrelli, Paolo Ricca, Chiara Rocca, don Achille Rossi, Maria Salvati, Matteo Schianchi, Chiara Scorzoni, Ambretta Senes, Gianluigi Simonetti, Marco Smacchia, Carola Susani, Francesco Targhetta, Simone Tonucci, Stefano Trasatti, Miguel Angel Valdivia, Giulio Vannucci, Cristina Ventrucci, Giorgio Villa, Edoardo Winspeare, Duccio Zola.
Progetto grafico orecchio acerboL’asino in prima pagina è di Gianluigi Toccafondo.
Per informazioni: [email protected] collabora su invito della redazione, i manoscritti non vengono restituiti.L’editore rimane disponibile ad assolvere i propri impegni nei confronti dei titolari di eventuali diritti.
Abbonamento solo digitale (pdf, epub, mobi) € 39Abbonamento Italia cartaceo + digitale € 79Abbonamento estero Europa cartaceo + digitale € 159Abbonamento estero resto del mondo cartaceo+ digitale € 199 Iban IT 30 A 05018 03200 000011361177 intestato ad Asino srl, causale: abbonamento annuale rivista gli asini. Conto corrente postale 001003698923. Carta di credito sul sito http://www.asinoedizioni.it/abbonamenti Paypal [email protected] oppure paypal.me/EdizioniAsino Abbonamento settimanale (1,5 euro a settimana con Paypal) http://www.asinoedizioni.it/products-page/abbonamenti/abbonamento-settimanale/ Abbonamento mensile (6,6 euro al mese con Paypal) http://www.asinoedizioni.it/products-page/abbonamenti/abbonamento-mensile/ Scarica il modulo per addebito diretto Sepa e paga a rate il tuo abbonamento http://www.asinoedizioni.it/wp-content/uploads/Mandato-per-addebito-diretto-SEPA.pdf
Geca industrie grafiche via Monferrato, 54 20098 San Giuliano Milanese MI. Finito di stampare nel mese di ottobre 2019Registrazione presso il Tribunale di Roma 126/2012 del 3/5/2012
69 | 2019 novembre
IN CASA 4 Un paese fermo di Sabino Cassese 7 Dubbi su Conte 2 di Gianfranco Bettin 9 Un campeggio climatico a venezia di Lorenzo Velotti11 Le cose cambieranno, signori del pianeta di Greta Thunberg12 Lavoro: export e cause delle crisi industriali di Francesco Garibaldo 15 Non esiste un pianeta b del Gruppo agroecologia di Fuorimercato17 Roma. Appunti sulla città degli altri di Francesco Pecoraro21 Come cambia l’Italia. Discontinuità e continuismo di Giuseppe De Rita incontro con P. Giacchè
PIANETA27 L’isola dei fucili. Migranti di ieri, migranti di oggi di Amitav Ghosh incontro con A. Nadotti e N. Gobetti 31 Le elezioni in Israele non c’è solo Netanyahu di Davide e Gad Lerner 33 Afghanistan. Guerra e democrazia di Giuliano Battiston 38 Dall’Africa. Contadini e migranti di Nora McKeon 45 Dal Marocco: siamo fuorilegge nel nostro paese di Leila Slimani e Sonia Terrab EDUCAZIONE E INTERVENTO SOCIALE
46 Tutto il peggio della scuola italiana di Piergiorgio Giacchè 49 Un’esperienza di formazione? di Stefania Petaccia 53 Le contraddizioni del sostegno a scuola di Roberta Bandiera e Giovanni Monterosso 56 Dopo basaglia. un saggio di P.A. Rovatti di Amedeo Gagliardi 58 Pericolo rom o rom in pericolo? di Marco Brazzoduro
POCO DI BUONO 62 Sembrare va quasi bene come essere, a volte di John Ashbery 67 Piero Scaramucci. Un ricordo di Oreste Pivetta 69 L’arte del documentario di Alex Gibney incontro con C. Battocletti 72 Un cinema che narra i marginali di Bonifacio Angius incontro con C. Cossu 76 Vergognarsi guardando Tarantino di Emiliano Morreale 79 Salvatore Mannuzzu tra letteratura e politica di Michela Calleda e Federica Graziani STORIE 83 Quelle radio degli anni Settanta di Rinaldo Gianola 85 Le parole intraducibili di Cristina Ali Farah
I DOVERI DELL’OSPITALITÀ 91 Umile rimostranza sull’arte del romanzo: R.L. Stevenson contro Henry James di Robert Louis Stevenson
I disegni di questo numero sono di Armin Greder tratti da Noi e loro (Else e Orecchio acerbo 2019)
corriamo, corriamo perocché il tempo è breve
4
GLI A
SINI 69
ruolo più attivo delle classi dirigenti. Le collet-tività sembrano oggi esser divenute apatiche. Le classi dirigenti prigioniere della politica dei ruoli e degli schieramenti, invece che della politica dei programmi. Il punto di partenza dovrebbe essere la riscoperta di nuove conso-nanze tra classi dirigenti e popolazione, che richiede un impegno reciproco. E richiede an-che l’abbandono di una mitologia anti-elitista che, partendo dalla polemica contro la “casta”, ha preso piede in Italia. Le élite sono indispen-sabili: ciò che importa è che siano aperte. Solo grazie alle élite aperte si può avere vera egua-glianza, nel senso di pari opportunità.
Negli ultimi decenni si stanno affermando molte esperienze di democrazia diretta, partecipativa e deliberativa che riprendono vecchie pratiche o ne mettono in campo di nuove – dal sorteggio, ai referendum, all’utilizzo delle piattaforme in-formatiche –, ma che sono tutte accomunate dal superamento dei partiti, della delega e della tra-dizionali formule della rappresentanza politico-elettorale come strumenti privilegiati di aggre-gazione, mediazione, sintesi e trasmissione degli interessi e delle domande sociali. Come giudica queste esperienze? Quali sono i loro pregi e i loro limiti?
I cambiamenti sociali, economici e cultu-rali della nostra società stanno mettendo a dura prova la legittimazione e forse la tenuta stessa delle istituzioni democratiche. L’aumento delle disuguaglianze, i perduranti effetti negativi della crisi del 2008 sulla finanza pubblica (vincoli di bilancio, contrazione della spesa pubblica e del welfare), la trasformazione del lavoro e dei si-stemi di comunicazione di massa, la frammen-tazione del tessuto sociale, l’invadenza e la co-lonizzazione del mercato rispetto alle sfere della riproduzione sociale generano diffusi sentimenti di frustrazione, risentimento e sfiducia popolare che si traducono a livello politico in una sem-pre più marcata astensione e volatilizzazione del voto, nella polarizzazione del dibattito pubblico e istituzionale, fino a un vero e proprio sdoga-namento di posizioni xenofobe e razziste. In un quadro come questo di impoverimento e preca-rietà di larghe fasce della popolazione, di insta-bilità politica, di imbarbarimento delle relazioni sociali e culturali – un quadro allarmante, che potremmo definire di “crisi sistemica” – come può rigenerarsi la democrazia? Da dove ripartire, con quali strumenti e stelle polari?Il punto di partenza non può che esser quello della partecipazione delle collettività alla de-terminazione delle loro sorti, seguito da un
IN CASAUN PAESE FERMO
DI SABINO CASSESE
INTERVISTA A CURA DELLA REDAZIONE DEGLI ASINI
5
IN CASA
GLI A
SINI 69
zare lo Stato del benessere: abbiamo bisogno di un nuovo Beveridge.
Quanto crede che possa durare un’Europa che come si diceva dell’Italia è stata fatta ma non sono stati fatti gli europei? Un’Europa che si tiene in piedi ma non cammina in avanti? che non è uno Stato e ancora meno un Divenire? che fa solo trattative e non ha un processo o un disegno comune se non difensivo e necessitato dagli ordini di grandezza di altri Stati e Sviluppi?Non condivido il giudizio negativo sullo svi-luppo dell’Europa, implicito nella domanda. L’Unione europea è un grande successo: ha evitato le ecatombi della prima parte del seco-lo scorso. È un potere pubblico che si è affer-mato in mezzo secolo, mentre gli Stati si sono affermati in un arco di tempo oscillante tra tre e cinque secoli. Infine, interi settori legislativi, come quello ambientale, in Italia, sono tribu-tari dell’Unione europea. Tutti circoliamo libe-ramente nell’Unione. Gli studenti universitari fanno esperienza all’estero, abbiamo a Firenze un Istituto universitario europeo. Guido Cala-bresi ha osservato qualche anno fa che gli Stati dell’Unione europea sono più uniti di quelli degli Stati Uniti d’America (in questi ultimi gli Stati sono divisi sulla pena di morte, cosa che non accade nell’Unione europea).
Come crede possa rinascere e poi formarsi una classe dirigente degna di questi due nomi, una classe che non sia acqua, e un dirigere che ab-bia una direzione di senso e delle competenze reali?Solo con un massiccio investimento nell’istru-zione, un diritto trascurato finora. L’istruzione produce un “people’s empowerment”, libera i cittadini da una strettoia da cui dipendono benessere, sviluppo, progresso, civiltà. Uno studio recente compiuto da uno studioso ita-liano negli Usa ha mostrato che è dal livello di istruzione e non da quello di reddito che dipendono benessere, assenza di criminalità, condizioni di vita, relazioni con gli altri.
Giudico positivamente le esperienze di demo-crazia deliberativa o partecipativa (di cui stra-namente non si parla in Italia), negativamente quelle di democrazia referendaria (perché si prestano a manipolazioni e sfruttamento in senso plebiscitario). La democrazia partecipa-tiva richiede un centro che prende le grandi decisioni (il Parlamento). Le periferie informa-no, consultano, ascoltano le comunità locali. La democrazia referendaria ha in sé due ele-menti negativi. Tende a escludere il dialogo, la riflessione, la discussione. Si presta a un uso plebiscitario (si pensi soltanto al referendum del 2016 e all’uso che se ne è fatto). Nel 1995 Christopher Lasch scrisse: “La difficol-tà di porre dei limiti al potere della ricchezza fa capire che è la ricchezza stessa che deve esse-re limitata. Quando il denaro parla, tutti sono costretti ad ascoltare. Per questo una società de-mocratica non può permettere un’accumulazio-ne illimitata”. Alla luce del forte e costante au-mento delle disparità economiche e sociali a cui stiamo assistendo da anni in Italia e in molti altri paesi, quanta diseguaglianza può soppor-tare la democrazia?Penso che vadano innanzitutto valutate accu-ratamente le diseguaglianze. La maggior parte dei calcoli tiene conto solo dei redditi. Biso-gna valutare l’effetto del sistema fiscale (della progressività). E calcolare l’effetto delle go-vernment largess, cioè dei trasferimenti diretti a ridurre le diseguaglianze, in attuazione del principio di eguaglianza in senso sostanziale. Bisogna mettere questi elementi nel conto delle diseguaglianze, altrimenti – per un pa-radosso – non si mettono nel conto delle di-seguaglianze proprio gli effetti delle istituzioni che in un secolo sono state introdotte – sotto la pressione delle forze popolari, per assicura-re l’eguaglianza sostanziale. Una volta valutate attentamente le diseguaglianze, ne vanno stu-diate le cause, che non risalgono alla globaliz-zazione, ma vanno cercate nei cambiamenti tecnologici in corso, che stanno modificando il lavoro e i lavori. Fatto questo, occorre raffor-
6
GLI A
SINI 69
IN CASA
La riduzione dei parlamentari è un chiaro at-tacco alla democrazia rappresentativa, ma può anche avere una giustificazione razionale: da mezzo secolo abbiamo venti ulteriori legisla-tori, i consigli regionali, che fanno lo stesso mestiere del Parlamento, ed è quindi ragione-vole ridurre i membri di quest’ultimo. Resta-no i problemi successivi: leggi da modificare di conseguenza e formula elettorale.
Per iniziativa di Ugo Mattei e Alberto Lucarel-li il disegno di legge su “beni comuni, sociali e sovrani” elaborato dalla cosiddetta commissione Rodotà è stato riproposto quale progetto di legge di iniziativa popolare. Qual è la sua opinione in merito a tale iniziativa e, più in generale, qual è la sua posizione sul tema dei beni comuni?La corrente favorevole a una normativa sui beni comuni ha scoperto in ritardo, sotto l’in-fluenza di studiosi stranieri, istituti che esiste-vano in Italia da secoli, le proprietà collettive, gli usi civici. Preferirei rafforzare gli istituti che abbiamo, piuttosto che inseguire mode stra-niere. Aggiungo che le condizioni del nostro Paese in molti casi impongono l’esercizio pri-vato di servizi, perché quello pubblico finisce con il degrado, che incentiva il ricorso paralle-lo a succedanei offerti dal settore privato.
La politica c’entra fino a un certo punto, il Par-lamento è diventato uno stadio di tattiche tra-sformiste e un giardino di infanzia grillino, ma la cultura non quella dello spettacolo ma quella politica dov’è finita?C’è, ma è rinchiusa nelle accademie. È spesso debole per aver per troppo tempo ignorato lo studio della realtà. È debole per eccessiva chiu-sura nei saperi disciplinari. Ma anche i mezzi di comunicazione sono responsabili di questo “tradimento dei chierici”, perché non li chia-mano a sufficienza a esprimersi.
Nel 2016, lei ha curato una raccolta di Lezioni sul Meridionalismo (Il Mulino), con interven-ti su Salvemini, Dorso, Rossi-Doria e gli altri grandi meridionalisti, notando che le istituzioni e le norme formali vanno necessariamente calate nelle differenti realtà sociali ed economiche. Con questa consapevolezza, come è possibile inter-venire nella realtà sociale e nelle istituzioni del Mezzogiorno, per colmare il persistente divario Nord-Sud?Sarebbe necessaria una nuova Cassa per il Mez-zogiorno, cioè una concentrazione straordina-ria di risorse umane e finanziarie su obiettivi chiari, con tempi definiti. L’attuale frammen-tazione delle energie su tre livelli (Europa, Sta-to, regioni) si sta rivelando poco funzionale.
Il populismo ha già vinto? Il taglio dei parlamen-tari (senza alcuna motivazione razionale e fuo-ri da qualsiasi contesto di riforma elettorale), la riduzione indiscriminata dei vitalizi/pensioni, il ridimensionamento drastico del ruolo del Parla-mento, il referendum propositivo senza quorum, l’esasperazione personalistica delle leadership, il discredito nei confronti della politica: si tratta di altrettante forme di demagogia con tendenze plebiscitarie e autoritarie che hanno fatto del po-pulismo l’ideologia dominante. Ciò a prescindere da mutamenti istituzionali e riforme di sistema. Il taglio del numero dei parlamentari, posto come condizione da M5stelle per la realizzazione del programma di governo segnala che, in ogni caso, il populismo ha già vinto?
7
IN CASA
GLI A
SINI 69
nale non aveva fatto vincere nessuno, in termi-ni di seggi e di potere di coalizione, di capacità di aggregare una maggioranza. Le elezioni e, prima, il sistema elettorale avevano prodotto un parlamento discorde, con tre poli, M5s, centrosinistra e centrodestra, quest’ultimo già scosso però dalla rivalità tra Forza Italia e Lega, con Salvini ad aver superato Berlusconi e in grande spolvero di fronte alle nuove camere e disposto ad affrontare anche da solo la que-stione del governo, tanto più dopo che il Pd si era lasciato sdraiare sul divano dei pop-corn da Renzi, fuori gioco. Pensava, il Pd, che il Conte 1 andasse a sbattere e aveva deciso che si poteva far pagare al Paese il prezzo dei suoi errori, del-le sue inaudite derive xenofobe, razziste, au-toritarie, della regressione politica e culturale, e perfino morale, che ha avviato e proseguito per mesi e mesi. Non aveva messo in conto che, in realtà, orientare i peggiori umori del paese dalla postazione del governo, in primis dal Viminale ma non solo, significava anche legittimare quegli umori, spalancare loro porte e finestre e piazze, e mamma Rai, consolidar-li, diffonderli. E portare Salvini verso il 40%, con Meloni pure gonfiata, e tutto il seguito di destre estreme e fascisti ringalluzziti, con l’ap-plauso di ceti popolari ingannati e ben dispo-sti, peraltro, a farsi ingannare. Mentre, poi, la caduta verticale dei 5stelle non recava che mi-seri recuperi di voti a sinistra. Un calcolo sbagliato, rivelatore della poca lu-cidità, della miseria della stessa presunta spre-giudicatezza politica dei maggiorenti del dopo elezioni. Non si gioca a scacchi mangiando pop-corn, al massimo si guardano le partite degli altri.Ma oggi, appunto, dopo la svolta dell’estate, quei limiti potrebbero gravare sulla sorte non di un’opposizione scolorita bensì sulla sorte di chi ha in mano le leve del governo. In questo senso, preoccupano molto di più. Le diversi-tà potrebbero essere affrontate e risolte in un quadro di consapevolezza storica che favorisse uno sguardo comune più alto, più comples-so, soprattutto avvertito delle vere emergen-
DUBBI SU CONTE 2DI GIANFRANCO BETTIN
Al netto del Grande Sollievo – Salvini fuori dal Viminale, la Lega via dal governo –la nascita e i primi passi del governo Conte 2 evidenziano tutti i limiti che avevano portato, prima, alla formazione del Conte 1 e, poi, alle infamie che ha prodotto nei quattordici mesi della sua esistenza. I limiti, anche, per cui non promette, infine, molto di buono per il pros-simo futuro. Un governo di questo tipo, di vera svolta, avrebbe bisogno di uno slancio, di un progetto anche solo abbozzato, intuìto, per compiere il salto necessario da ciò che inevitabilmente era al momento in cui è nato, cioè lo sbocco ob-bligato per chi voleva evitare le elezioni, e ciò che dovrebbe essere in base alle esigenze del Paese, cioè un governo di convergenza tra il meglio o il meno peggio della politica tradizio-nale e il di più che si è prodotto nella politica “alternativa”, quindi tra Pd e sinistra e Movi-mento 5 Stelle. Solo un simile sforzo potrebbe garantire che la svolta di questa sorprendente estate produca qualcosa di più che un accroc-co tra terrorizzati e/o una manovretta dei più furbi, Renzi in testa, opportunisti come Paolo Rossi in area di rigore di fronte alla prepotenza autolesionista di Salvini al Papeete. Che cosa spinge a dubitarne? Intanto, se que-sto sforzo fosse davvero nelle corde dei pro-tagonisti dell’attuale scena di governo, se vi fosse nel loro bagaglio politico la consapevo-lezza che operazioni del genere possono dav-vero avere un senso più profondo, un respiro più largo e un orizzonte più ampio, e insom-ma una necessità in un certo modo storica, ci avrebbero provato sul serio già all’indomani delle elezioni politiche del 2018. Il proporzio-
8
GLI A
SINI 69
IN CASA
mare a salvare le vite; l’impegno di chi, maga-ri piccola minoranza, non cessa di ragionare sul presente e sul futuro, in un gruppo, una rivista, un’associazione, uno spazio in rete, un luogo di incroci e di pensieri lunghi e pratiche concrete. Anche un movimento grande, gran-dissimo, guidato, suscitato da una ragazzina, apprezzabile anche per come se ne frega dei babbioni che le fanno la spiega, a lei, fingendo di non essere – spesso – i falliti che sono. Anche di fronte a questo il governo non è an-dato al di là di parole, proseguendo anzi finora sulla scia di quanto già faceva il Conte prece-dente. Ma su di esso non può dire che si pro-ietti qualche spinta da fuori, dal basso, al di là di quel che si è appena ricordato e che coinvol-ge realtà ristrette (FridaysForFuture a parte).L’estate ha sorpreso e fatto respirare, ma la sta-gione in corso, fin qui, è ancora senza svolta.
ze del tempo: la crisi climatica e ambientale, la povertà cresciuta in questi anni, il divario nell’accesso alle opportunità della formazione e della conoscenza, le derive sociali innescate dalla crisi di dieci anni fa e (quasi) mai rien-trate, il drammatico urgere della crisi globale, planetaria nei suoi effetti socio-economici, de-mografici, migratori e ambientali.Il nuovo governo che abbiamo visto finora all’opera non sembra affatto nuovo, a questo proposito. Vivacchia, (si) concede qualche bo-nus, spese rivolte a questo o quel settore, molti annunci, una cornice presunta di diversità e di svolta, ma in effetti non sembra discostarsi dal solito andazzo. Non lo fa nelle politiche concrete, nei capitoli di spesa e nelle priorità operative dell’agenda politica. Lo si può, for-se, capire: non sono certo superate le difficoltà della finanza pubblica, dei vincoli comunitari, del peso del debito. Ma non accade nemmeno sul piano della visione generale, della cultura politica che muove e ispira e fa parlare il gover-no. È un problema dei partiti che lo sostengo-no e lo compongono, dei loro rappresentanti. Ma è anche un affare di chi li ha eletti, votati, di coloro che, pure, hanno festeggiato la cac-ciata di Salvini dal Viminale e la “svolta” esti-va. Compiuta quest’ultima, sembra di essere tornati ai soliti giochini di corto respiro. Anzi, quella stessa svolta, ora, risulta sempre più il prodotto di un autogol piuttosto che l’esito o di una crisi oggettiva (quale, in fondo, è) o di una battaglia politica dell’opposizione. Tra le smanie megalomani del Papeete e la ri-presa di una politica di poco coraggio e basso profilo del nuovo governo, c’è lo spazio non colmato di un’attesa e di una speranza politi-ca. In quello spazio, magari perché era esta-te, nemmeno i movimenti, nemmeno le forze sociali, hanno saputo creare politica, imma-ginare orizzonti diversi, imporre, proporre, interpretare contenuti all’altezza della crisi e delle attese. È un vuoto che peserà. È stato in parte attraversato da alcune cose che un po’ di luce, a volte una luce purissima, la esprimono: il coraggio e la determinazione di chi resta in
9
IN CASA
GLI A
SINI 69
dell’iper-turistizzazione portata avanti da multi-nazionali parassitarie come Airbnb, è invasa da navi da crociera che, oltre a essere i mostri più inquinanti (202 navi inquinano come tutte le auto d’Europa), danneggiano gravemente l’eco-sistema lagunare così come le fondamenta della città, è minacciata dall’innalzamento del livello del mare nonché da una grande opera (contro l’innalzamento stesso) come il Mose, a sua vol-ta emblematico d’inutilità e dannosità di queste opere così come della corruzione che portano con sé. Ma i temi affrontati in quei giorni non si sono limitati a questo. L’agenda è stata ben più am-pia: dalle lotte indigene Mapuche raccontate da Moira Millàn all’ecotransfemminismo di Non Una Di Meno, dall’attivismo di Nnimmo Bassey contro le multinazionali del petrolio in Africa a quello del collettivo olandese Shell Must Fall, dall’ecologia politica di Emanuele Leonardi al tema delle migrazioni climatiche. Il merito è quello di aver tracciato la linea che unisce la lotta al patriarcato con quella all’estrattivismo, quella contro le grandi opere con il recente movimen-to contro i cambiamenti climatici, la critica alle invasioni turistiche con la rivendicazione della libertà di movimento per chi si muove per ne-cessità. Necessità, chiudendo il cerchio, in gran parte dovuta proprio al colonialismo, alla crisi climatica e all’estrattivismo.Il riconoscimento dell’intersezionalità di queste lotte è un enorme passo avanti che sembra es-sere sempre più evidente (finalmente) nell’im-maginario attivista italiano ed europeo. Così, in Italia, non solo i movimenti risultano rafforzati dalla convergenza delle lotte, ma riescono anche a superare divisioni che negli ultimi anni li han-no indeboliti incredibilmente rispetto ai propri colleghi europei. È questo, in qualche modo, il grande merito della crisi climatica ed ecologica: l’aver portato a galla, in teoria e in pratica, il filo che unisce tutte le lotte anticapitaliste che, forse una volta per tutte, riusciranno a lottare unite.Il fatto che al campeggio metà delle presen-ze provenisse da altri paesi europei di certo ha aiutato. Forte era la presenza di Ende Gelände,
Il campeggio climatico di Venezia, svoltosi dal quattro all’otto settembre al Lido di Vene-zia, rappresenta, a mio vedere, un fondamentale punto di svolta per i movimenti italiani e per le varie lotte in cui sono coinvolti. Occorre pre-mettere che scrivo con l’ingenuità – ma forse an-che il necessario distacco – di chi, pur conoscen-do la situazione italiana, vive all’estero da anni, e segue a distanza gli avvenimenti della penisola dove torna solo saltuariamente. Un’ottima oc-casione per tornare, tuttavia, è stata offerta dal primo “campeggio climatico” in Italia, alla quale ho partecipato con una serie di aspettative che, con mio piacere, sono state pressoché del tutto esaudite. Prima un po’ di contesto: il lancio di un “cam-peggio climatico” è stato esplicitamente inspira-to da pratiche esistenti da tempo in vari paesi del nord Europa, dove i movimenti ecologisti e anticapitalisti convergono per alcuni giorni in campeggi autorganizzati orizzontalmente per conoscersi, fare rete, discutere, imparare gli uni dagli altri e, soprattutto, fare strategiche azioni dirette contro particolari obiettivi politici: dal-le miniere di carbone alle raffinerie, da vertici internazionali ai centri economici delle città. Non che questo tipo di attivismo sia stato del tutto inesistente in Italia (si pensi ai campeggi No Tav), ma a Venezia, per la prima volta, un appuntamento italiano ha assunto una dimen-sione europea, adottando l’inglese come lingua ufficiale e invitando partecipanti da tutta Euro-pa (più della metà dei presenti), nonché attiviste e attivisti da altri continenti.La scelta di Venezia non è un caso. Quest’ulti-ma è simbolo dell’intersezione tra le lotte eco-logiste e anticapitaliste. Venezia è infatti vittima
UN CAMPEGGIOCLIMATICO A VENEZIA
DI LORENZO VELOTTI
10
GLI A
SINI 69
IN CASA
tra gruppi con diversi orizzonti ideologici di ri-ferimento ma con comuni obiettivi ecologisti e anticapitalisti, possano ripetersi e moltiplicarsi lungo la penisola.Le alleanze fondamentali, tuttavia, non si limita-no a quelle rilevanti in particolare per le dinami-che interne del nostro fronte. Ce ne è un’altra, evi-dente per noi ma meno per chi scrive sui giornali e siede nelle istituzioni. Parliamo dell’alleanza tra i comitati territoriali e i giovani di Fridays for Fu-ture. I primi – No Grandi Navi, No Tav, No Tap, No Triv eccetera – sono i grandi nemici di ogni governo, o meglio: ogni governo è loro nemico, perché minacciano lo sviluppismo, l’ideologia che accomuna le destre alle cosiddette sinistre. Grandi opere, crescita e sviluppo economico, mentre la giustizia ambientale e l’autodetermina-zione dei territori vengono ignorate mentre chi le difende viene accusato di essere la retrograda “Italia del no”. Meravigliosamente, l’ala sinistra del partito unico della crescita, appartenente alla corrente “capitalismo verde”, è tuttavia fanati-ca dei secondi: di Greta e di Fridays for Future, tanto da, per esempio, invocare la giustificazione delle assenze scolastiche delle giovani scioperanti del 27 Settembre. Ecco qui come la tattica del dilemma colpisce ancora, perché il campeggio è stato organizzato dal comitato No Grandi Navi insieme a Fridays for Future e ha visto sventolare bandiere No Tav tra le amiche e gli amici di Gre-ta, rompendo la divisione che si cerca di imporre tra manifestanti buoni e manifestanti cattivi, Ita-lia del no e “giovani che ereditano il futuro”. Da che parte sta, ora, il partito della crescita coi suoi ministri, se da questa parte della barricata siamo tutti ecologisti, antiestrattivisti, ecotransfemmi-niste, anticolonialisti e anticapitalisti? Il più grande merito di questo campeggio è stata dunque la rottura, in Italia, di molte barriere che hanno finora diviso e danneggiato le lotte per la gioia di chi, nel frattempo, faceva profitto. Così, mentre rompiamo queste barriere, disegniamo insieme la sempre più chiara linea di demarca-zione tra gli sviluppisti capitalisti estrattivisti (per quanto green vogliano sembrare) e noi, che lottiamo per un sistema interamente diverso.
dalla Germania, anch’esso una convergenza di movimenti piuttosto che un movimento vero e proprio. Il loro consiglio è stato fondamentale per le azioni dirette, che si fondano su orizzonta-lità e consenso e su un’organizzazione puntuale. Azioni profondamente mediatiche pianificate intorno alla strategia del dilemma piuttosto che sugli scontri diretti con la polizia. In altre parole, azioni intelligenti che mettano i nostri obietti-vi politici e le forze dell’ordine in un dilemma per cui qualsiasi scelta prendano, i vincitori, alla fine, siamo noi. È stata in gran parte questa, o per lo meno in questa direzione, la strategia per l’occupazio-ne del tappeto rosso. Alle cinque del mattino dell’ultimo giorno di festival del cinema, men-tre le guardie dormivano, abbiamo dato inizio alla giornata con un jogging sostenuto verso il red carpet. Elicotteri, celerini e giornalisti sono arrivati solo ore dopo. E a quel punto, di fronte a una massa festosa, colorata, pacifica, che re-sisteva cantando seduta sotto il sole e sotto gli occhi dei giornalisti di tutto il mondo, le no-stre forze dell’ordine, note internazionalmente per ragionevolezza e pacifismo, si sono trovate davanti al dilemma: fare una mattanza, metten-do in imbarazzo perfino il ministro Costa che per l’occasione ha dichiarato “siamo dalla stessa parte della barricata”, o lasciarci vincere. Hanno scelto la seconda. E così, la convergenza delle lotte non è stata li-mitata ai contenuti ma si è estesa a pratiche e strategie, tradizionalmente separate dalla sta-tica linea che divide violenza e non violenza. La coesistenza di gruppi anarchici europei e di gruppi italiani che anarchici non sono è stata resa possibile dal fatto che, come succede all’e-stero, durante un’azione diversi blocchi di per-sone possano liberamente scegliere, con mutuo rispetto, di aderire a tattiche di diversa intensità, attenendosi solo a un previo consenso generale. Personalmente, ritengo si tratti di una prova di maturità il cui tempo era arrivato, un’esigenza richiesta dal momento storico in cui ci trovia-mo e da cui nessuno si dovrebbe più tirare in-dietro. Ho speranza che alleanze di questo tipo,
11
IN CASA
GLI A
SINI 69
Così Greta Thunberg, 16 anni, militante ecolo-gista, ha parlato ai leader mondiali durante il Summit sul clima delle Nazioni Unite tenuto a New York lunedì 23 settembre:
È questo il mio messaggio: vi terremo gli occhi puntati addosso.È tutto sbagliato. Io non dovrei trovarmi qui, ma a scuola, all’altro capo dell’oceano. Eppu-re, chiedete ai giovani di sperare. Come osate! Con le vostre vuote parole mi avete rubato i sogni e l’infanzia. So bene di far parte dei pri-vilegiati. Le persone soffrono, muoiono, interi ecosistemi crollano. Siamo all’inizio di un’e-stinzione di massa e voi non sapete fare altro che parlare di soldi e di favole di continua cre-scita economica. Come osate!Sono più di trenta anni che la scienza è sta-ta molto chiara, ma voi continuate a guardare altrove, e venite qui a dirci che state facendo abbastanza quando non c’è alcun segno di po-litiche e soluzioni assolutamente necessarie.Dite che ci ascoltate e capite l’urgenza, ma per quanto mi arrabbi e mi deprima, non ri-esco a credere alle vostre parole. Perché se è vero che capite la situazione e continuate a non far niente, allora sareste l’incarnazione del male e mi rifiuto di crederlo.L’idea corrente di dimezzare le emissioni in dieci anni ci dà solo il 50% della possibilità di restare al di sotto di 1,5 gradi centigradi, con il rischio di innescare una reazione a catena irre-versibile, fuori dal controllo degli uomini. Il cinquanta per cento è forse accettabile ai vo-stri occhi, ma i vostri numeri non includono i momenti di crisi, la maggior parte dei cicli di
retroazione, il riscaldamento ulteriore nasco-sto dall’inquinamento tossico dell’aria, né le questioni di equità e giustizia climatica. Inol-tre, fanno affidamento ai miliardi di tonnellate di CO2 che la mia generazione dovrà estrarre dall’aria con tecnologie ancora inesistenti.Dunque non possiamo accettare un rischio del 50%, perché saremo noi a dovere convivere con le conseguenze.Secondo le migliori previsioni fornite dalla com-missione intergovernativa sul cambiamento cli-matico, per avere il 67 % di possibilità di restare al di sotto di 1,5° di aumento del riscaldamento globale, il mondo avrebbe dovuto emettere 420 gigatoni di CO2 entro il primo gennaio 2018. Quella cifra è oggi ancora sotto i 350 gigatoni. Come avete ancora il coraggio di fingere che questo possa risolversi senza cambiare niente e ricorrendo solo a qualche soluzione tecnica?Con il livello attuale di emissioni, il totale re-stante di CO2 sarà tra 8 anni e mezzo del tutto scomparso.Il motivo per cui oggi qui non sono stati pre-sentati progetti o soluzioni coerenti con que-ste cifre, è che queste sono troppo sgradevoli, e voi non siete in grado di dirci come stanno veramente le cose.Ci state ingannando, ma i giovani hanno co-minciato a capire il vostro tradimento. Le ge-nerazioni future hanno gli occhi puntati su di voi. E se decidete di ingannarci, vi dico: Non vi perdoneremo mai. Non vi permetteremo di farla franca. È qui, proprio ora, che diciamo basta. Il mondo si sta svegliando. Che lo vo-gliate o no, le cose cambieranno.Grazie.
LE COSECAMBIERANNO,
SIGNORI DEL PIANETADI GRETA THUNBERG
TRADUZIONE DI PAOLA SPLENDORE
12
GLI A
SINI 69
IN CASA
Il quadro europeo risente di una situazione dell’economia globale che sta sperimentando un rallentamento sincronizzato sia delle eco-nomie avanzate, sia dei mercati emergenti quali Brasile, Cile, Cina, Colombia, Filippine, India, Indonesia, Malesia, Messico, Perù, Rus-sia, Sudafrica, Tailandia, Turchia. Una delle cause principali è la guerra dei dazi tra Cina e Usa. In Europa pesano, infine, le scelte di con-tenimento generalizzato dei bilanci pubblici, criticato da Draghi, deciso nel pieno della crisi 2008-2018.Per dare un senso a queste notizie è bene com-prendere la struttura del sistema industriale dell’Unione Europea. Esso è ormai da quasi trent’anni un sistema integrato transnazionale. Ciò significa che, ad esempio, un’azienda ita-liana può decidere di investire in Spagna con finanziamenti francesi, o in Polonia con finan-ziamenti tedeschi; ciò dipende dalla libertà di circolazione dei capitali. Nel corso di trent’an-ni si sono quindi create delle filiere produttive – chiamate catene del valore – transnazionali; queste catene produttive non sono solo ma-nifatturiere, esse infatti hanno anche parti di servizi che vengono aggiunti al prodotto mani-fatturiero finale. Oggi, infatti, si parla di mani-fattura ibrida per indicare quei prodotti, come l’Iphone, dove l’oggetto materiale e i servizi che esso fornisce non sono separabili.Le catene del valore hanno due ragion d’essere principali. Una è quella di utilizzare le diffe-renze normative, legislative, fiscali e di costo del lavoro tra i vari paesi dell’Unione per ri-cavarne un vantaggio competitivo. La Germa-nia ha, ad esempio, spostato una quota delle sue attività industriali a est. In questi casi si ha in genere un flusso di semilavorati o parti dai paesi a più basso costo verso gli altri che com-pletano il processo con le parti nelle quali la differenza competitiva è data dalla tecnologia e la competenza industriale. La seconda riguar-da le specializzazioni produttive che spesso possono prescindere da ragioni di costo; è più costoso cercare di costruire ex novo una spe-cializzazione produttiva già esistente altrove
Draghi ha confermato il rallentamento dell’economia europea; il rallentamento ha il cuore nella manifattura. La manifattura euro-pea ha un punto centrale di agglomerazione in Germania. La Germania, infatti, ha detto Draghi, rappresenta il 28% del prodotto in-terno lordo della zona euro e il 39% del va-lore aggiunto dell’industria e, in Germania, il 23% del valore aggiunto prodotto viene dall’industria.La Germania che si sta avvicinando alla re-cessione tecnica, cioè con due trimestri con-secutivi di calo del pil, ha chiuso il 2009 con un -2% della produzione industriale e, secondo le stime degli industriali metalmec-canici tedeschi, chiuderà con il segno meno anche il 2020. Anche la Francia pur in una situazione migliore per la diversità del suo modello di esportazione, inizia a mostrare segni di una possibile incipiente contrazione industriale.L’Italia, a sua volta, ha il cuore industriale nel Nord e nei suoi distretti industriali che sono fortemente integrati con la struttura industria-le sia tedesca, sia, nel Nord-Ovest, francese.Essi stanno già sperimentando, se si confron-ta il secondo trimestre del 2018 con quello del 2019, dei cali sia se si guarda ai settori merce-ologici che ai principali distretti industriali. I cali più vistosi si hanno nei settori/distretti più legati al mondo dell’automotive.Ciò che preoccupa Draghi e gli analisti è il crescente “contagio”, a livello europeo, da parte dell’industria verso i servizi; se ciò tro-vasse conferma la situazione si farebbe mol-to seria anche per i paesi meno dipendenti dall’industria.
LAVORO:EXPORT E CAUSE
DELLE CRISI INDUSTRIALI DI FRANCESCO GARIBALDO
13
IN CASA
GLI A
SINI 69
la Cina, dell’India, del Brasile, ecc., ma che in termini assoluti rappresentano una quota im-portante della domanda affluente globale. L’Italia esportava nel 2018 il 33%, il 25% in va-lore aggiunto. I suoi punti di forza sono i beni capitali della metalmeccanica strumentale, come la Germania, il made in Italy, la chimica, la farmaceutica. Il peso dell’auto come pro-dotto finito è in calo costante mentre rimane molto alto il contributo della componentistica dell’auto che lavora in larga parte per l’export, specificatamente per l’industria automobilisti-ca europea – Germania, Francia, Inghilterra. Un po’ meno di un quarto dell’occupazione italiana dipende dalle esportazioni.La Spagna esportava il 36%. del suo Pil, il 27% in valore aggiunto. I suoi punti di forza sono gli autoveicoli, la chimica e il settore alimenta-re. Tre quarti del valore aggiunto dell’auto, che ha un peso significativo, dipende da imprese di proprietà straniera. Più in generale una quota significativa, il 12% nel 2013, dell’occupazione dipendeva dall’imprese straniere.La Francia esportava il 30% del suo Pil, il 22% in valore aggiunto. La Francia a differenza dagli altri tre è un importatore netto perché importa più di quanto esporta. In Francia solo il 12% del valore aggiunto proviene dall’industria. Il modello di esportazione francese si basa su beni di consumo e beni di lusso e ha una forte componente dipendente dai servizi. In Francia l’industria dell’auto contribuisce allo 0,4% del valore aggiunto; un ruolo importante è quello della chimica. Circa il 20% dell’occupazione francese dipende dalle esportazioni.La scelta di forzatura dell’export è gravida di conseguenze. In primo luogo non è socialmen-te neutrale. Ad esempio, l’auto e i prodotti del lusso sono tra quelli che trainano l’export extraeuropeo; incentivare l’export vuol dire quindi non investire sui consumi interni, tan-to meno su quelli di natura collettiva. I capitali finanziari che hanno alimentato questa scelta sono gli stessi che hanno finanziato la cresci-ta a debito che ha portato alla crisi del 2008; il loro criterio di scelta è il livello di profitti,
piuttosto che utilizzarla. Entrambi i casi non riguardano solo la produzione materiale ma anche, sempre di più, sia la fornitura di servizi sia di prodotti informatici che consentano la digitalizzazione della produzione. Ognuna di queste catene globali del valore può essere più o meno frammentata in molti gradini inter-medi, si parla in genere della sua lunghezza; e possono essere più o meno internazionalizza-te. Una delle più lunghe e con più presenza di fasi intermedie in paesi diversi è quella dell’au-tomotive. Ad esempio, nei manufatti che la Germania esporta, quasi un 25% del valore aggiunto viene da attività produttive realizzate all’estero nelle specifiche catene del valore; per la Francia e l’Italia i valori sono più alti, vicino al 30%.Questo sistema europeo è stato costruito con un chiaro orientamento all’export sia inter-no all’Unione sia a livello globale. Per capire l’importanza dell’export basti pensare che 36 milioni di posti di lavoro nella Ue dipendono dall’export extra Ue; di questi, 19 milioni sono nella manifattura. La manifattura rappresenta quasi il 30% di questo calcolo. Il contributo più importante dell’export all’occupazione si ha nella chimica, seguita dalla metalmeccanica strumentale.I primi quattro paesi esportatori sono Germa-nia, Italia, Spagna e Francia. La Germania è la quarta economia del mondo ed esportava nel 2018 1.317.556 milioni di euro (1,317 tri-lioni) per anno, pari al 47% del suo prodotto interno lordo (Pil), il 32% in termini di va-lore aggiunto. In Germania il 23% del valore aggiunto prodotto viene dall’industria. Il mo-dello di esportazione tedesco si basa su beni capitali, cioè sull’insieme di beni strumentali che compongono il processo produttivo, siano essi macchine utensili o software specializza-ti. Un po’ più di un quarto della occupazione tedesca dipende dalle esportazioni. Una parte consistente, il 4,6%, del valore aggiunto, viene dall’industria dell’auto. L’export tedesco si ri-volge alla cosiddetta classe media globale, cioè a quegli strati percentualmente minoritari del-
14
GLI A
SINI 69
IN CASA
non si distribuisce casualmente ma immobi-lizza specifiche aree territoriali, ad esempio il Sud dell’Italia, e interi paesi, ad esempio quelli dell’est europeo in un percorso di progressivo degrado della matrice industriale sia in termi-ni quantitativi, la deindustrializzazione, sia in termini qualitativi, restare prigionieri di atti-vità a basso contenuto tecnologico e a scarso valore aggiunto.Avendo in mente questa struttura allora an-che le politiche necessarie diventano più com-plesse, come abbiamo sostenuto più nel det-taglio Riccardo Bellofiore e io nel libro Euro al capolinea? La vera natura della crisi europea, pubblicato da Rosenber&Sellier.. Non basta, anche se è necessario, dire che ci vogliono po-litiche espansive. Ad esempio una svolta ver-de in Italia con politiche di incentivazione ad acquistare auto elettriche si tradurrebbe nella conferma dell’arretratezza nostra e in un flusso di commesse per la Germania se contestual-mente non si intervenisse sulla struttura in-dustriale. Analogamente la messa tra parentesi delle politiche di austerità non può tradursi solo in un impulso ai consumi privati, deve in primo luogo favorire un New Deal nel quale lo Stato interviene, e interviene per selezionare cosa e come produrre. Ruolo dello Stato che paradossalmente proprio il neoliberismo ha esaltato per i suoi fini; si tratta ora di quali-ficare a sinistra il suo ruolo lungo una linea di socializzazione degli investimenti e della oc-cupazione, per creare cioè valori d’uso sociali. Questo richiede dei “deficit attivi” dei bilanci pubblici, cioè deficit pianificati per stimolare lo sviluppo economico che li riassorbirà.
non certamente la stabilità e la qualità dell’oc-cupazione. Una delle conseguenze la stiamo pagando in Italia dove una parte significati-va delle crisi aziendali è legata a investimenti multinazionali sia europei che extraeuropei e che decidono le chiusure aziendali solo su basi di bilancio.In secondo luogo, quando l’export raggiunge le dimensioni prima indicate, introduce un’in-certezza strutturale; qualsiasi mutamento nelle ragioni del commercio internazionale si riper-cuote amplificato lungo la catena del valore, come sta accadendo ora, con la diversità della Francia.Il settore automobilistico è un caso che mette in chiara evidenza le relazioni e i nessi causali tra queste notizie sparse. Esso rappresenta cir-ca il 6% dell’occupazione totale dell’Unione Europea, e l’11% di quella manifatturiera. Il surplus del commercio europeo che viene ge-nerato è di circa 90 miliardi. È costituito da 2.220 imprese – di cui 230 assemblatori finali e produttori di motori – distribuite in 25 paesi. Nel 2018 l’Ue ha prodotto il 20% delle auto nel mondo e la Germania da sola quasi un ter-zo di quelle europee.L’Ue ha visto una riduzione, nei primi otto mesi dell’anno, del 3,2% di immatricolazio-ni rispetto allo stesso periodo del 2018; se si confronta il solo mese di agosto il calo è pari all’8,4%. Se si guarda alla produzione, la con-trazione a livello europeo è stata del 6,2% nei primi sei mesi del 2019, dopo una contrazio-ne dell’1,7% nel 2018. La Germania ha speri-mentato un calo dell’11% della produzione nei primi sei mesi del 2019. La riduzione, legata alla crisi del sistema di relazioni commerciali globali decisa da Trump, colpisce amplifican-dosi proprio i settori più guidati dalla scelta dell’export, come nel caso dell’auto tedesca e a cascata di tutta la sua fornitura in europa, a Est e a Sud.In terzo luogo la distribuzione della struttura industriale è organizzata gerarchicamente con delle aziende/paesi capofila e altre/i in decre-scente livello di autonomia. Questa gerarchia
15
IN CASA
GLI A
SINI 69
Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre a Conversano (Bari), si è svolta l’assemblea di Fuorimercato – Autogestione in movimento. Nel pomeriggio del venerdì si è tenuta la plenaria “Non esiste un pianeta B. Lottare per la giustizia ambientale e sociale” a cui sono intervenuti associazioni ed esponenti dei movimenti e comitati territoria-li. Questo testo è un appello alla partecipazione all’incontro e una traccia della discussione che vorremmo fare.
Nell’epoca del capitalocene dove il ca-pitalismo regola i rapporti tra le perso-ne e tra queste e la natura, cerchiamo di costruire la nostra posizione ecologista. L’agroecologia – non come miglioramento di un piano esistente ma come trasformazione ra-dicale di questi rapporti – è la cornice teorica con cui vogliamo confrontarci per guardare alle nostre esperienze di riorganizzazione del lavoro.Le mobilitazioni dell’ultimo anno dalla Marcia contro le grandi opere inutili, al dibattito-se-minario organizzato da Genuino Clandestino “Cosmopolitiche. Pratiche e movimenti della transizione ecologica”, ai tre scioperi globali, hanno rafforzato la nostra idea dell’impossibi-lità di una giustizia ambientale senza giustizia sociale. I temi portati in queste mobilitazioni ci riguardano da vicino perché il rispetto dell’am-biente non è una questione morale, tecnica o efficientista ma è prettamente politica e stretta-mente collegata all’idea di società che abbiamo. Le nostre produzioni fuorimercato sono pra-tiche concrete per la riduzione delle emis-sioni di CO2 la riconversione ecologica delle produzioni e l’agroecologia sono le chiavi di volta per il raffreddamento del pianeta.
Questo approccio è naturalmente connesso alla necessità della pianificazione democratica delle produzioni e dell’uso delle risorse sia nel nel nostro piccolo che su scala planetaria: la ri-duzione delle produzioni non può essere iden-tica tra aree ipersviluppate industrialmente e aree sottosviluppate.A partire dai nostri bisogni e dal cosa e come produciamo, ci riguardano tutti i proces-si di sfruttamento degli esseri umani e del-la natura. A partire da questa base vorrem-mo rafforzare alleanze e costruirne di nuove. Assumiamo lo slogan “L’agroecologia è femmi-nista o non sarà” e per questo vogliamo chie-derci come nei rapporti di produzione (e ri-produzione) che auto-organizziamo possiamo tendere maggiormente all’equità di genere, di classe di specie. Sfruttamento, razzismo e pa-triarcato, infatti sono frutto dello stesso sistema antiecologico, il capitalismo. Si basa tanto sullo sfruttamento della natura tanto quanto su quel-lo di altri soggetti e soggettività che devono sot-tomettersi a compiere in silenzio il lavoro ripro-duttivo. Ripensare e guardare con attenzione gli equilibri di potere all’interno dei rapporti del lavoro in auto-organizzazione è fondamentale. Pensiamo che difesa del territorio è difesa del nostro corpo, che difesa dei nostri corpi è difesa dell’autonomia dei nostri territori e dell’auto-determinazione di questi a partire dall’emanci-pazione economica.Inevitabilmente i nostri territori, i nostri corpi e il cibo sono le basi per una riflessione e azione, per la costruzione di un’alternativa al mercato. Parliamo di cibo come terreno di scontro e di costruzione e ci riferiamo al concetto di sovrani-tà alimentare coniato da La Via Campesina per rimettere al centro la titolarità delle comunità locali di decidere cosa, come e per chi produrre come base della propria autodeterminazione. Dall’analisi e dalla riappropriazione collettiva delle risorse come obiettivo cerchiamo di capire come farlo e quali siano gli ostacoli che incon-triamo quando siamo già in questo cammino. Questo implica resistenza alle logiche dell’e-strattivismo e del produttivismo che impedi-
NON ESISTEUN PIANETA B
DEL GRUPPO AGROECOLOGIA DI FUORIMERCATO
16
GLI A
SINI 69
IN CASA
scono l’accesso alla salute e alle risorse a intere fasce di popolazione e la necessità di organizzar-si. Crediamo che la resistenza al modello estrat-tivista passi per la costruzione di queste stesse alternative, sebbene piccole e sperimentali. Queste stesse contrastano gli stili di vita, alle opere e alle produzioni che devastano il clima e l’ambiente, senza le quali ci si continuereb-be a scontrare tra il diritto al lavoro e quel-lo alla salute e all’ambiente, o tra il diritto al cibo economico prodotto da devastazione e sfruttamento o il cibo di qualità per pochi. Ci riguarda tutto quello che succede nei nostri territori e siamo consapevoli che spesso per sal-vaguardare” le nostre vite agro ecologiche” è ne-cessario organizzarsi attraverso la solidarietà per e contro e/o sostenere i numerosi e già esistenti movimenti territoriali contro le devastazioni e le grandi opere inutili.Vorremmo che questa plenaria e l’assemblea nazionale di Fuorimercato siano spazi utili al “nostro” interno e che proseguano con il tavo-lo di lavoro permanente sull’agroecologia in continuità con le riflessioni elaborate da alcuni nodi e/o singoli/ e siano aperti a tutte e tutti. Facciamo riferimento alle riflessione dei movi-menti internazionali come la Via Campesina e la sua visione sul clima e migrazioni, migra-zioni e agricoltura, migrazioni e lavoro sala-riato, con una particolare attenzione al tema del lavoro agricolo talvolta o spesso assente nella riflessione sulla transizione ecologica. Abbiamo bisogno di legare l’ambito rurale con quello urbano, i movimenti per la terra con i movimenti che praticano percorsi di riap-propriazione e rigenerazione degli spazi a uso abitativo e non solo, di difesa del suolo dalla cementificazione, di difesa dell’aria e dell’ac-qua dagli inquinamenti prodotti dall’indu-stria, dai trasporti, da edifici insalubri, da un sistema energivoro centralizzato, concentrato e inefficiente basato sui combustibili fossili. Ci interessa promuovere e intrecciare in un’ot-tica ecologica la riflessione su come spazi o beni comuni possano agevolare la presa di parola di come al contempo questo processo si rafforzi
nella costruzione di lavoro in autogestione. Vi invitiamo a costruire insieme le connessioni tra la dimensione territoriale di tante esperien-ze, che agiscono attorno ai temi della giustizia sociale e ambientale, e la dimensione necessa-riamente più articolata e generale, che necessita di nuove forme di condivisione e partecipazio-ne (autodeterminazione, riconoscimento, ri-distribuzione, ri-conversione della produzione e della ri-produzione).
17
IN CASA
GLI A
SINI 69
ne abbiamo che una cognizione parziale, de-formata dall’esistervi quotidianamente, dallo spostarsi lungo certe direttrici e non altre, dal camminare certe strade e non altre, cioè il più delle volte dall’usarla, in un’area, mentale o fisica che sia, piuttosto ristretta. Questo stra-namente vale anche per coloro che ogni gior-no l’attraversano in lungo e in largo, come ad esempio i tassisti, che sono tra le persone che, pur dicendone in continuazione, meno sanno della città. Allora anche quella che mi appare come una specie di opacità strutturale, cioè storica e non eliminabile, è probabilmente solo mia igno-ranza. È il mio non sapere le cose della Città del Ponte --- come talvolta di pensare da quan-do, anni fa, lessi un libro divenuto per me fon-damentale, Sacralità dell’acqua e sacrilegio dei ponti di Anita Seppilli, che mi disse le ragioni dell’esistenza dell’Urbs in questo luogo e del titolo tecnico di Pontifex di cui ancora, dopo un tempo lunghissimo, si fregia il Papa –, è la mia ignoranza che causa l’approssimazio-ne e in fondo la convenzionalità del giudizio sul sistema di oggetti grandi e piccoli, di spa-zi privati e pubblici, di persone e cose semo-venti, che chiamiamo Roma. Ignoranza non solo mia, ma praticamente di tutti coloro che blaterano della città, che ne hanno una visio-ne identitaria, o pratica, letteraria, scientifica, urbanistica, nostalgica, o non ce l’hanno per niente, ma ne parlano lo stesso. Abito sul confine tra la città e la non-città di Roma Nord-Ovest, cioè tra la città pianificata in un certo modo, prima della Guerra, e quella pianificata in altro modo, o non pianificata af-fatto, nel Dopo-Guerra e successivamente negli anni Sessanta e Settanta e Ottanta e Novanta e Duemila, fino ai giorni nostri, in un’impressio-nante continuità di non-visione.Se uscendo di casa vado a sinistra, cioè verso ovest, dopo un centinaio di metri mi inoltro in un magma di palazzine che risale ai Settanta ed era in costruzione quando Ettore Scola girava il suo, per me brutto, Brutti sporchi e cattivi e qui davanti, proprio qui sul Monte detto Ciocci,
ROMA. APPUNTI SULLA CITTÀ DEGLI ALTRI
DI FRANCESCO PECORARO
Ormai --- dopo esserci nato e averci vissu-to per più di settant’anni e dopo aver lavorato per trentacinque anni come architetto negli uffici tecnici del Comune --- sono convinto che Roma non possa essere capita ma, anche conoscendola molto bene e sapendone la sto-ria e avendone ben chiari gli assetti e le dina-miche (non è il mio caso), solo percepita per parti. Soprattutto da chi come me, proprio in quan-to romano figlio di romani, più che abitarla ne è abitato, un modo per dire che sin dalla nasci-ta è pervaso dalla sua cultura e dal linguaggio che vi si parla e non c’è verso di liberarsene per guardare la città e allo stesso tempo guardarsi nella città, dall’esterno. Le parole di Roma, per esempio, per quanto mi sforzi più o meno consciamente di tener-le a bada --- da quando il registratore Gelo-sino di un mio amichetto di palazzo, cui i genitori non negavano nulla, mi restituì per la prima volta voce e inflessione rimasi di sasso perché credevo di parlare italiano, ci tenevo a parlare italiano, e invece mi espri-mevo in romanesco –, le parole della città, dicevo, mi schizzano fuori per conto loro negli scatti d’ira, come per esempio nel traf-fico, con quell’orrendo “Ma ‘ndo’ vai, testa-dicazzo?” ormai del tutto automatico, non sono io a dirlo, è Roma. Tutti coloro che abitano Roma si soffermano almeno una volta al giorno, anche per un ac-cenno, a parlare di Roma: questa città non si fa mai dimenticare, nemmeno per un secondo, nel bene e soprattutto in quello che ci sembra il male. Dicevo percepita perché la maggior parte di noi che parliamo di questa città non
18
GLI A
SINI 69
IN CASA
non-rispondente ai requisiti che per me avreb-be dovuto avere la città moderna.Oggi via Angelo Emo, che oggettivamente fa pena, non mi dispiace affatto, con quel suo sparti-traffico polveroso, largo e alberato da alti platani che ogni tanto schiantano su qual-che automobile, occupato perennemente da auto in sosta, e dal flusso di traffico che ral-lenta in corrispondenza di un super-mercato --- che lì, per mancanza di parcheggi di per-tinenza, non ci dovrebbe stare --- dove la car-reggiata si restringe a causa delle macchine in doppia fila. Tutto quello che vedo è sbagliato, compresa la strada stessa, tutto è in violazione di norma e di buon senso e di un minimo di istanza estetica che non sia nelle matite unifor-mi degli architetti di allora, ma non così sba-gliato e repellente, come la città che si incontra più a monte, dalla quale sto fuggendo.Capisco un possibile stupore di fronte alla pa-rola repellente in riferimento all’intera via Bal-do degli Ubaldi e alle sue estese, talvolta scar-rupate, adiacenze, ma data la mia formazione, sono tra i pochi che pensa di avere coscienza di come la città dovrebbe essere e di come in-vece è. Questa coscienza, che so attardata nelle istanze moderniste e poi post-moderniste del Novecento, mi produce una continua soffe-renza da dis-approvazione, che si manifesta con un sordo borborigmo interiore, come un dolore leggero e costante, con qualche fitta acuta là dove mi accorgo di errori e stupidità e ramiciate recenti, che è quando si vede be-nissimo l’imporsi della brutalità del profitto su minime, quasi umili, esigenze di forma, come per esempio i cigli dei marciapiedi in traverti-no segmentato, invece che tagliato curvo (cen-tinato, come si dice in gergo tecnico) a misura. Cose di cui in pochi ci accorgiamo, perché più o meno da tutti, intellettuali compresi, la città viene vissuta quasi come un fenomeno natu-rale, di cui si conosce, ma in fondo si accetta, l’in-governata origine speculativa. Se sei nel brutto, se vivi immerso in un mondo di oggetti che non puoi approvare, né come insieme, né presi singolarmente, allora obtorto
per via di qualcuno che deve averlo posseduto, c’era un consistente nucleo di baracche, poi sgomberato e demolito, che successivamente ha tentato più volte di riformarsi. Le baracche dei senza-tetto si accostavano via via l’una all’altra in una mutua assistenza natu-rale, formando così l’embrione se non di una strada, di un tracciato, facendomi capire qual-cosa su come nasce una città, su quali bisogni fonda la sua densità. Più volte in anni recenti ho visto sul Monte formarsi e ri-formarsi una piccola città primordiale, che era quasi subi-to demolita oppure bruciata in grandi vam-pe, per la gioia di un mio co-inquilino, uomo simpatico e del tutto normale il quale, mentre le baracche ardevano, si augurava che ci fosse ancora dentro qualcuno.Quando esco di casa senza un vero scopo, cioè quando esco tanto per uscire, cioè per cardio-camminare a passo svelto, o solo per curiosare, osservare, mi butto d’istinto a destra, cioè verso est, cioè verso Roma. Vado naturalmente incon-tro alla città che, ai miei occhi e alla mia stanca sensibilità urbanistica, ha ancora qualche titolo per essere chiamata tale e, subito dopo la pau-sa del Sottopasso dell’Olimpica, del Nodo di Scambio, del Primo Ponte Ferroviario, del Se-condo e più antico altissimo Ponte di mattoni, e poi del Capolinea Atac in costruzione e del Distributore Agip, trovo tessuti già post-guer-reschi ma pianificati ancora secondo le logiche di occupazione dello spazio proprie del Piano Regolatore del 1931, ancora legate a un’idea pro-spettica e rinascimentale della città, però già tol-leranti verso forme come il villino e la palazzina. Cammino verso la Roma geometrica primo-novecentesca ma anche qui vedo strade diritte, tessuti a scacchiera e palazzone attaccate le une alle altre a formare quinte urbane che, se appe-na fuori di casa avessi svoltato a sinistra, non avrei visto. Insomma, il brano di città inner-vato dagli assi principali di via Angelo Emo e di via Cipro, con gli anni e con la permanenza su via Baldo degli Ubaldi, me lo sto facendo piacere, mentre un tempo, da abitante della città storica quale ero, l’avrei disprezzato come
19
IN CASA
GLI A
SINI 69
nanti e pregiati sono spesso puro disordine, ma hanno per noi un significato estetico, forte al punto da essere ormai diventati intoccabili parchi a tema, invasi e bolliti dal turismo di massa. Nessuno in pratica sa niente di archi-tettura e di città, ma poi quando viaggiamo è ciò che principalmente andiamo a vedere. Già in via Angelo Emo si manifesta una certa lesione negli oggetti e nei dispositivi così detti di arredo urbano, nei quali includo le soglie dei marciapiedi sconnesse e crepate, le radici degli enormi alberi affioranti nello spartitraffi-co spelacchiato, i parapedonali sbilenchi e tut-to il restante sfasciume cui il romano di oggi si è abituato e che più su, uscendo dalla città verso ovest e attraversando vasti brani di peri-feria, ritroverà come una regola inflessibile a denotare, piuttosto che l’indiscutibile incuria dell’amministrazione, il carattere degli abitanti che riassumerei così: di tutto ciò che sta fuori casa mia --- eccettuato il parchetto dove gioca mio figlio e il percorso che devo fare per an-dare al supermercato, in farmacia, al bar e al garage --- non me ne può fregare di meno. Forse non è esattamente così, perché l’atten-zione (come cessazione della non-curanza) del cittadino di Roma, si estende al percorso ne-cessario per arrivare sul posto di lavoro, tutte le mattine che ha fatto iddio, quando si verifica quella sorta di stanca irritata mobilitazione ge-nerale sulle strade sugli autobus e sulle metro-politane e odiamo tutto ciò che ci ostacola e ci rende sgradevole lungo e difficile il tragitto. Se questo è lo spirito invalso e vincente, se lo spazio pubblico come ente civile condiviso non interessa più nessuno, perché comportarsi diversamente dalla signora che in vestaglia sta depositando un materasso sul marciapiede, ac-canto ai cassonetti stracolmi? Quando la rimproveri e quella ti risponde “’O fanno tutti, perché noo devo fà io? E poi noo vede che lo schifo c’è già?”, non puoi fare altro che tacere, perché se la norma non si interio-rizza, allora semplicemente non c’è, e nemme-no tu sei più tanto sicuro che sia giusto rim-proverarla…
collo sei costretto a relativizzarlo in più brutto, meno brutto, brutto accettabile, non-brutto ec-cetera. Quello di via Angelo Emo è, giudicato per intero e sommariamente, brutto accettabi-le, perché contiene elementi ancora in accordo con la mia idea di città, anche se non con la mia concezione di architettura, su cui sarebbe troppo complicato qui soffermarsi, e ammesso che ne abbia effettivamente una. Una cosa che ho imparato nel corso dei de-cenni trascorsi, prima nel Novecento poi negli anni Duemila, è che vivo nel gusto degli al-tri, che la città è degli altri, che è un prodotto collettivo e, come tale, dice molte cose su chi siamo, quindi non può essere come la vorrei se non per piccoli brani, per brevi tratti di strada, per sistemazioni circoscritte, per singoli edifici che approvo, se non addirittura ammiro. Se la città è fatta di oggetti grandi, medi e piccoli, cioè di enti edilizi disposti in qualche modo --- il modo in cui sono disposti è de-terminante --- che formano lo spazio-strada, lo spazio-piazza e una quantità di spazi ibridi come i vialoni e i piazzali, gli slarghi e quelli che chiamo stradoni, che è quando una strada si allarga per accogliere una grossa quantità di traffico in flusso perenne di attraversamento (un esempio di stradone infinito è Via Palmiro Togliatti): se la città, dicevo, è questo affastel-larsi di oggetti che formano e arredano spazio, la prima cosa che novecentescamente preten-derei è ordine. Sto dicendo dell’ordine dell’Artificio a fronte del disordine caotico della Natura. Concetti molto di base, ma molto precisi, che stanno già dentro per esempio La città ideale di Urbino, o lo Sposalizio della Vergine del Perugino, quadri molto diversi ma che hanno in comune una definizione dell’urbano come luogo del con-trollo geometrico e prospettico sull’ambiente e che, nonostante il Rinascimento sia terminato col terminare del Novecento, ancora mi danno conforto, nella repulsione che provo per gran parte della Roma del Dopo-Guerra. Questo della città che ci piace è un discorso complicato. Anche i centri storici più affasci-
20
GLI A
SINI 69
IN CASA
semplici e austeri, in cui si manifestava la spe-culazione edilizia di allora. Perché se la città può esistere senza pianificazione, non può esi-stere senza speculazione. Quindi il punto non è speculazione sì, specu-lazione no. Il punto consiste nelle norme im-poste dalla pianificazione urbana, nella qualità della stessa e nella capacità della politica di far-le rispettare. La città a est di via Vittor Pisani è un prolungamento della norma, della razio-nalità, del decoro massonico-borghese con al-tri mezzi. Quella a ovest, fatto salvo qualche episodio, è l’immagine dell’individualismo piccolo-borghese e della corruzione tardo-no-vecenteschi. Ed è lì che abito. Oggi al posto di piccolo-borghese meglio usare sintagmi come ceto medio esteso, a indicare un ampio strato sociale dove nessuno vuole più diventare borghese, perché la cultura e lo sta-tus borghesi come riferimento di scalata socia-le non esistono più. Ma la Roma borghese, sia pure come guscio semi-svuotato della sua classe sociale di riferimento, grazie alle norme di salva-guardia introdotte nel Piano Regolatore del ’62, esiste ancora. Come esiste, ormai svuotata degli abitanti d’origine e ampiamente solidificata, la Roma sotto-proletaria, lascito di una sottoclasse sociale scomparsa che ha fatto la storia di questa città nel secondo Novecento. Nella mia traiet-toria, questa Roma geometrica comincia oltre la cesura di via Leone IV. Da lì in poi mi lascio alle spalle la dis-approvazione e faccio posto al giudizio puntuale, perché la città che mi circon-da nella sua regolarità primo-novecentesca, ma di fatto rinascimentale, in fondo mi sta bene, anche perché è qui che sono nato. La democrazia del secondo Novecento si è di-mostrata singolarmente incapace di produrre, non dico bellezza, ma almeno un ordine una disciplina una norma visive per la città di nuo-va costruzione. Per questo cerco costantemente rifugio nella Roma aristocratica dei papi e in quella successiva della borghesia massonica: aborro entrambe, ma solo in quanto regimi politici, perché come produttori di città furono molto più bravi della democrazia parlamentare.
E comunque l’Artico si sta sciogliendo, la Groenlandia anche, il permafrost del Grande Nord si de-solidifica, la Siberia brucia, taglia-no l’Amazzonia e la trasformano in truciolato per cucine economiche, pescano tutto quello che c’è nel mare, i peti di miliardi di maiali e mucche aleggiano nell’atmosfera, cosa vuoi che sia un matarazzo pe’ strada? Che cambia?Procedendo verso ovest tocco finalmente il margine, nettamente percepibile, della città precedente a quella dello Stradone, cui sopra faccio cenno, cioè quella pianificata e costruita secondo norme e tecnologie e linguaggi otto-centeschi. L’imbocco di via Candia è una sor-ta di cancello aperto sull’ordine edilizio, sulla città massonico-borghese che, sia pure debol-mente, si rifà all’utopia urbana rinascimentale di cui dicevo e che, con alcune modifiche, nel XIX secolo diviene quasi città corrente.Via Candia è satura di Smart, di Yaris, di Toyo-ta Iq e Aygo e gipponi di tutte le marche, tutti uguali, e Bmw e molte altre automobili che fanno status. Perché Roma è così: in superficie si fa status con l’auto. Nei bus e nella metro viaggia il popolo degli abissi, gli immigrati e in genere i dominati più o meno anziani, oppure i giovani e gli iper-giovani che vanno e ven-gono da scuola. In via Candia si imbottiglia e sgassa la moltitudine impaziente di scooter di cui la città è satura: ormai non più motocicli ma proprio moto, capaci di arrivare a in pochi secondi a 100 km/h, che filtrano attraverso il traffico compatto, si ammassano ai semafori pronti allo scatto. In via Candia si manifestano molto concretamente le masse ansimanti dei bus che vanno a incanalarsi sulle corsie prefe-renziali del centro storico e gli infiniti pullman alti 5 metri che portano in giro i turisti. Tutto questo naturalmente è città, è gusto de-gli altri, è la Roma che ci aggioga ogni giorno. Non è come la vorremmo, è come è. Qui inizia una città fatta per le carrozze a ca-valli che, grazie alla razionalità paratattica dell’impianto --- in pratica un elenco di isolati --- regge abbastanza bene l’urto quotidiano di un traffico che tende ad annullarne i valori,
21
IN CASA
GLI A
SINI 69
discontinuità della guerra ci diede la voglia di rinascere, ricostruire, ha portato al miracolo ita-liano, all’uscita dalla povertà vera. Il Sessantotto un po’ meno, perché fu molto sovrastrutturale, però ci ha dato un pezzo di classe dirigente non indifferente, perché bene o male molta della gente che si vede in giro ha fatto il Sessantot-to in prima persona. Ci ha dato il senso che una società non può vivere senza il gusto del passaggio generazionale, l’idea che in fondo un po’ di fantasia al potere – vecchio slogan loro – non farebbe male. Nel ’93 c’è stata la tragedia dei partiti, il loro disfacimento, la vittoria della magistratura con Tangentopoli. Però ci ha dato anche Berlusconi, questa è la tragedia. Significa che il Paese si è ripreso dalla sua continuità su un livello più basso. Chi è Berlusconi? È uno che ha le televisioni, che si presenta bene, che dice “mi consenta”, insomma, è uno che funzio-na. Adesso ce ne siamo scordati, ma nel 1995-96 Berlusconi aveva la maggioranza sicura in que-sto Paese. Finita questa era disgraziata, chiama-ta Seconda Repubblica, c’è stata la crisi econo-mica, che è una discontinuità apparentemente più forte, perché in fondo un Parlamento con il 55% di anti-europeisti, anti-industriali, non ci piace, però l’abbiamo votato e ce lo teniamo. Questa discontinuità è talmente diversa dalle precedenti che non si sa se ci lascerà più poveri, come con Berlusconi. In fondo forse siamo più vichiani che continuisti, quindi la fine di que-sto ciclo e il passaggio a uno nuovo potrebbe essere migliore di quello che è stato negli anni precedenti. Ho qualche preoccupazione perché ci stiamo immettendo in un ciclo senza classe dirigente, amministrazione, tecnocrazia, élite e cultura di
Volevo cominciare dal tema del rapporto tra discontinuità e continuità confrontando due pe-riodi storici differenti. Il Sessantotto era partecipa-zione, il momento giallo-verde è stato tutto media-tico-elettorale. Io ho l’impressione che la questione sociale rimane determinante, ma che non c’è più un corpo sociale determinante, robusto. Anche perché, precedenti rapporti Censis ci hanno ine-vitabilmente descritto come siamo, e questo rende un po’ problematico il discorso della discontinuità, nel senso che queste fasi sembrano necessarie, rit-miche, anche salutari, purché il continuismo in un certo senso si affermi. Sul continuismo, però, lei lascia aperto un discorso che è interessante: non è un lasciare andare, è un ripensare, rifondare, cercare un continuismo che non c’è. Lì si apre una domanda proprio su questa esigenza di un conti-nuismo diverso dalla continuità, che nel saggio Il cimento del continuismo (pubblicato dal Censis quest’anno) non è concretamente spiegata. Si capi-sce che è una finestra, ma non si capisce qual è la sua visione.Il problema vero, in questo momento, è che il continuismo dimostra sempre di più di non avere vitalità: c’è, ma non dà senso alla vita, non dà partecipazione, non elimina la dise-guaglianza. Il continuismo è per molti, anche per me, un elemento positivo in una società, perché mantiene la linea lunga, però ogni volta che c’è una discontinuità siamo più poveri. Se si pensa alla periodizzazione di Delai, i quattro gradi di discontinuità sono stati: la fine della Seconda guerra mondiale, il Sessantotto, il ’93 e infine l’arrivo di “questi qua”, come dice Cec-carelli. Potremmo dire che più erano forti, più hanno lasciato una buona traccia; meno erano forti, meno hanno dato una buona traccia. La
COME CAMBIA L’ITALIA.DISCONTINUITÀ E CONTINUISMO
DI GIUSEPPE DE RITA
INCONTRO CON PIERGIORGIO GIACCHÈ
22
GLI A
SINI 69
IN CASA
no? No. Il nemico del Censis è stata la crona-ca, il fatto che dovevamo entrare in cronaca. Se non entravamo in cronaca non entravamo sui giornali, non facevamo audience, non facevamo opinione. Abbiamo resistito per cinquant’anni a essere noi stessi. Tanti enti di ricerca sono fini-ti nella trappola, perché fanno la ricerca che ser-ve solo per il titolo del giorno dopo e nel giro di qualche anno chiudono. Vogliono entrare nella cronaca perché per loro entrare nella cronaca è il meglio, per me invece significa fare un passo indietro. Però mi rendo conto quanto sia difficile: anche i nostri clienti vogliono la stessa cosa. Se l’azien-da farmaceutica che produce tante pillole mi dà 50mila euro vuole il convegno, il ministro che fa il discorso, tre articoli di giornale. Altrimen-ti, dice: “Per cosa te li do i soldi?”. Quindi ci ritroviamo in un periodo difficilissimo e fati-cosissimo perché non ci sono più i meccanismi che io chiamo assiali, che ci hanno permesso, le volte precedenti, di ritornare da una discon-tinuità alla continuità con meccanismi nuovi. Se vai a vedere il mitico Nord-Est, da me ama-tissimo, sono tutti clienti dei private banker: vendono l’azienda e comprano titoli di rendita, sostanzialmente. Questo è il mondo. Noi ci ar-rabbiamo perché il reddito di cittadinanza crea dei disoccupati sul divano, ma guardate che sul divano c’è gran parte della migliore Italia di ieri. Se ci fossero ancora quelli che nel ’50 hanno rifatto le case, o quelli che nel 1969-70 hanno creato il boom della piccola industria, andrebbe bene, ma qui non c’è niente.Noi abbiamo fatto una riunione su un tema stravagante: com’è nata la Dc. La Dc è nata su quattro punti, erano i problemi più assiali. Vediamo se oggi c’è qualcosa di simile a fare da asse del nostro ripartire. Il primo punto è il peso del grande partito. De Gasperi volle un grande partito. Questa era l’origine, cosa di cui poi si sono scordati. Ciò significò far fuori tutti i vecchi aventiniani – tranne Spataro e Gonella, perché erano suoi amici –, ha voluto fuori tutti i cristiani sociali e i cattolici comunisti. Oggi se ti guardi intorno, che soggetto forte hai? La
sviluppo. Oggi la burocrazia è scomparsa, non esiste più. Io ho frequentato la burocrazia ita-liana dal ’55 in poi: c’erano ex fascisti, non c’era dubbio, c’erano massoni, però erano bravi. Il direttore generale della pubblica istruzione fi-niva per fare il vice segretario generale al Qui-rinale. Era una classe dirigente burocratica che sapeva il fatto suo. Ma oggi non c’è neppure una tecnocrazia. Ma ci rendiamo conto di che cosa era l’Iri all’epoca e con quale tecnocrazia trattammo nel ’56 per entrare in Europa?Mi ricordo, l’ho anche scritto, quando si fecero le trattative per l’Europa – parlo del 1955, 1956 e 1957 – i tre che andarono in Europa a far la trat-tativa furono gli ambasciatori Ducci e Bobba più Sebregondi, il mio capo di allora. Mi ricor-do quando ci fu la settimana in cui dovevamo fargli capire che l’area depressa dell’Italia non era il delta del Po, come credevano loro, bensì il Mezzogiorno. Far entrare nei Trattati il pro-blema del Mezzogiorno è stato frutto di alcuni dossier che avevamo preparato a Roma e che si erano portati lì. Oggi se mi domando chi va a Bruxelles a trattare mi viene la pelle d’oca. Se ci va un ambasciatore terrà la dignità del col-loquio, ma anche loro ormai non sono più gli ambasciatori di una volta, preparati, seri, che avevano dei direttori generali terrificanti.Arriviamo pure a dire che non abbiamo un élite convincente. Se pensiamo, lo dico banalmente però è così, che siamo prigionieri della cronaca. Notate, le pagine di commento di “Repubblica” sono scritte tutte da giornalisti. Significa che la cronaca ha invaso anche la testa della gente, ha invaso la professionalità, il ruolo, il potere di al-cuni rispetto ad altri. Chi fa cronaca è potente, chi non fa cronaca non è potente. Come fai a creare un élite se il tono complessivo del dibat-tito è: cronaca, cronaca, cronaca.Quando ho scritto i miei cinquant’anni di con-siderazioni generali, spesso mi sono domanda-to chi ci è stato nemico. Per un gruppo come il Censis, che da cinquant’anni fa il Rapporto annuale gratuitamente, perché non ce lo paga nessuno, ce lo paghiamo noi attraverso 50 o 60 contratti l’anno, chi ci è stato nemico? Sarace-
23
IN CASA
GLI A
SINI 69
che avevano stampato, allora Mattioli costituì l’unica filiale Comit fuori di Milano, a Roma. A Roma non c’era mai stata e non ci sarà più una filiale Comit, fu solo per il riciclaggio delle AM-lire. Tanto per dire i meccanismi.Quindi, da una parte il partito forte e dall’altra parte l’alleato grande. Chi cura i nostri interessi a Washington oggi? Salvini, che il giorno pri-ma è stato da Putin? Di Maio? Conte? Chi ci garantisce? Vogliamo cambiare alleanza? Fac-ciamo che il grande alleato dei prossimi cin-quant’anni sarà la Cina? Ma chi va a trattare? Con gli americani trattarono e garantirono Mattioli, insieme a Cuccia, Morelli e Quintieri. Abbiamo quattro persone così oggi? Abbiamo Draghi. È uno solo e non è detto che poi sia così profondamente appartenente ai poteri tra-sversali da poter garantire questa parte. Forse la dimensione internazionale, i circuiti finanziari americani li copre. Ci servirebbe un Mattioli oggi, altrimenti alla Goldman Sachs chi ci va? Chi tratta sullo spread con quelli che fanno il circolo? Siamo sempre in attesa di sapere se sale o scende perché nessuno lo controlla.Ultimo punto è quello delle categorie. La Dc è stata forte grazie al collateralismo. Perché intor-no aveva Coldiretti che copriva un milione di contadini, Confartigianato con Germozzi che gli copriva 700mila artigiani, e così via. La cosa strana è che il collateralismo non l’ha inventa-to né Montini né De Gasperi. Se l’è inventato Pio XII. È strano, perché era un papa romano, nobile, reazionario, amico dei tedeschi, aveva tutto per non piacere. L’unica cosa è che andò a San Lorenzo dopo il bombardamento, men-tre il duce no. Pio XII nei primi di luglio del ’44, meno di un mese dopo che Roma era stata liberata, chiamò due maestri elementari: Ma-ria Badaloni, che sarebbe diventata poi sotto-segretario di Stato alla Pubblica istruzione, la padrona del Ministero, e Carlo Carretto, che era stato dirigente di Azione Cattolica e poi li-tigò con Gedda e se ne andò a fare l’eremita in Africa. Li chiamò e gli disse: “Questa è la busta con i soldi, in cortile c’è una macchina, doma-ni partite, girate tutto il Mezzogiorno e in ogni
stessa Lega non è un soggetto forte. Appare tale perché Salvini fa il bullo, perché controlla tre o quattro regioni, perché sa gestire bene la perife-ria, però non è forte.Secondo punto: l’alleato forte. Nel ’45 De Ga-speri mandò una delegazione italiana a Wa-shington a trattare per il dopoguerra. Questa delegazione italiana, non si capisce bene da chi fu decisa, era formata da quattro persone: Cuccia, Mattioli, Morelli e Quintieri. Nessuno ne sapeva niente. Qualche mese dopo Montini andò negli Stati Uniti per tre settimane: non ha mai detto chi ha visto. Alla domanda della nipote, o del marito della nipote “ma che sei andato a fare, chi hai visto?”, rispose “ero anda-to per ferie”. Che Montini fosse andato in ferie negli Stati Uniti non ci ha mai creduto nessu-no. Dopo sei mesi De Gasperi sancì l’alleanza fatta prima.Notare, perché fa parte del terzo punto: la composizione della missione resta sconosciuta ai più, tranne che per i lettori di cose strava-ganti. Nel libro di memorie dell’ambasciatore Ortona, che nessuno ha letto, c’è scritto che questa delegazione fece un grande lavoro. C’era il problema delle AM-lire da riconvertire, c’era il problema del debito. Quando De Gasperi nel ’47 fece fuori i comunisti e i socialisti dal go-verno, perché questo era l’accordo, i comunisti decisero di fare una grande battaglia popolare per il tradimento della collaborazione antifa-scista: non fu facile per De Gasperi tradire la cultura che aveva fatto la Resistenza. Mattioli scrisse una lettera a Togliatti, tramite Rodano, in cui dice di stare attenti, di non rompere in quel momento perché l’America non avrebbe capito e l’Italia senza l’America non era nessu-no. Il rapporto con gli statunitensi era allora un rapporto duplice perché c’era anche l’entourage di Roosevelt che era tutto massonico. Dai dati, dai documenti, emerge che è stato Mattioli a garantire il rapporto con gli statunitensi, più degli ambasciatori e più del piano Marshall. Il regalo che Mattioli fece agli statunitensi, la contropartita che gli diede, fu la soluzione delle AM-lire. Loro avevano una miliardata di roba
24
GLI A
SINI 69
IN CASA
tutto, in Russia come in Cina. Il fatto è che oggi si sono spaccati, o si sono alleati, due diversi po-teri: uno garantisce la sicurezza, uno garantisce un senso della vita. Per esempio, Putin garanti-sce la sicurezza. Se oggi si va in Russia si dice: “Non saranno liberi, però si sentono sicuri”. Dall’altra parte però, l’alleato scelto da Putin è Cirillo, Metropolita di Mosca, cioè uno che garantisce la Santa Russia, la tradizione, cioè l’i-dentificazione collettiva con qualcosa che non sia l’oggi. Questa coppia funziona. Mentre in Italia e in Europa no, perché nessuno garantisce la sicurezza e nessuno può garantire uno scopo, un senso della vita. Se in Italia parli di radici cristiane, l’Europa moderna dice che non sono cristiane, sono illuministe e si litiga subito. La stessa cosa avviene in Cina. In Cina c’è un siste-ma che ammazza, ogni anno ci sono migliaia di esecuzioni capitali, però la situazione è sicura, il partito governa. Allo stesso tempo, il partito da tre anni a questa parte ha riscoperto Confucio, oggi lo dicono: “Governiamo col confuciane-simo, perché il confucianesimo è la correttezza dei rapporti”.Per certi versi anche nei paesi arabi è così: da una parte c’è la serrata brusca sui comporta-menti individuali, anche qualche impiccagione, come in Iran, e poi c’è la sharìa, c’è Maometto. A riderci sopra, noi avevamo Salvini e Di Maio: Salvini che faceva la sicurezza e Di Maio la lot-ta alla povertà... lo dico scherzando. Erano la caricatura di Putin, la caricatura del consolato guelfo, in cui un console dà la sicurezza e l’altro dà il senso della vita.Il rancore invece è il sintomo che l’ascensore sociale si è fermato, non ci sono più traguardi. Noi dobbiamo trovare qualcosa che sia insieme risposta alla sicurezza e al rancore dandogli una prospettiva di futuro, un senso della vita. Putin è riuscito a mettere insieme questi due aspetti, non va in piazza con il rosario. Salvini fra l’al-tro si era preso il consolato della sicurezza, non poteva prendersi anche quello del senso della vita, lo doveva lasciare a Di Maio. Il ridicolo è che noi usciamo da una discontinuità forte con niente fra le mani.
provincia costituite una sezione dei maestri cattolici italiani, perché i meridionali non han-no mai avuto flussi di cultura. L’unica persona che pensano sia culturalmente vicina a loro è il maestro elementare. Noi dobbiamo coprire il vuoto”. Qualche giorno dopo fece lo stesso discorso non a Bonomi ma ai bonomiani, cioè a Coldiretti. Il collateralismo nasce con Pio XII non con Montini, non con De Gasperi. Ancora oggi se tu vuoi un minimo di elettorato semi-cattolico devi andare da Coldiretti, da Confar-tigianato. Ecco queste quattro cose hanno fatto la Dc di allora, sono stati gli assi su cui si è co-struita l’Italia.Questo è il problema del nostro continuismo, perché il continuismo vero sarebbe di capire quali sono gli assi equivalenti a quelli di set-tant’anni fa. Il fatto vero è che non riusciamo a capire dove impegnare la ricerca per lo snodo, l’asse che ci fa riprendere velocità. Io che sono sempre stato un ottimista di natura, in questo momento sono un po’ più prudente.
E poi c’è un altro problema: a che serve un centro di ricerca se nessuno ti adopera? Una volta il Cen-sis faceva l’autocoscienza della società, ma adesso chi la ascolta questa coscienza? Manca proprio l’interlocuzione. Lei dice giustamente: il sociale è protagonista. Il suo testo si apre con due motori su cui vorrei fare una domanda: il rancore e la sicurezza. Mi sono chiesto il perché del rancore? Come mai, dopo tutto quello che ha raccontato, le persone che sono passate dai campi agli uffici senza passare per le officine, non sono grate a que-sto meccanismo democristiano, poi comunista, che li ha portati a questo livello? Forse è più avidità, voglia di continuare a essere sicuri del consumo, piuttosto che essere rancorosi, perché il rancore ver-so il politico a me sembra un po’ come il razzismo verso l’immigrato. Perché anche questo problema della sicurezza, è un bisogno o è una funzione? Cioè, l’insicurezza esiste, ma l’insicurezza ha ve-ramente come risposta la sicurezza?Il punto cruciale l’ho scritto un anno e mezzo fa in un librettino intitolato Il consolato guelfo. Nel mondo il problema della sicurezza c’è dapper-
25
IN CASA
GLI A
SINI 69
no, lui lo rappresenta proprio in maniera totale.È un problema di misura del linguaggio, che non è soltanto il parlare. Linguaggio è anche pensare, ragionare. Le discontinuità si rivelano come rotture di linguaggio. Con il Sessantot-to abbiamo avuto una rottura del linguaggio. Con il ’93 abbiamo inserito la parte penalistica del reato, il sospetto di reato, la galera. Anche stavolta il linguaggio è cambiato. Salvini parla un linguaggio strano, che non è la misura ita-liana del linguaggio. La cultura italiana si basa sulla misura del linguaggio, e non perché ab-biamo avuto grandi poeti misurati nel linguag-gio, ma perché tutti noi siamo stati abituati dai nostri maestri elementari ad avere il senso della misura. I greci dicevano che il grande pecca-to dell’uomo è la dismisura. Quando perdi la misura sei un dismisurato. La non misura è il grande peccato. E noi oggi siamo in un mecca-nismo di dismisura del linguaggio.L’altro giorno sono andato alla commemo-razione dell’avvocato Ambrosoli. C’era tutta la Milano bene, il Piccolo Teatro era pieno, Mattarella stava in prima fila. C’erano tutti. Tranne il Sindaco perché stava trattando per le Olimpiadi. Io dovevo parlare per ultimo, pri-ma del Presidente. Ho detto: “Guardate che la legalità non è un valore. La legalità è un eserci-zio ostinato. Se pensate alla vita di Ambrosoli, Ambrosoli ha fatto l’esercizio ostinato della le-galità. Per quattro anni, cinque anni, si è spul-ciato tutti i bilanci, passetto per passetto. Il meccanismo è l’ostinazione del valore. Il valore non basta senza ostinazione. Io ho avuto una madre-maestra. Ricordo perfettamente la mia maestra elementare, la signora Menghini. Ri-cordo il mio maestro degli ultimi tre anni alle elementari, il professor Cabras,” – Mattarella ha sorriso perché il nipote del mio maestro sta nel suo staff – “mi ricordo la capacità di queste maestre di essere ostinate nel farti fare per la decima volta la stanghetta, per la quattordice-sima volta una ‘a’ aperta in una certa maniera. I valori valgono se c’è un’ostinazione dietro”. Altrimenti fai la nave della legalità, fai il tre-no della legalità, fai l’anno della legalità. Non
Come mai non è ridicolo questo ridicolo? Noi ci ridiamo, ma noi in fin dei conti siamo persone normali. Gli altri godono, non si capisce come fare.Il ridicolo non è ridicolo perché si rincorre la cronaca e quindi nessuno, né io né lei, nessuno di noi è in grado di dire: “Stiamo due minuti fermi e guardiamoci negli occhi”. Se li guardas-simo negli occhi gli diremmo che sono ridicoli. Però siccome loro non si fermano, continuia-mo ad andare avanti così. Morisi, cioè il capo portavoce di Salvini, ha una macchina di 16 o 33 persone e ogni mattina dà un foglietto a Sal-vini con scritti i fatti di cronaca, gli episodi da cavalcare. Fa colazione con una granita di caffè alle 8,30 di mattina e dopo comincia a parlare della cronaca. E tu che fai? Gli dici “stai buo-no, fermati, guardati allo specchio”? Lui non si guarda mai allo specchio, è impossibile per loro guardarsi allo specchio perché cavalcano la cro-naca, e cavalcare la cronaca significa non avere un momento di sospensione in cui qualcuno ti può dire: “Guardati in faccia, sosta dinanzi allo specchio per un minuto e mezzo e poi ne par-liamo”.
C’è anche questo... il problema che chi sta di fron-te è focalizzato soltanto a mettere in evidenza il ridicolo senza andare oltre. Se è vero che da un lato non c’è classe dirigente, mi sembra che neppu-re dall’altra parte ci sia qualcosa. Ciò che rimane da fare è usare lo stesso tipo di logica: rispondere a un tweet cercando di ridicolizzare persone ridi-cole. Anche sui giornali, vediamo “la Repubblica” che cerca di inseguire il “Fatto Quotidiano” sui titoli. Però si fermano lì, oltre all’annuncio del ri-dicolo non c’è niente. Loro vogliono che si passi dalla cronaca alla pubblicità della cronaca. Non si tratta di dire che l’imperatore è nudo, è il popolo che dovreb-be dire che è nudo, ma non lo fa. Vivendo nello stesso meccanismo se ne guarda bene. Per cui Salvini lo rappresenta in maniera totale, molto meglio di Berlusconi – il quale si rappresentava come il vincitore della lotteria –, mentre Salvini
26
GLI A
SINI 69
IN CASA
cultura individuale. Cosa gli importa al diretto-re del bell’articolo di Mauro Magatti a pagina 28. Lui ha il problema della prima pagina.La verità è che l’intellettuale tradizionale, lo Sciascia di turno, non esiste più. Lo stesso Scia-scia finale, del resto, era diventato radicale, par-lava troppo. Il contraltare di Sciascia è Saviano. Saviano scrive tutte le settimane su “l’Espresso”, scrive una volta ogni tre giorni su “la Repubbli-ca”. A quel punto, non vale più, non suona più, non ha più il senso del suono. Sono dei solisti che da soli non sanno stare e quindi preferisco-no intrupparsi nella grande orchestra..
serve a niente perché resta sul piano generale.La prima cosa da fare oggi è restituire la misura attraverso le figure fondamentali: i genitori, le maestre elementari. Perché se non restituisci la misura non ce la fai. I profeti del domani sono coloro i quali hanno l’ostinazione della misura.
Sento un’enorme mancanza, oggi, sul piano delle figure di intellettuali di riferimento. Di giornali-sti, scrittori, studiosi che, venendo dalla genera-zione cresciuta sotto il fascismo e durante la guerra mondiale, si ponevano i problemi della civiltà, della società, della trasmissione di cultura, della formazione di una popolazione che era in gran parte analfabeta. Ho nostalgia di Sciascia, che penso fosse una delle persone fondamentali nel raccontare l’Italia in modo provocatorio, di Paso-lini, Morante, Calvino, Moravia. Non ci sono più figure di riferimento culturali che potevano essere il riferimento per le maestre elementari, per il cro-nista di “Paese Sera”, ma che davano una sorta di super-io al lavoro culturale che serviva poi nella trasmissione alle cosiddette “masse”. La Morante scriveva un libro ogni quattro anni, la critica letteraria di Cardarelli usciva ogni mese, ogni due mesi. Oggi l’intellettuale di quel tipo finisce nella cronaca. Saviano scrive un articolo a settimana. Io scrivo un articolo ogni venti giorni e già mi costa. Un articolo alla settimana, me lo spiegava Giampaolo Pansa quando eravamo giovani, è una tragedia. Dice: “Ma io oggi che scrivo? Che devo dire? Che mi invento?”. L’intellettuale che deve scrivere una volta alla settimana non è più un intellettuale. Però il mondo dell’opinione, il mondo della co-municazione si cattura lì.Se tu pensi a Luca Ricolfi, una persona che stimo molto e che fa questo mestiere. Ricolfi che scrive il fondo del “Messaggero” è catturato dalla cronaca. Se il direttore gli telefona e gli chiede per il giorno dopo il fondo su, lui scrive il fondo su Putin. Non è più il Ricolfi che co-nosciamo, che vedevamo una volta ogni tanto. L’intellettuale si è fatto prendere dalla voglia di apparire ogni giorno nella cronaca, perché sa che la cronaca sul mercato vale di più della sua
27
GLI A
SINI 69
PIANETAL’ISOLA DEI FUCILI. MIGRANTI DI IERI, MIGRANTI DI OGGI
DI AMITAV GHOSH
INTERVISTA CON ANNA NADOTTI E NORMAN GOBETTI
Nei tuoi ultimi libri (e forse non solo negli ultimi), anche ne L’isola dei fucili (Neri Pozza 2019), il meticciato linguistico è un tratto molto evidente. È chiaro che non si tratta solo di pasti-che lessicali. È come se nelle tue opere le lingue assumessero un corpo e diventassero protagoniste. Ci sembra una scelta oggi di grande rilevanza politica e culturale. Sebbene io scriva in inglese, la mia sensibilità linguistica si è forgiata nel pluralismo lingui-stico del subcontinente indiano. Tali circo-stanze, con il loro potenziale creativo, hanno avuto un’influenza profonda, anzi direi for-mativa, sulla mia opera. Il problema di come riprodurre in un’unica lingua una realtà mul-tilinguistica sottostà in un modo o nell’altro a tutta la mia opera, e a seconda dei periodi ho raccolto questa sfida in modi diversi.Per me è sempre stato evidente che non può esserci alcuna soluzione naturalistica, e tanto meno “realista”, ai dilemmi letterari posti dalla fluidità del paesaggio linguistico del subcon-tinente. Cercare di restituire sulla pagina l’in-tero spettro delle lingue in gioco è semplice-mente impossibile. Ne consegue che le uniche soluzioni possibili sono di tipo formale: vale a dire che la pluralità linguistica dev’essere sug-gerita retoricamente e non naturalisticamente.
All’inizio, ad esempio quando stavo scrivendo il romanzo Le linee d’ombra, ho adottato un approccio influenzato da Proust. Ho cercato di rendere la narrazione completamente inte-riore, e così è diventata un collage di ricordi frammentari; le scene e anche la conversazioni venivano raccontate come brandelli di memo-ria in cui il tessuto linguistico è stato smussato dal tempo. In seguito mi è parso di poter trovare soluzio-ni migliori, ovvero più stimolanti o eleganti, in altre dimensioni della lingua, ad esempio la prosodia, la lingua e il metro. Con i tre ro-manzi della Trilogia della Ibis – Mare di papa-veri, Il fiume dell’oppio e Diluvio di fuoco – mi sono mosso in una direzione del tutto diversa. Questi romanzi sono ambientati in molti luo-ghi nell’area dell’Oceano Indiano, e presenta-no una molteplicità di personaggi eterogenei come quelli che realmente all’epoca popolava-no i “mondi fluttuanti” dei mari orientali. In questo universo riccamente multilinguistico quasi ogni singolo personaggio aveva un’iden-tità linguistica complessa.Oggi questi esperimenti letterari sono più che mai necessari, perché ci troviamo in una nuova era, l’Antropocene. L’intensificarsi del riscalda-mento globale negli ultimi decenni è di per sé
28
GLI A
SINI 69
PIANETA
gli indiani hanno completamente dimenticato il proprio ruolo nel commercio dell’oppio. Le sofferenze inflitte alla Cina attraverso l’oppio indiano rappresentano uno dei più grandi crimini della storia dell’umanità, e io ritengo che gli indiani debbano fare i conti con questo aspetto del loro passato. Rabindranath Tago-re, il poeta indiano cui fu attribuito il premio Nobel nel 1913, una volta scrisse: “È diventa-to sempre più evidente che al di là dei confini d’Europa la fiaccola della civiltà non intende-va portare luce ma appiccare incendi. Così è accaduto che pallottole di oppio sostenute da palle di cannone fossero dirette al cuore della Cina, un’atrocità di cui la storia non aveva mai conosciuto l’eguale...”Tra la guerra in Iraq e la guerra dell’oppio ci sono chiari parallelismi, soprattutto nei discor-si che le hanno giustificate. C’è tutta questa retorica evangelica, queste presunte buone in-tenzioni: “Stiamo agendo per il bene del mon-do”. Ma sotto tutto questo c’è una mostruosa violenza, una mostruosa avidità e cupidigia. Ho scritto la Trilogia della Ibis in un periodo in cui questo tipo di ideologia capitalista era allo zenit, e si era convinti che il mercato fosse Dio. In tale contesto, mi colpiva che nessuno si rendesse conto che per i liberisti il primo e più importate banco di prova era stato l’oppio. Tutto ciò è stato cancellato dalla memoria.
Anche i rapporti fra India e Cina sono al centro della trilogia della Ibis. Oggi in Europa l’asce-sa dell’India appare molto meno minacciosa di quella della Cina. Si sottolinea come l’India sia una democrazia mentre quello cinese viene con-siderato un regime dittatoriale. Ma c’è davvero una differenza sostanziale fra l’autoritarismo de-gli attuali governi cinese e indiano (nonché di molti governi occidentali)?Sì, è vero che la “comunità globale” tende a vedere più favorevolmente l’India che la Cina. Ciò ha molto a che fare con la storia del nazio-nalismo indiano e in particolare con l’eredità di Gandhi. Ed è fuor di dubbio che l’India appaia all’Occidente molto meno minacciosa
un effetto dell’accelerazione generale: nel mo-vimento di merci, persone, macchinari e infor-mazioni, nonché nel ritmo delle estinzioni, dei dislocamenti forzati e del collasso ecologico. Tutti processi che hanno già avuto un impatto profondo, sebbene largamente ignorato, sulla lingua e sulle pratiche letterarie.
L’opinione pubblica europea assiste con grande apprensione all’ascesa economica e politica della Cina. Leggendo la trilogia della Ibis si ha modo di conoscere il retroterra storico dei rapporti fra Europa e Cina, un tema poco presente nella con-sapevolezza dei cittadini europei, e che forse ci aiuta a comprendere meglio come si è giunti alla complessa situazione attuale.Ci sono molti curiosi paralleli fra la la bilancia commerciale odierna e quella del Settecento e dell’Ottocento: allora, come oggi, il mondo occidentale aveva un enorme deficit commer-ciale con la Cina. Fu per questo che la Compa-gnia delle Indie orientali britannica cominciò a esportare oppio verso la Cina su larga scala, con conseguenze catastrofiche per quel paese. Alla fine naturalmente gli inglesi dichiararono guerra alla Cina in nome del Libero Mercato, ma il principale prodotto che loro esportava-no, l’oppio, veniva prodotto nella Bengal Pre-sidency in regime di monopolio di stato! Mi meraviglia che oggi i politici e i loro consiglieri continuino a usare lo stesso linguaggio otto-centesco quando parlano di Libero Mercato: è come se questa idea non avesse un passato, non avesse una storia.L’Occidente ha sempre avuto un grande talen-to nel dimenticare le proprie malefatte e nel ricordare quelle degli altri. Questa amnesia ha, io credo, un costo terribile. Poche persone oggi rammentano che le guerre dell’oppio venne-ro combattute in nome del Libero Mercato. Talvolta mi chiedo se gli ideologi che disqui-siscono delle virtù del Libero Mercato siano consapevoli degli orrori provocati da questo complesso di idee. Per quanto gli occidenta-li non siano gli unici che hanno preferito di-menticare questo capitolo della storia. Anche
29
PIANETA
GLI A
SINI 69
rateria. Ma questa è anche la regione in cui le potenze europee hanno scaricato tonnellate di scorie radiottive. L’insieme di questi fattori ha creato un letale circolo vizioso, influendo sulla vita di milioni di persone. Solo una pic-cola percentuale tenta di attraversare il Medi-terraneo, per la maggior parte si riversano nei paesi confinanti. Ma col passare del tempo è inevitabile che gli effetti di questi dislocamenti forzati si ripercuotano su tutto il mondo. Oggi ci sono città della Cina che hanno centinaia di migliaia di lavoratori immigrati africani.
La migrazione verso l’Europa è il tema centrale del tuo ultimo libro, L’isola dei fucili. È eviden-temente un argomento all’ordine del giorno, ma il modo in cui tu lo affronti è molto peculiare. Da un lato trai ispirazione da, e ti attieni a, avve-nimenti di stretta attualità, dall’altro l’impianto romanzesco si sviluppa intorno a snodi narrativi (presagi, coincidenze, apparizioni, eventi quasi miracolosi) in cui è presente una dimensione di mistero e trascendenza inafferrabile con gli stru-menti della razionalità.Sì, la migrazione verso l’Europa, e l’Occiden-te nel suo complesso, è uno dei temi centrali del libro. Scrivendone ho ampiamente attinto alle mie conversazioni con migranti arrivati n Italia attraverso il Mediterraneo. Per me queste conversazioni sono state esperienze davvero ri-velatrici. Ho scoperto che i processi migratori sono molto più complessi di quanto avessi im-maginato. Dietro ogni viaggio c’è una molte-plicità di cause: il clima, necessità economiche, coincidenze, dinamiche famigliari, fantasie, tecnologia, amicizie, inimicizie, solidarietà... Ogni storia è un’epopea.Una volta, a Roma, stavo camminando die-tro un italiano in sedia a rotelle spinto da un badante bangladese. L’italiano parlava delle sue “avventure”, che consistevano fondamen-talmente in viaggi turistici in vari paesi del mondo. Mi venne da pensare che le avven-ture del badante sarebbero state molto più interessanti...
della Cina. Anche questa visione ha una lunga storia. Già nel Settecento gli inglesi considera-vano i cinesi come i loro unici seri concorrenti per il ruolo di “razza superiore”. Il fatto che la Cina fosse un impero unitario è uno dei motivi per cui non ci fu alcun serio tentativo di con-quistarla da parte dell’Occidente. Gli indiani invece furono sottomessi con grande facilità e finirono per essere considerati “docili”. Questa è una delle ragioni per cui gli inglesi riteneva-no che fossero particolarmente adatti al lavoro coatto. Oggi il fatto che l’India venga spesso definita la più grande democrazia del mondo gioca potentemente in suo favore. Ma di fatto, come è sempre più evidente, l’India sta diven-tando una sorta di dittatura della maggioranza molto repressiva e intollerante. È una situazio-ne difficile e minacciosa.
Una delle aree in cui più si concentrano gli in-vestimenti (non solo economici, ma anche cultu-rali e formativi) cinesi è il continente africano, che è stato a lungo uno dei poli del colonialismo europeo e oggi è il luogo di provenienza di una gran parte dei migranti che cercano di arrivare in Europa. In questo scenario in continuo mu-tamento gioca un ruolo fondamentale anche il cambiamento climatico, che è al centro dei tuoi due ultimi libri, il saggio La grande cecità e il romanzo L’isola dei fucili. Un groviglio quasi inestricabile.Europa e Africa sono inestricabilmente con-nesse fin dal periodo ellenistico e dall’epoca dei faraoni. L’eredità di cinquecento anni di inter-venti europei in Africa, dalla tratta degli schia-vi al colonialismo e, più di recente, l’apartheid e il neocolonialismo, hanno profondamente destabilizzato l’intero continente. Quando si guarda a questa realtà è difficile distinguere i diversi fattori. Per esempio, una prolungata, terribile siccità ha colpito il Sahel e la Soma-lia. Nello stesso periodo, l’eccesso di pesca nel Mare Arabico ha portato alla drastica diminu-zione delle riserve ittiche privando dei mezzi di sostentamento moltissime persone, che di conseguenza hanno dovuto ripiegare sulla pi-
30
GLI A
SINI 69
PIANETA
e cattivi, mentre, almeno in Italia, nel trattare questo tipo di argomenti si tende a rifugiarsi die-tro una maschera di distacco, se non di cinismo. Il tuo è un approccio che impone di riflettere e interrogarsi. Sottolinea il dovere di farsi le giuste domande oltre che cercare delle risposte.Se il mio approccio sembra ingenuo è perché la scrittura occidentale contemporanea è ormai intrappolata in gabbie sovrapposte di ironia e cinismo. Io non voglio avere assolutamente nulla a che fare con questo tipo di scrittura. Quindi è inevitabile che per contrasto una voce narrante come quella dell’Isola dei fucili susciti sconcerto. Una volta si poteva credibil-mente sostenere che l’ironia fosse sovversiva, un mezzo per criticare il potere, ma oggi ve-diamo che in tutto il mondo l’ironia è ormai un’arma in mano alla destra, ai conservatori e ai razzisti. Sono davvero riusciti a perfezionare l’arte dell’ironia: l’universo digitale della destra pullula di ironia violenta. In questo contesto credo sia estremamente necessario che gli scrit-tori trovino altre voci.
L’isola dei fucili si svolge in buona parte in Ita-lia, paese che negli ultimi anni frequenti abitual-mente e di cui ormai parli benissimo la lingua. La tua attenzione al nostro paese un po’ ci lusinga e un po’ ci sorprende.
Be’, Anna, la ragione per cui nel corso degli anni ho continuato a venire in Italia è che fin dal mio primo libro ho ricevuto un’accoglien-za molto calorosa. Di ciò, tu sei in non picco-la parte responsabile, sia perché mi hai dato una voce che gli italiani apprezzano, sia per-ché la nostra amicizia è stata un grande dono (e per questo il mio ultimo libro è dedicato a te, e a Irene Bignardi, anche lei mia amica da trent’anni). Devo dire che ho quasi altret-tanti amici in Italia che in India! Credo fosse inevitabile che prima o poi scrivessi qualcosa ambientato in Italia.
Una delle cose che più ci ha colpito in L’isola dei fucili è il fatto che non temi di esporti a possibili accuse di “ingenuità”. Nel tuo libro ci sono buoni
31
PIANETA
GLI A
SINI 69
LE ELEZIONI IN ISRAELE:NON C’È SOLO
NETANYAHUDI DAVIDE E GAD LERNER
Nel 1993, nel suo prolisso volume Israele e il suo posto fra le nazioni (A Durable Peace: Israel and it’s Place Among the Nations, il libro non è stato tradotto in italiano), il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu raccontava la sua visione “hobbesiana” del Medio Oriente. In un contesto così “dispotico,” scriveva, Isra-ele poteva aspirare, tutt’al più, a prosperare mantenendo una “pace di deterrenza” coi vi-cini arabi. “La prevalenza del radicalismo in Medio Oriente, e il pericolo che nell’assenza di tradizioni democratiche un regime possa diventare radicale da un giorno all’altro, signi-fica che la pace deve fondarsi su garanzie di sicurezza”. Non era certo una teoria origina-le. Il padre del sionismo revisionista, Vladimir Ze’ev Jabotinsky, simpatizzante di Mussolini e acerrimo nemico di ogni declinazione socia-lista del nazionalismo ebraico, aveva già for-mulato la sua dottrina del Muro di Ferro nel lontano 1923: solo esercitando la forza, e senza illudersi di poter cooperare con i suoi vicini, il nascituro Stato degli ebrei avrebbe potuto garantirsi il suo spazio vitale. Tradotta nel lin-guaggio dell’uomo della strada israeliano, que-sta è la teoria secondo cui “l’unico linguaggio che capiscono gli arabi è quello del bastone”. Su questo tipo di argomentazioni si era dun-que fondata la lunga carriera politica di Netan-yahu, dopo che già prima di lui Begin, Shamir e Sharon avevano sovvertito i rapporti di forza riducendo a minoranza il sionismo d’impron-ta socialisteggiante del fondatore Ben Gurion. La sinistra si era macchiata di un “errore con-cettuale”, sosteneva Netanyahu appena nomi-nato premier nel 1996, riprendendo le istanze teorizzate nel libro: cioè quello di pensare che
la pace da sola garantisse la sicurezza, e non il contrario. Ogni concessione era invece agli occhi di Bibi nulla più che una “riedizione di Monaco nel 1938,” una dimostrazione di de-bolezza che andava sostituita col rafforzamen-to militare supportato da exploit diplomatici e innovazioni tecnologiche capaci di sedurre i nemici arabi fino a indurli ad accantonare la non-questione palestinese. In altre parole, le petromonarchie del Golfo, l’Egitto e la Siria andavano costretti con la forza e per conve-nienza al riconoscimento dello Stato d’Israele; rinunciando a sventolare la bandiera (dal suo punto di vista meramente propagandistica) della causa palestinese.Un quarto di secolo più tardi Benjamin Ne-tanyahu sembra essere arrivato al capolinea della sua parabola politica, dopo aver superato il fondatore dello stato Ben Gurion per nume-ro di giornate trascorse al potere. Ma proprio allorquando si assiste alla sua parabola discen-dente, la visione di Netanyahu è divenuta lo Zeitgeist della politica israeliana. Le elezioni del 17 settembre 2019, una replica ravvicinata e avventurosa di quelle tenute solo pochi mesi prima in aprile, e che si erano risolte in uno stallo politico, hanno registrato sì una levata di scudi contro il personaggio Netanyahu, ma anche un appiattimento generale sulle sue idee politiche, rimaste coerenti con quel libro degli anni Novanta. Ecco allora che l’opposizione lo critica non per la paralisi del processo di pace, per la crisi nella la striscia di Gaza o per la re-torica xenofoba contro gli arabo-israeliani, ma per la sua megalomania, per il coinvolgimento nei casi di corruzione, e per le mosse-anti-de-mocratiche a cui sarebbe pronto pur di salvarsi dagli imminenti processi. Per il resto, come ha scritto il giornale “Haa-retz”, gli avversari sono una schiera di “Wan-na-bibis,” vorrebbero cioè essere il più possi-bile come lui, ma senza di lui. L’ex generale Benny Gantz, il cui partito “Blu e Bianco” per molti versi assomiglia a un Likud senza Ne-tanyahu, in campagna elettorale insisteva di essere in grado di emulare Bibi sul piano della
32
GLI A
SINI 69
PIANETA
diplomazia internazionale. Il suo vice, l’incon-sistente ex presentatore televisivo Yair Lapid, portabandiera di una laicità minacciata dal messianismo apocalittico degli ultraortodossi, ne ha imitato perfino la nota tattica di gridare alla disfatta in fieri nel giorno delle elezioni. Quanto alla sinistra, ormai ridotta a un ruolo marginale nel sistema politico israeliano, soffre ancora, a distanza di anni, lo choc terroristi-co della seconda intifada e dei suoi uomini-bomba. Da allora il Labour, ormai travolto dai centristi persino nell’enclave liberal-pro-gressista di Tel Aviv, concentra la sua azione politica sulle tematiche sociali di lotta contro le disuguaglianze, autocensurandosi riguardo alla questione palestinese e all’obiettivo dei due Stati per cui aveva sacrificato la sua vita Yitzhak Rabin. L’incapacità di confrontarsi con quel trauma e di riproporre una soluzio-ne di pace per la convivenza dei due popoli, condanna la sinistra a rimanere succube di una realtà politica plasmata da Netanyahu.Davvero alternativa rimane invece la Lista Araba Unita (13 seggi), la rappresentanza della minoranza arabo-israeliana. Lo scorso aprile i quattro partiti che la compongono, in disac-cordo su come formare la lista comune, aveva-no finito per dividersi in due formazioni e sco-raggiare i propri elettori, che scelsero in massa di astenersi dal voto. Ma il 17 settembre, in seconda battuta, si sono affermati solidamente come terzo polo. Al punto che il loro leader Ayman Odeh ha twittato, citando il Libro dei Salmi: “La pietra scartata è divenuta la pie-tra angolare.” Richiamo suggestivo, rivelatosi un po’ troppo ottimistico, benché la tornata elettorale abbia segnato un’indubbia svolta nel campo arabo: se è vero che, secondo i sondaggi, l’87 per cento degli arabo-israeliani vorrebbero che il loro partito entrasse in una coalizione di governo, e ancor più che ormai preferiscono definirsi “arabo-israeliani” piuttosto che “pa-lestinesi.” A Bibilandia, però, nessuno prende in considerazione l’eventualità di stipulare ac-cordi politici con gli arabi, malgrado la timida apertura in questo senso di Ayman Odeh alla
vigilia delle elezioni. E comunque, lo ha dimo-strato l’aritmetica all’indomani della seconda tornata, a meno di defezioni a destra ciò non basterebbe a comporre un governo delle oppo-sizioni che riscuota il sostegno della maggio-ranza alla Knesset. Di fatto, se Netanyahu non riesce a forma-re una coalizione con gli alleati tradizionali, come aveva fatto dopo le elezioni del 2009, 2013 e 2015, è solo a causa dell’improvvisa ri-volta dell’ex braccio destro e alleato Avigdor Lieberman. Da sempre difensore delle istanze laiche, Lieberman aveva digerito negli anni il matrimonio di convenienza fra Netanyahu e i partiti ultra-ortodossi, forti di un elettorato fedelissimo e in crescita per ragioni demogra-fiche.L’intransigenza di Lieberman sul tema della legge per la coscrizione obbligatoria degli ul-trareligiosi, che ha impedito la costituzione di un nuovo governo in primavera e continua a imporre uno stallo dopo le nuove elezioni, è stata dunque interpretata dai più come prete-stuosa: una scusa per inguaiare il suo ex pa-drino politico. Riaccendendo i riflettori sulla questione del rapporto fra religione e Stato, dal tema dei matrimoni civili all’obbligo di chiusura per i negozi e l’assenza di trasporti pubblici di Shabbat, Lieberman ha danneg-giato Netanyahu attirando a sé l’elettorato di destra infastidito dal sodalizio con i religiosi. Il resto l’ha fatto la sparata di Bezalel Smotrich, leader di un partito pro-insediamenti ma fede-le al Likud, secondo cui Israele dovrebbe essere governato dalla “legge religiosa”.A qualche settimana dalla seconda tornata elettorale, che già era senza precedenti per la sua vicinanza a quella di aprile, in Israele non è più tabù discutere di un terzo ritorno alle urne. A meno di colpi di scena, come un passo indietro di Netanyahu, un’improvvisa disponi-bilità di Gantz a entrare in un governo di lar-ghe intese, o un ritorno di Lieberman al vec-chio ovile delle destre, l’ineluttabilità di una terza consultazione appare scritta nei numeri. E visto che per Netanyahu si avvicina anche la
33
PIANETA
GLI A
SINI 69
resa dei conti sul piano giudiziario, qualcuno già storpia la citazione di Einstein sulle pros-sime guerre mondiali: “Non so quali armi si useranno per le terze elezioni, ma per le quarte si useranno pietre e bastoni.” E chi riuscirà ad abbattere Netanyahu dovrà comunque fare i conti con il suo vecchio libro.Se questi sono i limiti angusti in cui resta imprigionato lo scenario politico israeliano, e l’establishment dello Stato ebraico sembra puntare tutte le sue carte sull’azzardo di una scivolosissima alleanza con l’islam sunnita con-tro il nemico-spauracchio dell’Iran sciita, pure va rilevato un esito imprevisto e incoraggiante delle ultime elezioni: il dilemma esistenziale di Israele, la contrapposizione lacerante fra una visione laica del suo sistema democratico e le pulsioni integralistiche alimentate dai movi-menti messianici, non si è risolta a favore di queste ultime. Permane un equilibrio, nono-stante la demografia sembrasse giocare a favore degli oltranzisti che puntano a fare di Israele uno Stato mediorientale sottomesso ai vincoli dell’appartenenza religiosa.Per fortuna, anche la destra, su questo terre-no pericoloso per le sorti della democrazia, si divide. La marea del fondamentalismo che imperversa nell’islam mediorientale e che per reazione ha contagiato anche l’ebraismo, non sembra più invincibile. All’opportunista Ne-tanyahu, pronto a sottomettersi strumental-mente all’egemonia culturale del movimento dei coloni pur di conservare il potere, la mossa non è riuscita.Più difficile è immaginare come il nazionali-smo palestinese possa sottrarsi alla tenaglia da cui rischia di essere stritolato: da una parte l’intransigenza israeliana, dall’altra il jihadi-smo che pretende di annullare la causa palesti-nese – giudicandola anch’esso secondaria – nel mare magnum di una guerra terroristica mon-diale, seminatrice di morte ma destinata alla sconfitta.
AFGHANISTAN.GUERRA E DEMOCRAZIA
DI GIULIANO BATTISTON
È la storia di una elezione più volte riman-data, poi “sospesa”, infine boicottata e conte-stata, quella delle presidenziali che si sono te-nute il 28 settembre nelle 34 province afghane. Un’elezione che avrebbe dovuto saltare, resa superflua dalla firma di quell’accordo tra i Ta-lebani e l’inviato di Trump, Zalmay Khalilzad, che il presidente Usa ha prima cercato e poi invece sabotato con un dietrofront improvviso e inaspettato. Un’elezione i cui risultati sono ancora incerti nel momento in cui scriviamo, ma che entrambi i candidati più accreditati, l’attuale presidente Ashraf Ghani e il “chief of executive officer” Abdullah Abdullah, rivendi-cano di aver vinto. Una storia già sentita, per molti afghani e per gli osservatori di questo Paese che ha appena celebrato i 100 anni dall’indipendenza dagli inglesi e registrato i 18 anni dall’inizio dell’in-tervento militare degli Stati Uniti, quel 7 ot-tobre 2001 che ha condotto al rovesciamento dell’Emirato islamico dei Talebani, alla più lunga guerra degli americani e a troppe morti civili.Le dichiarazioni di vittoria di Ghani e Abdul-lah aggiornano una saga che li vede antagoni-sti da molti anni. In particolare dal ballottag-gio delle precedenti presidenziali, nel giugno 2014. Dopo il conteggio dei voti, entrambi si accusavano di brogli. La temperatura politica aveva raggiunto i massimi livelli. Intervenne il “pompiere” John Kerry, allora segretario di Sta-to Usa, che minacciò: “fate i bravi, altrimenti ritiriamo soldi e soldati”. È nato così un gover-no di unità nazionale con Ghani presidente e Abdullah quasi primo ministro (posizione non prevista dalla Costituzione) che ha paralizza-
34
GLI A
SINI 69
PIANETA
bano. Viste attraverso gli occhi degli afghani, hanno un senso diverso: rappresentano i tas-selli più evidenti di un sistema strutturalmente corrotto, che non esprime né tutela gli interes-si della cittadinanza, piegato invece ai privilegi di pochi. Privilegi che la politica e le elezioni cristallizzano, anziché ribaltare.Anche per questo il tasso di partecipazione alle presidenziali del 28 settembre è stato molto basso. Dei circa 9 milioni e 700mila cittadi-ni iscritti alle liste elettorali, avrebbero votato soltanto 2 milioni e 600mila. Un quarto dei potenziali elettori. E meno di un decimo della popolazione totale. Dati che rivelano una di-saffezione crescente verso il sistema politico-istituzionale, riconducibile a fattori diversi: l’economia che cresce ma senza generare red-dito, benessere e lavoro diffuso; la paralisi, conflittualità e corruzione del governo; le mi-nacce dei Talebani; il fatto che tutte le elezioni precedenti siano state contrassegnate da brogli e corruzione (qualcuno però nota che 2,6 mi-lioni di voti veri sono preferibili ai 7 milioni di voti gonfiati registrati nel 2014).Ma c’è un altro fattore, determinante. L’idea che la politica locale sia perlopiù eterodiretta. Che a decidere siano Islamabad (tradizionale sponsor dei Talebani) e Washington (princi-pale sostenitore, ma sempre più riluttante, del governo di Kabul). Che sia una percezione giustificata lo dimostra, oltre alla nascita del governo di unità nazionale, proprio la vicenda di queste ultime presidenziali: fino a 3 settima-ne prima del 28 settembre nessuno in Afghani-stan avrebbe scommesso che si sarebbero tenu-te. Perché gli Stati Uniti stavano per chiudere l’accordo con i Talebani, che avrebbe portato a un governo ad interim, facendole saltare. Con un tweet, però, Donald Trump ha cambiato la sorte di 30 milioni di afghani. Il 7 settembre Trump ha sospeso via Twitter i negoziati tra i Talebani e il suo inviato, Zalmay Khalilzad, rivelando che una delegazione degli studenti coranici era attesa a Camp David per il giorno successivo, così come il presidente af-ghano, che avrebbe incontrato separatamente.
to le attività dell’esecutivo e istituzionalizzato il conflitto che voleva sanare. A distanza di 5 anni, a contendersi la poltrona dell’Arg, il pa-lazzo presidenziale di Kabul, sono sempre loro due: il sistema politico non è riuscito a espri-mere candidati alternativi sufficientemente forti. In ballo questa volta però non c’è soltanto l’antagonismo personale tra Ashraf Ghani, il pashtun ex tecnocrate già docente in presti-giose università statunitensi, poi ministro del-le Finanze e rettore dell’università di Kabul, accentratore convinto di incarnare lo Stato, e Abdullah Abdullah, l’eterno sfidante, oftalmo-logo di formazione, già braccio destro del leg-gendario “leone del Panjshir”, il comandante Massud, e rappresentante del partito a mag-gioranza tagica Jamiat-e-Islami. In ballo c’è anche la residua legittimità del sistema creato dopo il rovesciamento dell’Emirato islamico, il governo dei Talebani bombardati alla fine del 2001, esclusi dagli accordi di Bonn e poi cor-teggiati diplomaticamente dagli Stati Uniti: al-meno finché Donald Trump non ha mandato all’aria il negoziato tessuto a Doha per quasi un anno dal suo inviato, Zalmay Khalilzad, con la delegazione degli studenti coranici gui-data da Abdul Ghani Baradar. Non un bar-buto qualsiasi, ma un mullah tra i fondatori del movimento talebano, catturato in Pakistan nel 2010 nel corso di un’operazione congiunta della Cia e dei servizi segreti di Islamabad e rilasciato nell’ottobre 2018 proprio per favorire il processo di pace. Quel processo di pace a cui i Talebani, pur avendo sabotato il processo elettorale con più di 400 attacchi in 29 delle 34 province del Paese, non rinunciano ancora. In attesa che l’amministrazione americana torni a dare segnali politicamente coerenti.Le precedenti tornate elettorali, al di là della correttezza e trasparenza del loro funziona-mento e dei risultati finali, sono state salutate dalla comunità internazionale come puntate di un progressivo consolidamento della demo-crazia liberale, tappe successive dell’inevitabile democratizzazione dell’Afghanistan post-tale-
35
PIANETA
GLI A
SINI 69
rivelato alla tv afghana Tolo alcuni contenuti specifici dell’intesa, ancora segreta: ritiro entro 135 giorni dalla firma di 5,400 dei circa 14mila soldati Usa, chiusura di 5 basi militari, riduzio-ne della violenza in 2 delle 34 province, Kabul e Parwan. Sui tempi del ritiro del resto delle truppe, nulla di certo – forse in 16 mesi, così da soddisfare le esigenze elettorali di Trump, che nel novembre 2020 ambisce a un secondo mandato. In cambio, Khalilzad avrebbe otte-nuto la presa di distanza esplicita dei Talebani da al-Qaeda e la disponibilità a incontrare in futuro gli altri attori politici afghani, inclusi i rappresentanti del governo di Kabul, consi-derato illegittimo dai Talebani. Meno di una settimana dopo, è arrivato il dietrofront di Donald Trump. Perché?La prima ragione ha a che fare con il prota-gonismo narcisistico di Trump, che avrebbe forzato la mano per assicurarsi visibilità e quel riconoscimento da statista e mediatore a cui ambisce con convinta approssimazione. Cer-cava la paternità anche simbolica dell’accordo di pace, senza tener conto né delle esigenze del governo del Qatar, che per molti mesi ha ospitato i negoziati, né delle obiezioni interne ed esterne, inclusa quella della Rabbari shura, la cupola della leadership talebana, che avreb-be dato il via libera alla propria delegazione a recarsi negli Stati Uniti, ma soltanto dopo la firma, non prima, così da evitare un “suicidio politico”. La decisione di Khalilzad di rivelare l’intesa, e parte dei contenuti, prima della firma effetti-va, ha consentito agli scettici, a Kabul quan-to a Washington, di alzare la voce. La scelta di invitare a Camp David, nel Maryland, alla vigilia dell’anniversario dell’11 settembre, una delegazione talebana di alto profilo ha susci-tato le inevitabili obiezioni dei Repubblicani conservatori. Che hanno trovato una sponda autorevole all’interno della stessa amministra-zione Trump. Per ragioni diverse, hanno solle-vato obiezioni anche nove tra ex ambasciatori e inviati speciali degli Usa in Afghanistan. In una dichiarazione pubblica, hanno sostenuto
Secondo Trump, l’incontro di Camp David sarebbe saltato a causa della postura militarista dei Talebani, incompatibile con il processo di pace in corso, e in particolare a causa dell’at-tentato di giovedì 5 settembre a Kabul che ha causato la morte, tra gli altri, del sergente sta-tunitense Elis Angel Barreto Ortiz. Nient’altro che un pretesto. Nominato nel settembre 2018 inviato per la riconciliazione in Afghanistan, Zalmay Khalilzad ha negoziato con i Talebani sulla base di un assunto implicito ma condivi-so: guerra e dialogo procedono di pari passo. Così è stato per entrambi gli attori, che hanno aumentato la pressione militare sul nemico, per negoziare da una posizione di forza. Che sia temporaneo, come pare lecito ipotizzare, o definitivo, il dietrofront di Trump va ricondot-to dunque ad altre ragioni. Prima di analizzar-le, qualche nota sulla posta in gioco. “Le grandi nazioni non combattono guerre senza fine”. Nel discorso del febbraio 2019 sullo Stato dell’Unione, Trump aveva difeso la politica di disimpegno militare dalla Siria e dall’Afghanistan, ricordando i costi umani e fi-nanziari della guerra e ribadendo la promessa, già fatta in campagna elettorale, di riportare presto a casa i soldati statunitensi. Aveva inol-tre dichiarato di aver “accelerato le negoziazio-ni per raggiungere un accordo politico” con i Talebani. Il mese prima, l’inviato Khalilzad aveva ottenuto il consenso preliminare dei Ta-lebani sull’impianto generale dell’accordo di pace, articolato in 4 punti: ritiro delle trup-pe straniere, garanzia che l’Afghanistan non tornasse crocevia dei jihadisti a vocazione glo-bale, un cessate il fuoco prolungato o perma-nente e il dialogo intra-afghano. Un impianto che Khalilzad per lungo tempo ha presentato come “un pacchetto tutto incluso”: prendere o lasciare.Ai primi di settembre Khalilzad ha annun-ciato che l’accordo con i Talebani era chiuso, almeno “in linea di principio”. Il 2 settem-bre l’inviato americano ha sottoposto il testo all’attenzione del presidente Ashraf Ghani, a Kabul. La sera stessa, l’inviato di Trump ha
36
GLI A
SINI 69
PIANETA
principali, ma era un accordo bilaterale: con-cedeva troppo ai Talebani, il sufficiente (sal-vare la faccia) a Washington e poco o nulla al governo di Kabul. Prevedere quel che succederà ora è difficile. Le posizioni del segretario di Stato Usa Mike Pompeo, dei portavoce Talebani, così come dei principali attori regionali del conflitto, da Mo-sca a Pechino, da Teheran a Islamabad, sem-brano suggerire che il dialogo potrebbe ripren-dere in futuro, anche se sarà difficile ricucire lo strappo di Trump in tempi brevi. Trump potrebbe approfittare di questa interruzione per ricompattare parzialmente il fronte in-terno, nella speranza che il pendolo militare oscilli finalmente dalla parte degli Stati Uniti. Ma le forze in campo rimangono le stesse. Lo stallo militare è destinato a rimanere tale. Gli Stati Uniti non possono sconfiggere i Talebani, e tanto meno il contrario. Salvo che il presi-dente Trump non voglia perseguire la strada del ritiro unilaterale, un accordo politico con i Talebani è l’unica soluzione alla guerra. Ma la condizione affinché il negoziato conduca, se non alla pace, a una relativa stabilità, è che non venga piegato alle esigenze elettorali degli Sta-ti Uniti, e che la retorica di Washington sulla “ownership afghana” del processo di pace non sia più un pretesto per abdicare alle proprie responsabilità, ma lo strumento per tener con-to anche degli interessi della società afghana e delle istituzioni che, per quanto malamente, la rappresentano.Ecco perché le presidenziali del 28 settembre, la trasparenza del conteggio dei voti, l’esi-to finale (previsto il 7 novembre), il tasso di partecipazione, sono così importanti. Tutti questi elementi avranno un peso determinan-te nell’accentuare il forte deficit di legittimi-tà del governo e delle istituzioni oppure, al contrario, nel colmarlo. Un presidente forte di un mandato elettorale chiaro e veramente rappresentativo rafforzerebbe l’esecutivo, in chiave domestica e come argine agli appetiti delle potenze regionali. Un presidente indebo-lito da scarsa affluenza, controversie elettorali,
la legittimità della soluzione negoziata al con-flitto, chiedendo però “che il ritiro completo delle truppe avvenga solo dopo una vera pace”, non prima, e che il governo afghano venga so-stenuto, non tagliato fuori dai negoziati. Quando Khalilzad gli ha sottoposto il testo dell’accordo raggiunto con i Talebani, il pre-sidente Ghani ha chiesto tempo. Voleva capire fino a che punto Khalilzad avesse tradito l’im-pegno iniziale: offrire ai Talebani un “pacchet-to completo”, che condizionasse la soluzione al conflitto tra la guerriglia in turbante e gli americani all’avvio di un confronto esplicito tra i Talebani e il governo di Kabul. Di fronte alla riluttanza dei Talebani a sedersi al tavolo negoziale con Kabul, l’amministrazione Usa ha infatti avviato un dialogo bilaterale con gli studenti coranici, prima assicurando che l’ac-cordo avrebbe beneficiato anche il presidente Ghani e le istituzioni che rappresenta, poi, però, derubricando il dialogo intra-afghano (i punti 3 e 4 dell’impianto originario dell’ac-cordo) a elementi secondari che gli afghani avrebbero potuto discutere tra loro, in un se-condo momento. Quel che si dice “lavarsene le mani”.Così, dopo mesi in cui si è invocata retorica-mente la centralità degli afghani nel proces-so di pace – un processo che doveva essere “condotto dagli afghani, per gli afghani” – il governo si è ritrovato con le spalle al muro, politicamente indebolito, costretto o quasi ad accettare i termini di un accordo opaco, che non garantiva né la sopravvivenza del sistema politico-istituzionale afghano, né quel cessate il fuoco prolungato o permanente su cui Gha-ni insiste da anni. Il “pacchetto completo” si era trasformato in due accordi distinti, quasi svincolati l’uno dall’altro: il primo tra Taleba-ni e Usa, il secondo, fumoso, tra Talebani e forze politiche e sociali afghane. Si tratta della quarta ragione che ha portato al collasso del negoziato: il deficit strutturale dell’accordo. L’accordo con i Talebani non ha funzionato perché era squilibrato. Avrebbe dovuto porre fine a un conflitto che contempla tre attori
37
PIANETA
GLI A
SINI 69
proprio deficit di legittimità, ulteriormente accentuato – paradosso della politica afghana a sovranità limitata – dalle elezioni. Che vinca Ghani o Abdullah, dunque, rimane il vulnus strutturale di un sistema, inaugurato dai cac-ciabombardieri Usa nel 2001, è sempre più fragile. Aggrappato a un voto che rappresenta il 10% della popolazione. Guerra e democra-zia, ci dice il voto afghano, non vanno proprio d’accordo.
accuse di brogli, ne uscirebbe malandato. Se l’esito del voto dovesse essere di nuovo con-troverso, come pare ragionevole ipotizzare a giudicare dalle dichiarazioni dei due candidati principali, allora il nuovo presidente – che sia Ghani o Abdullah Abdullah – ne uscirebbe davvero malconcio. I Talebani potrebbero gri-dare ancora una volta alla farsa. Le istituzioni tremare, più ancora che sotto le bordate mi-litari degli studenti coranici, sotto il peso del
38
GLI A
SINI 69
PIANETA
frica Subsahariana e non prendono sufficiente-mente in considerazione quello che è successo in un secolo di sfruttamento dei territori rurali africani (una significativa eccezione è il docu-mento di lavoro sulla migrazione e sul lavo-ro salariato dell’European Coordination Via Campesina, del 2017). Inoltre, una voce assen-te nel dibattito è quella delle comunità da cui provengono i migranti e delle organizzazioni rurali che stanno lavorando per assicurare che le nuove generazioni di contadini africani ab-biano l’opportunità di costruirsi delle vite di-gnitose a casa. Questo articolo cerca di ricostruire tali questio-ni dal punto di vista di queste organizzazioni, per raccontare la loro versione delle evoluzio-ni che hanno portato alla “crisi migratoria” di oggi, per evidenziare le iniziative in atto oggi, per costruire alternative per le nuove genera-zioni contadine e per discutere criticamente le risposte politiche dell’Ue. Il tutto, ritenendo che sia fondamentale difendere sia il diritto di migrare sia il diritto di scegliere di stare a casa propria.
Migrazione, agricoltura, colonialismo nell’A-frica occidentaleLa mobilità è sempre stata una componente importante della vita dell’Africa occidenta-le. Nel Sahel è accentuata sia dall’importante presenza di comunità di pastori sia dalla lunga stagione secca, che ha stimolato il consolida-mento di spostamenti stagionali nel corso di centinaia di anni.La colonizzazione ha avuto su queste società un impatto distruttivo (si veda, su tutte, la de-scrizione che ne hanno dato i romanzi di Chi-nua Achebe). I gruppi etnici sono stati divisi e i movimenti stagionali dei pastori di bestiame interrotti da confini imposti. Dopo l’abolizio-ne della schiavitù, le amministrazioni coloniali introdussero varie forme di lavoro coatto (per piantagioni o grandi cantieri), che spesso com-prendevano una mobilità forzata. Come sem-pre con le varie forme di sfruttamento colo-niale, questa pratica è stata giustificata con il
Molta della “migrazione irregolare” dall’Africa sub-sahariana verso l’Europa ha origine nell’Africa occidentale. Si tratta di una migrazione “economica”, che ha le sue radici in decenni di politiche che hanno impoverito le economie rurali ed espropriato i piccoli pro-duttori agricoli per fare spazio a monocolture destinate all’esportazione. Sotto la pressione di populismi nazionalisti e configurazioni politi-che xenofobe, l’Ue sta reagendo cercando di bloccare il flusso di migranti africani indeside-rati nei loro paesi di origine. La formula a lun-go termine per “affrontare le cause alla radice della migrazione” attraverso lo “sviluppo” dei paesi di origine segue la dottrina dominante della “modernizzazione” economica, basata soprattutto sul settore privato. Tale strategia prevede l’uso di fondi di cooperazione dell’Ue per consentire alle corporation dell’agri-busi-ness europeo di cercare “nuove opportunità di investimento nei mercati emergenti” (si legga il documento della Commissione Europea del 2017 EU European External Investment Plan Fact Sheet, https://ec.europa.eu/europeaid/eu-external-investment-plan-factsheet_en), pro-muovendo in questo modo lo stesso modello di produzione agricola e le catene globali di valore che hanno alimentato le ondate migra-torie di oggi.L’attivismo della società civile europea ten-de a concentrarsi sulla difesa del valore della mobilità e sulla denuncia delle violazioni dei diritti umani dei migranti africani. Si tratta certamente di temi cruciali. Tuttavia, queste denunce non colgono le cause strutturali a lungo termine del malessere agricolo che è alla base delle attuali forme di migrazione dall’A-
DALL’AFRICA:CONTADINI E MIGRANTI
DI NORA MCKEON
TRADUZIONE DI SARA GIANNESSI E GIORGIO LAURENTI
39
PIANETA
GLI A
SINI 69
In Senegal, ad esempio, i maggiori donatori (Francia e Comunità economica europea) fi-nanziarono soprattutto programmi di svilup-po che puntavano a promuovere la produzio-ne di singoli prodotti per l’esportazione – riso, arachidi e cotone – attraverso l’istituzione di strutture regionali parastatali per lo “sviluppo”, che ignoravano la natura polivalente dell’agri-coltura contadina, la logica socioeconomica dell’unità familiare estesa, la conoscenza e le abilità dei contadini e l’impatto delle mono-colture sull’ambiente. Ci vollero delle morti di massa dovute alla sic-cità e carestia a metà degli anni settanta per iniziare a interiorizzare il fatto che le aree ru-rali africane erano drammaticamente impove-rite e che molto dipendeva da cattive politiche (come dimostrò la ricerca di R. Bates, Markets and states in tropical Africa, University of Cali-fornia Press, 1981). Ma i tentativi dei governi di portare rimedi furono schiacciati dai piani di aggiustamento strutturale che, dai primi anni ottanta, Fmi e Banca Mondiale imposero a molti governi africani in cambio dei prestiti di cui avevano bisogno per restare a galla. Que-sti piani si concentrarono sul “far quadrare i conti” attraverso la privatizzazione, l’apertura dei mercati (esacerbata dall’avvento del Wto nel 1995), e la diminuzione dell’intervento dello Stato nell’economia. L’impatto che tali politiche avrebbero avuto sui mezzi di sosten-tamento delle campagne non fu tenuto in con-siderazione. Le organizzazioni contadine non furono invitate al tavolo dei negoziati. Questo ulteriore sconvolgimento delle eco-nomie e società rurali e delle unità familiari di base ebbe l’effetto di aumentare il ricorso alla migrazione come strategia di sopravvi-venza. L’abbandono delle campagne aumentò notevolmente negli anni settanta, ma le città africane non offrirono le possibilità di impiego che avevano caratterizzato l’urbanizzazione nel periodo della industrializzazione in occidente. In un primo periodo, questa mobilità avvenne soprattutto all’interno della regione, anche in relazione al boom dell’agricoltura da espor-
carattere ritenuto indolente del colonizzato e la missione civilizzatrice dei colonizzatori.Quando le potenze coloniali impiantarono colture destinate al mercato, l’equilibrio ecolo-gico e socio-economico dell’Africa occidentale venne sconvolto. Le monocolture consumaro-no la fertilità del suolo e provocarono l’erosione dei campi, prima protetti da pratiche agricole tradizionali quali la consociazione agraria e il dissodamento minimo che gli agronomi euro-pei condannavano come disordinato, pigro e primitivo. Se precedentemente erano le cala-mità naturali la fonte principale di precarietà dei contadini e degli allevatori – i quali però le potevano prevedere con anticipo e avevano sviluppato strategie di difesa, anche attraverso la mobilità – ora erano gli interessi dei poteri coloniali e i meccanismi di mercato a rendere vulnerabili le comunità rurali. L’introduzione di un’economia monetaria e la conseguente diffusione dei debiti nelle aree rurali indeboli-rono i capifamiglia, resero vulnerabili le unità familiari estese, aggravarono la posizione delle donne. In modo molto capillare, l’esperienza coloniale screditò il sapere, le abilità, la cultura e i valori dei popoli africani. Poco cambiò per la popolazione rurale con l’indipendenza politica nei primi anni sessan-ta. La paura di disordini in città portò i go-verni ad assicurare cibo a basso costo alle aree urbane attraverso un abbattimento dei prezzi dei prodotti agricoli e l’importazione di ma-terie prime dall’estero, politiche che finirono per togliere ai produttori africani i loro mer-cati naturali. Il modello di sviluppo che venne adottato marginalizzò i contadini. Riponendo fiducia nella teoria della modernizzazione, lo sviluppo fu concepito come un continuum dal meno al più, che richiedeva iniezioni esterne di capitale e tecnologie moderne e negava il valore delle capacità innovative della popola-zione rurale locale. I produttori agricoli ven-nero organizzati in cooperative calate dall’alto per promuovere la produzione e la vendita per l’esportazione. Gli ex-poteri coloniali, diven-tati donatori, approvavano questo approccio.
40
GLI A
SINI 69
PIANETA
cooperative ufficiali.La combinazione dei piani di aggiustamento strutturale e di un’altra forte siccità nella metà degli anni ottanta stimolò un ulteriore svilup-po delle associazioni autonome. In un certo senso la crisi ha funzionato come stimolo per le associazioni contadine per riflettere sulle cause strutturali della mancanza di cibo e per elabo-rare nuove strategie di sviluppo più adatte alla loro situazione e al loro ambiente rispetto ai modelli proposti dagli “sviluppatori” nazionali ed esteri. Né i governi nazionali né i donatori stranieri sembravano capaci di riconoscere e supportare questi sforzi indipendenti. Negli anni ottanta, il Fongs si espanse per in-cludere 24 associazioni con base regionale di tutto il paese, totalizzando oltre 2000 gruppi di villaggi con un numero di membri attivi di circa 400mila persone, ma il governo rifiutò la sua richiesta di prendere parte alle discus-sioni sul Piano di aggiustamento strutturale agricolo, motivando questo rifiuto con il fat-to che non era l’unica federazione nazionale a rappresentare la popolazione rurale. La rispo-sta del movimento fu di organizzare un forum nazionale agli inizi del 1993, drammaticamente intitolato Quale futuro per i contadini senega-lesi? Per la prima volta la popolazione rurale, la maggioranza della popolazione, presentò al governo la propria valutazione sull’impat-to degli aggiustamenti strutturali e le proprie proposte per il futuro. Il Forum pose le basi per la fondazione di un Comitato nazionale per il dialogo con la popolazione rurale (Cncr) che il governo fu obbligato ad accettare come interlocutore. Nel corso delle ultime due de-cadi e mezzo il Cncr è stato impegnato in un processo di rafforzamento della propria forza e legittimità, delle alleanze e della capacità di ne-goziazione e confronto con lo Stato. Il primo passo fu una vigorosa campagna per la riap-propriazione dell’identità, dell’orgoglio e del senso di responsabilità dei contadini, sminuito da decenni dal trattamento descritto sopra. Il secondo passo era costruire un’identità comu-ne e una piattaforma basata su aziende agricole
tazione che richiedeva braccianti, soprattutto in Costa d’Avorio, Ghana, Nigeria, Senegal. Questa dinamica fu sconvolta dalla crisi eco-nomica, sociale e politica degli anni novanta in questi paesi: si svilupparono nuovi circuiti di migrazione, emerse una rete di traffico illecito di migranti e aumentarono le partenze “clan-destine” verso l’Europa, processi che avrebbero poi portato all’odierna “crisi migratoria”.
Nascita ed evoluzione del movimento contadino in Africa occidentaleCome ha reagito la popolazione rurale allo sconvolgimento della vita e allo sfruttamento del proprio lavoro? La loro forte e abile resi-stenza è una storia pressoché sconosciuta in Europa, dove l’immagine che si ha dei conta-dini africani è di povertà e arretratezza. Già tra la fine degli anni sessanta e la fine degli anni settanta iniziarono a svilupparsi iniziative, so-prattutto nei paesi in cui l’ambiente politico era più permissivo rispetto alle dittature mi-litari di cui la regione abbondava. In Burkina Faso nel 1967, un insegnante fortemente moti-vato, Bernard Lédéa Ouedraogo, facilitò la tra-sformazione dei gruppi tradizionali dei giovani nella società Mossi, i Komi-Naam (“potere dei giovani”), in una associazione autonoma che aveva come scopo lo sviluppo di un sistema di solidarietà e sicurezza economica e sociale nel-le comunità interessate. In Senegal associazio-ni di contadini autonomi iniziarono a sorgere in varie regioni del paese nei primi anni settan-ta, quando la popolazione agricola ruppe con il tradizionale atteggiamento fatalista e iniziò a cercare soluzione ai problemi di cui lo Stato non poteva o non voleva occuparsi. I membri erano soprattutto donne e giovani, cioè quanti non avevano potere né nella struttura tradizio-nale né nella “moderna” economia monetaria. Nel 1974 le associazioni si scambiavano visite e organizzavano incontri. Nel 1976, dodici asso-ciazioni formarono una federazione nazionale, che ottenne lo status legale nel 1978 come Fe-derazione delle ong senegalesi (Fongs), un ti-tolo imposto dal governo per distinguerle dalle
41
PIANETA
GLI A
SINI 69
temente criticate dalla società civile europea. Inoltre, secondo il coordinamento delle Ong europee per lo sviluppo (Concord), lo Euro-pean Trust Fund for Africa messo in atto in seguito al summit di Valletta sulla migrazione del 2015, “dirotta l’assistenza ufficiale per lo sviluppo su obiettivi e azioni finanziarie che non sono più collegate agli obbiettivi di svilup-po dell’Ue ma piuttosto a obiettivi di politica interna all’Ue finalizzati ad arrestare il flusso migratorio”, con conseguenze imprevedibili in termini di sviluppo, diritti umani, governa-bilità e sicurezza nei paesi partner (EUTF for Africa: Partnership or conditionality?, https://concordeurope.org/2017/11/22/eu-trust-fund-africa-ep-event/).L’obiettivo a lungo termine dell’Ue è espres-so nei termini di agire sulle “cause profon-de” della migrazione irregolare. Il principale strumento a lungo termine dell’Ue, il Piano di investimenti esterni (Eip), è stato instituito nel contesto del Migration Partnership Fra-mework adottato nel giugno 2016. È descritto dalla Commissione Europea come uno stru-mento per “promuovere una crescita inclusiva, la creazione di lavoro e uno sviluppo sosteni-bile e così contrastare alcune delle cause alla radice della migrazione irregolare”. Con un contributo di 4.1 miliardi di euro da parte del-la Commissione, ci si aspetta che l’Eip stimoli più di 44 milardi di euro di investimenti da parte di investitori del settore privato europeo entro il 2020.L’Eip offre “garanzie” per promuovere inve-stimenti nei paesi dove essi sono “attualmente difficili” e per facilitare investimenti di sogget-ti privati “che potrebbero altrimenti investi-re di meno o per niente”. Allo stesso tempo, l’Eip mira a supportare “riforme” di politiche nei paesi partner. Il problema è che questo tipo di iniziative, come dimostrano esperienze pas-sate, non porta vantaggi ai piccoli produttori e alle comunità rurali. Il “miglioramento del contesto economico” si risolve nella riduzione delle tasse per le corporation e in cambiamenti di politiche che facilitano il loro accesso alla
familiari, la base, unità integrata dell’agricol-tura e nella società senegalese.Era evidente che l’organizzazione del movi-mento contadino a livello nazionale non sa-rebbe stata sufficiente in un ambiente in cui i livelli decisionali erano sopranazionali. Il 2000 vide la creazione della Rete delle organizza-zioni dei contadini e dei produttori agricoli dell’Africa occidentale (Roppa), che ora racco-glie 13 piattaforme nazionali e circa 80 milioni di contadini. Questa rappresenta le aziende agricole familiari nei confronti con le autori-tà regionali e in forum continentali e globali. Questa rete cerca di proteggere i produttori dell’Africa occidentale dalla sleale concorrenza estera, di dirigere le politiche pubbliche e gli investimenti verso un’agricoltura sostenibile basata sulla famiglia, di spingere per riforme agrarie e leggi sui semi che proteggano i pro-duttori contadini, di ottenere investimenti in servizi sociali e infrastrutture nelle aree rurali, di costrire sistemi alimentari nazionali e regio-nali in cui piccoli produttori e territori rura-li trattengano un valore aggiunto attraverso la lavorazione e la vendita dei prodotti, e di assicurare la partecipazione della popolazione nell’influenzare le politiche. Dal 2000 il Rop-pa ha saputo accreditare il movimento conta-dino come attore politico imprescindibile. La “crisi migratoria” vista dall’EuropaLa mobilità intra-africana rappresenta il 70% della mobilità dell’Africa occidentale. Tuttavia la percezione europea è quella di un “esodo” di africani disperati che fuggono dalla povertà in cerca di un “El Dorado” europeo. Si ritiene che milioni di africani stiano aspettando di partire per l’Europa alla prima opportunità. Questa immagine distorta della realtà è diventata una questione esplosiva in un clima politico in cui crescono nazionalismi e populismi xenofobi.Incapace di imporre una gestione collettiva ed equa a livello europeo della questione migran-ti, la risposta iniziale dell’Ue è stata quella di cercare di bloccare i viaggiatori indesiderati attraverso misure restrittive che sono state for-
42
GLI A
SINI 69
PIANETA
periodo. Almeno dagli anni ottanta, le orga-nizzazioni senegalesi hanno espresso il deside-rio di mantenere il controllo di un progetto sulla propria società. Ad esempio, Mamadou Cissokho, leader contadino, ha scritto nel li-bro Dieu n’est pas un paysan (2009): “L’Africa ha resistito a forti shock: la tratta degli schiavi, lo sfruttamento coloniale, le calamità natura-li. Un centinaio di volte la nostra società sa-rebbe potuta scomparire. Qual è il segreto di questa resistenza? I nostri valori. Se vogliamo costruire uno sviluppo sostenibile, dobbiamo iniziare da ciò che siamo noi contadini come esseri umani che vivono nello stesso territorio, condividendo valori morali, religiosi, culturali e sociali, che ci hanno permesso di affrontare le avversità della vita.” I movimenti contadini cercano di sviluppa-re risposte che favoriscano le comunità rurali nella loro interezza, inclusi i giovani, con l’o-biettivo di affrontare le questioni strutturali che le riguardano. A partire da una raccolta di interviste condotta tra il 2009 e il 2013, la visione dei migranti che emerge è quella di giovani “tra due mondi”. Molti lasciano i vil-laggi quando finisce il lavoro stagionale nelle terre di famiglia e vivono per la maggior par-te dell’anno nelle città, ma restano legati alle proprie famiglie (Grad/Roppa, Jeunes ruraux en Afrique de l’Ouest, Bonneville, Grad, 2014). I problemi strutturali più importanti che i gio-vani incontrano sono le difficoltà nell’ottenere accesso al credito e alla terra, aggravate da un orientamento allo sviluppo agricolo che stimo-la il land grabbing. Manca un sostegno per il tipo di attività produttive che essi potrebbe-ro portare avanti nelle proprie zone rurali. La mancanza di servizi e infrastrutture nelle aree rurali – risultato di decenni di abbandono da parte delle politiche e degli investimenti pub-blici – aumenta l’attrazione delle aree urbane.Le strategie e le politiche proposte dalle po-polazioni rurali dell’Africa occidentale e dalle loro organizzazioni sono notevolmente diverse da quelle proposte dall’esterno. Per organiz-zazioni come Fongs, Cncr e Roppa la via da
terra e l’importazione dei loro fattori di pro-duzione.La Finestra per gli investimenti dell’Eip per “Agricoltura sostenibile, imprenditori agricoli e agribusiness” ripete la narrativa dominan-te riguardo la necessità di investire capitale e tecnologie per la creazione di opportunità di lavoro per giovani imprenditori nelle catene globali di valore, ignorando le evidenze sem-pre più numerose per cui questi modelli di ca-tene tagliano fuori tutti i possibili beneficiari tranne i più abbienti (maschi) produttori delle più produttive aree dei paesi dell’Africa Subsa-hariana. In ogni caso, nessuno sforzo è stato fatto per consultare i piccoli produttori nella progettazione della Finestra, e il loro poten-ziale accesso ai fondi dovrebbe essere media-to da istituzioni finanziarie come la European Investment Bank e la African Development Bank che, come è noto, non sono attrezzate per lavorare con i piccoli produttori. Se l’Ue volesse davvero agire sulle cause pro-fonde della migrazione, invece, dovrebbe cam-biare le politiche europee agricole e di com-mercio che penalizzano i piccoli produttori africani e sostenere i modelli di produzione agroecologica che praticano e i sistemi alimen-tari territoriali in cui agiscono.
E dal punto di vista delle comunità rurali dell’Africa occidentale?Negli studi che analizzano le cause della mi-grazione e propongono risposte politiche c’è una grossa lacuna riguardante la conoscenza dei movimenti e delle comunità della popola-zione rurale dell’Africa occidentale, nonostan-te la crescente visibilità e capacità di azione di organizzazioni quali Roppa e Cncr. Quando si consultano queste organizzazioni, l’imma-gine che emerge è molto diversa dalla ver-sione “made in Europe”, costruita dai media o dalle autorità dell’Ue. Per iniziare, è messo in discussione il quadro dell’attuale situazione della “crisi” migratoria. La popolazione rurale non la considera un’emergenza inaspettata, ma piuttosto il risultato di un’evoluzione di lungo
43
PIANETA
GLI A
SINI 69
ConclusioneLe evidenze stanno dalla parte delle aziende agricole a conduzione familiare e dei sistemi alimentari territoriali dell’Africa occidenta-le, non del miraggio dell’Ue delle “moderne” catene agroalimentari controllate da investito-ri europei. Una fonte di queste evidenze è il Comitato delle Nazioni Unite per la Sicurez-za Alimentare Mondiale (Committee on World Food Security, Cfs): riformato nel 2009, esso è diventato l’unica sede della politica alimentare globale in cui le organizzazioni che rappresen-tano coloro che sono direttamente interessati dalle politiche in discussione partecipano sullo stesso piano dei governi (per un approfondi-mento, rimando al mio libro Food Governance, Jaca Book, 2019). Il Roppa è uno dei soggetti chiave nell’autonomo “Meccanismo della so-cietà civile” che si interfaccia con il Cfs. Il Cfs ha dimostrato che i piccoli produttori sono responsabili del soddisfacimento del 70% del fabbisogno alimentare mondiale e della rea-lizzazione del 90% di tutti gli investimenti in agricoltura. Inoltre, l’80% del cibo consuma-to in tutto il mondo non transita attraverso le catene globali dei sistemi di approvvigiona-mento “moderni”. Al contrario, è negoziato in mercati territorialmente integrati che sono di-rettamente collegati ai sistemi alimentari loca-li, nazionali o regionali, più inclusivi nei con-fronti di giovani e donne, più remunerativi per i produttori alimentari su piccola scala, e che consentono a una maggiore percentuale del-la ricchezza creata di essere mantenuta e ridi-stribuita all’interno delle economie territoriali (www.csm4csf.org/connecting-smallholders-markets.analytical-guide/)Il pensiero comune sullo “sviluppo” e sul-l’“innovazione” ritiene che i piccoli produttori africani siano confinati in un manto di arcaica, immobile sussistenza. Ciò è smentito dalla no-tevole capacità delle aziende familiari dell’A-frica occidentale di ricomporre le molteplici fratture cui sono state sottoposte dall’avvento del colonialismo e continuano a nutrire le loro
seguire non è l’agribusiness e l’agricoltura da esportazione, ma un’agricoltura familiare che finalmente riceva il sostegno che merita. Le loro posizioni sono supportate da dati affida-bili e azioni concrete. Basandosi sull’esperienza del Fongs e del Cncr, il Roppa sta estendendo ai paesi di tutta la regione una rete di Osser-vatori delle aziende familiari. Il Cncr ha dimo-strato che le aziende agricole familiari nutrono la maggior parte della popolazione del paese (Cncr/Fongs, Comment les exploitations fami-liales peuvent nourrir le Sénégal, www. fongs.sn/spip.php?article38). È stata poi affrontata la questione di come facilitare l’insediamento di giovani agricoltori e di come coinvolgerli nelle organizzazioni contadine.Il lavoro di monitoraggio del Roppa ha identi-ficato i settori promettenti per giovani e donne (produzione di ortaggi, pollame, ovini, trasfor-mazione di prodotti agricoli) e le condizioni chiave perché essi restino nelle aziende fami-liari: accesso alle risorse naturali e materiali, possibilità di avere entrate adeguate attraverso l’accesso a mercati remunerativi, accesso a cre-diti adeguati, supporto e formazione tecnica, riconoscimento e valorizzazione dello status di “contadino” e miglioramento delle condizioni di vita nelle zone rurali. Un grosso sforzo di pressione è ora rivolto dal Roppa agli stati dell’Africa occidentale e all’Ue per istituire strategie e fondi per l’inse-diamento di giovani in agricoltura sulla base di “un nuovo paradigma, che consideri l’oc-cupazione giovanile come motore per trasfor-mare l’agricoltura familiare nel rispetto della sua multifunzionalità e dei valori su cui si basa”. La strategia del Roppa affronta la ne-cessità di cambiamenti nelle politiche e negli investimenti pubblici per rendere l’agricoltura più remunerativa e i territori rurali luoghi più piacevoli in cui vivere. Ma prende atto anche della necessità di migliorare lo status e la per-cezione dei giovani e la loro partecipazione al processo decisionale nelle rispettive famiglie e organizzazioni e prevede misure per consegui-re tale obiettivo.
44
GLI A
SINI 69
PIANETA
sono in gran parte in linea con le analisi e le proposte dei movimenti contadini.L’Ue si trova in una situazione ancora più am-bigua. Siamo abituati ai problemi di incoe-renza delle politiche, per cui i buoni propositi di promuovere i diritti umani e la sicurezza alimentare vengono sopraffatti dagli interessi economici espressi nelle politiche agricole e commerciali. Ora ci si avvicina a qualcosa di ancora più spiacevole. L’Ue porta avanti poli-tiche orientate all’utilizzo di fondi pubblici per sovvenzionare gli investimenti delle imprese europee che promuovono approcci per lo svi-luppo agricolo e per la fornitura di cibo che penalizzeranno ulteriormente le economie ru-rali africane, distruggeranno le unità familiari che garantiscono la stabilità sociale, e alimen-teranno il flusso di giovani in Europa. Proprio ciò che sta stimolando reazioni populiste e xenofobe e creando serie difficoltà politiche a livello nazionale e regionale in Europa.Queste contraddizioni politiche potrebbero aprire delle opportunità per la società civile e per i movimenti sociali per difendere sia i diritti dei migranti sia le politiche e gli investi-menti necessari per dare alle popolazioni rurali possibilità di lavoro nei loro paesi di origine. Ciò richiederebbe la costruzione di un dialogo tra organizzazioni di diverso tipo in Africa e in Europa: i produtto-ri su piccola scala e le loro comunità, giovani, migranti, lavoratori agricoli, consumatori, la diaspora, ong, academici, media. Certo, si tratta di un’alleanza complessa ma il momento è propizio. Sotto la pressione dell’attuale ondata di populismo autoritario di stampo nazionalista e della distruttività di un capitalismo sempre più speculativo c’è una richiesta forte di convergenza tra movimenti e attori che stanno combattendo la stessa lotta anche se in aree diverse e utilizzando termini diversi. Il diritto di scegliere di migrare o di vivere dignitosamente a casa può costituire un terreno fertile di incontro.
società nonostante la quasi totale mancanza di sostegno da parte delle politiche pubbliche. Ed è smentito dal fallimento sempre più evidente del sistema di approvvigionamento alimentare gestito dalle corporation, con i problemi am-bientali, di insicurezza alimentare, di malnu-trizione e obesità che genera.Le relazioni di potere che collegano il capita-le e le élite politiche in Europa e Africa sono ancora salde, ma anche qui ci sono segni di ambiguità. Le autorità africane sono estrema-mente suscettibili alle lusinghe dei programmi di investimento architettati dalle corporation e cedono a pressioni per accettare accordi e in-vestimenti commerciali che sono chiaramente dannosi per le economie africane e l’integra-zione regionale. Allo stesso tempo, le medesi-me autorità pubblicano documenti politici per la trasformazione dell’agricoltura africana che
45
PIANETA
GLI A
SINI 69
DAL MAROCCO:SIAMO FUORILEGGE NEL NOSTRO PAESE
DI LEILA SLIMANI E SONIA TERRAB
TRADUZIONE DI SAVERIO ESPOSITO
Riprendiamo da “Le Monde” del 24 settembre scorso il manifesto scritto dalla scrittrice Leila Slimani e dalla regista Sonia Terrab per chiedere che il loro paese il Marocco cambi decisamente la sua legislazione in materia di sessualità. Il ma-nifesto è stato sottoscritto, a quella data, da 470 intellettuali e cittadini, in maggioranza donne.
Noi, cittadine e cittadini marocchini, dichiariamo di essere dei fuorilegge. Noi vio-liamo delle leggi ingiuste e obsolete che non hanno più ragione di esistere. Abbiamo avuto relazioni sessuali al di fuori del matrimonio. Abbiamo abortito o siamo stati complici di aborti. Abbiamo imparato a fingere e ad adat-tarci. Ma ancora per quanto?Ogni giorno, ogni ora, in segreto, di nascosto, ci sono donne come noi, uomini come te, con-servatori o progressisti, personalità pubbliche o anonimi, di tutti gli ambienti e di tutte le regioni, che osano reagire responsabilmente, che godono ed esistono di per sé, che spezzano catene e irridono leggi perché amano.Ogni giorno io mi rendo colpevole di amare e di essere amata. Ogni volta che una donna vie-ne arrestata io mi sento e sono complice. Mi dico: potrei essere io, ma poi taccio e vado per la mia strada e faccio il possibile per dimenti-care... Ma non riesco più a farlo, ho esaurito la mia capacità di sopportazione. Perché il mio corpo appartiene a me, non appartiene né a mio padre né a mio marito né al mio ambiente né agli occhi degli uomini della strada, e ancor meno appartiene allo Stato.Oggi non voglio più vergognarmi. Io che amo, abortisco, che ho rapporti sessuali senza essere sposata. Io che mi nascondo. Io che rischio il disonore, l’infamia, la prigione. Questa cultu-ra della menzogna e dell’ipocrisia sociale gene-ra la violenza, l’arbitrio, l’intolleranza. Queste
leggi liberticide e inapplicabili sono diventa-te strumenti della vendetta politica o privata. Sono una spada di Damocle che ci minaccia e ci ricorda che la nostra vita non ci appartiene. Come accettare tutto questo? E perché accet-tarlo? Ancora e ancora?...Nel 2018, in Marocco 14.503 persone sono state inquisite o incarcerate in base all’articolo 490 del codice penale, che punisce le relazioni ses-suali al di fuori del matrimonio. 3.048 persone sono state incarcerate perché colpevoli di adul-terio. Ogni giorno nel nostro paese vengono praticati dai 600 agli 800 aborti clandestini. Tutte queste persone devono finire in galera? E perché devono finire in galera i loro “complici” (medici, membri di associazioni)?Noi crediamo che la società marocchina sia matura per il cambiamento e perché vi siano infine riconosciuti il rispetto della vita privata e il diritto di disporre del proprio corpo. La nostra società e il nostro paese lo meritano. Ci appelliamo ai governanti, a chi ha il potere di decidere, ai nostri legislatori affinché dia-no prova di coraggio e facciano questo passo avanti aprendo un dibattito a livello naziona-le sulle libertà individuali. Non si tratta di un lusso, non si tratta di una concessione, si tratta di una necessità.Come favorire lo sviluppo della gioventù, come permettere il giusto coinvolgimento del-le donne nella società, come impegnare dav-vero il nostro paese sulla linea del progresso, dello sviluppo umano, se le nostre libertà in-dividuali non vengono rispettate, se la nostra dignità viene calpestata, se ci troviamo tutte e tutti fuori dalla legge? Tutte e tutti fuorilegge, fino a quando la legge non cambierà.
46
GLI A
SINI 69
EDUCAZIONE
EDUCAZIONE E INTERVENTO SOCIALE
TUTTO IL PEGGIO DELLA SCUOLA ITALIANA
DI PIERGIORGIO GIACCHÈ
Che dire di più? Come spiegare meglio tutto il peggio della scuola italiana? Mi costa doverlo ammettere ma – pagina dopo pagina – mi sono scoperto d’accordo con quello che scrive Ernesto Galli della Loggia sul suo libro intitolato L’aula vuota. Come l’Italia ha distrutto la sua scuola, edi-to da Marsilo nel giugno scorso, proprio alla fine dell’anno scolastico. Un libro di ragionamenti partoriti da una posizione che non condivido, ma che infine hanno “ragione”, e l’atteggiamen-to anti-sinistro che avverto come letteralmente anti-patico riguarda le mie “ragioni del cuo-re” – direbbe il filosofo – ma il fastidio non mi impedisce un accordo di fondo su quasi tutto quello che Galli scrive sulla scuola italiana (e il “quasi” è più una cautela che una riserva). Infine cosa dice è più importante di come lo dice, ma ancora più condivisibile è il “perché”: sullo sta-to e sulla storia della scuola italiana non si può più mentire e peggio non si può tacere. Per la verità, qui va subito fatta una critica o presa una distanza: quando Galli dice che “Per anni non ci siamo accorti di quanto stava accadendo sotto i nostri occhi. Non ci siamo accorti di come, pezzo per pezzo, venivano smontate e gettate via parti decisive di quella scuola dove la maggior parte di noi è cresciuta e si è formata…” sta abu-sando di un Noi (maiestatis?) che non mi com-
prende e che – insieme a tanti altri Asini – mi offende. Al contrario, il sostanziale accordo sulle osservazioni e le conclusioni di Galli, lo si deve al fatto di averle largamente anticipate in anni da subito sospetti e, andando a ritroso, perfino durante le lotte e le colpe del sessantotto, nel quale c’erano molti più innocenti critici che in-coscienti esegeti di una “contestazione” che ci si ostina a raccontare come una “rivoluzione” (per di più armata). Critici inascoltati e inefficaci d’accordo (ma anche il libro dell’autorevole Gal-li della Loggia non avrà ahimè alcuna possibilità di incidere sulla scuola presente e futura), ma attenti e attivi nel criticare sia l’illusione utopica che l’ideologia pedofila, nonché il progressismo cieco che ha ispirato la lunga trafila delle rifor-me che hanno reso deforme la scuola italiana… Anche noi, nel nostro piccolo, avevamo indivi-duato la “nuova” fase cominciata con Berlinguer e i suoi quaranta soloni e – ministro dietro mi-nistra, destra dopo sinistra – finita o sfinita nella inconsistenza pubblicitaria della “buona” scuola del giovane Renzi… E già denunciato la beffa di chiamare “autonomia” una libertà amministra-tiva sotto ricatto e per il profitto (della azienda scuola e non più dello studente cliente), mentre si andava mortificando la libertà e l’autorità di tutti gli insegnanti naufragati nella stessa bar-
47
INTERVEN
TO SOCIALE
GLI A
SINI 69
lettorato – a pretendere promozioni e consola-zioni, gratifiche sociali e sostegni psicologici di ogni tipo e per ogni figlio… Questo sovraccari-co di funzioni o di finzioni – si può aggiungere – illude il corpo insegnante di avere un’anima, e di poter compensare il basso livello economico con l’alto valore della missione sociale: ogni docente, per metà impiegato e per metà infermiere, si di-mentica magari di avere un mestiere… Studiare dunque non riguarda più nemmeno lui, se non lo studio di quale atteggiamento, sentimento, procedimento è più conveniente adottare nell’e-poca della dittatura della democrazia… Ma “la sede propria della democrazia non sono le aule scolastiche”, protesta Galli della Loggia in un articolo pubblicato sul “Corriere” nel 2018 e di cui ricorda le tante avverse voci di protesta, soprattutto contro la provocatoria proposta di rimettere sotto la cattedra la “predella” che la innalzava. Forse invece aveva ragione anche su questo dettaglio, ovvero sulla distanza da rista-bilire fra docente e studente, che era funzionale a una diversa trasmissione e una divisa responsa-bilità fra due doveri diversi, poi azzerati in nome dei diritti universali che finalmente ispirano il non-luogo di una aula-piazza dove non alloggia-no le classi di una volta ma nuove “comunità” che si amano, si liberano, creano e si ricreano… Che poi ci siano maestri o professori all’altezza di questa concreta utopia è vero graziaddio, ma la norma o la moda che vuole che la libertà e l’uguaglianza e la fraternità non siano più scritte nella bandiera ma si inscrivano fra i banchi di una scuola senza più barriere, distanze, difficol-tà, non è una riforma e nemmeno una rivolu-zione, ma solo una ideologica e infine metodo-logica imposizione. Sì, siamo d’accordo anche sulla predella di Galli per rimettere a posto, se non la prospettiva, almeno la giusta prossemica fra adulti e ragazzi e perfino bambini, senza però prenderla troppo sul serio poiché la cattedra non è un pulpito ma un palcoscenico, con tutte le conseguenze che comporta per l’attore…Il punto centrale e dolente è lo scambio avve-nuto fra Istruzione e Formazione – insiste Galli della Loggia, (magari sbagliando nell’uso all’in-
ca… per tacer del cane bastonato, ovvero della fine del prestigio che fino a ieri li proteggeva…A ciascuno il suo però, ed è vero che il libro di Galli della Loggia è attualmente il più ragiona-to e documentato intervento contro la deriva di una scuola pubblica che si è voluta parificata in tutti i sensi, e cioè “democratica” e “moderna” e “comunitaria” ed “egalitaria” e “funzionaria”, e chi più ne ha pensate più ne ha messe in nome dell’imperativo isterico dell’Aggiornamento, ov-vero dell’assoggettamento alla società e dell’as-servimento al mercato. Scuola scolara e non più magistra vitae, ma soprattutto scuola non più concepita come parallela a quella società che si doveva incontrare soltanto all’infinito, cioè dopo la fine dei suoi corsi di studio. Ecco, è “lo studio” quello che è venuto a mancare anzi si è finito per negare – sostiene Galli – a vantaggio del “lavoro”, inteso non più come sbocco pro-fessionale ma come addestramento immediato: un tempo fra il sapere e il fare c’era il mare del-lo studiare (a rischio di affogare). Adesso anche i sommersi vengono tutti salvati e, quel che è peggio, l’apprendimento si è snaturato in “ap-propriazione”: un contatto diretto con un dato da assimilare – spiega il libro a pagina 141 – invece di cogliere il valore simbolico e infine il “perché” del sapere ovvero il suo senso ma anche la sua funzione primaria… (corsivo ovvero riassunto mio).Ma, come si vede, si sta andando sul difficile, e non è lecito estrarre frammenti e argomenti dalla densità di un saggio che delle incessanti ri-forme della scuola italiana ne discute la filosofia e ripercorre la storia, a partire da quella del mi-nistro Gentile (che meno fascista non si poteva!) fino al fallimento di una internazionale quadra-tura del cerchio scolastico all’europea; un libro che cioè insegue gli anni e gli atti fino ad oggi, che poi è già il domani di una scuola per la quale probabilmente (rubando una profezia dell’ami-co Rastello) “un dopodomani non ci sarà”. L’aula è vuota intitola sconsolato Galli, ma sa che è un titolo sbagliato perché invece è piena e ancora gravida di promesse e progetti che fanno della scuola un “servizio” vuoto a tempo pieno, verso il quale si incitano le famiglie – ovvero l’e-
48
GLI A
SINI 69
EDUCAZIONE
Stato… con diabolica puntualità”. Ma anche il Cambiamento, prima di essere lo slogan di tutti i partiti, è il mantra evocato e recitato da tutti i loro elettori, e prima ancora da tutti “noi” con-sumatori. Già, perché il Mercato e la sua Cultu-ra “non è un’area, ma è l’aria” che si respira tutti e che almeno a scuola si dovrebbe poter analiz-zare, studiare, e perfino criticare… chissà! In questo studio e verso questa critica non si estende troppo il libro di Galli della Loggia, piuttosto concentrato sul “testo” della scuola che sul “contesto” più grande di lei e di tutti noi… Fermarsi al limitare delle influenze e dominanze della cultura del capitale e del mercato, è una scelta legittima e infine Galli ha tutto il dirit-to di voler restare sulle sue posizioni, anche se molte sono le occasioni e le considerazioni che potevano portarlo fuori tema scolastico e tocca-re il fondo del problema culturale di fondo… Un rimprovero però gli va fatto, quando la po-sizione presa diventa non solo antipatica ma er-rata, soprattutto per un professore di storia che non dovrebbe sempre buttarla in filosofia: parlo dell’ultimo capitolo da lui dedicato alla “vittoria di don Milani”, dove non ci sono inesattezze in quello che dice e cita e spiega a proposito della famosa Lettera a una professoressa, poi stralciata e adattata a lettera scarlatta della Scuola Democra-tica; ma resta invece grave che uno storico non la ricordi come un Atto e un Fatto, cioè come un gesto politico e non un testo di pedagogia. La storia di quegli anni era sì pervasa di ideolo-gia, ma è un tessuto di avvenimenti e di azioni, di mobilitazioni e di discussioni che la Lettera di Don Milani – più di ogni altro intervento – ha alimentato, per non dire “convertito”.Non è stato un bene chiudere un bel libro sulla scuola privilegiando la polemica anziché la gra-titudine verso il piccolo libro di un grande prete che ha fatto prendere coscienza a un’intera gene-razione. Magari anche all’autore de L’aula vuo-ta, che per forza ma anche per amore ha vissuto anche lui il periodo dove a scuola, come nella società, “la classe non era acqua”…
glese della parola “educazione” che, secondo l’e-timologia, vuol dire elevare, non allevare ovvero “formare”) – e quel punto ha dettato la linea che ha portato la scuola fuori dai suoi binari tradi-zionali, per spingerla a credersi rete metropolita-na con cento stazioni e altrettante “formazioni”. Ma non c’è comunque nessuno e nemmeno il professor della Loggia che voglia fermare il fu-turo, ma soltanto si vuole invitare a riflettere di più, verificare meglio, forse addirittura correg-gere il tiro e – ha ancora ragione Galli – rimette-re al suo posto “il passato” prima di spericolarsi nel futurismo degli stenterelli (maschera doc fiorentina…). E non per valorizzare la disciplina della storia, ma la sua “materia” in senso pieno e concreto, giacché il fare scuola è certamente ali-mentato dal Passato, in tutti i casi e in tutti i cor-si. È infine il passato la miniera del docente, che può diventare sorgente del discente nel regolare e perfino banale cammino dell’istruzione…Dico questo perché non si travisino le rimem-branze e le riflessioni di Galli della Loggia (che talvolta sembrano riaprire l’eterna querelle tra gli antichi studi umanistici e le nuovissime “ap-plicazioni tecniche”) per dargli del conservato-re, del nostalgico, del reazionario – come qual-cuno, nel suo Minimum fax, ha cominciato a fare… Peraltro la nostalgia e la conservazione e soprattutto la “reazione” si dovrebbero invece ri-svegliare davanti a una “distruzione della scuola italiana” che è sotto gli occhi di tutti, senza far differenze fra educatori mancati ed educandi maleducati… E stavolta davvero vale il “Noi” di più di una generazione e di tutta la popolazione scolastica di oggi e di ieri e ieri l’altro. Dare a Cesare tutta la sua parte di responsabilità è però giusto, visto che tutti i politici che hanno pre-dicato e razzolato nella scuola italiana si sono sempre inorgogliti di aver dato un contributo nel nome e nel segno del Cambiamento a Nes-sun Costo: a modificare normative e mansioni o aumentare scartoffie e riunioni non si spende nulla e per di più si passa “alla storia”, come è capitato a tutti i ministri – nessuno escluso, an-nota Galli a pag. 38 – che alla fine di ogni anno scolastico cambiavano “le regole degli esami di
49
INTERVEN
TO SOCIALE
GLI A
SINI 69
legame tra formazione e lavoro è espressione di un bisogno pragmatico: il conseguimento di un titolo abilitante. Se questo percorso è in parte motivato da una necessità di sicurezza sociale, la relazione con lo studio e la ricerca può essere vissuta come un ostacolo che si frappone tra lo studente e il pro-prio bisogno di autonomia. Per alcuni, quindi, la relazione con la formazione può essere oppor-tunistica: imparare nella sola prospettiva valuta-tiva e selezionare gli apprendimenti nella misura in cui ciò possa risultare utile al superamento di una verifica. Circolano nei più disparati canali, copie delle domande di verifica, elenchi di quiz a crocette, drastici riassunti di interi programmi, alcuni talmente asciugati da essere organizzati in forma di risposta alle domande che vanno per la maggiore. Quest’approssimazione non sembra essere un atto di ribellione a un sistema di rife-rimento culturale o formativo adottato dall’Uni-versità, e anche se lo fosse, non si coagula in atti concreti, propositivi e collettivi all’interno della facoltà. L’organizzazione burocratica del corso rende dif-ficile la vita soprattutto ai lavoratori: non devono esserci interferenze di nessun tipo, soprattutto sul piano logistico e di controllo dei risultati. Solo per fare un esempio, una studentessa non era riuscita a partecipare a un ultimo incontro di tre ore, all’interno di un ciclo di ventidue ore complessive di frequenza obbligatoria e la giusti-ficazione era un impedimento lavorativo. Una delle responsabili dei tirocini ha così risposto all’imprevisto: “Questo corso non è pensato per i lavoratori, dovete mettervelo in testa!”. Inevita-bilmente, la dispersione tra il primo e il quinto anno è consistente, soprattutto tra coloro che hanno un impiego.Le ventidue ore sono appuntamenti “obbliga-tori” in cui un addetto al laboratorio conduce il tirocinio chiamato indiretto, svolto in parallelo a quello diretto condotto in itinere nella scuo-la. Questo percorso prevede una serie d’incontri volti a istruire sul modo in cui scrivere e compi-lare delle griglie di valutazione. Ci sono griglie specifiche relative all’organizzazione dello spazio
UN’ESPERIENZA DI FORMAZIONE?
DI STEFANIA PETACCIA
Siamo a Bologna, nella facoltà di Scienze della formazione primaria, e da diverse settimane tre-cento studentesse e studenti sono stati “seleziona-ti”: seguiranno il percorso abilitante per lavorare nella scuola dell’infanzia e primaria. Negli ultimi anni questa formazione ha ricevuto sempre più attenzione da parte di un ampio nu-mero di aspiranti. Di conseguenza, altri lavorano alla costruzione di una macchina formativa sem-pre più efficiente nel suo sottile e rigido sistema organizzativo.A frequentare questo percorso sono prevalen-temente donne, circa il novanta per cento sul numero totale, e le controverse relazioni tra identità e ruoli sociali propongono quella na-turale associazione che accosta alla sessualità femminile un richiamo al materno, alla cura dei figli, e quindi sul piano sociale alla cura e crescita dei figli degli altri. Diverse confessano di aver scelto questo percorso mosse dall’amo-re per i bambini o esortate dalle loro madri, anch’esse insegnanti, che previdenti nel di-fendere e promuovere un futuro certo per le proprie figlie, hanno incoraggiato il vantaggio di un lavoro sicuro in cui scarseggia persona-le e che dichiara, come garanzia, un impiego privo di incertezze. Al numero di freschi di-plomati si aggiunge un’altra categoria consi-stente di persone tra i trenta e i quarant’anni che cercano, attraverso un percorso di studio aggiuntivo, uno strumento per uscire dalla maglia di precarietà economica, umana e di prospettiva professionale. Un gran numero di questi iscritti lavora già nella scuola, all’inter-no di contratti mal remunerati con cooperati-ve socio-educative oppure attraverso relazioni con il precario mondo dell’associazionismo. Il
50
GLI A
SINI 69
EDUCAZIONE
possa sprigionarsi quella forza costruttiva che viene, nelle parole di Lea Melandri, dall’azione collettiva, che mobilita e trasforma, che crea pre-supposti e momenti per inventare, raffigurare e anticipare alternative. L’esperienza introdotta in Autorità e potere nella scuola all’interno dell’Er-ba Voglio, aveva la politica e il lavoro culturale come collanti che univano insegnanti, alunni, studenti, psicologi, maestre, genitori e ne faceva-no protagonisti di un ragionamento e un’azione diretta. Erano tentativi di stabilire dei rapporti liberanti, senza riguardo per le funzioni e le com-petenze precostituite, senza l’intenzione di elabo-rare un freddo discorso da scienze pedagogiche. Racconto di un tentativo, concreto, reale, che cerca un’alternativa all’aderenza. A Bologna, il desiderio di impossessarsi dello spa-zio e del tempo del dibattito rispetto alla propria formazione e condizione, ha visto gli studenti e le studentesse attivi nella protesta Maestri non per caso. La lotta, piuttosto animata, che questi universitari hanno creato si è rivolta ai diploma-ti, che non avendo investito abbastanza sul pro-prio capitale umano, non meritavano altro che l’esclusione dal lavoro a scuola. Di fatto la loro principale argomentazione è stata una rivendi-cazione di casta garantita da una preparazione scientifica e da un percorso di studio universita-rio e superiore mirato. D’altro canto, la maggior parte degli attori, amministrativi e pedagogisti del corso, ha la stessa lungimiranza pragmatica e finalista, gli stessi interessi economici: per legitti-marsi e detenere il potere concorrenziale nella ge-stione della formazione docente hanno bisogno di costruire e difendere un ordine del discorso.
Se scendiamo nel realistico sistema neoliberale di produzione, la grande macchina, considerando i suoi numeri, non può né rallentare né fermarsi. Le aule contengono tra le duecento e le duecen-tocinquanta persone e smistare questa massa, at-traverso una verifica che sia il più possibile “fun-zionale” e veloce, è il processo più efficiente. L’esercizio di un controllo è affinato attraverso una severa organizzazione logistica, questo non fa altro che disgregare e indebolire le relazioni.
della scuola, schede dedicate al modo di fare ac-coglienza o rivolte al ruolo dell’insegnante osser-vato. Gli appuntamenti prevedono l’illustrazione di questi modelli e si concentrano su cosa scrivere e con quali caratteri grafici, su come osservare ciò che accade in classe o su cosa non tralasciare nella compilazione dei modelli. Sono griglie in cui si dovrebbe “imparare a osservare” sotto indicazio-ne, riducendo il campo delle priorità, della com-plessità e soggettività a uno schema formulato dai docimologi. L’impedimento lavorativo non è previsto, non può essere incanalato nel rigido schema delle re-gole. Dopo centotrenta ore di tirocinio in classe e diciannove indirette, tutto può andare perduto a causa di tre ore di assenza per un impedimen-to di lavoro “giustificato”. A quel punto, visto il tuo lavoro precario nella scuola, in cui attraverso delle messe a disposizione riesci a lavorare a sin-ghiozzi per alcuni mesi, conviene rischiare con la Dirigente piuttosto che perdere un anno di università, a causa di un tirocinio che potrebbe risultare “incompleto”.L’irrigidimento burocratico genera negli studenti e nelle studentesse uno stato di timore, che ali-menta l’esercizio di un’autodisciplina diretto a ridurre le possibilità di errore e riuscire a stare dentro il serrato schema di obblighi. Lo spazio vitale e riflessivo è quindi drasticamente ridotto dal pragmatico opportunismo di alcuni iscritti, dalle difficoltà esistenziali delle persone schiaccia-te dal precariato e, in definitiva, da un sistema formativo che non si cura degli effetti della pro-pria organizzazione. Si vuole sopravvivere e sfuggire alla noia o alla frustrazione quando dopo un anno, se non si è sostenuto l’esame, i laboratori di quaranta ore “scadono” e bisogna ripeterli da zero. Bisogna barcamenarsi in una città inospitale, soprattutto se fuori sede, a causa di quelli che sono i gran-di temi della casa e dei costi della vita. In queste condizioni, rassegnazione e remissività finiscono per sostenere in qualche modo il senso di un’ope-razione che svolge, attraverso la formazione, un preciso lavoro culturale e strutturante. É difficile immaginare che in questo contesto
51
INTERVEN
TO SOCIALE
GLI A
SINI 69
cui abbonda un linguaggio ricco di ammiccanti terminologie anglosassoni: outdoor education, cooperative learning, peer education, circle time.Si aggiunge, a tutto questo, una forma prevalente di adattamento alle richieste normative, che ac-centuando la dipendenza dalla centralità statale e dagli interessi economici, riduce qualsiasi forma di difesa o riflessione sui termini dell’autonomia. Nel Decreto Legislativo n. 62 del 2017 in materia di valutazione e certificazione delle competenze, attuativo della Legge sulla Buona Scuola (n. 107 del 2015) si trova un riferimento normativo che prescrive le Prove Invalsi. Se esiste la legge, le pro-ve vanno somministrate perché necessarie e utili a fini statistici. L’approccio neutrale, tecnocratico ed esecutivo non favorisce altro che l’adattamen-to aderente alla realtà così com’è. Questo è un preciso lavoro educativo, oltre che culturale, vol-to ad annullare qualsiasi posizione critica. Riportiamo questo discorso su un piano di real-tà. Lo scorso anno mi è capitato di lavorare per lungo tempo in una scuola statale che applica un modello sperimentale. Nello specifico la scuola in questione sviluppa il valore dell’ospitalità attra-verso un rinnovamento degli spazi e della didat-tica. Le aule non sono organizzate con la dispo-sizione classica dei banchi, ma con isole di lavoro che dovrebbero favorire l’esercizio della coopera-zione. Inoltre vi è uno spazio, chiamato agorà, in cui si dovrebbe fare esperienza attiva delle prati-che che favoriscono il senso di “comunità”. Tutto questo è pensato anche per favorire l’inclusione di quei bambini o bambine con difficoltà, quelli che definiscono in gergo tecnico gli alunni con bisogni educativi speciali e disturbi dell’appren-dimento. Questa caratteristica, portata a vessillo dall’Istituto, attira le attenzioni di alcuni peda-gogisti che lavorano all’interno dell’Università. Da un lato la Scuola necessita della sacra ap-provazione degli alti gradi istituzionali della ri-cerca, per ottenere credibilità e riconoscimento e accedere ai finanziamenti pubblici. Dall’altro, i pedagogisti speciali per l’inclusione hanno bi-sogno di riferimenti concreti provenienti dal “mondo reale”. Durante una programmazione tutte le insegnanti sono chiamate a rapporto, e la
Si arriva, alla fine, al punto di modificare razio-nalmente gli studenti per farli abituare alle forme di pianificazione governamentale degli individui. Attraverso questa pervasività ci si adatta più fa-cilmente all’ordine gestito dall’alto o alle norme difese per il principio della trasparenza: così for-se una volta entrati a scuola ci si adatterà, con maggiore facilità, ai dettami prescritti dal o dalla Dirigente di turno. Si dimentica quindi che il modo di strutturare un percorso, la gestione del processo e dei rapporti tra le parti, è anch’esso formativo. A questa tendenza si accompagna il lavoro cul-turale di alcuni dei titolari dei corsi di studio. Il corso si divide in due principali macro-aree. La prima comprende gli insegnamenti teorici, cioè di coloro che si occupano dei paradigmi della ri-cerca empirica, con l’obiettivo di farne conoscere metodi e approcci qualitativi e quantitativi. Ci sono i teorici delle metodologie didattiche e valu-tative, gli esperti in modelli di progettazione e in-novazione, il folto gruppo di pedagogisti, quelli interculturali, gli speciali per l’inclusione e la pe-dagogia generale e sociale. L’altra area comprende settori disciplinari come la didattica dell’italiano o della matematica, fisica e chimica oppure storia e geografia. L’impianto teorico dei settori pedagogici e meto-dologici pecca spesso di efficacia. Questi insegna-menti cooptano dalla realtà dei dati traducendoli in un linguaggio esautorato, il cui scarso valore sembra essere il risultato di una distanza tra la teoria e la prassi. In altre parole, la traduzione in termini teorici di ciò che non ha nella realtà con-creta la propria sostanza. Oppure ci sono coloro le cui riflessioni viaggiano su un piano utopistico e il cui linguaggio scade molto facilmente nella retorica. Inoltre i riferimenti culturali proposti non passano quasi mai per la lettura diretta e approfondita dei classici della pedagogia. Nelle scritture pedagogiche proposte, le teorie e le ri-flessioni che avevano contraddistinto la vita in-tera di donne e uomini, sono spesso sostituite da surrogati contemporanei e frammenti di un cor-po di pensiero complesso. Questo, nel peggiore dei casi, è ridotto a marketing della pedagogia in
52
GLI A
SINI 69
EDUCAZIONE
universitario con i dati da cui trarre le sue teorie. Solo per quel giorno si vuole quindi il bambi-no difficile in classe, costretto invece a stare per un anno intero fuori dall’aula perché d’intralcio, perché fastidioso, perché provocatorio e rabbio-so. Solo per quel giorno, per il resto dei mesi che precedono quell’appuntamento istituzionale e per quelli che seguiranno, sarà un escluso di cui importerà solo a pochi. Siamo molto distanti da alcune esperienze del passato. Penso alla Scuola laboratorio dell’Uni-versità di Chicago di Dewey, oppure all’efficacia teorica e comunicativa, perché portatrice di un’e-sperienza di vita oltre che di tecnica operativa e di lotta contro il centralismo statale, di Bruno Ciari, o ancora all’esperienza di Lamberto Borghi, che in La scuola e la città esprime sia il proprio ra-dicamento nell’azione quotidiana che un’onestà intellettuale nei riferimenti culturali e politici e, di conseguenza, una chiarezza nel suo modo di porsi nella storia. Da queste lezioni si impara che l’esperienza edu-cativa, l’attivismo e le pratiche non si apprendono in lezioni formali o in una simulazione teorica. Sono riferimenti che hanno trovato nella relazio-ne autentica, nel vissuto e nell’esercizio reale la propria consistenza. Esistono studenti, docenti e ricercatori consapevoli e con menti lucide, ma la percezione è che la frammentazione conduca all’isolamento e quindi al silenzio. C’è bisogno di costruire, creare o ripopolare contesti in cui po-ter inventare, raffigurare e anticipare alternative o resistenze, dentro o fuori dai luoghi istituzionali.
vicedirigente scolastica comunica che la settima-na successiva vi sarebbe stata una visita da parte di un’importante insegnante dell’Università. La richiesta che questa portavoce compie è quella di far calare nella realtà, per un unico giorno, la bella veste dei principi pedagogici adottati, “mi raccomando chiudete le aulette a chiave”. Quin-di bisogna far spettacolo, fingere per un giorno di avere quella credibilità e coerenza tra il dire e il fare che si sottoscrive nel PTOF, cambiare le carte affinché tutti siano in qualche modo soddi-sfatti: l’Istituto nella sua immagine e l’insegnante
53
INTERVEN
TO SOCIALE
GLI A
SINI 69
e a lavorare come supplenti, senza certezze ri-spetto alle opportunità di uscire realmente dal precariato.Rigidamente definita invece l’organizzazione del corso. La normativa ministeriale prevede che gli specializzandi acquisiscano 60 CFU attraverso lezioni, laboratori e tirocinio. Nella concreta vita quotidiana del corso, lo specializ-zando frequenta lezioni frontali in cui il rituale principale è il mantra dell’inclusione scolasti-ca: “la lezione frontale non va più bene”. Altro che dissonanze cognitive! Ma d’altronde biso-gna fare quello che il prete dice, non quello che il prete fa. Le lezioni poi si svolgono seguendo ritmi serrati. Si comincia con un periodo inten-sivo da giugno fino a settembre (con la pausa di agosto), dal lunedì al venerdì, dalla mattina alla sera. Tanto per essere sicuri che i “futuri” (il virgolettato è d’obbligo, dal momento che moltissimi lavorano già a scuola) docenti dige-riscano, metabolizzino e casomai riflettano an-che sui contenuti di didattica attiva, trasmessi nel corso della giornata da mamma Universi-tà. Durante le lezioni, molti dei fondamenti della pedagogia speciale e non solo, come ad esempio la predisposizione di un ambiente ac-cogliente, la disponibilità al dialogo, il focus sull’autonomia e sull’autovalutazione degli ap-prendimenti vengono sistematicamente disat-tesi. Le lezioni si svolgono nelle aule che gli or-ganizzatori “trovano” libere dalle altre esigenze dei corsi universitari, senza un calendario fisso, ma prevedendo dei contrappelli con controllo sul registro firme (con relativa paternale: “non provate a fare i furbi!”), che salvano la forma dove la sostanza si annulla. All’emergere di cri-ticità relative al corso la risposta solitamente si trincera dietro la burocrazia: “la normativa prevede questo o quest’altro e bisogna ade-guarsi”. Gli esami sono organizzati in sessio-ni di una giornata intera, batterie di prove in cui i singoli moduli vengono tayloristicamente esaminati uno dopo l’altro. Lo spazio in cui il corso di specializzazione sul sostegno educa all’autovalutazione e all’autonomia, o quello dedicato alla valutazione del corso da parte dei
LE CONTRADDIZIONI DEL SOSTEGNO A SCUOLA
DI ROBERTA BANDIERA E GIOVANNI MONTEROSSO
L’anno scolastico è iniziato e, come di consueto, molte cattedre sono ancora vuote. Negli ultimi anni si è evidenziata in particola-re la carenza di insegnanti di sostegno, a fronte del numero crescente di studenti certificati ai sensi della legge 104/92. La percentuale di que-sti è aumentata tra il 2014 e il 2017 del 8,3% ed è più che raddoppiata se si analizzano i dati su un periodo di vent’anni (erano 123.862 l’a.s. 97/98, sono 268.246 nel 2018, fonte Miur). Tenuto conto della mancanza di docenti spe-cializzati sul sostegno il Miur ha attivato a feb-braio 2019 la quarta sessione dei corsi di spe-cializzazione, istituiti dalle università su tutto il territorio nazionale, con accesso a numero chiuso e costi di iscrizione – con poche diffe-renze tra le diverse università – intorno ai 3000 euro. Molti dei candidati risultati idonei nelle tre prove di accesso (un test a risposta multi-pla preliminare, una prova scritta e una prova orale), non sono comunque stati ammessi alla frequenza del corso. Il numero di posti messi a bando è risultato insufficiente non solo rispet-to al bisogno delle scuole, ma anche inadegua-to ad accogliere l’ampio numero di precari che attendono da anni occasioni di formazione e di stabilizzazione.Una cosa è certa: il titolo non garantisce nul-la dal punto di vista lavorativo. È uno dei re-quisiti per la partecipazione a un concorso di cui ancora non si conoscono né tempi né mo-dalità. Nel frattempo i governi si succedono, cambiano colori e cognomi, ma su istruzione e assunzione dei docenti ognuno modifica, ta-glia, rinvia. Il risultato è che anche quest’anno le cattedre non sono coperte mentre gli spe-cializzandi continuano a frequentare un corso
54
GLI A
SINI 69
EDUCAZIONE
ratore (perlopiù precario) e tirocinante nel-la medesima istituzione, perché i tirocini già svolti o gli anni di esperienza non possono es-sere riconosciuti. Oppure di essere precari in un istituto primario e tirocinanti in una scuo-la dell’infanzia, tirocinanti in un professiona-le e precari alla secondaria di I grado, e così via combinando. Alla normativa nazionale seguono poi le diverse applicazioni territoria-li, con il risultato di un’ampia varietà di situa-zioni. In alcuni atenei gli specializzandi con un incarico in una scuola dello stesso ordine e grado in cui sono iscritti possono “spacchet-tare” le ore di tirocinio: possono farne valere così 75 di quelle in svolgimento per incarico e “offrirne” altre 75 come tirocinanti; per altre università, invece, valorizzare le ore di servi-zio per il tirocinio comporta dover produrre due relazioni finali. In altri atenei ancora i percorsi lavorativi sono interamente ignorati e ogni corsista è obbligato a rocamboleschi incastri per inserire le 150 ore di tirocinio nel-la propria settimana lavorativa.Il quadro della situazione diventa ancora più grottesco se si analizza la realtà delle assunzioni di personale sui posti di sostegno. Da un lato viene proposto ai docenti un percorso rigido e ultra selettivo, secondo una logica che mistifica la fabbricazione e la vendita in serie di lauree e diplomi con l’acquisizione e la certificazione di competenze. Dall’altro il numero sempre più alto di certificazioni obbliga le scuole a dover utilizzare altri criteri (spesso neanche troppo trasparenti) per l’assunzione annuale del per-sonale. Questo vale per il sostegno in misura ancora maggiore rispetto a quanto accade per i posti comuni. La precarietà in questo ambi-to ha cause strutturali: per l’anno scolastico 2019/2020 l’organico di diritto sul sostegno, le cattedre cioè assegnate annualmente alle istitu-zioni in riferimento al numero di alunni iscrit-ti e di classi previste, è composto da 100.080 posti (fonte Dossier “Assunzioni e supplenze 2019”, Cisl). La possibilità di assumere e di stabilizzare docenti partendo da queste catte-dre si scontra con la mancanza di personale
partecipanti è sostanzialmente nullo, se non in qualche laboratorio. La logica è chiaramente quella dell’Università azienda, che organizza la catalogazione della merce (il sapere pedago-gico certificato dop), la fornisce e riscuote le dovute gabelle.Da normativa, è prevista la possibilità di as-sentarsi per un massimo del 20% dalle lezioni frontali. Peccato che i singoli moduli (com-plessivamente 270 ore) siano divisi, in perfetta logica neoliberista, in mini-moduli da 15-20 ore, per cui assentarsi un giorno intero signi-fica perdere almeno 4 ore ed essere già oltre la soglia del 20% tollerato. Non un docente in-serito a scuola ha fatto un’ora di lezione: esimi accademici raccontano in 15 ore (in maniera quindi inevitabilmente superficiale) gli ultimi nuovissimi trend della pedagogia speciale (i mantra di cui sopra) e non esiste (almeno in sede di lezione frontale) alcuno scambio pro-duttivo tra esperienze scolastiche e formazio-ne dei docenti che invece le SISS, pur con i loro limiti, riuscivano in qualche modo a cre-are. Solo i laboratori sono tenuti (in parte) da docenti che lavorano nella scuola: l’universi-tà conserva gelosa il suo potere sul cielo della theoria, lasciando la sporca praxis in mano a docenti scolastici assunti tramite bandi (che, per inciso, sono andati più volte deserti e per molte università, viste le condizioni contrat-tuali offerte, non è stato semplice assumere docenti per i laboratori).Per il tirocinio e per i laboratori invece, “vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste” (D.M 8 febbraio 2019, n. 92, art. 3) e non c’è giustificazione che tenga: non la-voro, né famiglia, né malattia. Le ore vanno svolte integralmente e quelle perdute si recu-perano. Il tirocinio, anche questo normato nei dettagli dal ministero, prevede 150 ore da svolgere sul sostegno in un istituto statale. La stragrande maggioranza dei partecipanti però lavora già a scuola, alcuni anche da diversi anni. Per cui durante il tirocinio, de facto già svolto in diversi anni di esperienza, ci si trova nella condizione paradossale di essere lavo-
55
INTERVEN
TO SOCIALE
GLI A
SINI 69
litati, che non hanno preso incarichi sulle pro-prie discipline (dunque con punteggi più bassi perché con meno esperienza), a scuola iniziata anche da settimane. Una procedura che sem-brerebbe emergenziale se non si riproponesse identica ogni anno scolastico. Nella realtà delle scuole spesso l’unica conti-nuità è data dagli educatori/educatrici, figure professionali assunte non dal MIUR ma da cooperative esterne e che lavorano con tutele e contratti molto peggiori di quelli dei docenti. La gestione emergenziale delle assunzioni elu-de il fatto che per dare continuità bisognereb-be attuare un ampio piano di stabilizzazione e formazione di tutto il personale che da anni sopperisce alle mancanze del sistema. Una for-mazione sul sostegno a numero chiuso, a pa-gamento, organizzata in tempi estremamente risicati non può essere una garanzia per nes-suno. Non per i docenti, non per gli studen-ti, ancora meno per approssimare l’obiettivo dell’inclusione scolastica e lavorativa nella scuola e nella società. Senza una formazione adeguata – sul sostegno e non solo –, non lega-ta ad una patente da acquisire all’ingresso, ma costruita negli anni, in cui l’esperienza si co-struisce insieme allo studio, in cui la comunità scolastica funziona da ambiente educativo non solo per i ragazzi ma anche per i docenti, senza insomma una formazione libera, accessibile e gratuita per tutti i docenti, l’inclusione sociale resta solamente tra le pagine delle normative, nella buona volontà e nelle buone intenzioni che continuano a lastricare la via dell’inferno della scuola pubblica.
specializzato, per cui le potenziali assunzioni si trasformano in contratti a tempo determinato di docenti senza specializzazione che non pos-sono per normativa essere stabilizzati.Il resto dei posti sono cattedre richieste an-nualmente “in deroga” dagli istituti, come se fosse un’esigenza temporanea. Queste sono inevitabilmente destinate a supplenze. Si tratta di numeri non trascurabili: nell’a.s 2018/2019 sono stati 65.890 nelle scuole statali di tutti gli ordini e gradi sul territorio nazionale. Andan-do a vedere i dati di tre diversi Uffici Scolastici Regionali emerge poi un dato che conferma che la carenza è strutturale, che non è stata gestita in questi anni e che le azioni messe in atto per riempire questa mancanza non sono assolutamente adeguate alle esigenze reali. In Veneto, ad esempio, ai 6336 posti di diritto si aggiungono 3457 posti assegnati in deroga (nota Usr Veneto del 24/07/2019); ancora più allarmante la situazione dell’Emilia Romagna in cui i dati quasi si equivalgono: la nota del 18 luglio riporta 5.437 posti per l’organico di diritto e 4.349 posti in deroga. Per il sud Ita-lia l’aumento dei posti in deroga emerge come dato significativo in un generale calo progres-sivo di iscrizioni osservato negli ultimi anni (nota Usr Puglia 10 settembre 2019).Tutti questi incarichi vengono gestiti intera-mente dai singoli istituti, anche in quei ter-ritori in cui negli ultimi anni si è iniziata a sperimentare la modalità delle convocazioni unificate da graduatorie di istituto (I,II e III fascia). In questo sistema gli unici che parla-no di continuità didattica sono quei dirigenti che, facendo leva sui legittimi desideri delle fa-miglie, vorrebbero sfruttare questa situazione di caos per scegliere i propri docenti riconfer-mando quelli che hanno già svolto servizio, ag-girando così le graduatorie. E dunque all’uto-pia istituzionale del docente di sostegno ultra selezionato e ultra specializzato – e all’ideolo-gia che la ispira, che garantisce alle universi-tà il potere sul sapere pedagogico “legittimo” – corrisponde una realtà in cui l’insegnante è scelto dalle graduatorie incrociate dei non abi-
56
GLI A
SINI 69
EDUCAZIONE
DOPO BASAGLIA.UN SAGGIO
DI P.A. ROVATTIDI AMEDEO GAGLIARDI
Come faccio a continuare a prestare la mia opera come medico, se vengo ucciso come uomo? Con questa domanda posta da Schin-fu, dopo aver assistito alla conquista da parte del nemico della città in cui si trovava il suo ospedale, Franco Basaglia conclude La maggioranza deviante.Domanda che fa intuire come la rigida divisione del lavoro nella dimensione della cura diventi spesso solo strumento di potere, di oppressione, di impasse e di cattive pratiche.È questo a mio parere il tema del breve ma denso saggio, Le nostre oscillazioni, scritto da Pier Aldo Rovatti per “180, Archivio critico della Salute Mentale”, nel quale riprende un discorso per ri-costruire criticamente un rapporto tra filosofia e follia.L’autore invita gli operatori ma non solo, a guardare all’esperienza della “follia” partendo dall’osservazione delle proprie oscillazioni vitali, tenendo uno sguardo sul nostro precario equilibrio, quello dello “stare a cavallo di un muretto”. Un’immagine che esprime in modo semplice ma efficace la posizione nella quale provare a riconoscersi: un equilibrio instabile che si può mantenere accettando la condizione del “non so”, del “dubbio”, per poter accedere a quella liberazione di cui Basaglia in Italia e nel mondo è stato assoluto protagonista.Si tratta di un contributo puntuale e necessario al dibattito culturale oggi, in un momento dove la paura per la diversità si ostina a far tacere l’altro tracciando confini e alzando nuovamente muri. Ponendo al centro l’arte dell’oscillazione e invitando a confrontarsi con questa
dimensione, Pier Aldo Rovatti cerca di tracciare e riprendere un sentiero diverso.Sì perché diciamolo serenamente, negli ultimi anni in pochi hanno seguito questa indicazione. In questi ultimi trent’anni si è progressivamente imposto un modello rigido che ha pensato di far crescere efficienza ed efficacia attraverso l’aziendalizzazione delle istituzioni. Anni in cui si è fatta strada l’idea, sia nella concezione delle organizzazioni che di conseguenza nella pratica degli operatori, di un modello deterministico, prestazionale, disciplinare, derivato dalle organizzazioni produttrici delle merci. Questo modello ha creduto di poter rinunciare alla dimensione relazionale, segmentando le funzioni e i ruoli professionali, esasperando un “professionalismo” degenerativo, chiuso: la conseguenza è stata quella di aumentare le barriere e le difficoltà di accesso ai servizi per le persone più fragili.È in questa direzione che si sono imposte pratiche che di fatto hanno congelato la consapevolezza di tali oscillazioni, irrigidendo i sistemi organizzativi, allontanando i piani alti dai piani bassi, senza comprendere che bisognava invertire la piramide o almeno renderla più fluida, perché il momento della verità nelle organizzazioni di servizio, si forma nella relazione tra operatore e utente, che per questo motivo deve essere il centro dell’attenzione.Per contro oggi vediamo risvegliarsi l’ansia del controllo e della sorveglianza, un’ansia mai sopita che nell’attuale situazione di degrado culturale dilaga. Lo vediamo anche in questi giorni dove al Senato passa la proposta di collocare videocamere di sorveglianza nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e nei servizi per persone fragili. Una proposta inutile e dannosa per la protezione delle persone, come dimostra ampiamente la storia delle istituzioni totali e come testimonia il docufilm del 2015: 87 ore di Costanza Quattriglio, che racconta la morte di Francesco Mastrogiovanni in un reparto psichiatrico di ospedale, film interamente girato con immagini dalle telecamere
57
INTERVEN
TO SOCIALE
GLI A
SINI 69
agli altri, per poter uscire dai pasticci e dai paradossi che queste ci propongono.Negare questa possibilità vuol dire far morire la nostra umanità, accettando la rigidità della sola dimensione della sofferenza, che opprime, schiaccia, immobilizza, dentro ruoli precostituiti, magari più rassicuranti in un primo momento, perché ci illudono di essere “i più normali tra i normali”, ma incapaci di generare nuove strade, nuovi percorsi, nuove possibili vitali oscillazioni.
interne. Telecamere che allontanano, separano, escludono, annientando il senso di responsabilità personale degli operatori.L’obiettivo della riflessione di Pier Aldo Rovatti è quello di dare un contributo etico per restituire l’umanità necessaria quando ci si occupa della cura delle persone. Di questo lo ringrazio. Questo è possibile, ci spiega, se sappiamo riconoscere la follia come un valore in ognuno di noi. Dimensione che ci permette di trasformare la struttura e le regole che ci guidano, cercando e giocando insieme
58
GLI A
SINI 69
EDUCAZIONE
PERICOLO ROM O ROM IN PERICOLO?
DI MARCO BRAZZODURO
“I rom italiani purtroppo ce li dobbiamo te-nere”. È una frase uscita di bocca al nostro ex vicepresidente del consiglio e certifica in modo inequivocabile l’ostilità verso questa vituperata etnia. Non è stato un atto isolato. Lo stesso si-gnore a proposito della donna rom, scarcerata perché incinta, non si è lasciato sfuggire l’occa-sione per vomitare la sua inciviltà auspicando che le fosse impedito di procreare. Né possia-mo dimenticare l’orgogliosa rivendicazione della ruspa, severa risolutrice della guerra ai rom. Una vera e propria guerra che affonda le sue radici in tenaci quanto infondati pregiudi-zi e che di tanto in tanto si manifesta con epi-sodi di violenza: la bambola esplosiva regalata a una bambina che elemosinava, l’incendio doloso dell’insediamento a Opera (Milano, 2007), la caccia all’uomo a Ponticelli (Napoli, 2008), il pogrom alla Continassa dopo che una ragazza aveva falsamente accusato due rom di averla stuprata (Torino 2011), la fucilata a una infante in braccio alla madre a Roma (2018). E si potrebbe continuare tra dichiarazioni razzi-stiche, minacce, aggressioni e violenze.Perché questa ondata d’odio addirittura ali-mentata da chi ha la responsabilità istituzio-nale della coesione sociale e dell’inclusione ? Perché additare come meritevole del disprezzo e dell’ostilità collettiva un’intera etnia quando il dettato costituzionale (art. 6) prescrive la tu-tela delle minoranze nessuna esclusa ? Non è bastata la tragedia del porrajmos ovvero dello sterminio perpetrato dal regime nazista con l’eliminazione di 500mila rom e sinti ?I rom arrivati in Europa tra il 1300 e il 1400 (la prima testimonianza storica della loro pre-senza in Italia – Bologna – risale al 1422) sono
stati trattati sempre con sospetto che spesso ha tracimato in discriminazione e persecuzio-ne. Perché si è continuativamente manifestato nella storia dell’umanità il bisogno di un capro espiatorio cui addebitare falsamente la causa di disagi, incertezze, paure ? La innominabile tra-gedia degli stermini nazisti non ci ha insegnato nulla ? Oggi solo voci, per fortuna isolate – ma ricordo una consigliera comunale (di Motta Visconti) che aveva messo a disposizione il suo forno per la bisogna – reclamano impu-dentemente l’eliminazione degli “zingari”, ma il disprezzo, gli stereotipi, la discriminazione persistono e purtroppo tendono ad aumenta-re. Domanda (retorica ?): ma l’umanità non si libererà mai della necessità di odiare ? Mi rifiuto di credere che l’odio sia un elemento costitutivo della natura umana e come tale ine-liminabile.Per odiare una persona o una collettività è necessario dipingerlo negativamente attri-buendogli comportamenti odiosi e caratteri-stiche di totale alterità. Per quanto riguarda i rom una delle accuse più diffuse e condivise è quella del rapimento dei bambini. Ricor-do un episodio di un paio d’anni fa quando la presenza in Grecia di una bambina bion-dissima presso una famiglia rom costituita di membri con pelle scura ha scatenato un putiferio internazionale che si è placato solo quando la famiglia originaria della bambina è stata rintracciata e ha dichiarato il proprio consenso alla sua presenza presso la famiglia ingiustamente accusata. In genere i rom interrogati sull’argomento ri-spondono che hanno già tanti figli per conto loro e che non gli passerebbe per l’anticamera del cervello il pensiero di rapire. A contrasto di questa diffusa convinzione è stata pubblicata una ricerca dal titolo significativo (La Zingara Rapitrice di Tosi Cambini Cisu 2008) in cui si esaminano 10 anni di inchieste giudiziarie sul tema. Ne risulta che in primo luogo non è mai stato trovato un bambino/a scomparso/a in un insediamento di rom, anche se in tutti i casi di scomparsa i campi rom sono i primi
59
INTERVEN
TO SOCIALE
GLI A
SINI 69
a venire setacciati e sarebbe la prova regina di quell’assunto. In secondo luogo oltre a riferi-re dei numerosi casi di accuse conclusesi con la dichiarazione di insussistenza del fatto, si esaminano due casi di condanna per “tentato rapimento” in cui accusa e difesa non aveva-no testimonianze a loro favore e il giudice ha dimostrato di credere all’accusa. Un’altra con-danna per tentato rapimento è stata erogata a Napoli dopo l’uscita del libro. Un ragazzina di 16 anni ha scontato 4 anni di reclusione. Dopo la liberazione, intervistata, ha dichiarato che lei si era recata presso quell’abitazione ma che il neonato del cui tentato rapimento era sta-ta imputata non l’aveva mai visto. Tra l’altro dopo la condanna, e i termini prescritti, il suo avvocato aveva avanzato richiesta al giudice di sorveglianza dell’ammissione agli arresti domi-ciliari. La richiesta ricevette un diniego perché “data la cultura di appartenenza elevata era la probabilità di reiterazione del reato”. In questo modo il giudice dimostrava sorprendentemen-te di condividere il pregiudizio. Del resto quando si vuol colpevolizzare una persona o un gruppo sociale l’argomento dei bambini funziona. Per esecrare i comunisti si propalò la notizia che se li mangiavano. Gli ebrei ne avrebbero fatto oggetto di sacrifici rituali. I primi cristiani, osteggiati dal potere, furono oggetto di una campagna di discredi-to che li imputava – guarda caso – di rapire i bambini. Corsi e ricorsi.Un segno della supposta marcata alterità ri-guarda il nomadismo. Anche qui molta igno-ranza. Vorrei innanzitutto rammentare un certo percorso semantico. Fino a pochi anni fa i rom e sinti venivano apostrofati col termi-ne di “zingari”, un epiteto che gli antropologi definiscono come eteronimo cioè come nome dato dall’esterno. I rom e sinti tra di loro non si chiamano così. Inoltre è un termine che ha assunto nel tempo un significato derogatorio per cui gli intellettuali e attivisti rom hanno iniziato una battaglia tesa al riconoscimento del loro etnonimo: rom o sinti. Le persone più aperte e democratiche hanno quindi sostitui-
to il termine zingari con quello di “nomadi” considerato scevro del contenuto spregiativo. Da cui i “campi nomadi”, gli “uffici nomadi” ecc. Ma anche qui si è trattato e si tratta di un errore perché i rom e sinti non sono più no-madi da generazioni. Ma un errore persisten-te. Recentemente mi è accaduto di ascoltare con sconcerto in una trasmissione radiofonica un eminente politico, la onorevole Meloni, dichiarare che se i rom sono nomadi devono “nomadare”. Così la sullodata signora ha colto due piccioni con una fava. Dimostrando nel contempo la sua ignoranza e le sue tenaci radi-ci autoritarie. La sua ignoranza perché i rom e sinti sono stanziali da generazioni e il suo au-toritarismo perché pretende che un individuo o un’etnia rimanga obbligata a un comporta-mento dato. Ma la nostra costituzione consen-te o non consente che un nomade decida di diventare stanziale e a me che sono stanziale la costituzione mi riconosce o no la libertà di diventare nomade ?Sul nomadismo di rom e sinti vorrei anche contestare una diffusa convinzione, quella che detta pratica sia la conseguenza di una libera scelta e che sia addirittura un tratto istintivo dei rom e sinti, quasi che possedessero uno specifico gene. Infatti si sente spesso dire che hanno il nomadismo nel Dna. Niente di più falso.La verità è che il nomadismo ha rappresenta-to una risposta culturale adattiva alle persecu-zioni subite. Esistono centinaia di editti delle città stato e dei comuni medievali dove si con-cede a “li cingani” una presenza limitata a due/tre giorni nel territorio. Trascorsi i quali ap-propriarsi dei loro beni o anche ucciderli non costituiva reato.Il processo di creazione del capro espiatorio comporta l’attribuzione di una serie di carat-teristiche negative. Il soggetto da disprezzare ed esecrare deve meritarsi il disprezzo e l’odio. Quindi i rom e sinti rapiscono i bambini, ru-bano, non vogliono lavorare, costringono con la violenza i figli a elemosinare, non vogliono integrarsi ecc. Ho cercato di esporre argomenti
60
GLI A
SINI 69
EDUCAZIONE
a confutazione del primo di questi pregiudi-zi. I rom rubano? Per una risposta corretta a questo assunto vanno rammentati alcuni ele-mentari concetti sociologici. Come tutte le società anche le comunità rom sono dotate di una struttura sociale a forma di piramide con al vertice i ricchi, le famiglie di successo e alla base il sottoproletariato. I rom segregati nei campi appartengono al sottoproletariato vale a dire a una collettività stabilmente esclusa dal mercato del lavoro e come tutti i sottoprole-tari, vivano essi a Roma, a Milano, a Londra o a New York, sbarcano il lunario praticando anche varie forme di illegalità tra cui il furto, il taccheggio ecc. Non certo l’aggiotaggio o il trasferimento illecito di capitali all’estero, ov-viamente reati dei colletti bianchi.I rom non vogliono lavorare? Posso smentir-lo sulla base della mia esperienza (frequen-to assiduamente i “campi” da oltre 25 anni). Quando entro in un “campo” la prima cosa che mi chiedono è: “Quando ci sgomberano?” così dimostrando una condizione psicologica di marcata precarietà: molti vivono avverten-do come una spada di Damocle sulla propria testa, quella del possibile sgombero.La figura sociale del rom come viene coltiva-ta dall’immaginario collettivo alimentato dai mass media è quella del “nomade” straccione, sporco, residente nei campi, spesso discariche di rifiuti di ogni genere. È una rappresentazio-ne deformata e caricaturale, funzionale però al ruolo di capro espiatorio. In realtà la società rom – peraltro assai articolata al suo interno – non è composta solo di sottoproletari. In Italia ad esempio si stima che i rom e sinti ammon-tino a 150-180 mila. Quelli che vivono ghettiz-zati nei campi e che possiamo ritenere in gran parte sottoproletari sono 26mila vale a dire il 15% del totale, una minoranza. La maggioran-za vive nelle case, paga l’affitto, lavora, manda i figli a scuola, è perfettamente integrata.Altra accusa scagliata contro i rom e sinti è quella che non vogliono integrarsi. Pertanto l’implicito corollario è che la condizione di esclusione non è il risultato del rifiuto della
società maggioritaria quanto della volontà di autoesclusione. Certo è vero che molte comu-nità si sono rinchiuse in sé stesse, compattan-dosi e rafforzandosi attraverso l’endogamia. In alcuni campi ho personalmente rilevato l’e-levatezza del numero di matrimoni tra primi cugini. Ma anche qui ci aiutano i paradigmi antropologici. Le comunità si chiudono in sé per sopravvivere agli ambienti ostili. E difatti la sopravvivenza dell’etnia dei rom e sinti a se-coli di persecuzioni anche violente è quasi un enigma antropologico tanto è vero che sono anche stati etichettati come popoli della resi-stenza. La mia esperienza mi induce a ritenere questa diffusa convinzione infondata. Cerca-no con fatica di dotarsi dei documenti neces-sari – il permesso di soggiorno se stranieri, la casa popolare, la tessera sanitaria eccetera – ed esprimono una evidente contentezza quando li ottengono. Segni inequivocabili a mio avviso di una volontà di integrazione e partecipazio-ne attraverso l’accettazione delle regole.Pochi sanno che diverse istituzioni e agenzie internazionali, dalla Nazioni Unite al Con-siglio d’Europa all’Unione europea, solo per citarne alcune, sono ripetutamente interve-nute con dichiarazioni, esortazioni, iniziative concrete a sostegno di rom e sinti. Per contra-starne l’emarginazione e promuoverne l’inclu-sione. Ad esempio nel 2011 l’Unione Europea ha sollecitato i 27 stati aderenti a dotarsi – se già non l’avessero – di una strategia naziona-le d’inclusione. Il governo italiano l’ha adot-tata nel 2012. Il documento relativo, di circa 100 pagine, è stato redatto dall’Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) a sua volta istituito nel 2003 su richiesta della mede-sima Ue. Il contenuto è altamente apprezzabi-le: si fonda sulla individuazione di 4 pilastri sui quali costruire un processo di inclusione: casa, lavoro, salute e istruzione. Le analisi sviluppate e le proposte individuate risultano ragionevoli e coerenti e scaturiscono da una corretta cono-scenza della articolata situazione di rom e sinti in Italia. L’attuazione concreta della strategia è demandata a tavoli bilaterali che le Regioni e i
61
INTERVEN
TO SOCIALE
GLI A
SINI 69
Comuni più grandi avrebbero dovuto istituire. Sono trascorsi più di 7 anni e la condizione di rom e sinti invece di migliorare è peggiorata. La Strategia è completamente fallita. In questi giorni – luglio 2019 – dal cilindro del nostro ineffabile vicepresidente del Consiglio è salta-to fuori l’ennesimo coniglio volto a distrarre i cittadini dalle concrete difficoltà che li attana-gliano. Mi riferisco alla circolare che richiede ai prefetti di procedere a un censimento dei campi nomadi. Li si considera configurare “un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pub-blica”. L’obiettivo è quello di adottare misure “finalizzate alla riaffermazione della legalità”. La storia si ripete. Già nel 2008 il ministro Maroni aveva fatto approvare dal Consiglio dei Ministri tre ordinanze per contrastare “l’e-mergenza” dei “campi nomadi” con la nomina di Commissari ad hoc. Anche in quell’occasio-ne era stato predisposto un censimento salvo poi registrare l’annullamento dell’intera ope-razione – che nel frattempo aveva raccolto la condanna del Parlamento europeo – in forza di sentenza del Tar confermata in sede di Con-siglio di Stato e Cassazione.Permane comunque il senso di queste opera-zioni che partono dal presupposto dei “campi” come luoghi di malaffare, covi di criminalità, serbatoi di illegalità diffuse. Così tentando di giustificare l’ostilità, l’avversione, l’odio contro rom e sinti. I “campi” sono in realtà luoghi di segregazione razziale dove si ammassa il sotto-proletariato rom. Come tutti i sottoproletaria-ti, ovvero gli esclusi, anche rom e sinti confi-nati nei “campi” per sopravvivere si arrangiano ricorrendo anche a pratiche illegali. Ma il nodo sta nella povertà e quindi l’approccio al tema va rovesciato: contrastando efficacemente l’in-digenza si abbatte la necessità di aggirare le leggi. Possibile che nessuno si dia la briga di leggere un manuale basico di sociologia della devianza? Si eviterebbero tanti approcci goffi e sbagliati. Naturalmente i miopi interventi meramente repressivi – gli sgomberi – si am-mantano del mantra dato dal “ripristino della legalità”. Chi può essere contro la legalità? Ma
esiste un altro livello di legalità, sempre tra-scurato, che è quello dei diritti umani solen-nemente sanzionati dall’Onu, tra cui in primis è il diritto a un rifugio adeguato come pure il diritto a un livello di vita dignitoso. Esiste anche una Carta internazionale dei diritti del fanciullo con una serie esplicita di tutele. Gli sgomberi forzati minacciati da Salvini e come vengono costantemente praticati in Italia – ultimo clamoroso esempio quello praticato a Giugliano (Napoli) – violano apertamente la normativa internazionale, gli impegni assunti dall’Italia, il buon senso, lo spirito di umanità che dovrebbe presiedere a tutte le attività uma-ne in specie a quelle esercitate dal potere.I rom, diffusi in tutti i paesi d’Europa (e non solo, avendone personalmente incontrati per-sino in Patagonia) ne costituiscono la mino-ranza più numerosa. Presenti da otto secoli, rappresentano a pieno titolo una componente del variegato e ricco mosaico antropologico europeo. E all’Europa, alla cultura europea hanno apportato un contributo prezioso an-che se misconosciuto. Si pensi alla musica, alle arti figurative, alla letteratura, alla poesia. Eb-bene quando cesserà l’ostilità contro di loro ? L’antiziganismo è un nostro problema, un pro-blema della società maggioritaria. Quando ci libereremo di quel vergognoso tarlo, di quel sentimento primordiale, animalesco che è l’o-dio contro il diverso?
62
GLI A
SINI 69
POCO DI BUONO
SEMBRARE VA QUASI BENE COME ESSERE, A VOLTEDI JOHN ASHBERY
VERSIONI DI DAMIANO ABENI E MOIRA EGAN
Ancora su John Ashbery il poeta che abbiamo così amato è scomparso il 3 settembre 2017. Aveva compiuto 90 anni il 28 luglio.Del suo ultimo libro, Commotion of the Birds (Ecco, 2016), Ben Lerner ha detto: “La scrittura di John Ashbery ha sempre trattato in modo profondo del tempo (quale poesia non ne tratta?), ma le poesie più recenti affrontano il tema della tarda età/era – ‘la vita è una storia breve breve’; ‘i saldi pantagruelici sono finiti’; ‘ne abbiamo avuto tutti / a sufficienza, in gioventù’ – in modi alquanto variati. La magnifica Strepito degli uccelli guarda all’indietro dalla ‘luce vivida dell’oggi’ a secoli di innovazione e tradizione artistica, risultando allo stesso tempo una parodia dei periodi accademici e artistici ma anche uno stupendo distillato degli stessi. Penso che la si possa classificare tra le sue poesie migliori, ma cosa importano le classifiche: se, a quasi novant’anni, Ashbery guarda all’indietro, lo fa perché si trova più avanti di noi”.Abbiamo scelto un verso del “title-poem” della sua più recente raccolta come titolo a questa minima sil-loge. In questa riga, leggerezza e pesantezza sono perfettamente bilanciate in purissimo stile ashberiano. John ci consente di sorridere, godendoci la beffarda ironia di “quasi” e “a volte”, e allo stesso tempo ci incupisce facendoci pensare alla nostra era narcisistica di fakeness e gratificazione istantanea insinuando in noi l’idea che forse, forse forse, ci stia dicendo che la “Civiltà” Occidentale è condannata. E qualsiasi interpretazione scegliamo, avremo allo stesso tempo ragione e torto, come succede quando si cade nella magnifica ragnatela di Ashbery.
STREPITO DEGLI UCCELLIScorriamo rapidi attraverso il diciassettesimo secolo.L’ultima parte è ok, molto più modernadella prima. Adesso c’è la Commedia della Restaurazione.Webster e Shakespeare e Corneille erano okper il loro tempo ma non moderni abbastanza,per quanto un passo avanti rispetto al sedicesimo secolo
63
GLI A
SINI 69
POCO DI BUON
O
di Enrico VIII, Lasso e Petrus Christus, che, paradossalmentesembrano più moderni dei loro immediati successori,Tyndale, Moroni e Luca Marenzio tra gli altri.Spesso è questione di sembrare piuttosto che essere moderni.Sembrare va quasi bene come essere, a volte,e ogni tanto va altrettanto bene. Che possa essere anche meglioè questione che sarebbe opportuno lasciare ai filosofie ad altri della loro schiatta, che sanno le cosein un modo che per gli altri è impossibile, anche se le cosesono quasi le stesse cose che sappiamo noi.Sappiamo, ad esempio, che Carissimi ha influenzato Charpentier,ha misurato le proposizioni attaccandogli in coda un loopche riporta le cose all’inizio, solo un po’più in alto. Il loop è italiano,importato alla corte di Francia e dapprima disprezzato,poi accettato senza alcuna menzione della suaorigine, come i francesi sono avvezzi a fare.Può essere che alcuni lo riconoscanonella sua nuova veste – che può essere rimandataa un altro secolo, quando gli storici sosterrannoche tutto è accaduto normalmente, come risultato della storia.(Il barocco ha un modo tutto suo di rovinarci addosso,quando pensavamo di averlo chiuso per bene nell’armadio.Il classico lo ignora, o lo tollera blandamente.Ha altro per la testa, di minor rilevanza,si viene a sapere). Nondimeno, facciamo bene a crescerci insieme,pregustando impazienti il modernismo, quandotutto andrà per il meglio, chissà come e perché.Fino ad allora è meglio abbandonare i nostri gustia qualsiasi cosa ci sembri adatta a loro: questa scarpa,quella cinghia, un giorno giungeranno a sembrarci utiliquando la presenza pensosa del modernismo si sarà installatadappertutto, come le planimetrie scartate di un progetto architettonico.È bello essere moderni se si riesce a sopportarlo.È come essere lasciati fuori sotto la pioggia, e arrivarea capire che si è sempre stati così: moderni, fradici,abbandonati, per quanto con quell’intuizione fuori dal comuneche ti dà coscienza di non essere mai stato destinato a esserequalcun altro, per cui gli arteficidel modernismo verranno passati in rassegnaproprio mentre appassiscono e svaniscono nella luce vivida dell’oggi.
64
POCO DI BUON
OG
LI ASIN
I 69
IL LAMENTO SULLE ACQUE Per il discepolo non era cambiato niente. L’umore era ancoragrigia tolleranza, mentre la strada marciava con luicantando il suo motivetto disperato. Una volta, un gridos’alzò improvviso uscendo dalle colline. Quell’antico, sconcertante convincimento
un’altra volta. Il sesso ne faceva parte,come anche lo shock del giorno che si fa notte.Per quanto trovavamo sempre qualcosa di delicato (troppo delicatoper certi gusti, forse) da toccare, da desiderare.
E tenevamo in gran conto questo genere di materialitàche congestionava il peso della luce di stella, la faceva apparirefibrosa, eppure in ciò si trovava una chancedi vedere il presente come se non fosse mai esistito,
limpido e informe, in un’atmosfera come cristallo intagliato.A Latour-Maubourg hai detto che era cosa buona, e sulle scaledi Métro Jasmin i corrieri ci hanno fatto cenno correttamente e ilpatto è stato stretto in cielo. Ma adesso gli attimi ci circondano
come una folla, volti inquisitori, alcuni ostili,altri enigmatici o volti altrove verso una forma anteriore del tempodata una volta per tutte. La scia del jet incide uno svolazzo finaleche si scioglie mentre resta. Il problema non è come procedere
ma ha a che fare con l’essere: se ciò sia mai stato, e di chisarà. Essere al principio, solo un passogiù dal marciapiedi, e così riattratti nella scintillantetempesta di neve di tentacoli urticanti del come si sarebbe risolto il tutto
se mai l’avessimo risolto. E la voce gli è tornatadall’altra riva del lago, accarezzandolo contropelo: “Tualtro far non puoi che disfare il male che facesti”. Le sambuchelo ingentiliscono, e noi non siamo mai un po’ più vicini alla collisione
delle acque, alla pace della luce che affoga luce,afferrandola, sostenendola nel fluire. Tutto è uno. Staovunque, il suo nuovo messaggio, colpa, l’ammissionedella colpa, il tuo nuovo modo di essere. Il tempo compra
il ricevitore, l’astante del sistema precedente, ma non puòricomprare il resto. È la notte che è cadutasul bordo dei tuoi passi mentre la musica finiva.E abbiamo sentito per la prima volta le campane. La scena è tutta tua, ho detto.
65
POCO DI BUON
OG
LI ASIN
I 69
AMICI Mi piace parlare in rima perché io stesso sono rima.
NijinskyHo visto un cottage in cielo.Ho visto una mongolfiera di piombo.Non riesco a trattenere le lacrime, e mi scendonosulla mano sinistra e sulla cravatta di setama non posso e non voglio fermarle.
Un giorno i vicini si lamentano di uno sgradevole odoreproveniente dalla sua stanza. Sono uscito a passeggioma non ho incontrato neanche un amico. Un’altra volta esconel mondo. Trema, trema di continuo.Tremava prima che lo vedessie presumibilmente lo fa ancora.
Il banchiere appoggia la mano sulla mia.Ha la faccia linda come un fazzoletto bianco.Parliamo di sciocchezze come al solito.Io traccio piccoli cerchi sulla luce che entradalla finestra su zampe da cavalletto per segare la legna.Poi vedo che siamo tre.Qualcuno è entrato nella stanza mentre parlavo dei miei problemi di soldi.Vorrei che Dio mettesse fine a tutto ciò. Iomi giro e vedo la luna nuova oltre il vetro. Vengo strappato viacosì bruscamente che mi si ferma il respiro, sensazione non sgradevole.
Mi sento come se avessi portato il messaggio per annisulle spalle, come Atlante, senza mai rendermene contodato che non ho mai conosciuto altro. In un altro sensoio ho a che fare con il messaggio. Voglio metterlo giù(nei due sensi di “metterlo giù”) in modo che tupossa comprendere il gradevole destino che ci attende.Sospiri. I tuoi sospiri non lasciano adito ad alcuna impazienza,solo un vasto lago vulcanico, vasto quanto il mare,in cui il cielo, più piccolo di così, si riflette.
Prendo il cappelloe sono tenuto a ripetere con tattoil saluto formale di cui sono incaricato.Nessuno fa errori. Nessuno fuggeormai. Mi mordo il labbro emi volto verso di te. Forse adesso capisci.
Il sentimento è un gioiello come una perla.
POCO DI BUON
O
SONATA AZZURRATanto tempo fa l’allora ha cominciato a somigliare all’oradato che l’ora non è altro che intraprendere una nuova ma purtuttaviaindefinita strada. Quell’ora, quella una voltavista da molto lontano, è il nostro destinoa dispetto di cos’altro possa mai succederci. Èil passato prossimo di cui i nostri tratti,le nostre opinioni, sono fatti. Noi ne siamo la metà enon ci importa niente del resto. Noiriusciamo a vedere avanti quanto basta perché il resto di noi siaimplicito nei dintorni che il crepuscolo è.Sappiamo che questa parte del giorno arriva ogni giornoe sentiamo che, dato che ha i suoi diritti, cosìnoi abbiamo il diritto di essere noi stessi nella misurain cui noi siamo in esso e non in qualche altro giorno, né inqualche altro posto. Il tempo ci va beneproprio nel modo in cui esso pensa se stesso, ma solo fino al puntoin cui noi non cediamo nemmeno di un centimetro, respirodel divenire prima che il divenire possa esser visto,o che arrivi a sembrare ciò che sembra significare ora.
Le cose che stavano giungendo perché se ne parlassesono giunte e ripartite e vengono ancora ricordatecome recenti. C’è un granello di curiositàalla base di qualche cosa nuova, che dispiegail suo punto di domanda come una nuova onda sulla riva.Nel giungere a dare, a rinunciare a ciò che avevamo,abbiamo, così ci pare, guadagnato o siamo stati guadagnatida ciò che stava passando, lucente della patinadi cose recentemente dimenticate e rinfocolate.Ogni immagine trova il posto giusto, con la calmadi non averne troppe, di averne proprio quanto basta.Viviamo nel gemito del nostro presente.
Se ciò era tutto ciò che c’era da avereallora potevamo ri-immaginare l’altra metà, deducendoladalla forma di ciò che si vede, che cosìviene inclusa nella propria idea di come noiavremmo dovuto procedere. Sarebbe tragico calzare a pennellonello spazio creato dal nostro non essere ancora arrivati,proferire il discorso che appartiene a quel luogo,perché il progresso ha luogo attraverso la reinvenzionedi queste parole da un fioco ricordo che se ne ha,violando quello spazio in modo tale dalasciarlo intatto. Eppure dopo tuttoqui ci stiamo bene, e abbiamo coperto una considerevoledistanza; il nostro passare è una facciata.Ma la nostra comprensione di esso è giustificata.
67
POCO DI BUON
OG
LI ASIN
I 69
un trasferimento con relativa promozione a Roma), perché a Milano aveva contribuito nel 1975 alla nascita di Radio Popolare (che avreb-be poi diretto dal 1992), perché aveva vissuto da cronista ma con qualcosa in più del croni-sta, con lo sguardo dell’intellettuale e con la passione civile di chi frequenta la politica nella concezione più nobile, più alta, della politica, aveva vissuto la stagione più tragica e insieme più ricca di Milano, la più cupa per il paese dalla fine della guerra in avanti: la strage di piazza Fontana e poi, attorno a quel terribile momento di svolta, le lotte operaie, i movi-menti studenteschi, il terrorismo... Qualcosa che ti rimane addosso, anni di paura, di com-plotti, di morte, ma anche di una nuova resi-stenza, di bisogno di democrazia, di trincee a difesa di quanto la Costituzione ci aveva ga-rantito e che le strategie del terrore complotta-vano per cancellare. Per un giornalista furono prove severe alla ricerca della verità o di qual-cosa che si approssimasse alla verità, che sve-lasse le falsificazioni, i depistaggi, l’invenzione dei colpevoli. Piazza Fontana rappresentò per la stampa italiana un’occasione di indipenden-za e il giornalismo italiano, o almeno una par-te di esso (cito solo Camilla Cederna, Giorgio Bocca, Marco Nozza, Marco Fini, Giampaolo Pansa e, più avanti, Ibio Paolucci, e, natural-mente, il nostro Piero Scaramucci) non rinun-ciò alla sfida e a misurarsi quindi con il potere, a confutare le sue tesi, le sue facili spiegazioni, le sue verità, quando ad esempio il questore indicò la pista anarchica, quando proclamò la morte di Giuseppe Pinelli prova certa di colpe-volezza, quando additò Valpreda come l’auto-re materiale dell’attentato (e fu Bruno Vespa, istituzionale come sempre, ad annunciare al telegiornale l’arresto del “mostro”).In quei tempi, assai lontani dai nostri e non solo cronologicamente (a dicembre sarà tra-scorso mezzo secolo), di fronte alle favole nar-rate da ministri e questori, molti giornalisti crearono comitati “per la libertà di stampa” (il primo proprio a Milano, undici giorni dopo la bomba) e Scaramucci fu tra gli animatori di un
Il 10 agosto era stato un’altra volta in piazzale Loreto, per partecipare alla comme-morazione dei quindici martiri, vittime dei nazifascisti. Un’altra volta Piero Scaramucci aveva voluto testimoniare la propria fedeltà agli ideali della Resistenza, manifestare il pro-prio impegno politico, impegno di una vita. Pochi giorni dopo sarebbe finito in ospedale, poche settimane ancora e sarebbe morto. Ave-va 82 anni (era nato nel 1937 a Praga, figlio di un perugino e di una intellettuale polacca, che avrebbe fatto conoscere in Italia, traducendoli, molti scrittori del suo paese, tra i quali Kazi-mierz Brandys). L’avevamo incontrato qualche mese prima, a una manifestazione del sindaca-to della stampa e poi una sera, quando ci si era riuniti per discutere qualcosa del futuro con-gresso della Federazione nazionale: come sem-pre sorridente, garbato, pronto a interloquire con il tono gentile e riflessivo, capace di con-siderare con intelligenza critica e con lucidità i fatti del mondo e con misurato scetticismo... Lo ricordiamo così, ottimo giornalista, bella persona, schiva: non so quanti tra i giovani lo conoscano. D’altra parte di lui si può dire che non avesse mai inseguito il successo, la fama, la notorietà, che pure avrebbe facilmente po-tuto raggiungere, grazie a un mestiere che gli aveva consentito di vivere tante storie e di rac-contarle, inviato della Rai: dalla morte di En-rico Mattei alle rapine della banda Cavallero, dall’alluvione di Genova ai più aspri conflitti sindacali, anche all’estero, nella Cambogia di Pol Pot o in Iran per la guerra contro l’Irak.La sua storia è molto “milanese”: perché nella sede Rai di corso Sempione aveva cominciato e aveva continuato a lavorare (aveva rifiutato
PIERO SCARAMUCCI.UN RICORDO
DI ORESTE PIVETTA
68
GLI A
SINI 69
POCO DI BUON
O
tinua, era entrato in Rai per concorso nel 1961. Presto, in Rai, s’era dovuto misurare con l’o-stilità dei democristiani. Nel sindacato aveva trovato una strada di contestazione di quel sistema, contestazione attenta alle regole della democrazia, sostenuta da una cultura politica riformatrice e dunque, all’interno di una isti-tuzione (in questo caso l’ente televisivo, ma si dovrebbe dire l’editoria in genere) capace di mediazione, ma radicale nello spirito e nei tra-guardi. Quando nel dibattito pubblico rimbalzò fra-gorosamente la proposta renziana del job act, Piero vide i pericoli e ancora si rivolse al sin-dacato: “Tutti i tentativi di erosione della de-mocrazia in Italia sono passati da un attacco al sindacato, negli anni Sessanta e Settanta con le bombe e lo spionaggio contro le lotte dei lavoratori, nei primi Ottanta con il craxismo e le marce antisindacali, nei Novanta con i tentativi berlusconiani di delegittimazione… Nell’attuale sfaldamento della sinistra il sin-dacato appare una delle poche (unica?) forze organizzate in grado di esprimere una dialet-tica. Finché dura”. Per questo non risparmiò fatiche anche nel “suo” sindacato, quello dei giornalisti, rivelando la sua vocazione e la sua intelligenza a ricercare tra le norme, tra le pro-cedure, nei contratti la garanzia dei diritti (fu tra coloro che scrissero lo statuto della Federa-zione nazionale della stampa), rinnovando la sua passione per la politica (fu tra i fondatori del Gruppo di Fiesole e di Nuova informazio-ne, quando la componente di sinistra, Rinno-vamento sindacale, sconfitta nel congresso del 1986, si sfaldò).Finché dura. C’è altro che nel pensiero e nella volontà di Piero Scaramucci dovrebbe durare: la memoria della Resistenza, della lotta di Li-berazione. Per poter ancora dare corpo a que-gli ideali, Scaramucci aveva aderito all’Anpi. Il 25 Aprile scorso, era stato invitato, oratore ufficiale, a celebrare quella data a Pavia. Ma il presidente della Provincia disse no, è una scelta troppo connotata politicamente, e il commis-sario prefettizio, che regge il comune, assecon-
bollettino di controinformazione democratica (BCD, con Giorgio Bocca, Guido Nozzoli, Marco Nozza, Morando Morandini). Accad-de persino che decine e decine di giornalisti, da tutta Italia, si fossero raccolti in assemblea per rivendicare l’autonomia della professione, la libertà di informare, e che avessero discusso per ore per tentare di rispondere a una doman-da centrale nella professione: come stringere il cerchio attorno al principio di obiettività? La via fu per alcuni una sostituzione: “onestà” al posto di “obiettività”. Rinunciando dunque all’ambizione di raccontare al lettore una veri-tà, invece presentando onestamente ciò che si sa, ciò che si è visto, ciò di cui si è testimoni, ciò di cui si dubita. Scriveva Marc Bloch: “Pri-ma ancora di fare il punto su ciò che ho ve-duto, è necessario che io dica con quali occhi l’ho veduto”. L’onestà è una virtù che non so-pravvive, se non vi sono certezza di autonomia e una carta chiara dei diritti e dei doveri. La discussione rivelò la maturità e la responsabili-tà di quel movimento. Poco è rimasto di quel-la consapevolezza, di quella cultura, di quella professione.In un articolo di otto anni fa (articolo che com-pare nel sito di Nuova Informazione, corrente sindacale dei giornalisti) Piero Scaramucci indi-cava alcune “questioni cruciali” di piena attualità anche oggi, questioni che riguardano in pieno il nostro sistema dei media: la pubblicità che guida le scelte editoriali, il precariato, il controllo po-litico, le clientele, i tentativi di delegittimazione del sindacato, il bisogno di etica. Concludeva rivolgendosi ai giovani, ai movimenti, ai gruppi minoritari, a quanti di fronte al degrado della politica e della cultura volevano e sapevano espri-mere nuove forme di opposizione e nuove voci critiche. Scriveva: “...questo nuovo antagonismo manifesta una dimensione etica, una necessità etica che è alla ricerca di una traduzione politica. Non è solo questione di pulizia, vi si intravvede qualcosa di assai più profondo e impegnativo. Questa dimensione etica allude a una società nel-la quale si è tutti più forti se non ci sono deboli”.Piero, che era stato un militante di Lotta con-
69
POCO DI BUON
OG
LI ASIN
I 69
Sono stati la vittoria di Trump e il Russia-gate sulle interferenze del Cremlino nelle ele-zioni americane del 2016, che hanno spinto il premio Oscar Alex Gibney a mettere il naso nel Paese che, durante la Guerra Fredda, fu l’incubo della sua nazione. Con Citizen K sulla saga dell’oligarca russo Mikhail Khodorkovsky, il documentarista americano ha cambiato solo apparentemente il suo bersaglio, ovvero i po-teri forti americani: indagando sull’oligarchia ventennale di Putin ha di fatto continuato ad avere un occhio a casa propria, visto il legame tra i due leader. “Americani e russi hanno un punto in comune: la fascinazione per gli uo-mini forti. La gente in Russia sa che Putin non si comporta correttamente, ma se ne disinte-ressa perché dà stabilità al Paese. In America è un po’ diverso: alcuni apprezzano Trump, per il suo lato truffaldino; piace il fatto che non abbia rispetto per la verità e che rappresenti la forza pura”, puntualizza il regista newyor-chese, classe 1953, che ha precedenti illustri in termini di anarchia e ribellione all’autoritari-smo nella famiglia originaria e allargata. È fi-glio, infatti, del giornalista e scrittore Frank, corrispondente del “Time” ed editorialista per “Life”- “Andiamo nella stessa direzione ma su media diversi”, precisa – ed è figliastro (parola orrenda) del pastore presbiteriano e pacifista William Sloane Coffin, uno dei leader del mo-vimento per i dritti civili americano, combat-tivo tra gli anni Sessanta e Settanta. Gli interessi di Gibney, che comprendono anche la musica (Jimi Hendrix and the Blues, 2001, Sinatra: All or Nothing at All, 2015), sono soprattutto abituati a tastare il polso alla de-mocrazia americana: Taxi to the dark side,
dò. Così cambiò l’oratore, ma Scaramucci non rimase a casa, pronunciò il suo discorso ai mi-crofoni di Radio popolare e anche i pavesi lo ascoltarono: “Sto nell’Anpi, uno degli ultimi baluardi dei diritti e della democrazia a partire dalla difesa della Costituzione. Ma l’Anpi non può sostituire la politica... Se il commissario prefettizio si è mosso da Podestà è segno dei tempi. Brutto segno... Che tanti pavesi si siano ribellati è un altro segno”. Lascio per ultimo il bellissimo libro che scrisse raccogliendo le parole di Licia Pinelli, la vedo-va di Giuseppe Pinelli, Una storia quasi soltan-to mia (Feltrinelli 2009), un libro che andreb-be conosciuto nelle scuole, bellissimo, su quei giorni bui, sul dolore nella solitudine di una moglie e delle sue figlie, sulla feroce ingiustizia di quel mondo impietoso nei confronti di chi non aveva potuto neppure difendersi da un’o-diosa accusa, da un’orchestrata calunnia, un libro sulla battaglia per la verità di una donna, che si trovò all’improvviso al centro e vittima di un intrico politico e terroristico. Libro che andrebbe letto magari insieme con le pagine dedicate alla notte in cui morì Pinelli, scritte da un’altra grande giornalista, mi pare dimen-ticata, Camilla Cederna. Per sapere qualcosa del nostro paese e della tragedia che ci colpì tutti e del suo lungo corso. Una storia qua-si soltanto mia dice molto di Piero, della sua passione civile, della sua sensibilità, di come si debba intendere il mestiere di giornalista. Ag-giungerei, per semplicità, del suo cuore.
L’ARTE DEL DOCUMENTARIO
DI ALEX GIBNEY INCONTRO CON CRISTINA BATTOCLETTI
70
GLI A
SINI 69
POCO DI BUON
O
bney, George Chignell e Erin Edeiken, ndr). “Mi ha molto impressionato la sua persona-lità: la sua epopea per me è stata un pretesto per comprendere la storia della Russia dopo la caduta dell’Unione Sovietica. Vi avevo messo piede per la prima volta nel 1972, viaggiando su un treno in cui si faceva propaganda comu-nista in inglese per noi stranieri. Oggi è un Pa-ese cambiato in maniera esponenziale: era più povero e molto più rigido”. L’intervista, su cui si impernia il documenta-rio, mostra il l’impenetrabilità di Khodorkov-sky: questione di carattere, ma anche di diffi-denza da parte di chi ha scontato dieci anni in una galera siberiana e si è visto, scontata la pena, sottoposto a un ulteriore processo in cui gli si contestava il furto del petrolio prodotto dalla sua compagnia. Non è un mistero il mo-tivo per cui gli altri oligarchi russi possono go-dere delle proprie ricchezze accumulate in un momento di vuoto legislativo: Khodorkovsky ha osato sfidare Putin e la risposta del premier è stata immediata e implacabile. Gibney attraverso materiale d’archivio mostra l’ascesa dell’ex agente del KGB, insediatosi ini-zialmente come “Presidente Provvisorio” con il placet di Yeltsin, divenuto man mano irre-movibile attraverso un controllo totale della stampa. Khodorkovsky ha scontato dieci anni di pena in una prigione a 6.700 chilometri da Mosca, vicino alla più grande miniera di uranio al confine tra Russia, Cina e Mongolia. Le sue attività petrolifere sono state requisite dallo Stato ed è stato sottoposto a due processi farsa. “Aveva il modo e il tempo di scappare, salvan-do all’estero il suo patrimonio. È un mistero il motivo per cui non sia scappato, potendolo fare. Ha detto di essere rimasto per proteggere i suoi dipendenti, ma io credo sia stato vitti-ma della propria arroganza. Non credeva che Putin avesse il potere o la volontà di mandarlo davvero in prigione e, se anche lo avesse fat-to, pensava sarebbe durata pochi mesi. Questi erano i suoi calcoli. Khodorkovsky è un duro. Vedeva arrestare pian piano i suoi collaboratori
sulla violazione dei diritti umani consentita dall’amministrazione Bush, ha vinto l’Oscar come miglior documentario nel 2007. Della stessa razza e qualità sono le inchieste sullo scandalo finanziario di Enron – Enron. L’eco-nomia della truffa (2005), su Chiesa e pedofilia (Mea Maxima Culpa: Silence in the House of God, 2013) e sulla new economy (The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley, 2019). “L’uso e l’abuso del potere è una mia ossessio-ne”, spiega Gibney, secondo cui per individua-re la polvere sotto il tappeto bisogna seguire il denaro. “Come ogni ragazzo della mia età ero molto affascinato da Marx ed Engels e ho ancora grandissima ammirazione per le analisi di Marx sul capitalismo. Un po’ di meno sulle sue idee prescrittive di attuazione”. Come aveva fatto per Ron Hubbard e Julian Assange, Gibney si approccia a Khodorkov-sky senza voler ritrarre un santino. Parte dalle origini umili dell’oligarca russo soffermandosi sulle tappe della scalata al potere e al capitale: da enfant prodige della finanza spregiudicata degli anni Novanta, e fondatore di una delle prime banche private in Russia, a magnate del petrolio, secondo un accordo sottobanco con altri oligarchi per spartirsi il bottino di una na-zione a pezzi. Dopo aver avuto il sostegno di Boris Eltsin al Cremlino, si è trovato a conflig-gere con Putin, sotto il cui governo, nel 2003, è stato condannato a dieci anni di carcere per frode ed evasione fiscale. Oggi vive a Londra in un esilio dorato, contando su un patrimonio di 500 milioni di dollari messi in salvo nono-stante la confisca in Russia dei suoi beni.“Mi interessa la sottile linea che separa chi usa il potere e chi ne abusa. Khodorkovsky rien-tra in entrambe le categorie. Capisce il potere molto bene e ha una grande abilità nell’analiz-zare le situazioni, ma è talmente determinato, che gli è capitato di perdere il senso del limite o del dovere che sarebbe necessario avere”. Il pretesto per il film è stato l’incontro con Khodorkovsky attraverso l’intermediazione di due dei produttori di Citizen K, John Battsek e P.J. van Sandwijk (gli altri sono lo stesso Gi-
71
POCO DI BUON
OG
LI ASIN
I 69
ve attivamente la democrazia e il rispetto dei diritti umani e comincia a essere rispettato in patria. “La gente provava risentimento per il modo in cui si è arricchito. Ha guadagnato il rispetto di molti russi per aver resistito a un arresto e a una detenzione arbitraria, dopo un processo assolutamente ridicolo. La gente ha capito che il problema non è Khodorkovsky, ma è il Cremlino”.Sia nel materiale d’archivio che nel corso dell’intervista a Gibney il magnate esibisce un sempiterno sorriso: “Non è un segno di empa-tia. Sorridere per lui può essere il sintomo di una genuina e deliziosa ironia; altre volte solo l’espressione di chi sta tentando di imbrogliar-ti o fiutando un affare”.In Citizen K. Gibney inserisce varie digressioni per rendere la parodia del potere. Racconta del tentativo di assassinare un agente doppiogio-chista con il gas nervino Novichok a Salisbury in Inghilterrra e di come gli esecutori, agenti del GRU (il servizio segreto militare russo), sorpresi dalle telecamere, abbiano sostenuto di essere turisti, venuti a vedere la cattedrale di Salisbury. Mostra il video di una canzoncina che corre in internet I want to marry Putin, un omaggio di San Valentino al leader, e lo stesso Putin, elettrizzato dalla presenza durante una cena di Goldie Hawn, canta Blueberry Hill. Recentemente qualcuno in Italia sosteneva di voler rompere con l’Europa per agganciarsi alla Russia e al rublo. Peccato che Gibney nelle maglie larghe del suo documentario non abbia infilato anche questo nanetto.
più stretti, ma si è sottoposto a una specie di prova di forza, di scontro ai vertici”. A muoversi per liberarlo è stata per prima la politica internazionale, minacciando di di-sertare le Olimpiadi di So i del 2014. Così il leader maximo russo ha dovuto concedere la grazia al suo acerrimo nemico, fornendo il destro per fare un martire di una figura non certo eroica. Gibney mostra lo spezzone di un’intervista, realizzata negli anni ’90, in cui Khodorkovsky affermava con orgoglio e vigore davanti alla telecamera di essere avido. “Kho-dorkovsky non conosce i codici del politically correct, ma credo che sia stato ragionevolmen-te onesto nel raccontarsi. Quello dopo il crollo dell’Unione Sovietica fu un momento storico folle, difficile e brutale per la Russia, che vive-va la transizione dal comunismo al capitalismo selvaggio. Khodorkovsky pensava che essere avido come Gordon Gekko, il protagonista di Wall Street, fosse una qualità. Non provava alcun senso di compassione verso i tanti con-nazionali che finivano in miseria, mentre lui si arricchiva. Solo nel periodo della detenzione ha avuto tempo di riflettere sul suo passato”. Gibney utilizza più volte la parola gan-gster. “Mi aiuta a sottolineare la spudorata alleanza tra i politici e gli oligarchi, che ap-profittarono del clima da far west, dovuto alle lacune legislative, per accumulare senza limiti, permettendosi uno stile di vita assai singo-lare. Gli uomini del servizio di sicurezza di Khodorkovsky, per esempio, erano dotati di kalašnikov come al tempo di Al Capone, sulla scia di un capitalismo che era e rimane bru-tale. La Russia di oggi è piuttosto lontana dal diventare un Paese democratico. Le elezioni sono state una farsa, la competizione elettorale una quinta teatrale. Fino a quando non ci sa-ranno stampa indipendente ed elezioni libere e il potere esecutivo non sarà soggetto a quello legislativo e giudiziario, non c’è modo di chia-marla democrazia”.Oggi dall’esilio Khodorkovsky organizza la dissidenza al regime di Putin finanziando “Open Russia”, una fondazione che promuo-
72
GLI A
SINI 69
POCO DI BUON
O
io che li scelgo; sono loro che scelgono me. Arrivano in un momento inaspettato, da una scintilla che, nel caso di Ovunque proteggimi, non riesco neppure a ricordare. Il punto è che loro sono parte di me e io di loro. Perfidia aveva un protagonista totalmente remissivo, timido e ingabbiato in sè stesso. Con Ovunque proteggimi ho voluto portare sullo schermo un personaggio che fosse totalmente all’opposto: l’apoteosi dell’impulsività. Io sono una perso-na timida e chiusa, ma anche molto impulsi-va. Quando costruisco dei personaggi parto da queste mie caratteristiche personali, le porto all’estremo. Trovo così il senso che mi porta ad andare avanti nella narrazione. Parto sempre dai personaggi e attorno a essi definisco l’azio-ne. Non faccio scaletta, non faccio soggetto. Comincio direttamente scrivendo una singola scena, tengo il fluire del racconto e poi a ritro-so costruisco una struttura. In fondo, il mo-vente del mio cinema è la paura. La mia pau-ra del mondo. Se non avessi avuto il cinema, probabilmente sarei stato una persona simile a quelle che racconto nei miei film. Non rie-sco ad accettare le contraddizioni del mondo. Vorrei scappare dal mondo e insieme lo vorrei prendere a calci. La fuga e la rivolta. Il cinema mi permette di fare entrambe le cose. In un certo senso è per me una terapia.
Che rapporto hai con la tradizione cinematogra-fica, non solo italiana?Credo che quando si fa cinema, così come quando si fa letteratura, il rapporto con la tra-dizione sia decisivo. Alessandro, il protagoni-sta di Ovunque proteggimi, è un musicista che canta brani della tradizione popolare sassarese. “Di questa musica non si interessa più nessu-no”, gli dice a un certo punto il suo anziano amico-manager. Anche a me dicono in tanti che il cinema che indaga in maniera autenti-ca sulla vita e sul mondo è destinato a spari-re. Non credo sia così. Non voglio crederlo. Ho sempre amato quel cinema, dovunque e da chiunque sia stato prodotto e girato. L’ho amato da quando ho ricordi lucidi. È come se
Alla fine, Ovunque proteggimi è un film sull’amore. Sull’amore cercato e, ancora di più, sull’amore negato. Dopo Perfidia (2014), Bo-nifacio Angius ritorna nelle sale con una prova convincente e matura. Una prova in cui alla solitudine e al dolore dei personaggi l’autore si avvicina come a una parte di sé. E come a un dato centrale della condizione umana. È attra-verso l’empatia con i suoi personaggi – sempre autentica, mai insincera – che Angius rovescia la marginalità (sociale) dei protagonisti dei suoi film in piena e assoluta centralità (uma-na); come succede nel cinema – o nella lettera-tura – che sempre è valsa la pena (e ancora vale la pena, anche se sempre di meno) di andare a vedere o di leggere.
In Ovunque proteggimi Alessandro è un cin-quantenne che vive nella periferia di una città di provincia di una regione d’Italia, la Sarde-gna, geograficamente e storicamente remota. Vive, si potrebbe dire, nell’isola di un’isola di un’isola. Incontra Francesca, una trentenne, nel reparto di psichiatria dove entrambi arri-vano portati dagli eventi drammatici di due esistenze difficili. Dimessi, fuggono in un lun-go viaggio attraverso la Sardegna alla ricerca di un bambino, il figlio che a Francesca è stato tolto dai servizi sociali. Ma cercano anche al-tro: un’accettazione affettiva e sociale che non hanno mai avuto.
L’impressione è che tu abbia lavorato sui perso-naggi più che sulla storia…Sì, effettivamente è così. Nei miei film lavoro soprattutto sui personaggi. E però non sono
UN CINEMACHE NARRA I MARGINALI
DI BONIFACIO ANGIUS
INCONTRO CON COSTANTINO COSSU
73
POCO DI BUON
OG
LI ASIN
I 69
ma non può essere per me”. Ma se invece vedi Una moglie di Cassavetes o Le notti di Cabiria, pensi che il cinema può essere per te; e che anche tu puoi essere per il cinema, puoi dire qualcosa con quel mezzo se quel mezzo può essere usato in quel modo. Congegni semplici ma straordinariamente efficaci. Questo sono il primo Fellini e Cassavetes. Fellini è diventato un’ossessione. Le notti di Cabiria sono per me un modello costante. La scena di Cabiria che va dalla Madonna e la implora: “Ti prego fam-mi cambiare vita”. Ecco quella è una scena che si ripete sottotraccia in tutti i miei film. Perché sono film su personaggi che vogliono cambiare vita. Personaggi che soffrono dentro una vita sbagliata. E io sento il loro dolore. Voler bene ai personaggi e raccontare qualcosa che ti è vi-cina, nella quale sei emotivamente coinvolto in maniera profonda: questo è ciò che mi in-teressa. Se racconti qualcosa di troppo lontano da te, il tuo film sarà povero, non trasmetterà nulla di veramente importante. Se ti metti die-tro la macchina da presa per inquadrare una scena e in quel momento non senti un acci-dente perché non ti importa niente della vita dei tuoi personaggi, il tuo film sarà una cosa inutile. Per te e per chi andrà a guardarlo.
Qualcuno ha accostato i tuoi film al cosiddetto “Cinema del reale”.Il cinema del reale è una modalità nuova, lega-ta anche al fatto che i costi di produzione sono molto alti e per farcela a produrre un film biso-gna ricorrere a tecniche di ripresa e a strutture organizzative semplici. Un nuovo modo di con-cepire la struttura di un film. Ma anche un nuo-vo modo di guardare al mondo. A me non inte-ressano, però, gli incasellamenti. La cosa che mi interessa è il grado di sincerità con cui io sento di fare il mio lavoro. Detesto, ad esempio, i film a tema, perché la focalizzazione sul tema ti por-ta lontano dall’elemento centrale, che per me è il personaggio, la persona e la sua vita spoglia. Quando leggo un romanzo di Dostoevskij non mi domando qual è il tema. Lo leggo seguen-do i personaggi. A distanza di anni mi ricordo i
lo avessi sempre amato. Mi ricordo una frase che a quattordici anni dissi a mia madre dopo aver visto, a casa, in vhs, Un uomo da marcia-piede di John Schlesinger. Dissi a mia madre: “Se uno nella vita riesce a fare un film così, dopo può anche morire”. Nei miei personaggi c’è molto del protagonista di quel film, di quel cowboy texano ingenuo e insieme rabbioso che affronta l’inferno di New York. Quel cinema lì sapeva essere insieme profondo e popolare. Ed è questa la strada che mi interessa. Quel cine-ma ha avuto, più che storie, personaggi stra-ordinari. Pensa a Jack Nicholson in Qualcuno volò sul nido del cuculo, o a Robert De Niro in Toro scatenato e in Taxi Driver. Ma lo stesso Silvester Stallone nel primo Rocky, quello del 1976, la rude purezza del personaggio, il suo cuore grande. Amo il cinema americano. So-prattutto quello degli anni Sessanta e Settanta. Sono nato nel 1982, quindi quel cinema l’ho conosciuto, da adolescente, non nelle sale ma con il vhs. Venivo da una famiglia che vedeva quel cinema lì. Erano film che un ragazzino poteva capire e amare. Poi, con il tempo, mi sono avvinato anche ad altri autori. Ad esem-pio, Luchino Visconti. Ludwig, per dire, è un capolavoro assoluto. L’avessimo, oggi in Italia, un autore capace di raccontare con lo stesso coraggio di Visconti l’universo borghese; di raccontarlo con la stessa brutalità e con la stes-sa sincerità. E poi la folgorazione per Fellini. Alla mia famiglia non piaceva Fellini. Io l’ho scoperto tardi. È vedendo La strada e Le notti di Cabiria che ho capito che non solo avrei vo-luto fare cinema, ma soprattutto che avrei po-tuto farlo. Cioè che c’era una strada al cinema, quella che vedevo meravigliosamente realizza-ta in quei due film, che poteva essere in qual-che modo anche la mia. E questa è una cosa che mi è servita molto. Così come mi è servito molto, per gli stessi motivi, vedere e studia-re i film di John Cassavetes. Provo a fare un esempio per spiegarmi. Prendi un autore come Sergio Leone, prendi C’era una volta l’Ameri-ca. Tu lo guardi… o almeno, io lo guardo… e penso: “Se il cinema è questa roba qui, il cine-
74
GLI A
SINI 69
POCO DI BUON
O
I protagonisti dei tuoi film sono dei marginali. Ma so che a te questo termine non piace…Siamo sicuri che i marginali siano poi davve-ro marginali quando uno si mette a fare un film o a scrivere un racconto? Ogni grande opera letteraria, ogni capolavoro del cinema parla sempre di personaggi ai margini. Barry Lyndon, ad esempio, non è un marginale? E il Mastroianni della Dolce vita, che non riesce a trovare il suo spazio nel mondo, non è an-che lui un marginale? E i vitelloni di “Otto e mezzo”, persi in un vuoto di significato tra-gico? In realtà, i cosiddetti marginali, sono i
sentimenti dei personaggi; dell’intreccio non mi ricordo quasi più niente. Allo stesso modo dete-sto le macchine narrative perfette ma vuote. Ad esempio, un film come I soliti sospetti di Bryan Singer è un thriller costruito, dal punto di vista narrativo, in maniera eccelsa, con tutti colpi di scena al momento giusto. Però poi i personaggi non esistono, e quindi è un film inesistente. Un cinema che non mi interessa per niente. Non parla delle persone. È solo costruito in maniera tale da essere sorprendente. Ma io non vado al cinema per sorprendermi. Io vado al cinema per sentire, per capire, per confrontarmi con una vi-sione del mondo e dell’essere umano.
75
POCO DI BUON
OG
LI ASIN
I 69
bene profondamente. Per esempio, prendi un regista che amo moltissimo, Ettore Scola. In quel capolavoro che è Una giornata particolare si sente che ama in maniera viscerale i perso-naggi sia di Mastroianni sia della Loren. E si sente che attraverso quei personaggi fa anche i conti con sè stesso. Vuoi invece un esempio di personaggi falsi e per di più di personaggi mar-ginali insopportabilmente falsi? Eccolo: quelli di Sporchi, brutti e cattivi.
Qualcuno ha definito il tuo film un road movie.Preferisco definirlo un film itinerante. La strut-tura del road movie è: io mi sposto e incontro un personaggio, poi mi sposto e ne incontro un altro, e così via. Si procede per accumulo. In Ovunque proteggimi, invece, più che apri-re ad altri orizzonti di rapporti il viaggio ser-ve per narrare la dinamica di avvicinamento-allontanamento fra Alessandro e Francesca, chiusi sino a quel momento nelle loro rispet-tive solitudini. È un film d’amore a più livelli. Amore tra madre e figlio; amore come ancora di salvezza per Alessandro e per Francesca, il “Ti prego, fammi cambiare vita” di Cabiria. Ed è un film di fuga. Si lega alla provincia, il tema della fuga, ma anche all’insularità, per-ché essere provinciali e insieme insulari è vero che raddoppia la penalizzazione e uno vorreb-be fuggire; ma raddoppia anche il vantaggio. Sono molto penalizzato perché sono provin-ciale e insulare, però, per esempio nel cinema, sono avvantaggiato, perché da una realtà lon-tana (in tanti sensi) ho la possibilità, che altri non hanno, di vedere il mondo intero. E di vederlo quasi fosse in scala. È perciò che fare cinema in Sardegna è una grande fortuna.
veri personaggi centrali, se si vuole fare cine-ma come io lo voglio fare. Sono loro il centro, perché è nelle loro vite che si aprono le feri-te, raccontando le quali si può capire qual-cosa del mondo e degli esseri umani. È chi li guarda dall’esterno con occhio falsamente pietoso che è per me il vero marginale. Chi, nel calduccio del suo salotto, osserva la vita sofferente di qualcuno per compiacersi del proprio buon cuore e mai ha camminato dav-vero per le strade del mondo e non sa e non conosce niente del dolore degli uomini, quel-lo è il vero emarginato. Cristiano Ronaldo, ad esempio, è un emarginato. Sembra essere al centro del mondo, ma in realtà non conosce niente del mondo. Leonardo Di Caprio è un emarginato: uno che ha sempre vissuto sotto i riflettori dello star system e non sa nulla delle sofferenze, della solitudine, del tradimento, dell’ingiustizia. Il cinema che a me interes-sa racconta non i marginali, ma gli uomini e le donne centrali nel loro spaesamento, nella loro sofferenza. E lo fa in maniera sincera.
I registi che si occupano di marginali hanno sem-pre uno sguardo sincero?Ce ne sono alcuni in cui avverto sincerità. Matteo Garrone, ad esempio. Ma non sempre è così. Senti parlare del mitico “pedinamento zavattiniano”. Ma quella cosa lì aveva senso quando c’era Zavattini, ora molto meno. Tutti quelli della generazione dei Zavattini o dei De Sica o dei Rossellini era gente che aveva vissuto la guerra, che conosceva per esperienza diretta la sofferenza e la povertà pur avendo un’estra-zione sociale borghese. Adesso il “pedinamento zavattiniano” che cosa vuol dire? Vuol dire for-se avere la pretesa di conoscere un determinato contesto sociale o una particolare condizione umana soltanto perché li si è osservati per qualche mese? Arrivo in Sardegna, vado in un villaggio di pescatori e dico “Oh guarda, che bel posto di merda… adesso ci faccio un film”. Se fai così, è ovvio che poi il tuo sguardo risul-terà insincero. Lo ripeto: quando racconti un personaggio, gli devi voler bene, gli devi voler
76
GLI A
SINI 69
POCO DI BUON
O
to, specie quello dei media: una Tarantinoland in cui i tempi e luoghi si squadernano davanti agli occhi, senza legame col tempo o con la real-tà. Con C’era una volta a… Hollywood richiama tutto il repertorio: gli spaghetti western e i piedi femminili, i lunghi dialoghi e il profluvio di cita-zioni. Da Sergio Leone ha imparato a costruire i film attraverso momenti forti, virtuosistici, come all’opera o nel musical e ormai il suo status gli permette di esibirsi con tutto comodo. È come se si mettesse in scena, si guardasse girare, e des-se soddisfazione agli appassionati perché parta la caccia ai riferimenti, e fiocchino le interpretazio-ni sulla rilettura della storia, le metafore del cine-ma e della visione (c’è un personaggio cieco, altri che si guardano sullo schermo, e pezzi di cinema vero e di cinema ricostruito che si intrecciano). L’accumulo di vinili, locandine, trailer, fumetti è un modernariato vintage soffocante e iterativo: si pensi, per contrasto, a come raccontava quei luoghi e quell’anno un film come Vizio di forma di Paul Thomas Anderson.Per lui la Storia sembra essere un’appendice della cultura pop, da essa generata. Il contesto non gli importa: è un paesaggio di pellicole ro-vinate, musiche pop, colori sgargianti o dilava-ti. La Hollywood che i personaggi di Tarantino attraversano è una specie di terra di nessuno: è finita l’epoca d’oro, non è ancora arrivata la ge-nerazione di Coppola o Spielberg, e i due pro-tagonisti si muovono orfani e smarriti. In loro evidentemente Tarantino si rispecchia: regista di successo mondiale, è però sempre legato al trau-ma del “dopo”. È rimasto un supercinefilo nerd che si è perso la grande festa della Hollywood classica, e prova a riportarla in vita. E la festa di tutte le feste è quella finale, il suo funerale ideale, il massacro. Del resto, la cinefilia è anche una forma di ne-crofilia, e per Tarantino, i cui film sono sempre danze macabre, questo è vero in modo parti-colare: un amore per le cose morte e dimenti-cate (specie se brutte), venerate anche nel loro deperimento e nel loro essere cascami reietti del passato. Quello che aveva da dire in questa dire-zione, però, Tarantino lo aveva detto con il suo
Il successo di pubblico e di critica di C’e-ra una volta…a Hollywood è per me un enigma. Un giocattolone piuttosto insulso, sontuosa-mente messo in scena ma prevedibile in ogni passaggio e in ogni gesto, diventa il film più del momento, quello che convoglia l’entusiasmo di più generazioni di pubblico colto e semicolto. È proprio l’entità di questi entusiasmi la cosa più interessante del film: in questi casi è la ricezione a illuminare il senso dell’operazione.Stavolta il regista è andato sul sicuro. Il western (Djando Unchained, Hateful Eights) è una terra pericolosa, un genere in disuso e senza fascino; il cinema sulla II guerra mondiale (Unglorius Ba-sterds) richiede una finezza di citazioni che Ta-rantino domina con maestria, ma che il pubbli-co ha gradito fino a un certo punto. Spostandosi nella Hollywood di fine anni Sessanta, Tarantino pone le premesse per soddisfare i fan senza spiaz-zarli mai, dando loro esattamente quello che si aspettano. È un luogo storico reso familiare da pubblicità e serie tv, su cui Tarantino si innesta senza scosse. Lo sfondo storico è la strage di Bel Air, in cui persero la vita Sharon Tate e i suoi invitati, nell’agosto del 1969, ma il film la prende di sbieco, raccontando una coppia di amici, l’at-tore Rick Dalton, vicino di casa della coppia Po-lanski/Tate e “cattivo” di mille film che non ha mai sfondato (DiCaprio), e la sua controfigura Cliff Boothe (Brad Pitt), i loro incontri e la loro estraneità a una Hollywood in crisi, tra telefilm western e trasferte in Europa, attrici bambine e produttori sopra le righe. Tarantino è l’ultimo regista-superstar, per alcu-ne generazioni anzi l’ultimo cinema americano possibile. La sua grande invenzione è però stata, paradossalmente, un nuovo ritmo dato al passa-
VERGOGNARSI GUARDANDO TARANTINO
DI EMILIANO MORREALE
77
POCO DI BUON
OG
LI ASIN
I 69
normale), pause e melanconie: è IL Cinema. Ta-rantino non rifarà più l’errore di dare ai suoi film un’anima (Jackie Brown, l’unica volta in cui ave-va ripreso il cinema del passato come qualcosa di carne e sangue) o di spingerli all’estremo della teoria, cioè alla contemplatio mortis (Grindhouse): rimane lì, astutamente a mezza strada, né serio né faceto.Divertente il film infatti non è, se fa ridere è sempre in maniera un po’ cinica e losca, perché la sua anima rimane nera, anche se Tarantino la nasconde. La malinconia del film riluce nono-stante tutto di qualche accento, e sono i momen-ti migliori. La successione di scenette scollegate è anche la rappresentazione narrativa di un’ago-nia, di un crepuscolo (il film, come l’ultimo di Eastwood, è girato in gran parte con la luce bas-sa del tardo pomeriggio). Prima dell’ultima sera del massacro, le luci dei cinema e di Hollywood che si accendono sono come la premessa di un Last Show, ma anche il miracolo di luci che si riaccendono solo per noi un’ultima volta (e a ri-accenderle sembra di sentire proprio la mano del regista). La salita finale dei protagonisti nella villa di Polanski è l’immagine di un’assunzione in un Olimpo notturno, in un Valhalla che è, con ogni evidenza, un regno delle ombre. La cosa che re-sta, alla fine, è proprio questo senso di morte, il tramonto di un mondo che non smette di finire, e di cui Tarantino assapora la fine sperando, con la bacchetta magica del suo cinema, di riportarlo in vita trasformato in perversa bellezza.O in qualcosa di pericolosamente simile. Lo aveva notato il miglior critico italiano della mia generazione, a proposito di Pulp Fiction: al cuore di Tarantino c’è anzitutto un desiderio di cool-ness. L’idea di trasformare in qualcosa di cool un passato privo di vita. Che, per essere cool, dev’es-sere appunto privo di vita, di storia. Deve essere, soprattutto, in partenza inferiore al regista e agli spettatori. È forse questo il vero piacere estetico oggi consentito senza inquietudine nel fruire i media: la paura davanti alla bellezza e alla me-moria impone di godere con ironia, anestetizzan-do il coinvolgimento che l’arte, popolare e non, rischia di portare con sé. Il segreto del successo
film più estremo e teorico, Grindhouse, non a caso un insuccesso. L’unico elemento di vita e di novità è, in C’era una volta… a Hollywood, una ritrovata attenzione agli attori, al senso della loro presenza scenica, anche se non sempre il ri-sultato è all’altezza dell’intuizione, e al massimo arriva a qualche gag simpatica ma dal fiato cor-to (la bambina che ripete i precetti dell’Actor’s studio). Anche perché, dall’altro lato, Tarantino rivendica la vuotezza fumettistica dei personag-gi, e i suoi attori scherzano, si prendono in giro, giocano di rimessa. La performance dell’attore fatto di carne e sangue è vista come qualcosa di quasi risibile, di cui il film fa, nella realtà dei fatti, tranquillamente a meno. Paradossalmente, Sharon Tate/Margot Robbie è il personaggio più intenso e autentico del film, perché il più vuoto, pura icona che si specchia in se stessa, come tor-nata dall’aldilà carica di doni sessuali.Gli episodi e siparietti del film dovrebbero dare l’idea di uno sperdimento, ma sono costruiti a freddo e a volte banali (una gag con Bruce Lee vista mille volte, però lunghissima e, beninte-so, in piano-sequenza); i dialoghi sorprenden-temente smorti, senza nemmeno il gusto della battuta memorabile dei primi film; il finale è uguale a quello di Unglorious Basterds, ma so-prattutto senza inventiva, come se l’avesse girato non Tarantino ma Robert Rodriguez. Una scena esemplare, forse la più estrema per la durata, è la ricostruzione, tra parodia e calco in scala 1:1, di un film western ostentatamente mediocre che è però, per l’attore interpretato da Di Caprio, un paradossale momento di riscatto. In scene come queste si vede al meglio l’ambiguità di Tarantino, che è anche il segreto del suo successo: il conti-nuo giocare tra ambizione smisurata e mancanza di serietà. Un doppio binario che gli consente di sfuggire a ogni obiezione: da un lato il suo atteg-giamento rimane di scherno, di divertissement. Dall’altro, non lo si può prendere solo come un gioco (in fondo anche Django Unchained era una versione diluita di Mezzogiorno e mezzo di fuoco, ma guai a dirlo), perché continuamente segnala marche d’autore, lentezze (ogni scena dura regolarmente il doppio di quel che sarebbe
78
GLI A
SINI 69
POCO DI BUON
O
giunge quello dell’ammicco, del club, del fan-dom, di un film fatto anche perché su Internet se ne possano reperire tutti i riferimenti segreti. Devo confessare di essermi vergognato ricono-scendomi, nerd cinefilo, come perfetto pubblico del film, di aver visto i film di Sam Wanamaker e di Giorgio Ferroni, i Tarzan con Ron Ely e i Matt Helm con Dean Martin. Mi sentivo come deve sentirsi un cliente di prostitute sulla tan-genziale, quando incrocia lo sguardo complice del magnaccia che gli fa intendere: “Noi ci ca-piamo, eh?”. Sì, Quentin, ci capiamo – pensavo con disagio –, ma non è mica tanto bello.Con formidabile istinto, Tarantino si situa dun-que al crocevia fra sensibilità, generazioni, ten-denze che sono al centro di alcune linee este-tiche fondamentali del nostro tempo. La sua operazione, che esibisce vistosamente la propria autorialità, è esattamente speculare al progetto delle serie tv, che invece elidono del tutto la di-mensione della messa in scena a favore di una centralità della narrazione. Entrambi, tra l’altro, impiantano un universo visivo riconoscibile e rassicurante, autonomo, un brand che funzio-na in maniera meccanica e può andare avanti all’infinito, e che viene potenziato oltretutto dal vintage (da Mad Men in poi essenziale a tantis-sima serialità americana). C’era una volta… a Hollywood accompagna il commiato dal cinema con la contemplazione del suo cadavere, anzi degli abiti che lo vestivano. Lo si può amare, di volta in volta, perché ci ricordiamo di quegli abi-ti, perché crediamo di poterli indossare a nostra volta, perché pensiamo che siano lì per noi, ci definiscano e ci diano un senso. In questo senso, Tarantino è davvero il regista più significativo del nostro tempo.P.S.: Questo articolo nasce da un’assenza. Guar-dando per la seconda volta il film mi chiedevo sempre più cosa ne avrebbe scritto un amico morto dieci anni fa, Vincenzo Buccheri, che su Tarantino ha lasciato pagine illuminanti. Que-ste scomposte riflessioni sono un tentativo di immaginare la sua recensione, che mi sarebbe piaciuto leggere, e che sarebbe stata ovviamente molto più ironica, lucida e tormentata.
di C’era una volta… a Hollywood è l’alleanza tra regista e pubblico ai danni dei personaggi: che salvano il mondo ma sono idioti, esibiti come tali, e meriterebbero di morire tutti (per cui il film potrebbe in realtà concludersi in qualunque modo). La verità è che gli eroi impliciti del film, i più cool di tutti, devono essere appunto il regi-sta e il suo pubblico.Qui si tocca la differenza tra l’apprezzamento del film da parte dei giovani e quello che gli ha tributato il pubblico di mezza età. Gli under 30 sembra identifichino semplicemente il cinema con Tarantino. È lui a traghettare la passione e il riuso, il canone, in qualcosa di riusabile. Essen-zialmente e giustamente colgono il lato ludico, ma non è escluso che nella sua visione trovino gli scampoli di un’emozione, una rigatteria da usa-re con libertà maggiore, come un punto di par-tenza e non d’arrivo. Il pubblico colto di mezza età invece trova l’apogeo di decenni di vintage, di riuso ironico di materiali, la consacrazione di forme estetiche e consumi culturali dominanti. Mi viene in mente un giovane scrittore che, una ventina d’anni fa, raccontava con entusiasmo di una nuova sensibilità di massa, fatta di rave in cui si ballavano le sigle televisive del passato mentre sugli schermi scorrevano immagini di telefilm anni Sessanta, tra manifesti d’epoca. Al che un amico più anziano, sconsolato, sbottò: “Tutti ci facciamo le seghe, Tiziano, ma non sia-mo convinti di star facendo la rivoluzione…” Tarantino non ci chiede di essere all’altezza di quello che vediamo, con la sensazione di ebbrez-za, divertimento, sorpresa, di quando si incontra qualcosa che spiazza e travolge; ma ci fa sentire a casa, tra povere cose rimesse in commercio, che abbiamo conosciuto o di cui abbiamo vissuto in maniera simile la fruizione (sigle, manifesti, ri-viste, film). Nell’innalzarle sullo schermo come icone, esibendone anche la ridicolaggine, il film ci rassicura e ci compiace; ci fa pensare che in fondo è la nostra vita redenta lì, che quella sia bellezza e che la nostra vita non ne sia, in fondo, priva. Lo spettatore ideale del film è perciò l’a-spirante cool, l’aspirante figo: il fighetto.Per lo spettatore cinefilo, a questi piaceri si ag-
79
POCO DI BUON
OG
LI ASIN
I 69
ancorato ai principi di legalità, senza mai ce-dere alla tentazione del giustizialismo e sempre profondamente attento al principio di ugua-glianza e alla giustizia sociale. Per vocazione politica, certamente, ma anche – forse soprat-tutto – religiosa. E fu grazie a questa, all’a-bitudine alla ricerca del cuore delle cose, che Mannuzzu esondò da tutti i ruoli che percorse. Come uomo della legge, seppe avere qualcosa di più della semplice nozione legale dei delitti e delle loro sanzioni e come uomo della politi-ca girò continuamente intorno alle necessità e alle aspirazioni della giustizia. “Ogni inchiesta, anche la più misera, è come una tragedia gre-ca”, scriveva in Il terzo suono e non c’è esergo migliore da tenere in mente per avvicinarsi alla militanza di Mannuzzu. Avendo sempre in so-spetto le denominazioni convenzionali – basta ascoltare uno dei suoi tanti interventi conser-vati su quella miniera di storia nazionale che è Radio Radicale – non prese mai la tessera del Pci. “Sono sempre stato nel sistema” diceva, “ma mai nel quadro. Se è esistita la disciplina di partito per me è esistita nella sua essenziali-tà”. Nel 76 fu tra i firmatari di una proposta di legge sulla tutela della maternità e sull’interru-zione della gravidanza, nel 77 fu tra i firmatari di un dl a tutela della libertà sessuale, ma nel ‘79, contrariamente alle posizioni del Pci, votò contro le leggi antiterrorismo e, da garantista, anni dopo continuò a rivendicare con forza quella sua opposizione. Negli anni Novanta, mentre in Italia imper-versavano le inchieste ai corrotti, i partiti en-travano in crisi, nasceva il mito del giudice-campione senza macchia nel ring nazionale, le richieste popolari di legalità si inabissavano in peana alla delazione e all’intercettazione, e l’aria di inquisizione avvelenava il sistema dell’informazione, Mannuzzu si tenne ben di-stante da entrambe le tifoserie che si andavano ingrossando. Estraneo ai due aspetti opposti e speculari della giustizia politica: quello dei giudici che mirano a sostituirsi alla politica e quello dei politici che pretendono di asservire la giustizia. Da subito Mannuzzu interven-
“È la sfumatura che discrimina ogni scelta politica. La rivoluzione che ti lascio.”
Tanto, forse tutto, è già stato detto sul Sal-vatore Mannuzzu scrittore e su quelle parole così inquiete e profonde che sono state la cifra della sua prosa e dei suoi versi. Eppure la figura di questo finissimo intellettuale, uno tra i più grandi del panorama italiano del 900, trascen-de la sua attività di scrittore.“Il fiato della gente addosso è la cosa più bella della politica”: Salvatore Mannuz-zu sintetizzava così la sua passione e la sua esperienza politica, dentro e fuori dalle isti-tuzioni. È da qui che ci piacerebbe parti-re per raccontare un altro angolo della sua vita, un altro aspetto di quello che è stato. Nessuna di noi due l’ha mai conosciuto e per entrambe rimane un cruccio, e cioè un tor-mento ma con un fondo leggero, che risponde meglio a chi ha saputo scrivere delle vite altrui conservando il “senso irreparabile dell’intru-sione” e quindi si spinge avanti, certo, ma con un pudore sorridente. Abbiamo imparato ad amarlo dalle pagine dei suoi libri e a volergli bene, a sentirlo profondamente affine, dai rac-conti dei suoi amici e sodali e dalla sua pagina Facebook, sulla quale, fino al 2017, ha conti-nuato ad annotare le sue piccole storie d’ogni giorno e però cariche di significati politici e religiosi.Fu deputato per tre legislature, Mannuzzu, nel decennio intenso e complicato che va dal 1976 al 1987, eletto come indipendente nelle file del Pci. E fu uomo tenacemente di sini-stra: approdato alla politica dopo ventun anni di carriera nella magistratura, fu saldamente
SALVATORE MANNUZZUTRA LETTERATURA
E POLITICADI MICHELA CALLEDA E FEDERICA GRAZIANI
80
GLI A
SINI 69
POCO DI BUON
O
prendere pubblica posizione contro le estre-mizzazioni di Piercamillo Davigo. Il 22 aprile del 2016 scriveva così: “Il magistrato Piercamil-lo Davigo sostiene anche delle cose giuste. Ma quando dice “i politici”, accusando la specie delle peggiori nequizie, sbaglia gravemente. E data la sua grande commestibilità fa del male, diseduca.”Si definiva “un vecchio gauchiste” e conside-rava la sinistra come opzione di cambiamento che si sostanzia nel principio di uguaglianza: quella meridionale era, in fin dei conti, una questione di uguaglianza tra Nord e Sud, quel-la femminile una questione di uguaglianza tra donne e uomini e di tutela delle differenze di genere perché, come diceva lui “le donne pos-sano essere se stesse e cioè differenti” ed era una questione di uguaglianza anche quella am-bientale, uguaglianza tra generazioni presen-ti, passate e future: “se il deterioramento del mondo prosegue nei termini che stiamo viven-do”, diceva nel 1989, “anche noi stessi domani saremo disuguali rispetto a noi stessi di oggi”.Nel 1987 si conclude la sua esperienza parla-mentare e nel 1988 Salvatore Mannuzzu cam-bia pelle un’altra volta: è l’anno durante il qua-le viene pubblicato Procedura, il suo primo e più fortunato romanzo. Ma senza gli anni da deputato, forse, non avremmo mai conosciuto il suo talento letterario. In Parlamento incon-trò e divenne amico di Natalia Ginzburg, gra-zie alla quale il libro arrivò all’editore Einaudi. Come lui stesso racconta in un’intervista alla rivista “Barta”, fu solo al termine della propria esperienza parlamentare che prese il coraggio di chiedere a Natalia Ginzburg di leggere i suoi romanzi. La Ginzburg ne rimase affascinata e, dopo una genesi travagliata il romanzo fu pub-blicato, aggiudicandosi il premio Viareggio nel 1989.La politica e la letteratura erano per Mannuz-zu due territori separati. Se in politica ci si “sente il mandato addosso” e il rapporto forte, vivo con le persone conduce a rispondere con responsabilità alle aspettative altrui, la lettera-tura è imprendibile, “la si sfiora”, ma rimane
ne per riorientare il discorso pubblico verso la posta in gioco più essenziale che l’impresa di Mani Pulite scoperchiava: la divisione dei poteri, vale a dire la sostanza della democrazia nel nostro Paese. La definizione cristallina dei rischi che si correvano nella stagione di indagi-ni del pool milanese – “la minaccia alla libertà della giurisdizione e all’indipendenza e all’au-tonomia dei magistrati”, governata dalla stessa logica insidiosa che gravava sul Parlamento, “che corre il pericolo di essere ridotto a mera stanza di registrazione di decisioni prese altro-ve” – in Mannuzzu sta insieme all’analisi della crisi di lungo corso di quei modelli di equilibri politici che sono stati la prima Repubblica e poi la seconda. E anche del consenso popolare intorno a Mani Pulite e dei meriti che larghis-sima parte dell’opinione pubblica le riconob-be – aver sconfitto quel sistema di potere “cui si dà il nome tout court di Tangentopoli, la parte per il tutto” – Mannuzzu evocò sempre le ragioni più di fondo. “Perché molti italiani, troppi nostri concittadini sono più propensi a chiedere quis custodiet custodes che a recitare l’apologo del mugnaio e dei giudici di Berli-no? Sarebbe spiegazione troppo incompleta ri-farsi a un’educazione civica che davvero è man-cata, e le responsabilità sono di tanti. Meglio indicare le basi materiali di questa omissione: la corruzione dell’assistenza come fenomeno di massa, la pioggia assistenziale irrazionale e improduttiva come pendant delle tangenti veri e proprie. Questa è stata Tangentopoli sicché adesso molti, troppi sono gli orfani dell’assi-stenzialismo ma molti, troppi sono anche gli orfani della fabbrica intesa anche come scuola di politica”. Ecco, per Mannuzzu la giustizia era tanto lontana dall’essere materia per soli addetti ai lavori quanto dall’essere tutelata esclusivamente dal gioco politico: nella par-tecipazione sociale, piuttosto, stava la garan-zia di effettività di quell’insieme di regole che possono “avvicinarsi il più possibile alla verità, senza ledere i diritti individuali”. Considerava fuorviante l’equazione tra politica e corruzio-ne e non esitò, già molto avanti negli anni, a
81
POCO DI BUON
OG
LI ASIN
I 69
ne della persona che comporta, per l’ammis-sione di pubblica impotenza e di incapacità a ristabilire i legami sociali, il suo discorso si in-tona sempre al tempo corrente e insieme risale ai valori più essenziali della nostra società. E a coloro fra i relatori di quello stesso tavolo che invocavano codici diversi per regolamentare le pene detentive, rispondeva: “L’ergastolo non è scritto solo in un codice di potenti e di sapien-ti, ma in codici che rappresentano la nostra società, l’ergastolo è scritto nell’anima colletti-va, è una responsabilità che non riguarda solo i potenti e i sapienti. Come non è un affare solo di poche centinaia di persone, coloro che espiano l’ergastolo, così non è un affare sol-tanto di governanti. È un connotato negativo del nostro tempo, dei suoi allarmi e della sua incapacità di fare fronte a essi”. Ma non c’è solo il basso continuo dei tempi lunghi, delle “trasformazioni molecolari nell’anima sociale”, pure necessarie, nelle parole di Mannuzzu. C’è anche il tempo breve della richiesta possibile e urgente di una legge parlamentare votata da tutti i rappresentanti delle forze politiche che faccia “saltare il tappo dell’ergastolo”. C’è il tempo, insomma, del richiamo a lasciare un segno nel codice che dimostri una volontà, che faccia “uscire dalla logica sconfinata della stru-mentalità, cui purtroppo troppe volte sembra ridursi la politica”.E la dimensione politica non smise mai di es-sere centrale nella sua vita. Non si iscrisse mai a nessun partito, l’abbiamo ricordato, ma fu capace di nostalgie commoventi nei confronti di quelli che lui stesso chiamava “i compagni del Pci”. Scriveva così su Facebook il 7 marzo del 2016, nel giorno del suo ottantaseiesimo compleanno: “Mi tocca telefonare ad Ama-zon, qualche volta. E mi rispondono col tu. E anche nelle lettere (e-mail) adoperano quella seconda persona. Appiattimento proprio dei nostri tempi grami, in cui le amicizie rischiano di non esserci; o comunque tendono a conta-re poco. Anche secondo Facebook i semplici partecipanti alle sue particolari corrisponden-ze vanno pomposamente, e sbrigativamente,
un “amore non corrisposto, perché se si ha il rapporto giusto, cioè se non la si adopera, ma si sta al suo servizio, allora la letteratura è qual-cosa che non si raggiunge mai nella sua inte-rezza”. L’uso della letteratura come strumento politico era impensabile per Mannuzzu e tanto più era contrario “alla sua beatificazione come dirigistica didattica civile”, convinto che “non si scrive per insegnare, oltre la forza specifica (quando c’è) del proprio racconto”, come di-ceva a Manuela Arca sull’“Unione sarda” del primo maggio 2016.Salvatore Mannuzzu era un mite, di quella mitezza che Norberto Bobbio aveva definito come la più “impolitica” tra le virtù ed è quasi un paradosso per un uomo con tante e tali con-vinzioni politiche: era pacato, misurato, deciso e capace. Non si abbandonava allo snobismo e si guardava dalle presunzioni. Basta riandare alla sua reazione al celebre giudizio di Eco, se-condo il quale i social avrebbero dato diritto di parola a legioni di imbecilli. Sempre a Manue-la Arca che gliene chiedeva conto diceva: “Li considero miei simili, confratelli. Non mi sen-to esente dai loro difetti ed estraneo alle loro maggioranze, perché dovrei provarne schifo?”. E da estraneo, anche a chi aveva convinzioni e ideologie ben distanti dalle sue, Mannuzzu non si comportò mai nel suo agire pubblico, inter-venendo insistentemente su quelle vicende so-ciali che erano “occasioni di dolore”, il carcere su tutte. Partecipando a un convegno sui limiti della pena detentiva organizzato da “Antigone” nel 1993, Mannuzzu dispiega i suoi argomen-ti giuridici contro il permanere dell’ergastolo nel nostro ordinamento legandoli in un canto puntuale con le qualità di “questo nostro tem-po”. E allora nell’indicare l’incostituzionalità della detenzione perpetua si chiede rispetto a quale Costituzione quella censura si sostanzi e qui è lo spunto per illustrare il rischio che quella censura si alleggerisca, in un tempo in cui non solo la Costituzione è delegittimata, ma “in senso più fondo, sono erosi i princi-pi, tutti i principi”. E così per la disumanità dell’ergastolo, per la reificazione e l’umiliazio-
82
GLI A
SINI 69
POCO DI BUON
O
austerità, che intendeva come nuova dimen-sione globale dei consumi, dei modi di produ-zione e di governo. “Mentre aumenta il rischio dell’ecosfera, mentre il mondo è sempre più devastato dalle disuguaglianze, non esiste ra-gionevole alternativa a un compromesso nuo-vo – storico nell’accezione più alta – per uno sviluppo sostenibile e un’equa distribuzione delle risorse mondiali. Solo così si può restitu-ire la politica ai suoi fini più veri”.Tanto, forse tutto, è già stato detto su Salvato-re Mannuzzu scrittore, sulle sue parole inquie-te e profonde. Tanto si continuerà a dire. Ep-pure la figura di questo finissimo intellettuale, di questo politico appassionato, di questo ri-goroso giurista appare oggi come un esempio necessario, un riferimento importante, un’ere-dità da guadagnare.
chiamati ‘amici’. Intendo resistere: a tutela ap-punto delle amicizie; che si costruiscono con un lungo lavoro di tutte le parti. Il tu io lo gradisco solo dagli amici veri (nel senso pro-prio e antico), dagli ex colleghi e da tutti i miei vecchi compagni del Pci (rimasti coerenti). – I quali ultimi mi danno un dispiacere se mi trattano col lei; ma ancora di più mi rincre-sce se – poco fisionomista da sempre e ora, in più, sventiato – io non li riconosco. Li prego: quando ci incontriamo si facciano vivi ai miei ricordi, innanzi tutto col tu.”Mannuzzu credeva profondamente nella poli-tica come dimensione collettiva e l’affetto per quella storia, per quella gente, per quei “com-pagni del Pci” rimase in lui sempre forte e pre-sente. Era convinto che il lascito più impor-tante di Berlinguer fosse proprio la controversa
83
GLI A
SINI 69
trasforma, nasce e inizia a trasmettere Cana-le 96, radio militante, “voce libera di Milano” definizione che confinava con “stazioni pirata” termine mutuato dai grandi giornali dalle ra-dio off shore britanniche, o radio “clandestina” che evocava uno spirito eversivo. Sul “Quotidiano dei lavoratori” apparve un avviso breve, mi pare recitasse così: “Canale 96, chi vuole collaborare telefoni al …”. Sem-plice. Telefonai e il sabato dopo mi trovai in un monolocale in via Mac Mahon a “mettere su i dischi” e a leggere le notizie, assieme a un compagno della Comasina che si era appena diplomato con me all’Istituto Zappa. Le tra-smissioni chiudevano a tarda sera con l’Inter-nazionale, ovviamente. Ci pensarono i carabi-nieri, con l’aiuto di un elicottero per “scoprire” l’antenna, dopo un paio di settimane a chiude-re la radio, a sequestrare le attrezzature perché la procura sosteneva che “la radio è un’emit-tente privata clandestina e come tale abusiva”. Di più: i carabinieri erano convinti che Canale 96 fosse una sede delle Brigate Rosse. Fu una grande operazione di marketing per noi, un’e-norme pubblicità. A dicembre la radio riaprì, pochi mesi dopo ci trasferimmo all’ex hotel Siviglia, in largo Richini, uno stabile occupato che era stato uno storico albergo per le com-
A volte è necessario fermarsi e volgere lo sguardo all’indietro. La scomparsa di Piero Scaramucci mi ha fatto tornare alla mente una Milano lontana nel tempo, per me comunque formidabile, gli anni Settanta, un giornalismo morale (anche se oggi può apparire un ossimo-ro), un’informazione civile e di battaglia politi-ca, mi ha ricordato l’impegno di molti per dare voce agli altri, a chi non poteva parlare. Questa storia inizia nel 1975 in Zona Sem-pione, area industriale e popolare, dove si mi-schiano una forte presenza operaia con una vecchia borghesia nascosta nei suoi lussuosi palazzi irritata dalle rivolte di giovani e lavo-ratori, timorosa di perdere i privilegi di un tempo. In una vertenza contro tagli e ristrut-turazioni gli operai e i tecnici della Elettronvi-deo, piccola fabbrica di elettronica, mettono in campo uno strumento inedito di battaglia: una radio, una radio di lotta che trasmette nel quartiere. Dall’etere arrivano i bollettini delle vertenze delle fabbriche della zona, si crea un circuito di voci, di raccolta di fondi, di solida-rietà e anche di emulazione. La radio diventa subito una novità politica, con l’intervento della Cooperativa culturale Sempione e la par-tecipazione di militanti della sinistra estrema. Nell’ottobre 1975 l’esperienza del Sempione si
STORIE
QUELLE RADIO DEGLI ANNI SETTANTADI RINALDO GIANOLA
84
GLI A
SINI 69
STORIE
di Stato, su Pino Pinelli, sulle trame nere.La parola chiave di quegli anni era Controin-formazione, ma presto non ci bastò: non era sufficiente criticare e contestare l’informazione ufficiale, l’aspirazione era di fare Informazio-ne con “I” maiuscola in diretta competizione con le strutture, il linguaggio, il potere dell’e-ditoria padronale. Il testo di riferimento era un saggio di Pio Baldelli, Informazione e controin-formazione edito da Mazzotta che ci avvertiva: “I mass-media sono un’arma micidiale nelle mani della classe dominante contro la quale si può combattere solo conoscendone a fondo i meccanismi e le tecniche”. La radio, allora, era una potenza, coglieva lo spirito di un Paese malmesso e arrabbiato, dava voce a tanti esclu-si. D’altra parte non era stata forse una radio, Radio Renascença nel 1974 a dare il via alla Rivoluzione dei Garofani Rossi in Portogallo? Fu una bella stagione, anche vista dopo tan-ti anni, con limiti ed errori, dilettantismo ed estremismo, ma piena di cambiamenti posi-tivi. Si formò una generazione di giornalisti, manager della comunicazione, operatori cul-turali, organizzatori di concerti, docenti, criti-ci, artisti…. poi, in molti casi, conquistati dal sistema, quello vero, più grande e potente. Col passare del tempo, come a volte accade, anche le grandi novità, le profonde rotture sociali, politiche e culturali perdono vigore, sono as-sorbite, ricondotte in parte o del tutto nell’al-veo degli interessi di casta e della convenienza personale, della carriera, degli umani opportu-nismi. D’altra parte niente più del giornalismo espone ai rischi di una caduta nel narcisismo, se non di peggio.
pagnie teatrali e poi una casa d’appuntamenti. Intanto nel Paese c’era stata una moltiplicazio-ne di radio libere, erano nate oltre 100 stazioni che avevano iniziato a trasmettere, a rompere il monopolio Rai, a esercitare il diritto costi-tuzionale di informare. Sentenze di pretori e magistrati alternavano vittorie e stop alla ri-voluzione in FM, ma la strada per la libertà dell’etere era aperta, davvero come un segno dei tempi. All’inizio fu una scossa terribile per il mondo paludato dell’informazione, per il regime della Rai lottizzata, per politici, editori, industriali. I più svegli tra i padroni si misero subito a oc-cupare frequenze e a lanciare radio commer-ciali producendo ascolti e profitti che durano fino ai nostri giorni. Le radio “ribelli” rappre-sentavano una ventata di novità, centinaia di neofiti del giornalismo che nulla sapevano di informazione fecero scuola, e che scuola, una specie di autoformazione provata sul campo. L’unico, uno dei pochi che ci capiva e aveva delle idee sagge, era Scaramucci che animava Radio Popolare. In quella congiuntura politi-ca, nel ’75 e nel ’76 il Pci conquista le grandi città e contende alla Dc il primato elettorale nel Paese, le radio furono un grande elemento di cambiamento. Umberto Eco venne in via Mac Mahon a parlare di “guerriglia semio-logica” mentre la palude dell’”informazione borghese” era scossa dalle dirette via etere degli scioperi operai, degli scontri alla “pri-ma” della Scala, delle assemblee studente-sche. Usavamo i gettoni e le cabine della Sip, niente cellulari, web o digitale. Ma era un bel giornalismo. Umile, trasparente, certamente ingenuo, ma incisivo e politico. C’era quasi una naturale, spontanea vocazione a raccon-tare i fatti, a raccogliere le voci, a diffondere culture ed esperienze, anche quelle trascurate o fino a quel tempo ghettizzate, le donne e gli omosessuali, c’era un profondo desiderio di verità, l’impegno di denuncia delle bugie del potere, dei poteri, perché nel nostro Dna c’era la scoperta della menzogna sulla Strage
85
STORIEG
LI ASIN
I 69
Continuiamo cercando. C’è chi suggerisce dal-mar, l’attraversare i paesi, ma anche badmar, attraversare il mare. Figura simbolo dell’avven-turiero per il somalo era il siman dall’inglese seaman, uomo di mare. Durante la seconda guerra mondiale sulle navi da guerra inglesi nel golfo di Aden, molti so-mali si arruolavano come marinai. Qualcuno tornava, qualcuno non tornava mai più. C’è un libro uscito di recente, intitolato Akui di Fatima Ahmed, è un meraviglioso racconto in prima persona dalla figlia di un seaman somalo, vissuto in Cambogia per 30 anni, sposato con una indo vetnamita, e tornato in Somalia negli anni 70 in fuga dalla guerra civile cambogiana.A proposito dei seaman Abdulkadir, che in Somalia faceva il pescatore, dice che i seaman non erano dei veri e propri avventurieri come lo sono i pescatori, perché a bordo delle grosse navi non c’è bisogno di conoscere il mare e i rischi che si corrono navigandolo. Ci riporta quindi all’idea dell’avventura come pericolo. Nabad aad filaneysid nahdin ma laha: è un pro-verbio citato da Farhaan. L’ho tradotto: mentre cerchi la pace non senti paura, non avverti il pericolo. Sono la speranza e la ricerca di pascoli migliori, la spinta prima all’avventura?Abubakar racconta che dopo aver attraversato il mare, dopo la sua avventura sognava di ripo-sarsi, di “prendere una pausa da questa enorme stanchezza”. A volte è più difficile convivere con la pace che con l’avventura.Per qualcuno anche attraversare la città è un’av-ventura. Per chi non conosce la lingua e ha paura dei controlli continui, Roma si presen-ta piena di incognite. In questo caso, le paro-le sono una guida sicura. Ecco un omaggio di
LE PAROLE INTRADUCIBILIDI CRISTINA ALI FARAH
PremessaLe pagine che seguono, sono lo script di cinque puntate, andate in onda nella primavera 2009 sulla rubrica Dizionario del programma radiofonico Fahrenheit. Settimanalmente, a un autore veniva chiesto di scegliere per cinque giorni una parola, seguendo un personale cri-terio, con la massima libertà. In quel periodo lavoravo a un progetto sulla memoria con un gruppo di giovani rifugiati somali che frequen-tavano la scuola di italiano Asinitas a Roma. Poiché spesso ci capitava di discutere a propo-sito della difficoltà di tradurre parole e concetti nelle due lingue, somalo e italiano, la propo-sta di Fahrenheit mi sembrò alquanto gravida di possibilità. Proposi il progetto ai ragazzi e ai loro insegnanti e lo accolsero con entusia-smo. Si trattò di incontri piuttosto informali, nel corso dei quali ogni stimolo nasceva da una parola e in qualche modo dall’impossibilità di tradurla. Trovavamo termini che la sfioravano, che spesso ci portavano in dimensioni che non prevedevamo. Questa è dunque la storia di un’associazione di idee partita da una parola.
Primo giornoLa nostra parola di oggi è avventura. Avventura è: vicenda singolare e straordinaria, caso inaspettato. Impresa rischiosa ma attraen-te per ciò che vi si prospetta di ignoto e vi si vive di fuori dal comune.Pare non esistere un termine corrispondente in somalo. Sul dizionario troviamo sursuur. Sur-suur baan galay significa ho corso un pericolo. Il pericolo è quindi un elemento connaturato all’avventura?
86
GLI A
SINI 69
STORIE
chiede di insegnargli l’arte della magia. Come posso imparare l’arte della magia? In questo giardino c’è il tuo posto, gli risponde, hai una notte per trovarlo. Quella notte per me è la fortuna, è il destino. Allora io mi chiedo: poi-ché molti di quelli che ci hanno preceduto non ci sono riusciti troveremo il nostro po-sto? Avremo la nostra notte, la nostra fortu-na?” Mi viene subito in mente una bellissima poesia di Gezim Hajdari, poeta premio Montale:“Partiamo di notte/dimenticando che siamo ciechi/ per raggiungere un territorio nudo/ del quale ha bisogno la nostra voce/ andiamo al mare per parlare/ e lanciare sassi contro il vento”.Marco Carsetti, maestro della scuola, cita l’e-spressione prendere un abbaglio. Quando si è abbagliati lo sguardo è offuscato, incapace di vedere chiaramente. Subito ai ragazzi viene in mente il miraggio. Tra i modi di dire miraggio, oltre a wirwir, c’è la parola dhaan dabagaalle, dhaan è il percorso per prendere l’acqua e dabagalle è lo scoiatto-lo. Il miraggio è la strada che fa lo scoiattolo per andare a prendere l’acqua. Da una parte rappresenta l’assurdo, ma Hassan dice che tra gli animali lo scoiattolo è l’unico che va in giro quando c’è molto caldo, dharaar si dice, quando il sole è alto, durante le ore roventi del giorno.Partendo dalla parola dharaar gli studenti spie-gano che ci sono tantissimi termini in lingua somala legati alla luce e alla sua intensità: barqo per indicare le prime ore del giorno, quando il sole è tiepido, cadceed la luce del sole quando tramonta e la più bella di tutte.Le parole sono come cristalli, hanno bisogno di un ambiente favorevole per formarsi. In Somalia la luce ha colori talmente diversi nel corso della giornata e delle stagioni che esistono tantissi-me parole per definirla. Queste parole segnano anche la divisione del tempo, della giornata, in modo diverso da come la pensiamo qui, in Eu-ropa. In una riflessione sull’alba e sul tramonto Abubakar ha scritto un bellissimo testo:
Geddi alla sua insegnante. Macalimadda waa Kiara maadada ay qoreyso mid mid aan ka qaatan ku mara magaalada.La maestra Chiara, le parole che scrive, ne ho prese alcune e ci attraverso la città. Infine, una citazione da L’ambigua avventura, romanzo scritto negli anni 50 da Cheikh Ami-dou Kane. Samba Diallo, l’eroe del romanzo dice: “Si dà il caso che alla fine del nostro viaggio noi siamo catturati, vinti dalla nostra stessa av-ventura. Ci rendiamo conto, d’un tratto, che lungo il cammino, una continua metamorfosi è avvenuta in noi, e siamo diventati degli altri. Talvolta la metamorfosi non si compie del tut-to, ci ferma nell’ibrido e così ci lascia. Allora ci nascondiamo, pieni di vergogna”.È il destino degli eroi quello di essere apripista, pegno di salvezza per una collettività. Vi lascio con un’ultima parola, sahan. Significa andare in avanscoperta, cercare buoni pascoli per il gruppo.
Secondo giornoLa parola che abbiamo scelto oggi assieme ai maestri e agli studenti della scuola di italiano Asinitas è abbagliare: offuscare la vista per una luce troppo intensa. Dal latino volgare adva-riare legato alla varietà dei colori. Esiste una traduzione di questa parola in somalo, cawir, “succede quando il sole è troppo forte e devi coprirti gli occhi” dice Xawa. “Cawirran si dice anche a colui che non vede”, aggiunge Yusuf, “al cieco”. A proposito del non vedere, di avere lo sguardo impedito, Farhan cita un proverbio:Meel il laga la’yahay il aa la istiraa, quando si arri-va in un paese di guerci, ci si cancella un occhio. “Non tutti abbiamo le stesse aspettative” conti-nua Farhaan “Quello che voglio dire è che poiché il caso ci ha portati qui, dobbiamo entrare a far parte di questa vita, di questa comunità”.E continua: “in una lezione che abbiamo se-guito qualche giorno fa, c’è la storia di uno studente che va da un mu’allim famoso e gli
87
STORIEG
LI ASIN
I 69
studenti della scuola di italiano Asinitas, ma in realtà è di una storia collettiva che sto parlan-do, una storia in cui c’entra l’Italia. Come tutti quelli nati fuori dalle grandi città, mio padre conosce bene il lessico dei nomadi.Nella cultura orale la memoria è considerata una grandissima virtù e per questo incoraggiata e sostenuta con varie strategie, per esempio con la luuq, la tonalità del canto, vengono enuncia-ti i versi. Luuq diversa da luuqad che significa lingua parlata sia in somalo che in arabo. Gli studenti di Asinitas, che non hanno rice-vuto una vera e propria educazione scolastica, sono quelli che ricordano più canti, detti e po-esie e ci ricamano continuamente la propria voce. Questa vena giocosa e incredibilmente creativa per esempio gli uomini istruiti come mio padre, l’hanno persa. Da piccolo lo chia-mavano Af Dabeyl mi ha raccontato una volta mia zia, bocca di vento, o forse lingua di vento, perché alla dugsi, la scuola di Corano, era uno di quelli che avevano più memoria. A questa lingua arcaica, rituale, saporosa, si aggiunga la sua profonda conoscenza dell’italiano. Non per esaltarlo, ce ne sono molti come lui di diversa o identica generazione. Quello che voglio dire è che esiste un vocabo-lario somalo-italiano per un motivo. Quegli esperti che negli anni settanta hanno lavorato al dizionario somalo italiano, sono gli stessi che hanno messo per iscritto il somalo, lingua fino a quel momento di tradizione orale. Un grup-po di esperti somalo italiani. Cosa importava agli italiani di una delle tante lingue africane parlata nel continente? A questo dobbiamo cer-care una risposta insieme.Gli scontri degli ultimi tempi hanno riversato su queste coste tantissimi somali. Molti cerca-no di tentare la sorte e di andare nei paesi del nord Europa in cui i richiedenti asilo ricevo-no un trattamento migliore. Ormai la voce si è diffusa e sanno che poiché hanno lasciato qui le loro impronte, è questo l’unico paese in cui possono cercare di rimanere. Chi sarà il ponte linguistico di queste persone, cosa ne è dei somali delle generazioni preceden-
“Io ringrazio Dio quando è il momento dell’al-ba e prego una preghiera della religione musul-mana che si chiama “l’alba”. Questa preghiera è per ringraziare Dio e dice: “il tempo per dormire è un piccolo morire” e dico grazie a Dio che mi fa ancora vivere dopo un piccolo morire. Perché ci sono tante persone che hanno dormito ma non riescono a rialzarsi un’altra volta. Al tramonto prego una preghiera che si chiama “il tramonto” per ringraziare Dio che mi ha lasciato ancora vivere perché ci sono tante persone che si sono svegliate ma non pos-sono ritornare alla loro casa per colpa di una cosa come un incidente e loro non se lo aspet-tavano e forse pensavano di fare tante cose ma la loro vita è già finita”.Chiudo con alcuni versi di una canzone di Jor-ge Palma, Eternamente tu, citati in epigrafe nel libro Aurore della notte di Ondjaki: “il tempo non sa niente/il tempo non ha ragio-ne/il tempo non è mai esistito/il tempo è una nostra invenzione... amore mio/il tempo siamo noi”.
Terzo giornoCome in italiano lingua è sia l’organo di fona-zione che il linguaggio vero e proprio così è per il somalo af, bocca e linguaggio.Farhaan e molti altri ragazzi del corso hanno più volte ribadito: “La prima difficoltà che si incontra arrivando qui è quella della lingua. Siamo come un bambino appena nato e un bambino appena nato ha bisogno di diverse cose per crescere e per questo occorre tempo”. Diversi anni fa stavo cercando di tradurre una ninna nanna tradizionale e mi mancava una parola. Questa parola sarà il tema di domani. Come sempre in questi casi ho chiamato mio padre in Inghilterra e gli ho cantato i versi che non avevo capito. È meraviglioso vedere la sua reazione in questi casi, potrei decidere di passa-re le mie giornate a cercare espressioni per me incomprensibili solo per sentire nella sua voce, quella specie di orgoglio che raramente ritro-va nel corso delle sue giornate. Sto parlando di mio padre e in questi giorni ho parlato degli
88
GLI A
SINI 69
STORIE
di grave calamità, quando si è obbligati, perché partire di pomeriggio, in mezzo alla giornata, significa lasciare molte cose in sospeso. È molto emozionante sentire il racconto dei ragazzi sul momento in cui hanno preso la de-cisione di partire. È qualcosa alla quale con-tinuano a pensare nel corso degli anni, come una ossessione, quasi nessuno parla di un’u-nica causa, forse una goccia che fa traboccare il vaso c’è, ma alla fine decidere di separarsi dalla propria casa è molto difficile, è come una sconfitta. Andarsene spesso è qualcosa di repentino.Uno dei giovani che frequentano il corso di italiano, si chiama Farhaan e l’ho nominato diverse volte in questi giorni. Il suo racconto è forse quello che ci colpisce di più, per le ri-petute partenze, il suo è un pellegrinaggio da un paese all’altro, prima verso lo Yemen, poi verso il Sudafrica e infine verso l’Italia. Tra queste destinazioni lui torna sempre a casa. È come se il suo partire nascesse sempre conte-nuto dal desiderio del ritorno. La prima volta parte di pomeriggio: ha solo 15 anni e lascia la sua città Beletweyne, per salvarsi dagli scon-tri. Corre, corre per 60 chilometri dice. Corre per 23 ore di seguito, poco meno di un giorno intero. Rimane in sospeso: qualche giorno dopo la guerra lo raggiunge anche nel paese in cui si è rifugiato. Per salvarsi si tuffa nel fiume e passa dall’altra parte. Alcune persone lo seguono, ma non ce la fanno e rimangono intrappolate nel fiume.La grande causa per cui si parte è nominata solo a tratti, quasi uno scongiuro, è la guerra civile, dalgalka sokeeye si dice in somalo. Lo scrittore Nuruddin Farah nel suo romanzo Legami, così spiega, il significato di questa espressione: “Dagaalka sokeeye” […]Dentro di sé, Jeebleh non riusciva a decidere come tradurre quella espressione somala: alla fine preferì il concetto di “uccidere un intimo” a quello di “fare la guerra a un intimo”. È molto interessante questa idea dell’intimità, insita nella violenza. Forse è anche questa la ra-
ti, degli intellettuali sparpagliati per il mondo che conoscono l’italiano come lingua propria, lingua in cui si sono formati? Stanno princi-palmente in Inghilterra, Canada, Olanda, Stati Uniti come rifugiati politici. L’anno scorso ero a Londra e stavo passeggian-do con mio padre e alcuni suoi amici. Mi sono resa conto che quando c’erano nei dintorni degli italiani (e a Londra ce ne sono parecchi) tutti loro alzavano inavvertitamente il tono della voce. Era inconsapevole, ma sembrava volessero lanciare un messaggio. In Inghilterra loro sono rifugiati comuni. Ma ecco, la lingua che hanno studiato da piccoli, la cultura che conoscono e che in qualche modo ammirano (perché è sempre questo il sentimento del co-lonizzato, di amore e d’odio nel confronti del dominatore) è l’italiano.Domenica stavo parlando con un’amica, Zahra Osman che sta lavorando a Bari come media-trice linguistica. “Noi che siamo qui e assistia-mo a questa nuova ondata”, ha detto, “dobbia-mo prepararci a tirare fuori qualcosa di buono da questa lingua e dal suo legame con l’italiano. Una lingua significa troppe cose”. Xawa una delle studentesse della scuola, mi ha raccontato una cosa strana oggi. Ha sentito la figlia rimasta a Mogadiscio al telefono e le ha detto che essere senza madre significa essere una testa a cui è stata tolta lingua. Cosa vale una testa senza lingua? Chiudo con i versi di una poesia di Grace Nichols tradotta da Paola Splendore nell’an-tologia Passaggi a ovest edita da Palomar, che cito:”Ho attraversato un oceano/ la mia lingua s’è perduta/ dalla vecchia radice/una nuova ne è spuntata”.
Quarto giornoIeri vi ho parlato di una ninna nanna al telefo-no e di una parola che non riuscivo a tradurre. La ninna nanna è così: Hobey hobeeyaa/Ya hobey hobeyaa/ e la parola mancante da cui sono rimasta affa-scinata è carrabay che significa partire nel po-meriggio. Si parte nel pomeriggio solo in caso
89
STORIEG
LI ASIN
I 69
sando a tutti i libri, ai disegni, ai diari, persino agli abiti che avevo amato. Una specie di lutto celebrato per una frazione di secondo. Mi fa im-pressione ora, perché come risultato di quella esperienza sono esageratamente disaffezionata, distaccata dagli oggetti. In Somalia in questi diciotto anni tutto ha fun-zionato, secondo Abubakar, quello che man-ca è l’istituzione. Vigeva questo motto dice Farhaan: ku qabso ku qadimeysid, occupa e non rimarrai a mani vuote (non rimarrai digiuno).Lo dice a proposito della casa in cui viveva nella città di Beledweyn improvvisamente rivendica-ta da altri proprietari. Avevano addirittura as-soldato dei mercenari per dissuadere eventuali testimoni. “Puoi cambiare casa”, dice Hassan, “ma è diffi-cile trasferire la tua home”. Eppure i somali sono tradizionalmente noma-di, caricano la casa sul cammello per muoversi verso pascoli più grassi. Sangub, poeta e drammaturgo somalo scrive: Durante il trasloco notturno, ci sono grida, ci sono urla, le anfore per l’acqua sono imballate male, come è calda la situazione, come è buio il tempo in cui mi sono svegliato!Hassan dice che il centro d’accoglienza in cui vive ora, è il luogo dove mangia e dorme, ma non è una vera e propria casa. “Posso dire che sento molto più come casa mia la scuola” ag-giunge. A scuola niidda aa laguu dhisaa, ti incoraggiano, ti motivano, letteralmente: ti costruiscono l’animo. Mi piace molto questa espressione, costruire l’animo. È forse l’animo la nostra dimora prima, il luo-go in cui dobbiamo imparare a convivere con noi stessi?Non è facile dormire in camerate in cui i malati sono mescolati ai sani, gli assassini agli onesti, come ripete più volte Abdulkaadir. O dormire in una stanza in mezzo a una radio e a un tele-visore perennemente accesi. “Noi abbiamo già parlato con l’ufficio numero 43, che circa la socialità del centro non ha mai fatto niente” scrive Farhaan.A proposito di socialità, un tema che ricorre
gione del pudore, del motivo per cui raramente i ragazzi usano questa espressione. Non dicono guerra civile, ma burbur, che si-gnifica frantumazione. Mentre ero in mezzo a quella frantumazione, ho deciso di entrare nel viaggio.Ma prima di entrare nel viaggio, fanno vari tentativi. Devono avere una forza titanica per entrare nel viaggio. E chi ha quella forza le pro-va tutte anche a casa. Abubakar per esempio, forma insieme ad alcuni coetanei un gruppo il cui motto è, “abbassate il fucile, alzate la pen-na”. Impugnare un fucile non può essere l’u-nico impiego possibile. Abubakar è costretto a partire, spinto dalla madre dopo essere stato ripetutamente minacciato di morte. Su il fucile e giù la penna. Abdulkadir, canta una canzone. Noi ascolta-vamo quelle parole e così dimenticavamo gli scontri, gli stenti, l’impossibilità di istruirci. Dulaayo soconaayaa /dhuxuntii aan doonaayaa/ dalkayga aan ka dhoofaayaa/ dirirta aan ka car-rarayaa.volo camminando, cerco una via di uscita, la-scio il mio paese, fuggo dalla contesa.
Quinto giornoL’ultima parola che abbiamo scelto è casa. In inglese house o home non sono la stessa cosa, home è l’intimità, la dimora, il luogo dell’ani-ma. C’è una differenza simile tra guri e daar anche se con sfumature diverse. Quando ho lasciato la mia casa avevo diciassette anni. Era da poco nato mio figlio così, uscen-do, non mi sono preoccupata di portare via un granché, sia perché ero convinta che sarei torna-ta, sia perché mi importava soprattutto di salva-re il bambino. L’ho appoggiato su un cuscino di quelli che si usano per i neonati e mi sono av-volta in un velo nero molto ampio. Poco prima di uscire mi ha sfiorato per un attimo il pensiero che non sarei potuta tornare, così ho preso il mio ultimo diario. Poche ore dopo, la casa è sta-ta assaltata e saccheggiata. Ne ho visti i brandelli sparpagliati per tutto il quartiere. Per un attimo ho sentito un forte senso di smarrimento, pen-
90
GLI A
SINI 69
STORIE
Non sono le pareti intorno che fanno del luogo in cui viviamo una casa. Le relazioni forse ci fanno piantare fondamen-ta, costruire l’animo, riparo e conforto allo stesso tempo. Allora la casa la potremo portare sempre con noi, la nostra casa potrà viaggiare. “Sono quella/ che va via”, scrive la poetessa Sujata Bhatt:“Sono quella/ che va via, sempre/ via con la casa/ che può solo restarmi dentro/ il san-gue- la mia casa che non ha posto/ in nessu-na geografia”.
spessissimo è quello dell’ospitalità. Sia socialità che ospitalità hanno a che fare con le relazioni, con le regole che diamo a queste relazioni. “Quando avevamo un governo, se ti trovavi in un negozio e arrivava uno straniero, lo facevi passare prima, tutti ci si impegnavano, perché non si trovava nel suo paese e bisognava acco-glierlo. Qui questa regola non sembra rispetta-ta. Non sono solo gli italiani a non essere ospi-tali, ma a volte non lo sono neppure i somali, i ‘vecchie lire’ li chiamano, quelli che abitano in Italia da anni. Diversi dai ‘Titanic arrivati’ con gli sbarchi, i quasi naufraghi”. Titanic e vecchie lire, due categorie.
91
I DOVERI DELL’OSPITALITÀ
GLI A
SINI 69
uomini che raccontarono le loro storie intorno al selvaggio fuoco da carnpo. La nostra arte si preoccupa ed è tenuta a preoccuparsi non tan-to di renderle le storie vere quanto di renderle tipiche, non tanto di afferrare i tratti di ogni episodio, quanto di dirigerli tutti verso un fine comune. Poiché al dilagare di impressioni, tut-te efficaci ma tutte distinte, che offre la vita, essa sostituisce una certa serie artificiale di im-pressioni, tutte invero rappresentate molto de-bolmente, ma tutte miranti allo stesso effetto, tutte rivelanti le stesse idee, tutte accordante-si insieme come note armoniose in musica o come tinte ben graduate in un buon quadro. Il romanzo ben scritto echeggia e riecheggia attraverso tutti i suoi capitoli, attraverso tutte le sue frasi, il solo pensiero che domina il suo spirito creativo; a esso deve convergere ogni avvenimento e ogni personaggio; lo stile deve essere alla sua altezza; e se vi è in qualche pun-to una parola che sembri non conformarvisi, bisognerà toglierla perché il libro sia piu for-te, piu chiaro, e (stavo per dire) più completo. La vita è mostruosa, infinita, illogica, rude e dolorosa; un’opera d’arte è, al confronto, sem-plice, finita, contenuta, razionale, scorrevole e svirilizzata. La vita si impone con l’energia bruta, inarticolata come il tuono; l’arte col-
Quale è l’oggetto, quale il metodo di un’ar-te, e quale l’origine del suo potere? Tutto il se-greto è che nessun’arte “compete con la vita”. L’unico metodo seguito dall’uomo, sia che mediti o che crei, è quello di socchiudere gli occhi davanti al bagliore e alla confusione del-la realtà. Le arti come l’aritmetica e la geome-tria distolgono gli occhi dalla rozza, colorata e mobile natura che si stende ai loro piedi, e guardano invece a una certa immaginata astra-zione. La geometria ci parlerà di un circolo, cosa mai vista nella natura; interrogata intorno a un circolo verde o a un circolo di ferro, essa si metterà la mano sulla bocca. Così con le arti. La pittura, paragonando miseramente la luce del sole con la biacca d’argento, rinuncia alla verità del colore, come già aveva rinunciato al rilievo e al movimento; e invece di gareggiare con la natura, combina un sitema di tinte ar-moniose. Similmente la letteratura, soprattut-to nel suo aspetto più tipico, quello narrativo, sfugge alla sfida diretta e persegue invece uno scopo indipendente e creativo. Se pure imita in qualche modo, imita non la vita ma il lin-guaggio: non i fatti del destino dell’uomo, ma l’enfasi e gli abbassamenti di tono con cui ne parla l’attore umano. La vera arte che trattò direttamente con la vita fu quella dei primi
I DOVERI DELL’OSPITALITÀUMILE RIMOSTRANZA SULL’ARTE DEL ROMANZO:
R.L. STEVENSON CONTRO HENRY JAMESDI ROBERT LOUIS STEVENSON
TRADUZIONE DI FLAMINIA CECCHI
92
GLI A
SINI 69
I DOVERI DELL’OSPITALITÀ
canza di ciò che chiama “l’immenso lusso” di poter litigare con il suo autore. Il lusso, per quasi tutti noi, è di mettere da parte il nostro giudizio, di venir sommersi dal racconto come da un’ondata, e di svegliarci, e cominciare a distinguere e trovare i difetti solo quando la lettura è finita e il volume messo da parte. Ma ancora più notevole è la ragione messa avanti dal signor James. Secondo lui, non può criti-care l’autore “perché”, dice confrontando quel libro a un altro lavoro, “sono stato bambino, ma non sono mai stato a a ricerca di un teso-ro sepolto”. Ecco, a dire il vero, un paradosso voluto; poiché se egli non è mai stato alla ricer-ca di un tesoro sepolto, si può dimostrare che non è mai stato bambino. Non è mai esistito un bambino (all’infuori di padron James) che non sia andato alla ricerca dell’oro, che non sia stato pirata, comandante militare e bandito delle montagne; che non abbia combattuto, e subito un naufragio e la prigione; che non si sia imbrattato di sangue le piccole mani, che non si sia valorosamente rifatto di una bat-taglia perduta, e non abbia protetto trionfal-mente l’innocenza e la bellezza. Il signor James ha protestato in un altro dei suoi saggi con eccellenti ragioni contro una concezione trop-po limitata dell’esperienza; per l’artista nato, egli sostiene, “i piu vaghi suggerimenti della vita” vengono trasformati in rivelazioni; e cre-do che, nella maggioranza dei casi, si dimostri vero il fatto che l’artista scriverà con molto più gusto ed efficacia intorno a quelle cose che ha soltanto desiderato di fare, che non a quelle che ha fatto. II desiderio è un telescopio mera-viglioso, e Pisgah il migliore osservatorio. Ora, poiché è pur vero che né il signor James né l’autore dell’opera in questione sono mai stati materialmente alla ricerca dell’oro, è probabile che tutt’e due abbiano ardentemente desidera-to e teneramente immaginato i particolari di una tale vita nei giovanili sogni a occhi aperti; e l’autore, contando su questo, e ben consa-pevole (vile e astuto uomo!) che un tal genere di interesse, essendo stato trattato spesso, trova un pronto accesso e una facile via per giungere
pisce l’orecchio, attraverso i ben piu forti ru-mori dell’ esperienza, come un suono creato artificialmente da un sapiente musicista. Una proposizione geometrica non compete con la vita; e una proposizione di geometria è un pa-rallelo buono e luminoso per un’opera d’arte. Sono ambedue ragionevoli, ambedue infedeli al fatto materiale, ambedue sono inerenti alla natura e nessuna delle due la rappresenta. Il romanzo, che è opera d’arte, esiste non per le sue rassomiglianze con la vita, che sono forzate e materiali, come una scarpa deve pur sempre essere di pelle, ma per la sua incommensura-bile diversità dalla vita, diversità che è inten-zionale ed espressiva, ed è insieme metodo e il senso dell’opera...La vita dell’uomo non è il soggetto dei roman-zi, bensi, l’inesauribile deposito dal quale i sog-getti devono essere scelti; loro nome è legione; e ad ogni nuovo soggetto – poiché anche su questo punto devo divergere per quanto è va-sto il cielo dalle opinioni del signor James – il vero artista varierà il suo metodo e cambierà il suo punto d’attacco. Ciò che in un caso era un gran pregio, diventerà un altro caso; ciò che formava la sostanza di un libro difficile può nel prossimo libro essere cosa futile e noiosa. Prima ciascun romanzo, poi ogni categoria di romanzi, esistono per se stessi. Prenderò come esempio, tre categorie pnncipali, ben distinte fra di loro: primo, il romanzo di avventura, che corrisponde ad alcune tendenze nell’uomo quasi sensuali e del tutto illogiche; secondo, il romanzo psicologico che risponde al nostro interesse intellettuale per le debolezze e per i moventi complessi e incostanti dell’uomo; e terzo, il romanzo drammatico, che tratta la stessa materia del teatro serio, e risponde alla nostra natura emotiva e al nostro giudizio mo-rale.Cominciamo dal romanzo d’avventura. Il si-gnor James si riferisce, lodandolo con singola-re generosità, a un libretto intorno alla ricerca di un tesoro nascosto; ma lascia cadere, cam-min facendo, alcune parole piuttosto sorpren-denti. Egli rimpiange in questo libro la man-
93
I DOVERI DELL’OSPITALITÀ
GLI A
SINI 69
germente agitato; e, con l’istinto artistico de-licato e giusto che gli è solito, evita quelle pas-sioni più violente le quali deformerebbero gli atteggiamenti che egli ama studiare, e cambie-rebbero i suoi personaggi sedentari da umoristi della vita ordinaria a forze brute e a semplici tipi di momenti più emozionanti. Invero, nel suo recente L’autore di “Beltraffio”, così giusto nella sua concezione, così agile ed elegante nel-la fattura, si fa uso della grande passione; come essa non è approfondita. Perfino nell’eroina il lavorio della passione è soppresso; e la gran-de lotta, la vera tragedia, la scène à faire passa inosservata dietro alla soglia di una porta chiu-sa a chiave. La dilettevole trovata del giovane visitatore viene introdotta, coscientemente o no, a questo fine: che il signor James, fedele al suo metodo, possa evitare la scena di passione. Ho fiducia che nessun lettore possa sospettar-mi di essere colpevole di sottovalutare questo piccolo capolavoro. Voglio semplicemente dire che esso appartiene a una definita categoria di romanzi, e che sarebbe stato concepito e trat-tato molto diversamente se avesse appartenuto a quell’altra definita categoria, della quale mi accingo a parlare adesso.Chiamo volentieri il romanzo drammatico con questo nome, perché mi dà la possibilità di indicare, giacché ci sono, un concetto er-rato, strano e particolarmente inglese. Si dice a volte che il dramma è fatto di avvenimenti. Esso è fatto di passione, che dà all’attore modo di rivelarsi; e quella passione deve crescere pro-gressivamente, o l’attore, mano a mano che il dramma procede, non potrebbe trasportare gli spettatori da un grado più basso e un grado più alto di interesse e di emozione. Una se-ria e buona opera di teatro deve perciò essere fondata su una delle appassionate cruces della vita, nella quale il dovere e il desiderio vengo-no a urtarsi nobilmente; e la stessa cosa è vera riguardo a ciò che chiamo, per questa ragione, il romanzo drammatico. Darò come esempio alcuni pregevoli esemplari, tutti dei nostri giorni e del nostro idioma: Rhoda Fleming di Meredith, quel meraviglioso e doloroso libro;
alle simpatie del lettore, si è basato dal prin-cipio alla fine sulla ricostruzione e sulla rap-presentazione particolareggiata di questi sogni giovanili. II carattere è per il ragazzo un libro suggellato; per lui un pirata è una barba, un paio di larghi calzoni e un libero complemento di pistole. L’autore, per amore di esattezza e per essere egli stesso più o meno adulto, am-metteva il carattere nel suo piano di lavoro, ma solo entro certi limiti. Se quelle stesse mario-nette avessero figurato in una trama di altro genere, sarebbero state mosse con intenti ben diversi; poiché in questo elementare romanzo di avventura, i personaggi devono venir pre-sentati con una sola specie di qualità – quella guerriera e formidabile.Così, nell’apparire perfidi nell’inganno e fatali nel combattimento, hanno servito al loro fine. Il pericolo è la materia trattata da questo ge-nere di romanzi; la paura è la passione con la quale esso giuoca ozisamente; e i caratteri sono ritratti solo in quanto rendono il senso del pe-ricolo e provocano l’attrazione della paura. Ag-giungere altri particolari, essere troppo intelli-genti, allarmare la lepre dell’interesse morale, e intellettuale mentre stiamo inseguendo la vol-pe dell’interesse materiale, non è arricchire ma immiserire il vostro racconto. Il lettore stupido ne sarà soltanto offeso, e il lettore intelligente perderà il gusto della lettura.Il romanzo di caratteri differisce in questo da tutti gli altri: che non richiede alcuna coeren-za nella trama, e per questa ragione, come è il caso di Gil Blas, è chiamato qualche volta romanzo di avventura. Si aggira intorno all’u-more delle persone rappresentate; queste sono, certamente, incorporate negli avvenimenti, ma non c’è bisogno che gli avvenimenti stessi, essendo tributari, procedano in ordine pro-gressivo; e i personaggi possono venir mostra-ti staticamente. Come entrano, così possono uscire; devono essere consistenti, ma non c’è bisogno che si sviluppino. Qui il signor James riconoscerà il tono di molti dei suoi lavori: egli tratta, generalmente, statica del personaggio, studiandolo quando è a riposo o soltanto leg-
94
GLI A
SINI 69
I DOVERI DELL’OSPITALITÀ
te se anche alquanto enfatica passione, rompe l’incanto con il guasto all’orologio dell’eroe. Tali personaggi e tali casi appartengono al ro-manzo di carattere; sono fuori posto nell’alta compagnia delle passioni; quando le passioni vengono introdotte nell’arte nel loro stadio piu acuto, noi ci aspettiamo di vederle, non eluse e vanamente lottanti come nella vita, ma elevantesi al di sopra delle circostanze e in fun-zione di destino. A questo punto mi posso figurare il signor Ja-mes che interviene con la sua lucida mente. Su molte delle cose che ho detto si mostrerebbe in apparenza incerto; a molte cose darebbe, se pure un po’ impazientemente, la sua approva-zione. Quel che ho detto poteva anche essere vero; ma non era quello che desiderava di dire o di sentir dire. Egli parlava del quadro finito e del suo valore una volta terminato; io, dei pennelli, della tavolozza e della luce del nord. Egli esprimeva le sue vedute nel tono per gli orecchi della buona società; io, con l’enfasi e la tecnicità dello studente inopportuno. Ma l’importante, potrei replicare, non è solo di divertire il pubblico, bensì di offrire consiglio utile allo scrittore giovane. E lo scrittore gio-vane non sarà aiutato dalle descrizioni geniali di ciò a cui un’arte può giungere nelle sue più alte espressioni, quanto da un’idea sicura di ciò che essa deve essere nelle sue forrne più bas-se. Quanto di meglio possiamo dirgli è que-sto: scelga un soggetto, sia di carattere, sia di passione; costruisca accuratarnente la trama in modo che ogni avvenimento valga a illustrare quel motivo principale, e ogni espressione ado-perata sia con esso in rapporti di affìnità o di contrasto; eviti una sotto-trama, a meno che, come in Shakespeare, la sotto-trama non sia un rovesciamento o un complemento dell’in-trigo principale; non permetta al suo stile di scadere al disotto del livello dell’argomento; colga il giusto tono della conversazione, senza guardare affatto a come gli uomini parlano nei salotti, ma con l’occhio volto al grado di pas-sione che può essere tenuto a esprimere; non permetta né a se stesso durante la narrazione,
Un paio di occhi azzurri di Hardy; e i due libri di Charles Reade, Griffith Gaunt e Il duplice matrimonio, intitolato originariamente Piccole bugie e nato da una commedia di Maquet il collega del grande Dumas. In questo genere di romanzo la porta serrata di L’autore di “Beltraf-fio” deve essere sfondata; la passione deve ap-parire sulla scena e pronunciare la sua ultima parola; la passione è l’alfa e l’omega, la trama, il protagonista e il deus ex machina; è tutto in-somma. I personaggi possono venire sulla sce-na in qualsiasi modo, non importa; l’essenziale è che, prima di lasciarla, essi vengano trasfi-gurati e sollevati al di sopra di loro stessi dalla passione. Si può, volendo, disegnarli minuta-mente; dipingere un carattere in tutte le sue dimensioni, per vederlo poi struggersi e mu-tare nella fornace dell’emozione. Ma non c’è affatto quest’obbligo; un bel ritratto non è ne-cessario, e il lettore s’accontenta di tipi astratti, purché siano profondamente e sinceramente commossi. Un romanzo di questo genere può anche essere un grande romanzo, anche se non contiene alcuna figura caratteristica; può esse-re grande, perché mostra le ansie di un cuore perturbato e l’espressione impersonale del-la passione; e, trattandosi di un artista di se-cond’ordine, è anche più facile che sia grande quando il fine è stato in tal modo limitato e tutta la forza della mente dello scrittore diret-ta esclusivamente alla passione. All’abilità che ha un magnifico campo d’azione nel roman-zo di carattere, sono sbarrate tutte le porte di questo più solenne teatro. Un movente ricer-cato, un’ingegnosa evasione dallo scopo finale, una piega verso l’umorismo invece che verso la passione, ci offendono come una cosa non sincera. Tutto dovrebbe essere semplice, tut-to diretto al suo fine. Da ciò proviene che, in Rhoda Fleming, la signora Lovel suscita tanto risentimento nel lettore; i suoi moventi sono troppo superficiali, i suoi modi troppo equi-voci per l’importanza e la forza di ciò che la circonda. Da ciò la veemente indignazione del lettore quando Balzac, dopo aver incominciato La Duchessa di Langeais con parole di una for-
95
I DOVERI DELL’OSPITALITÀ
GLI A
SINI 69
grandi uomini che lavorano su grandi temi è spesso la loro complessità, tuttavia la verità rimane immutata sotto le apparenze: quella semplificazione era il loro metodo, e quella semplicità è il pregio che li fa eccellere.
da Memorie e ritratti (1887), a cura di Arnaldo Frateili e Flaminia Cecchi, Bompiani 1947
né ad alcun personaggio nel corso del dialogo, di pronunciare una frase che non faccia diretta-mente parte della materia del racconto o della discussione del problema di cui si tratta. Non si dolga se questo sistema accorcia il suo libro; meglio cosi, poiché aggiungere del materiale privo di importanza non è un allungare ben-sì un sotterrare. Non si dia pensiero del dover rinunciare a migliaia di possibilità, così da se-guire sempre instancabilmente quell’unica che ha scelto. Non si preoccupi soprattutto se deve rinunciare al tono della conversazione, al par-ticolare piccante delle usanze del giorno, alla riproduzione dell’atmosfera e dell’ambiente. Codesti elementi non sono essenziali; un ro-manzo può essere eccellente, pur essendone del tutto privo; una passione o un carattere sono tanto più efficacemente riprodotti allorché si innalzano chiari da una circostanza essenziale. Si ricordi, in quest’epoca del particolare, delle epoche della compendiosità, dei grandi libri del passato, dei bravi uomini che vissero prima di Shakespeare e di Balzac. E, in primo luogo, tenga presente che il suo romanzo non è una trascrizione della vita, da giudicarsi per la sua esattezza, ma una semplificazione di qualche lato e aspetto della vita, destinata a riuscire o a fallire per la sua espressiva semplicità. Poiché, seppure ciò che noi notiamo e ammiriamo nei
Internazionale Kids è in edicolaOgni mese articoli, giochi e fumetti dai migliori giornali di tutto il mondo per bambine e bambiniAbbonati ora! internazionale.it/kids
Stagione 2019/20
CLASSICI RESTAURATIIN PRIMA VISIONE
EASYRIDER
di Dennis Hopper (USA/1969)
ZOGdi Max Lang e Daniel Snaddon (GB/2018)
IL TOPO BRIGANTEdi Jeroen Jaspaert (GB/2017)
OMAGGIO AD AGNÈS VARDA
APOCALYPSE NOW:FINAL CUT
di Francis Ford Coppola (USA/2019)
LO SCEICCO BIANCO
di Federico Fellini (Italia/ 1952)
I FIGLI DELLA VIOLENZA
di Luis Buñuel (Messico/1950)
VERTIGOdi Alfred Hitchcock (USA/1958)
IL DOTTOR STRANAMOREdi Stanley Kubrick (GB/1964)
VELLUTO BLU
di David Lynch (USA/1986)
Settembre
Dicembre
Marzo
Ottobre
Gennaio
Aprile
Novembre
Febbraio
Maggio
Per maggiori info: www.cinetecadibologna.it [email protected]