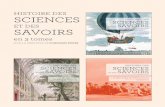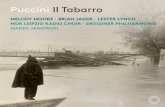Pasciuta - Il diavolo e il diritto: il Processus Satane (XIV sec.)
Il moscato di Dominique Vivant Denon
Transcript of Il moscato di Dominique Vivant Denon
Sicilia Antica, sede di Nicosia-Sperlinga Kiwanis International, Club di Nicosia
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna Comune di Nicosia
Associazione Culturale "Giovanni F. Natoli", Sperlinga
Atti delle giornate di storia locale
Nicosia, 2008-2010
a cura di
Salvatore Lo Pinzino - Giovanni DSUrso
Edizioni
l@
l<ii<qr~i~iu/t~~tzti il tutti i relatori degli incontri che hanno reso possibile questa pubblicazione con i loro c«ntri-
buti: arch. .Srill~r~tore Furine//a, dott. 17i/ippo Costa, dott.ssa ;\la~%ne/rna Costu, pro f. Saizto Casalotto, dott. .Si,bi.rtiano 1 i,rie+~z, dott. Rosa/-io I?A. l'atanq dott. Eernarztlo Car~isano, Sig. fAasi/io Aroizu, dott.ssa ~ \ l r~ / - i i~ Kugn Griida ed inoltre: prof. .Sahiutore C: Trol'uto, dott. G'iu.ceppe La lnco~o, dott.ssa Francesca D i fiaiico.
rille Istituzioni e alle rissociazioni Culturali/Club Service che hanno sostenuto, organizzato e patrocinato i convegni: Kiwanis Club di Nicosia (presidenti: 2472qe/0 Fwro e S'alr'atort. i\lag~io); Soprintendenza BB. CC. AA. di Enna (sovrintendente dott.ssa Hrutrice Basile); Comune di Nicosia (sindaco pro6 .4ntorzel/o Catania) Associazione Sicilia Antica (presidente dott. (r'io/'a~iiii D'( IKTO); Associazione Culturale "G. F. Natoli" (presidente dott. Jàlj~~7tore 1-0 I'ilzzino).
All'Tlnte Casa di Riposo "Barone B. Di Falco" (Sig. Alic/l?/e i\lail~pzo e dott. .Si/r/oize L7 CT<q/icl); a1l'I.T.C. "A. Volta" (dir. scol. Giuseppe Firce//a) per la loro disponibiliti logistica. lilla sig.ra Rosa Anna hlarino (Enna) al sig. Salvatore 1,a Gigiia (Nicosia) al dott. Alessandro hlancuso (XIcssina)
I /~~<qN~a~ioiic:joto Ari co)zi~qni e CHIYI rdito~i~~li': Salvatore J,o Pinzino
111 ~op~l i f i i~a: ( h a della Sicilia di ~ i b r a h a m Ortelio 1584 (tratta da I ,. Iachello, a cura, Ltzso/n n
frr p/!t~tt. I L \tn/zci del cai-fqSrnfi h/ S I 7 a/ X711Y secolo, Catania 1999)
O 2010 - Salvatore 1.0 Pinzino 8 2010 - Gli autori dei rispettivi contributi
Edizione Arti Grafiche NovaGraf s.n.c. C.da Piano di Corte, 18 - 94010 Xssoro Tcl. 0935,667864 - Fas 0935.620507 a~~~v.novagraf . i t
ISBN 978-88-88881-69-0
Atti delle giornate di storia locale : Nicosia, 2008-2010 / a cura di Salvatore Lo Pinzino,
Giovanni D'Urso. - Assoro : Noragraf, 2010.
1. Nicosia - ritti di congressi.
I. I,o Pinzino, Salvatore <1957->. 11. D'Crso, Giovanili <1958->.
945.8 1243 (:(:D-22 SBN Pa10229044
CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana 'iilberto Bombace"
287
Rosario P.A. PatanéSoprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna
Il moscato di Dominique Vivant DenonIl XVIII secolo e l’antico: archeologia e identità
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.48 Pagina 287
Il moscato di Dominique Vivant DenonIl XVIII secolo e l’antico: archeologia e identità
ROSARIO P.A. PATANÉ
Nel 1778 Ferdinando IV di Borbone instituì la Regia Custodia, prima strut-tura di tutela monumentale in Sicilia.1 Il 1778 è anche l’anno che in questa partedella Sicilia vide il viaggio di J. Houel e quello dell’équipe di R. de Saint-Non:entro pochi anni si concretizzeranno in grossi volumi riccamente illustrati. Vistoche il nostro filo rosso si dipana da Nicosia, ricorderemo che il Voyage di Saint-Non sorvola su Nicosia, che pure dice essere una delle città più considerevolidel centro della Sicilia;2 ma dedica un’incisione a Sperlinga (fig. 1).3 E’ superfluospiegare il motivo. “Quod Siculis placuit, sola Sperlinga negavit”. Il cuore ha le sueragioni: un francese in Sicilia deve andare in pellegrinaggio all’unica piazza filo-francese nella rivolta dei Vespri. Anche Houel va via immediatamente daNicosia, non trovandovi nulla di antico;4 ma disegna il castello di Sperlinga (fig.2).5 Come in genere i suoi contemporanei, Houel non vedeva il Medioevo.Normalmente, quello che fa muovere i viaggiatori internazionali del Grand Tourverso l’Italia meridionale e la Sicilia è l’interesse per l’antico: monumenti, ogget-ti di scavo, sopravvivenze nel contemporaneo. Per ripetere le parole di A.Momigliano, “Houel passò davanti alla Martorana di Palermo e alla cattedrale diCefalù quasi senza fermarsi, ma le giovani donne della Sicilia gli ricordavano deegreche (...). Lo interessava che la cattedrale di Siracusa fosse costruita su un tem-pio greco, e dedicava lungo spazio alle feste di Santa Rosalia a Palermo,l’Assunzione a Messina e Sant’Agata a Catania per un implicito dubbio che inqueste manifestazioni popolari si continuassero riti antichi.”6 Appunto, nelXVIII secolo studiosi e viaggiatori erano interessati alla Sicilia come ad una terragreca. Questo almeno vale per i non siciliani: giacché i Siciliani hanno costante-
289
Ringrazio il dott. Salvatore Lo Pinzino per l’invito a trattare l’argomento in questa sede. Perla collaborazione nell’elaborazione grafica delle cartine, ringrazio l’arch. Domenico Calabrò(figg. 14, 16) e Maurizio Bruno (fig. 22).
1 LO IACONO, MARCONI 1997, pp. 15-22; PAGNANO 2001, pp. 15-27.2 SAINT-NON 1785, IV, p. 117.3 SAINT-NON 1785, IV tav. 45.4 HOUEL 1785, p. 36.5 HOUEL 1785, tav. CLXIII, pp. 38-40.6 MOMIGLIANO 1979, p. 773.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.48 Pagina 289
290
Il moscato di Dominique Vivant Denon
Fig. 1
Fig. 2
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.48 Pagina 290
mente rifiutato di adottare i Greci come propri antenati, preferendo vedere lastoria di Sicilia come una lunga serie di invasioni, di dominazioni straniere e diconvivenze felici o infelici. Gli stessi Siculi, all’alba della storia, sarebbero statiinvasori...7
Il XVIII secolo, l’Età dell’Illuminismo e delle Rivoluzioni, è un momentocruciale per comprendere due fenomeni apparentemente indipendenti: il sorge-re del nazionalismo e la promozione dell’archeologia come una disciplina pro-fessionale.8 Non è questa la sede per affrontare il problema delle sopravvivenze,dell’importanza dell’antico nel Medioevo, nel Rinascimento italiano.9
L’attrazione verso il periodo classico si può far risalire all’Italia del XIV secolo.Nei liberi comuni, dominati dalla classe mercantile, c’era bisogno di una auto-definizione del potere diversa dai motivi religiosi del Medioevo: il mezzo sceltoper la legittimazione politica fu l’antichità. Il primo governante ad appellarsi alpassato sembra essere stato Cola di Rienzo: nel 1347, argomentando in favoredella creazione di una Repubblica Romana, usò la Lex de Imperio di Vespasiano(da poco scoperta) per cercare di dimostrare la superiorità del popolo sugliimperatori, donde la superiorità della sua repubblica sul papato.10 Fuori d’Italia,specie in aree lontane dal centro dell’antico mondo romano, una volta che il pas-sato aveva acquisito valore come argomento politico e sociale, si affermava l’im-portanza del proprio passato non classico. Il passato classico e il passato barba-rico (preistorico e medievale) si evolvevano parallelamente, man mano che ilcontesto socio-politico (non solo quello intellettuale) si andava trasformando.11
Ci limiteremo ad accennare al ruolo dell’antico nella cultura europea delXVIII secolo. La filosofia e il pensiero politico dell’Illuminismo furono precon-dizioni cruciali per il successivo emergere del nazionalismo. Acquistano impor-tanza i concetti di “bene comune” e “utilità”; la “verità” è a base della scienza.Nella ricerca del progresso della comunità, si cerca di imparare dal passato. Lecollezioni di antichità, che avevano contribuito a definire l’immagine del princi-pe, vengono ora viste per la definizione dell’immagine della nazione. I nuovimusei vengono organizzati sul principio di classificazione: non più oggetto dicuriosità, ma in vista del progresso delle arti e della scienza. Entro la trama delrazionalismo, il XVIII secolo va verso una prima rivoluzione nel metodo stori-
291
Rosario P.A. Patané
7 MOMIGLIANO 1979; MOMIGLIANO 1984; CESERANI 2000. Per il problema di colonizzazio-ne greca e popolazioni locali, cfr. MORGAN 1999; ivi bibliografia.
8 DÌAZ-ANDREU 2008, pp. 29 ss.9 DACOS 1979; SETTIS 1984; SCHNAPP 1994, pp. 74-107; DE LACHENAL 1995.10 FRUGONI 1984, pp. 53-54; DÍAZ-ANDREU 2008, p. 32.11 SCHNAPP 1994, pp. 109-193; TRIGGER 1996, pp. 33-116; POMIAN 2004, pp. 155-170; DÌAZ-
ANDREU 2008, p. 32 ss.; ivi bibliografia.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.48 Pagina 291
co. Il passato che gli antiquari del XVIII secolo pongono a modello era quellogreco-romano. L’Italia era un centro di attenzione, la principale destinazione delGrand Tour, il viaggio (di diversi mesi o di qualche anno) intrapreso dai giovanidell’élite sociale come rito di passaggio verso un’età adulta colta ed educata. Leantichità italiane, soprattutto dagli scavi di Roma, Ercolano, Pompei e dai sitietruschi, ricevevano grande attenzione. Le collezioni di antichità, già in voga neisecoli precedenti, lo divennero ancora di più durante il XVIII secolo. I giovanidell’alta società durante i loro viaggi alimentavano questo mercato, portando acasa come souvenir oggetti antichi e arte ispirata al mondo antico. Anche laGrecia conobbe questo crescente mercato di antichità, ma solo successivamen-te, dal momento che per secoli l’Impero Ottomano era stato quasi chiuso aglistranieri. L’interesse fu sostenuto da associazioni come la Society of Dilettanti:fondata nel 1734, intraprese spedizioni alla ricerca di antichità greche. I quattrovolumi delle Antiquities of Athens di James Stuart e Nicholas Revett furono pub-blicati nel 1762. Nel 1733 apre al pubblico il Museo Capitolino, con l’intenzio-ne di preservare l’eredità archeologica: rapidamente divenne di rigore per intel-lettuali, artisti e giovani del Grand Tour nella loro visita a Roma. Nel 1771 seguìa Roma, in Vaticano, il Museo Pio Clementino. A Napoli, un museo fu fondatonel 1750 da Carlo III nel palazzo reale di Portici; dal 1755 l’AccademiaErcolanese si dedicò allo studio dei rinvenimenti degli scavi. L’esempio deimusei italiani fu seguito in altri paesi. Da una parte vi fu il riordino di collezio-ni reali in cui sculture classiche avevano una parte importante (Vienna,Stoccolma). Ma d’altra parte sorsero nuove istituzioni statali. Nel 1753 si decisedi fondare il British Museum, per ospitare la biblioteca e la collezione donateallo stato da Sir Hans Sloane (l’apertura al pubblico è del 1759). Nel 1792 nasceil Louvre: con la Rivoluzione, le collezioni reali vengono destinate alla nazione.12
C’è oggi un approccio più professionale al passato, che si concretizza inmusei, università, e da ultimo associazioni culturali e industria del turismo. Si èavuto un importante fenomeno di crescita dell’interesse per il passato: diffusio-ne dell’interesse a un livello prima ignoto; ma anche diffusione, al di là dei suoilimiti geografici iniziali, di un modello della cultura occidentale. Le circostanzein cui questi cambiamenti sono avvenuti sono molto indicative. Nel 1789 laRivoluzione Francese mise in discussione il potere politico e l’ordine socialeprima sacrosanti. Il successo di queste idee si affermò nella prima metà del XIXsecolo. Gli stati non potevano più fondarsi sull’eredità della monarchia; occor-reva un nuovo tipo di legittimazione. Il concetto di nazione assunse questo
292
Il moscato di Dominique Vivant Denon
12 MOMIGLIANO 1955; GUALANDI 1978-79; DACOS 1979; OTTANI CAVINA 1982; GUALANDI1984; LOSURDO 1987; MOTTOLA MOLFINO 1991, pp. 11-26; HARTOG 1996, pp. 27-33; COMETA1999; SCHUBERT 2004, pp. 20-34; CATALANO 2007; DÌAZ-ANDREU 2008, pp. 41-55.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.48 Pagina 292
ruolo. La nazione aveva comunque un passato: di questo, e non degli eventi dellacasa reale, cominciò a occuparsi il nuovo tipo di storia.13
Il Settecento, e in particolare i decenni centrali del secolo, in Sicilia videro unparticolare interesse per l’ “antiquaria”, come veniva definita l’attività collezioni-stica e più in generale archeologica.14 Non era mancato in precedenza l’interes-se per l’antico da parte delle corti siciliane;15 ma dalla fase della Wunderkammer,finalizzata al prestigio del principe, non si era mai passati alla storia della comu-nità. Già con l’assunzione della corona di Sicilia nel 1713 da parte di VittorioAmedeo II di Savoia, dopo secoli di dominio spagnolo, si era determinato unmovimento di ripresa culturale. Ma soprattutto dal 1734 con l’avvento deiBorboni, si sviluppò l’esigenza di indagare il passato delle città del regno alloscopo di meglio definirne l’identità. Un particolare ruolo trainante ovviamentefu rivestito dagli scavi di Ercolano, grazie ai quali il giovane re Carlo di Borbonedoveva dare gloria al regno e non sfigurare davanti alle collezioni d’arte deimodelli familiari: le famiglie reali francese e spagnola, gliantenati Farnese.16 Il modello di Carlo di Borbone ebbeun forte impatto sulla Sicilia. Collezioni sorsero in diver-se città; e in diverse città furono compilate storie locali.La commedia di Goldoni La famiglia dell’antiquario, rap-presentata a Venezia nel 1749 ma ambientata a Palermo,mette in scena il personaggio del conte AnselmoTerrazzani con la sua demenziale passione per gli ogget-ti antichi. La figura del collezionista, nobile spiantato,con conoscenze alquanto approssimative, doveva risul-tare comicamente familiare agli spettatori. Ovviamentenon tutti gli antiquari del Settecento erano degli sprov-veduti, in preda alla moda del collezionismo di oggettiantichi; c’erano anche studiosi di buon livello, collezio-nisti in grado di ben interpretare i pezzi dei loro musei.17
In Sicilia, le collezioni più importanti furono quelle dellecittà dei principi di Torremuzza e di Biscari: Palermo e Catania. Si può indicare,come significativo esempio, il manifesto programmatico costituito dall’iscrizio-ne sul rovescio della medaglia coniata per l’inaugurazione del Museo delPrincipe di Biscari: “Publicae utilitati, patriae decori, studiosorum commodo” (fig. 3).
293
Rosario P.A. Patané
13 DÌAZ-ANDREU 2008, pp. 57-59.14 PAFUMI 2006; GIARRIZZO, PAFUMI 2009.15 ABBATE 2001.16 D’ALCONZO 1999.17 SALMERI 1992, pp. 63-65; SALMERI, D’AGATA 1998, p. 129; SALMERI 2001.
Fig. 3
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.48 Pagina 293
Ovviamente, nel quadro della cultura del tempo, la pubblica utilità e l’agio deglistudiosi non vanno intesi in senso democratico: il pubblico cui il museo eraaperto era costituito da persone che potevano essere ricevute dal padrone dicasa, aristocratici ed ecclesiastici di rango, oltre ai viaggiatori stranieri. Quanto aldecoro della città, il museo “era un punto di forza del piano di Biscari, dettatoda non comune lungimiranza e sensibilità in fatto di politica culturale, e volto adavviare un processo di valorizzazione del passato di Catania, e per suo tramitedi promozione della città in ambito internazionale”.18 Nel 1778 Ferdinando IVinstituì la Regia Custodia, affidando val di Noto e val Demone al principe diBiscari e val di Mazara al principe di Torremuzza e riconoscendo quindi de iurela posizione di preminenza che i due aristocratici avevano avuto nell’archeologiasiciliana.
Agira, a suo modo, visse un suo ruolo in questo fenomeno culturale. Si trat-tava, certo, di una città minore; ma dall’importante passato, ampiamente citatanelle fonti antiche. Studiosi locali, in contatto con i principali centri culturali del-l’epoca, si impegnarono in ricerche sulla storia patria. Grossi nomi dell’antiqua-ria, e viaggiatori stranieri, si posero il problema di cosa fosse rimasto della cittàche Diodoro e Cicerone (un locale e un romano, i cui scritti si collocano comun-que nell’ambito del I secolo a.C.) avevano descritto come ricca e piena di impor-tanti monumenti. E’ forse il solo caso in età moderna in cui Agira si sia inseritapienamente nei grandi flussi culturali del momento.
Il primo capitolo della storia di Agira di B. Attardi19 è dedicato al nome dellacittà: evidentemente per la cultura del tempo si trattava di un argomento impor-tante. Si contesta il punto di vista di Fazello20 e Pirri,21 secondo i quali il nomedella città andava riportato al greco Agirion ed era dovuto a miniere d’argentopresenti nel territorio. Si osserva che la città esisteva, e quindi doveva avere unnome, prima che i Greci arrivassero in Sicilia, al tempo dei Sicani; e del resto gliscrittori antichi che parlano di Agira non accennano mai a miniere d’argento; cir-costanza questa che era stata già osservata da Cluverio,22 il quale appunto dedu-ceva che il nome della città doveva essere stato stabilito non in greco da Grecima in siculo da Siculi. Il toponimo Agyrion ci è noto in questa forma da fontigreche; che appartenga in realtà ad una lingua diversa dal greco, è un’osservazio-ne interessante. Per l’Attardi la grande antichità della città di Agira, ben prece-dente alla venuta dei Greci in Sicilia, trova conferma nella leggenda di Ercole; se
294
Il moscato di Dominique Vivant Denon
18 SALMERI 2001, p. 2619 ATTARDI 1742.20 FAZELLUS 1558.21 PIRRI 1733.22 CLUVERIUS 1619.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.48 Pagina 294
gli antichi localizzavano adAgira una delle avventure del-l’eroe, vuol dire che avevanocoscienza della grande anti-chità della città. Con tutta unaserie di complessi calcoli, ilpassaggio di Ercole da Agiraviene fissato una quarantinad’anni prima della distruzionedi Troia, intorno al 1194 a.C.E quindi la fondazione dellacittà viene attribuita ai Sicani,che nella visione tucidideaabitavano la Sicilia prima deiSiculi.23 Può essere ridondantesottolineare come questeosservazioni ormai abbianoimportanza solo per la storiadella cultura nel XVIII seco-lo; sarebbe ingenuo registraresemplicemente la conclusionesecondo cui la città esistevaagli albori del XII secolo a.C.Le pagine di Attardi sonocondotte sulla base della let-tura delle fonti scritte, letturaaffrontata con gli strumenticritici messi a disposizione dalla cultura dell’epoca.24 Studia le monete, delle qualifornisce pure dei disegni (fig. 4); alcune sono attribuite alla città sicula. Non soloconosce le monete pubblicate da F. Paruta,25 ma anche altre viste localmente(con chiaro riferimento a cultori locali di storia patria).26
295
Rosario P.A. Patané
Fig. 4
23 LA ROSA 1989, pp. 50-52; ALBANESE PROCELLI 2003, pp. 18-25.24 Va anche osservato che le fonti greche sono sempre riportate in traduzione latina. La scar-
sa conoscenza del greco è un punto debole dell’antiquaria siciliana del Settecento: SALMERI 2001,pp. 30-31.
25 PARUTA 1612.26 ATTARDI 1742, pp. 19-20.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.48 Pagina 295
Il riferimento a dati tratti dall’osser-vazione di resti materiali è molto scar-no;27 ovviamente il “commentario”archeologico di Attardi non contienealcun tentativo di classificazione crono-logica dei resti che elenca: “anticheMemorie”, ma di una antichità indistin-ta. Non c’è mai il tentativo di individua-zione dei monumenti indicati nellefonti antiche. In ogni caso, la principa-le fonte di informazioni è costituitadalle fonti scritte; si tenta anche di usarele fonti numismatiche, con l’iscrizione econ la simbologia dei tipi; anche se siaccetta il principio dell’ipsa ruina docet,non si è ancora appreso a leggere ilmonumento e si ha comunque bisognodi fonti scritte che sul monumentodiano “lumi accertati”.
Nel 1778, con l’istituzione della Regia Custodia, i resti archeologici di Agiravengono presi in considerazione nel Plano, relazione programmatica, del primocustode della zona, il Principe di Biscari.28 Sostanzialmente le stesse indicazioniconfluiscono nel Viaggio, pubblicazione con la quale il Biscari mette i dati adisposizione degli studiosi.29 Oltre a conoscere il libro dell’Attardi,30 dalle osser-vazioni del Viaggio è evidente che aveva una buona conoscenza della situazio-ne.31 In questo caso l’attenzione è rivolta ai resti materiali: il principe dimostrauna conoscenza del sito probabilmente diretta; non individua resti antichimonumentali; non degna di un cenno il castello medievale, che ovviamente non
296
Il moscato di Dominique Vivant Denon
Fig. 5
27 ATTARDI 1742, p. 31. “Quali però fussero questi Castelli, situati intorno alla Città, rapportati daDiodoro, Diodoro non lo dice, nè è così agevole averne lumi accertati, ma dall’antiche rovine, e dall’antichi monu-menti, che alla giornata si ritrovano nel nostro distretto, è d’uopo credere, che fussero situati nelle contrade da noichiamati di S. Agati, di S. Venera, di frontè, e che vi fusse ancora l’antico Castello di Amesalo, oggi chiamatoRegalbuto; trovandosi continuamente nelle suddette contrade antiche Monete, antichi Edifizj, antiche Memorie,chiaro contrassegno, essere state ne’ tempi antichi abitate”. E’ il commento di Attardi ad una notizia diDiodoro (XIV 95,4).
28 PAGNANO 2001, p. 68, p. 142.29 PATERNÒ 1781.30 Che possedeva, nella sua biblioteca: cfr. PAGNANO 2001, p. 142 nota 75.31 PATERNÒ 1781, p. 49.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.48 Pagina 296
rientrava nei suoi interessi.32 Registra l’acquisizione per il suo museo di una basecon iscrizione;33 inutile sottolineare l’ingenuità dell’osservazione secondo cui gliAgirini avranno pure dedicato un monumento al grande storico locale e quindiè probabile che il Diodoro figlio di Apollonio fosse proprio lui: così non solo labase viene etichettata come monumento a Diodoro Siculo, ma rimane ancheacquisito il patronimico.
Disponiamo del resoconto della visita ad Agira di due illustri viaggiatori fran-cesi, Jean Houel (fig. 5) e Dominique Vivant Denon (fig. 6): entrambe le visiteebbero luogo nel 1778, entrambi i viaggiatori furono in contatto con lo stessostudioso locale, Pietro Mineo (fig. 7);34 il confronto dei due resoconti risultaquindi particolarmente interessante. J. Houel viaggiò in Sicilia tra il 1776 e il1779, realizzando i quattro volumi del Voyage Pittoresque. Dei dipinti realizzati inSicilia, e in parte duplicati a Parigi, 500 furono venduti a Caterina II di Russiaper poter finanziare la pubblicazione dell’opera.35 Nel 1778, da giugno a novem-
297
Rosario P.A. Patané
Fig. 6 Fig. 7
32 Per l’atteggiamento del Biscari nei confronti dei monumenti medievali, cfr. PAGNANO 2001,pp. 60-63.
33 PATERNÒ 1781, p. 49; IG XIV 588.34 Sulla figura di P. Mineo, cfr. FOTI 2004.35 MOZZILO 1979; VALLET 1979; TUZET 1995, pp. 86-98; PECORAINO 1989; GRINGERI
PANTANO 1999; FINO 2008, pp. 81-98; GRIGERI PANTANO 2009, pp. 61-68.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.48 Pagina 297
bre, percorse la Sicilia anche l’équipe dell’abate Richard de Saint-Non che, investe di curatore, intendeva realizzare un viaggio illustrato in Italia (realizzeràsolo quattro volumi, dedicati a Italia meridionale e Sicilia). Saint-Non in realtànon mise mai piede in Sicilia, dove la spedizione (diciannove persone) era diret-ta da Dominique Vivant, barone de Non (Denon con la Rivoluzione): brillantediplomatico, futuro direttore del Musée Napoleon (il Louvre, per intenderci); aParigi il lavoro sarà poi definito da un’ulteriore équipe di incisori e di collabora-tori.36 Nella forma letteraria del “viaggio”, si tratta di vere e proprie spedizioniscientifiche e imprese editoriali. Le poche pagine che i due francesi dedicaronoad Agira furono pubblicate tra il 1785 e il 1788; conosciamo gli scritti di Biscari;le ricerche di Mineo non sono state pubblicate: alla fine del XVIII secolo Parigie Agira non erano esattamente la stessa cosa.
J. Houel visitò Agira nell’estate del 1778, chiaramente motivato dalla letturadi Diodoro. Il testo del Voyage pittoresque riporta rapide annotazioni, che puòessere il caso di tradurre per esteso:
“Non trovando niente di antico in questo luogo [Nicosia], proseguii per S. Philippod’Argiro. La sua singolare posizione la fa riconoscere da molto lontano. E’ edificata pressola sommità di una montagna conica molto alta e perfettamente isolata. A prima vista si pren-de per una formazione vulcanica. Esaminando la montagna si perde presto quest’idea: non c’ènessuna traccia di vulcano: c’è l’opera delle acque del mare. Nella strada che è alla sua baseho notato uno strato di ostriche pietrificate, che è stato scoperto nello scavare questa strada, equesto strato di ostriche ha due leghe d’estensione.
Sono stato ricevuto molto bene in questa città dal Canonico Mineo, presso il quale ho allog-giato: ha una biblioteca molto vasta, aperta a tutti gli studiosi della città. Mi ha molto solle-citato a disegnare le antichità del suo paese, ma non ho trovato niente, con mio gran ramma-rico, che fosse degno di essere offerto ai miei lettori. Tutto quel che resta dell’antica città diAgira, che un tempo sorgeva in questo luogo, consiste in un bel muro di costruzione greca,situato presso la parrocchia Santa Margherita, nei pressi a mezza costa: vi ho trovato purepiccoli frammenti di architettura. Ho visitato il castello, che si trova alla sommità della mon-tagna: non è un’antichità, è opera dei Normanni.
Mi è stata fatta vedere con molta premura una piccola chiesa a due miglia e mezzo versooccidente, si desiderava che io la trovassi antica; ma qualunque desiderio io avessi di compia-cere gli abitati del luogo, non la trovai che vecchia e gotica.
L’antica Agira è stata la patria del famoso Diodoro Siculo. Nella sua storia, libro IV,egli parla di un presunto viaggio che Ercole fece in questa città, dei templi che gli furono con-sacrati, del culto che gli si rendeva, dei sacrifici che gli si facevano, da vivo, sebbene lui rifiutas-se. Questo dio, in riconoscenza per questa grata accoglienza, realizzò un lago di quattro stadi
298
Il moscato di Dominique Vivant Denon
36 TUZET 1995, pp. 75-85; FINO 2008, pp. 98-117; GRINGERI PANTANO 2009, pp. 68-76.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.48 Pagina 298
di circonferenza, nella pianura di fronte alla città. Si piantò un bosco; si eresse a lui un tem-pio sulle sponde di questo lago. Gli storici antichi scrivevano delle favole, e i moderni li imita-no al meglio in questo che in qualunque altra cosa.”37
Non è un caso che il viaggiatore francese sia stato ospitato da don PietroMineo: è probabile che lo studioso locale fosse in contatto con Ignazio PaternòCastello, principe di Biscari (fig. 3), delle cui lettere di presentazione Houel siserviva, viaggiando nell’interno della Sicilia. Viene lodata la assai vasta bibliote-ca di P. Mineo, aperta a tutti gli studiosi della città; questo atteggiamento di aper-tura, accanto all’interesse per l’antiquaria, è appunto tipico della cultura delmomento; rivela anche, però, che nella piccola città P. Mineo era un personag-gio di spicco ma non era il solo che avesse interessi culturali a un certo livello.38
E’ il momento degli antiquari che indagano e valorizzano il passato della propriacittà per promuoverne l’immagine: gli interessi antiquari di P. Mineo trovanoprecisi riscontri nella cultura dell’epoca.39 L’ospite straniero viene trattato conogni riguardo e guidato alla scoperta delle antichità locali. P. Mineo, di forma-zione napoletana,40 era un uomo di cultura in contatto con i grandi centri del-l’epoca, un raffinato lettore che aveva messo su una biblioteca personale dellostesso livello di quelle che si andavano formando nelle città maggiori.41 Raffinatocollezionista di oggetti antichi e studioso di antiquaria, doveva essere invecemeno in grado di affrontare la lettura dei resti architettonici.42 Houel vieneaccompagnato a vedere mura greche, ma non solo. Il castello non suscita il suointeresse: “ce n’est pas une antiquité, il est l’ouvrage des Normands”. EvidentementeHouel ha preferito fidarsi della sua lettura dei resti architettonici piuttosto chedi quello che gli avranno detto i locali sul presunto castello saraceno.43 Come
299
Rosario P.A. Patané
37 HOUEL 1785, pp. 36-37.38 Per l’interesse di P. Mineo per la ‘studiosa gioventù’, quindi per la formazione della futura clas-
se dirigente, ma anche per la concreta esistenza di un gruppo di allievi, cfr. FOTI 2004, p. 33, pp.54-65.
39 PAFUMI 2006; NAPOLEONE 2009. Gli interessi “scientifici” del Mineo sono documentatidalla buona presenza nella libraria di opere che spaziano in diversi settori, dalla medicina (conalcune delle opere più importanti e aggiornate che circolavano in Europa a metà XVIII secolo)alla matematica, alla fisica. Cfr. FOTI 2004, pp. 89-92.
40 Per il ruolo dello studio del mondo antico nella cultura napoletana del ’700 e gli effetti sullacultura siciliana, GIARRIZZO 1967; GIARRIZZO 1981.
41 FOTI 2004.42 L’impressione è confermata dalla presenza molto sporadica di testi di architettura nella
libraria di P. Mineo: Vitruvio, il De Architectura di G.B. Alberti, gli Elementi di architettura civile e mili-tare di G. Fonda; cfr. FOTI 2004, p. 92.
43 Sul castello cfr. AGNELLO 1960; PATANÉ 1989, pp. 97-103; MAURICI 1992, p. 363; ALBERTI1995; MAURICI 1997, pp. 346-349; MAURICI 2001.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.48 Pagina 299
atteggiamento metodologico, semplicemente la cultura dell’epoca “non vedeva”l’arte medievale; di solito queste opere barbare venivano semplicemente ignora-te: non ci si preoccupava neanche di condannarle.44 Quanto alla chiesetta fuoricittà, che non riesce a trovare antica ma solo “vecchia e gotica”: dev’essersi trat-tato di un episodio imbarazzante, a quanto si può giudicare non solo dal testo,ma anche dai disegni superstiti.
Nel testo del Voyage Pittoresque J. Houel dice che il suo ospite lo spronava adisegnare le antichità del luogo, ma di non avere trovato nulla che fosse degnodi essere offerto ai suoi lettori. E infatti nelle planches dell’opera non ci sono inci-sioni che riguardano Agira. Ma alcuni disegni in realtà erano stati eseguiti e nonfurono poi inseriti nella pubblicazione: tra gli acquerelli di J. Houel all’Ermitage,quattro si riferiscono ad Agira.45 Un disegno acquerellato46 (fig. 8) porta l’anno-tazione autografa di Houel “de S.t Filippo d’Argiro”; il soggetto è alquanto gene-rico: un’anfora e una coppa su una base di lastre di pietra. Si può pensare ad uno
300
Il moscato di Dominique Vivant Denon
Fig. 8
44 Cfr. TUZET 1995, pp. 93-94, p. 230; COMETA 1999, p. 69.45 Conosciamo quattro disegni originali di soggetto agirino, conservati all’Ermitage: nessuno
si riferisce ai presunti resti del tempio di Eracle. PECORAINO 1989, pp. 226-227, pp. 324-325.46 PECORAINO 1989, n° 196.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.48 Pagina 300
schizzo realizzato prima di arrivare in città.47 Un tratto di muro greco48 (fig. 9)dev’essere quello descritto nel testo: la tecnica costruttiva è rappresentata in det-taglio e consente di ipotizzare che il tratto di muro appartenga alla cinta cheDiodoro riferisce a Timoleonte.49 La chiesetta fuori città è probabilmente lacostruzione raffigurata in due tavole: un acquerello50 (fig. 10) dà la veduta delmonumento; su un altro foglio51 (fig. 11) sono i disegni tecnici: pianta, sezione,profilo, dettagli architettonici. Si tratta di un lavoro impegnativo, che magari l’ar-tista può aver portato a termine giusto per compiacere l’ospite agirino.
Dominique Vivant Denon visitò Agira nell’estate del 1778.52 Conosceva ladescrizione della città data da Diodoro, con un teatro importante quasi quantoquello di Siracusa e con sontuosi monumenti, e sottolinea il contrasto con lacittà da lui visitata: “Questa città è costruita sulla sommità di una roccia a pan di zucche-
301
Rosario P.A. Patané
Fig. 9
47 Anche per il numero di catalogo, 379; gli altri fogli portano i numeri 382-384.48 PECORAINO 1989, n° 195.49 PATANÉ 1992, pp. 80-82.50 PECORAINO 1989, n° 197.51 PECORAINO 1989, n° 198.52 MOZZILLO 1979; TUZET 1995, pp. 75-85; GRINGERI PANTANO 1999, p. 21; FIORENTINI
2005, pp. 198-199.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.48 Pagina 301
302
Il moscato di Dominique Vivant Denon
Fig. 10
Fig. 11
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.48 Pagina 302
ro: domina tutto il suo territorio che, secondo la storia, gareggiava con quello di Siracusa perestensione e ricchezza.” E più oltre: “Attraverso le case, ci inerpicammo per dei sentieri tor-tuosi e scoscesi, che non si possono certamente chiamare strade, ma che ne fanno le veci, fino incima alla montagna, dove non restano che le estese mura di un castello, costruito daiSaraceni”.53 E ancora: “Del resto, anche se l’aspetto esteriore appare oggi tanto spoglio,l’ubertosità e la ricchezza dell’antica Agira permangono in seno alla sua terra, che abbonde-rebbe ancora di tutto, se fosse coltivata, ed arricchirebbe i suoi abitanti, se disponessero di sboc-chi per lo smercio dei loro prodotti.”54
Oltre alle annotazioni del Journal di Denon,55 e alla versione confluita nelVoyage del Saint-Non,56 ci rimane una tavola, incisa su disegno di Chatelet (fig.12).57 E’ un panorama da nord-ovest, ben caratterizzato anche se molti dettagli
303
Rosario P.A. Patané
Fig. 12
53 Anche Denon evidentemente raccoglie la notizia secondo cui il castello era stato costrui-to dai Saraceni: per la cultura locale, un monumento che era di remota antichità e non era di etàclassica, finiva inevitabilmente per essere classificato come saraceno. Cfr. supra.
54 Settecento Siciliano, p. 218.55 Trad. it. in Settecento Siciliano, pp. 217-221.56 SAINT-NON 1785, IV, pp. 114-116.57 SAINT-NON 1785, tav. XLIV.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.48 Pagina 303
si sono persi per la particolare procedura, con gli appunti rielaborati a Parigi dacollaboratori diversi. Sulla destra è visibile il convento dei francescani, in cuil’équipe era ospite: la veduta è stata quindi ripresa dalle vicine alture, dove infattisi svolgeva la trebbiatura raffigurata in primo piano. La forma della montagnasu cui si distende l’abitato, con il castello in cima, è perfettamente riconoscibile;così come chiaramente identificabili risultano alcune costruzioni che caratteriz-zano l’aspetto dell’abitato. Ad esempio le chiese sono ben localizzate; anche sepoi le guglie dei campanili appaiono esageratamente allungate (evidentementel’incisore non avrà avuto grande dimestichezza con i campanili siciliani).
Il motivo principale della visita ad Agira era ovviamente la ricerca delle anti-chità, motivata dalla lettura di Diodoro. “Cercammo il tempio di Ercole e il lago cheegli fece scavare da suo genero Iolas. Ce ne indicarono il sito: si tratta di un’area depressa,posta tra il convento dei Francescani e la città denominata ancor oggi Lago d’Ercole. (...)”: lacultura agirina del momento dava importanza al racconto relativo al culto diErcole e si era posto il problema della localizzazione dei monumenti e del lago.
Può essere il caso di riportare per esteso la descrizione delle antichità dellacittà: “La stessa zona, se vi si effettuassero degli scavi, non sarebbe meno avara di antichità:i contadini, lavorando, vi trovano un gran numero di cammei, e di pietre incise. Feci la cono-scenza di D. Pietro Mineo, superiore della Collegiata, che ne ha fatto una collezione con alcu-ni splendidi esemplari; tra gli altri una sardonica incisa che raffigura un fauno che gioca conuna capra, eseguita con uno stile ed una raffinatezza pari a quanto io abbia mai visto di piùperfetto in questo campo. Ci sono anche dei vasi greci, rinvenuti nelle tombe, dove, secondo l’an-tica usanza greca, le salme venivano sepolte e non bruciate. Mi fu data un’essenza congelatadal tempo che somiglia al sapone, forse residuata dall’olio naturale che si deponeva in piccolivasi, accanto ai corpi; delle mandorle, anch’esse ritrovate, che, nel conservarsi, avevano assun-to la consistenza del carbone, come quelle di Pompei. Questo dotto canonico, il solo, forse, chead Agira abbia tenuto a sapere qualcosa, mi fece visitare la sua biblioteca che aveva arricchi-ta, con una spesa di cinquantamila franchi, dei migliori libri esistenti in tutte le lingue. Ebbela cortesia di promettermi alcuni appunti sul suo paese e di procedere a degli scavi, per render-li più interessanti. Mi inviò anche una bottiglia di vino greco, che mi disse di aver fatto luistesso, secondo un sistema indicato da Esiodo. Questo vino era ottimo, benché ancor troppo gio-vane, e non somiglia al vino locale; ciò dimostra quanto il metodo di produzione incida sullaqualità dei vini e questo potrebbe servire da lezione agli Italiani.
Prima di lasciare Agira, ritornai nuovamente nella zona del lago; osservai il terreno conrinnovata attenzione: trovai infatti alcuni avanzi di muri all’altezza delle fondamenta, e que-ste erano costruite in grandi blocchi. Scoprii, sotto la polvere, una superficie piana ed alcunevestigia di mosaico, il ché rivelava la presenza di un grande edificio. Fui accompagnato, là vici-no, presso un anziano abate, il quale, compiendo degli scavi nel suo giardino, aveva rinvenutouna stele con la seguente iscrizione greca:
304
Il moscato di Dominique Vivant Denon
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.48 Pagina 304
8
e numerose tombe con dei vasi di terracotta e delle salme ancora intatte: ciò indicherebbe chequesto luogo rimaneva fuori della città, che le vestigia trovate potevano appartenere ad un tem-pio e che questo tempio, data la sua posizione prossima al lago d’Ercole, poteva essere quelloche gli abitanti di Agira avevano innalzato all’eroe. D’altronde non si tratta che di congettu-re, poggiate su basi molto frammentarie: ma a delle antichità che risalgono a tremila anni, sideve chiedere tutto il possibile. Mi mostrarono delle case erette sulle fondamenta delle antichemura e la forma che queste mura davano alla città, chiusa e limitata dalla scarpata della mon-tagna, e dunque costruita sempre in modo scomodo. (...)”. Continua poi con una serie diconsiderazioni sulle città arroccate in cima alle montagne per motivi di difesa esulle conseguenze di queste scelte.59
La collezione di antichità di P. Mineo comprendeva, a quanto riferisceDenon, begli esemplari di pietre incise, trovate in quantità dai contadini lavoran-do nei campi circostanti. Anche il padre, don Ferdinando, si interessava di anti-che memorie della sua città e aveva avviato una collezione.60 Il soggetto delSatiro sessualmente interessato a una capra era venuto di moda con i rinveni-menti di Ercolano.61 E’ evidente che i “vasi greci rinvenuti nelle tombe” doveva-no provenire da scavi condotti appositamente: non solo si tratta di oggetti inte-ri, ma si erano anche fatte precise osservazioni sui rituali funerari.62 E’ appuntoil momento in cui si comincia ad attribuire alla ceramica figurata un interesseprima riservato solo alla scultura e alle collezioni epigrafiche e numismatiche.63
Gli interessi antiquari di P. Mineo non andavano solo agli oggetti d’arte maanche agli usi e agli aspetti naturalistici: gli unguenti, che ovviamente la scienzadell’epoca non era in grado di sottoporre ad adeguate analisi di laboratorio mache tuttavia osservava; le mandorle carbonizzate deposte nelle tombe. E’ unatteggiamento mentale che trova precisi riscontri nella cultura dell’epoca.64
305
Rosario P.A. Patané
58 Chiaramente: .59 Settecento siciliano, pp. 217-221.60 ATTARDI 1742, pp. 19-20.61 BOARDMAN 1997, p. 937 n° 258; MOESCH 2009, pp. 54-55.62 Il riferimento all’uso greco di inumare i morti deriva chiaramente dall’osservazione empi-
rica, dal dato archeologico; mentre è strana le negazione dell’uso greco di bruciare i morti, usoaltrettanto attestato archeologicamente, ma soprattutto ben descritto dalle fonti scritte, a parti-re da Omero.
63 CASTORINA 1998.64 Cfr. ad esempio STORONI MAZZOLANI 1980. Per l’attenzione alla storia naturale: SALMERI
2001, pp. 24-25; PAFUMI 2006, pp. 128-131; 140-142; NAPOLEONE 2009. Del resto gli interessi delMineo sono documentati dalla buona presenza nella libraria di opere a carattere scientifico, che spa-ziano in diversi settori, dalla medicina (con alcune delle opere più importanti e aggiornate che cir-colavano in Europa a metà XVIII secolo) alla matematica, alla fisica. Cfr. FOTI 2004, pp. 89-92.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.48 Pagina 305
Anche il vino prodotto secondo i precetti di Esiodo rientra in questa cultura, chenegli scritti degli antichi cercava insegnamenti per i settori più disparati. Dovevatrattarsi di un moscato.
Sono illuminanti al riguardo le osservazioni enologiche di Saverio Landolina(fig. 13), altro antiquario siciliano dell’epoca, dai vasti interessi culturali e socia-
li: nel 1803 è nominato Regio Custodedelle Antichità per il Val Demone e il Valdi Noto; nel 1809 fonda il Museo diSiracusa.65 Con riferimento a un passo diEsiodo,66 Landolina osservava che i versinon parlano di stendere l’uva prima alsole e poi all’ombra. Il procedimentoindicato da Esiodo per ottenere un vinopregiato doveva essere il seguente: racco-gliere i grappoli maturi e metterli adasciugare all’aria aperta per una decina digiorni; metterli poi nel torchio e lasciarliqualche giorno senza pressarli (sarebbe-ro, se no, troppo asciutti per produrrevino senza prima fermentare). Infine,lasciare scorrere il mosto nei tini.67
Evidentemente P. Mineo stava applican-do le stesse osservazioni altrove espresseda S. Landolina; e soprattutto l’argomen-to doveva essere di moda tra i dotti del-l’epoca. Di Landolina sappiamo senz’al-tro che dalla lettura dei testi antichi cer-cava lumi per restaurare l’antica ricchez-
za della Sicilia e che applicava alle sue vaste proprietà i risultati dei suoi studi diagraria;68 particolari attenzioni dedicò allo studio per la produzione della carta di
306
Il moscato di Dominique Vivant Denon
Fig. 13
65 MARTINEZ LA RESTIA 1955-1956; AGNELLO 1968; FISCHER-HANSEN 2001; GRINGERIPANTANO 2003, p. 40; RUSSO 2007; CIURCINA 2008, p. 50.
66 Le opere e i giorni, vv. 609-614: “Quando Orione e Sirio giungono a mezzo del cielo, e l’Aurora dallerosee dita vede Arturo, allora, o Perse, raccogli tutti i grappoli e portali a casa: li terrai al sole per dieci giorni edieci notti, e per cinque all’ombra; e al sesto giorno versa nei vasi i doni di Dioniso che dà molta gioia.” Il rife-rimento è alla prima metà di settembre: Orione e Sirio sono al centro del cielo verso il venti set-tembre; Arturo sorge all’aurora verso i primi di settembre.
67 Cfr. STOLBERG 2001, pp. 87-90.68 RUSSO 1993, p. 71, p. 99; FISCHER-HANSEN 2001, pp. 42-45.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.48 Pagina 306
papiro69 e di un vino che faceva risalire ai coloni greci70 (il ritratto qui riprodot-to è incorniciato da papiri e serti di vite, proprio per sottolineare questo suointeresse). Tra parentesi, notiamo che il moscato di Siracusa ebbe successo: adesempio Alexandre Dumas lo cita ripetutamente (era anche gurmet, non soloromanziere).71 E’ appena il caso di ricordare l’interesse per l’agricoltura del prin-cipe di Biscari.72 Quanto a P. Mineo, la famiglia possedeva importanti estensionidi terreno, della cui amministrazione dev’essersi occupato.73 A parte le ovvieconsiderazioni sulla cultura dell’epoca, dall’inventario della libraria si deduce unbuon interesse per la scienza agraria.74 In ogni caso, per la cultura del momento,la letteratura greco-romana creava un linguaggio comune ricco di connessioni;gli autori classici fornivano le basi per la comprensione della natura umana, delruolo della società, della libertà e la necessaria lotta contro la tirannia; lo studiodi usi, costumi, religioni degli antichi era visto appunto in una prospettiva diricerca della verità: migliorare le proprie condizioni attraverso lo studio di epo-che felici.75
Nella ricerca del lago e dei luoghi di culto citati da Diodoro, Denon fa teso-ro delle osservazioni dei dotti locali e verifica di persona le antichità visibili inloco. Da allora lo stato della questione non sembra avere fatto grandi passi avan-ti. Ancora nel XX secolo studiosi locali hanno sostenuto la localizzazione dellago di Eracle nella depressione di piazza Europa (secondo la toponomasticaattuale), con motivazioni mai sostenute da dati concreti (fig. 14 n° 1).76 Un tem-pio sarebbe sorto, ovviamente, sulle rive del lago. Le argomentazioni addottesulla identificazione del tempio di Eracle e Gerione con la chiesa Abbazia (fig.14 n° 2) sono assolutamente inconsistenti; non ha senso, ad esempio, discuterese le colonne della chiesa erano veramente appartenute al tempio:77 verrebbero
307
Rosario P.A. Patané
69 RUSSO 2007, pp. 79-88; ivi bibl.70 LANDOLINA 1802; SCINÀ 1827, III, pp. 246-257; RUSSO 2007, pp. 105-114.71 Le grand dictionnaire de cuisine, pubblicato postumo nel 1873, lo elenca tra i vini liquorosi stra-
nieri; ma ne parla anche nei romanzi: i tre moschettieri brindano con moscato di Siracusa, ilconte di Montecristo non lo fa mancare ai suoi ospiti.
72 MANGANARO 1968, p. 659.73 FOTI 2004, pp. 19-20, pp. 24-25, p. 64.74 FOTI 2004, pp. 91-92.75 DÍAZ-ANDREU 2008, pp. 42-43.76 FAVALORO 1922, pp. 54-56. Il volumetto di G. Favaloro, pur comprendendo una “Pianta
dei monumenti”, non offre in realtà contributi archeologici concreti; evidentemente utilizza unaStoria di Agira inedita di P. Sinopoli, il cui dattiloscritto è oggi conservato presso la BibliotecaComunale di Agira: cfr. PATANÉ 1992, p. 77. Per l’esplorazione archeologica di Agira: SCIBONA1981; BEJOR 1984.
77 FAVALORO 1922, pp. 39-41.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.48 Pagina 307
fuori misure impossibili. In realtà i presunti resti antichi sono da ricondurreall’abbazia medievale. E comunque uno scavo archeologico ancora inedito halocalizzato una necropoli di età ellenistica dentro l’area di piazza Europa (fig. 14n° 3):78 è una presenza incompatibile con un’area sacra della stessa epoca.
A poco si riducono i resti monumentali dell’importante abbazia medievale:nel XVIII secolo la chiesa è stata rifatta nelle forme attuali; questa operazioneovviamente ha cancellato i resti del vecchio edificio. La facciata del XVIII seco-lo (fig. 15) è crollata nel 1911 (quella attuale è del 1928).79 Qualche frustulo del-l’edificio pre-settecentesco rimane visibile (inglobato nella costruzione attuale) econsente di cominciare a farsi una pallida idea dell’aspetto dell’abbazia, nell’at-tesa che concrete indagini vengano a prendere il posto delle fantasiose conget-ture su preesistenze in cui si sono visti i resti di un tempio di età greca. Su un
308
Il moscato di Dominique Vivant Denon
Fig. 14
78 Lo scavo è stato condotto nei primi anni Ottanta dalla Soprintendenza BB.CC.AA. diAgrigento, all’epoca competente per territorio, con la direzione del prof. G. Scibonadell’Università di Messina. La pubblicazione definitiva dello scavo ci potrà fornire l’esatta esten-sione cronologica della necropoli.
79 PATANÉ 1989, pp. 37-47. Ringrazio per la gentile collaborazione padre Silvio Rotondo, par-roco della Abbazia di S. Filippo, così come il suo predecessore mons. Gaetano Daidone.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.48 Pagina 308
lato della chiesa è la cappella delSacramento, preceduta da unvestibolo di pianta quadrata(che risulta accessibile sia dallachiesa sia dall’esterno). Agliinizi del XX secolo P. Sinopolidava una descrizione essenzialedi quella che definiva “anticap-pella delle SS. Reliquie”:“Questa sala era l’antica aulacapitolare, e tutt’ora conservaun po’ della sua primitiva archi-tettura normanna nelle nervatu-re che partono dagli angoli e formate a fasci di modanatura prismatica nel cen-tro della volta ove fanno chiave, si allunga una specie di capitello pensile”.80 Lasala si presenta oggi con le modanature in pietra nuda sull’intonaco di volta epareti. E’ ricoperta da una volta a crociera rinforzata da costoloni in pietra chesi dipartono da quattro colonnine poste agli angoli dell’ambiente. Le basi dellecolonnine sono ben leggibili, mentre i capitelli sono stati visibilmente sostituitiin un recente restauro (fig. 16); così come recente è la decorazione della chiavedi volta. Gli intonaci esistenti non consentono di leggere i rapporti tra i costo-loni e le colonnine e il resto della struttura; tuttavia a prima vista la sagoma deicostoloni e la tipologia delle basi delle colonnine possono indurre a restringerela cronologia al XIV secolo.81 Dall’altro lato della chiesa, all’esterno, sul cortile,sono chiaramente visibili murature precedenti inglobate nella struttura attuale.In un tratto di muratura è ben visibile un’apertura coperta da un arco a ferro dicavallo, successivamente scalpellato (fig. 16). All’angolo del cortile si apre unpassaggio che mette in comunicazione con il sacrato. L’arco è molto rovinato,ma comunque perfettamente leggibile (fig. 16).82 La forma degli archi, la moda-natura delle relative cornici, indirizzano la cronologia verso il XII-XIII secolo.Un muro è costruito con blocchi regolari: si è voluto vedere in questo muro iresti di una costruzione antica, greca;83 ma la tecnica muraria a prima vista non
309
Rosario P.A. Patané
Fig. 15
80 SINOPOLI 1911, p. 82.81 Per la crociera con costoloni a bastone cfr. la loggia trasformata in base del campanile della
Chiesa Madre di Gangi. SPATRISANO 1972, pp. 178-179.82 A sesto acuto e sormontato da una cornice aggettante costituita da lastre di pietra poste in
piano sui conci dell’arco.83 Per una lettura di questo “tratto di costruzione isodomea” come struttura di età classica,
FAVALORO 1922, p. 40.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.48 Pagina 309
310
Il moscato di Dominique Vivant Denon
Fig. 16
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.48 Pagina 310
ha nulla di classico e rimanda alMedioevo (fig. 16). Una colonnina,quel che resta di un portale (fig. 16), èvisibile in un ambiente attiguo allacappella della Madonna del Rosario,che sorge sopra alla Cateva, il localesotterraneo in cui la tradizione ponela tomba di S. Filippo (fig. 17).Potrebbe essere il caso di condurreuna serie di indagini mirate volte adaccertare se la chiesa ingloba i resti diuna precedente chiesa, più piccola edisposta trasversalmente: l’attualecappella della Madonna del Rosarioavrebbe quindi preso il posto del pre-sbiterio della chiesa precedente e ilsotterraneo con la tomba del santofondatore si troverebbe proprio sottol’altare originario.84 Dalle fonti d’archi-vio pare appunto che debba essercistata una importante fase edilizia traXI e XII secolo; un altro momentoimportante dev’essere agli inizi delXIV secolo, quando ci fu una rivitalizzazione del culto del Santo.85 Ma anchealtre notizie rintracciabili nella bibliografia locale tendono a individuare prove“archeologiche” dell’identificazione con un tempio antico. Tre statue sarebberostate individuate all’inizio del XIX secolo sotto il pavimento della chiesa: sonostate riferite a Ercole, Jolao e Gerione.86 Allo stato attuale si può solo dire che
311
Rosario P.A. Patané
Fig. 17
84 Per cripte e per sepolture nell’area del presbiterio, cfr. di recente CHAVARRÍA ARNAU 2009,pp. 72-75, 172-179.
85 SINOPOLI 1926, p. 141, pp. 152-153; MESSINA 2000, pp. 65-66.86 SINOPOLI, p. 39: “Leggiamo in una memoria manoscritta ne’ primordi del secolo passato
queste parole: ‘Nello scavo fatto a’ nostri tempi per la pavimentazione nuova della chiesa, siritrovò un gruppo di statue abbracciate rappresentanti Ercole, Jolao ed un altro nume (Gereone)formate di pietra bianca. Se questi furono i déi di Agira non è inverosimile che il celebre tempioad essi dedicato era appunto in quel luogo ove si ritrovarono le loro statue’ – Che cosa ne avven-ne di quelle statue?... Etiam periere ruinae...”. Come fonte si indica “Archiv. della R. Badia –Memoria del Priore Santi Fiorenza contro le pretese del Prevosto della chiesa di S. Antonio diPadova in Agira”.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.49 Pagina 311
non è chiaro su cosa si sia basatal’identificazione delle tre divinità:non esistono immagini e la descri-zione si limita a indicare un gruppodi statue abbracciate, in pietra bian-ca. Senza mettere in dubbio la veri-dicità della notizia,87 nulla vieta dipensare che si tratti di un grupposcultureo di altra epoca, magarirelativo alla chiesa medievale.Indagini archeologiche miratepotrebbero aiutare a chiarire. Unaltro caso di presunta provaarcheologica riguarda la coppa di
marmo usata come fonte battesimale (fig. 18): se ne parla come di un oggettoantico rinvenuto localmente. Che non sia un’opera “antica” è fuori discussione;a prima vista sembra databile nel XVI secolo, in ogni caso è coerente con le fasipre-settecentesche dell’Abbazia. I cartigli con S. Filippo, lo stemma dell’Abbaziadi S. Maria Latina, lo stemma araldico sulla destra dovrebbero essere sin troppotrasparenti; ma si è anche parlato di simulacro di Gerione.
Mi sto occupando in maniera particolare della topografia dei luoghi di cultonell’Agira di Diodoro: in questa sede mi limiterò ad anticipare qualche conside-razione. Mi piace, inoltre, avanzare delle ipotesi sulle radici di tali culti.88
Ripartiamo quindi dalla lettura di Diodoro, per descrizioni di luoghi e ritinell’Agira a cavallo tra I secolo a.C. e I d.C. Eracle sarebbe passato da Agira,durante le sue peregrinazioni in Occidente all’inseguimento dei buoi di Gerione.Lì si sarebbe reso conto della propria divinità e di conseguenza avrebbe accetta-to onori divini. La versione diodorea delle avventure di Eracle in Sicilia è la piùelaborata, ed Eracle vi appare senz’altro come l’eroe mitico della colonizzazio-ne;89 Diodoro è una fonte abbastanza tarda, ma le avventure di Eracle in Siciliaerano ben note almeno dal VI secolo a.C.90 Dalla lettura del brano di Diodoro,91
si ricava che ai suoi tempi ad Agira era molto forte il culto di Eracle, collegato aquello di Iolao e di Gerione. Partiamo intanto dai dati concreti che si deducono
312
Il moscato di Dominique Vivant Denon
Fig. 18
87 Sarebbe intanto opportuna una verifica d’archivio.88 Per questo stesso tema, cfr. PATANÉ c.d.s. a; PATANÉ c.d.s. b.89 Diod. IV 22, 6-24.90 JOURDAIN-ANNEQUIN 1988-1989, pp. 144-145; ma cfr. anche JOURDAIN-ANNEQUIN 1992,
per una possibilità di datazione ancora precedente.91 IV 24, 1-6.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.49 Pagina 312
dal testo. Uscendo per la porta Eraclea, una strada conduceva a un luogo roc-cioso “non lontano dalla città” in cui si indicavano le impronte di Eracle e deisuoi buoi. “Davanti alla città” era un lago dal perimetro di quattro stadi, sacroad Eracle. C’era un temenos sacro a Gerione e uno sacro a Iolao; ma l’aspetto delsantuario extraurbano non viene per nulla descritto. Si celebrava un agoneannuo, ginnico ed equestre (e questo è tipico dei culti eroici).92 Il culto di Eracleavveniva in associazioni93 che si riunivano per il pasto comune e per celebraresacrifici. Si può anche supporre l’esistenza di strutture architettoniche per le garee per i pasti comuni, sul tipo di quelle note in diversi santuari.94
Fin qui la descrizione di luoghi e fatti che Diodoro vedeva; fin qui nondev’esserci spazio per dubbi. Altra cosa è l’aspetto eziologico, la ricerca sulle ori-gini del mito. Diodoro si preoccupava di indicare hv, “segni”, monumenta,come le orme nella roccia, il lago. Tra l’altro va osservato che quello delle ormeimpresse nella roccia è un prodigio che per Eracle si verifica almeno in un altrocaso, citato pure da Erodoto.95 Anche il lago sembra essere un monumentumdegno di nota: l’acqua doveva avere un ruolo importante; l’avventura siciliana diEracle è costellata di sorgenti, fatte scaturire per ristorarlo dalle fatiche.96
Indagando sui luoghi di Eracle nell’Agira dei tempi di Diodoro, ci può veni-re incontro lo studio di culti successivi. Vari elementi del mito devono esserestati cristianizzati e inseriti nella leggenda di S. Filippo. Una spia può essere vistanella, già notata, consacrazione dei capelli dei ragazzi a S. Filippo Diacono comegià a Iolao.97 Non ci sono ormai dubbi sulla storicità del santo, un monaco di ori-gine orientale, vissuto intorno all’VIII-IX secolo;98 ma, come spesso accade, allafigura storica si affianca una storia leggendaria. Il mito di Eracle doveva essere
313
Rosario P.A. Patané
92 MANGANARO 1991, p. 216, p. 219 con bibl. ivi cit.93 Erano ammessi liberi e schiavi: associazioni cultuali aperte agli schiavi sono altrimenti atte-
state nel I secolo a.C. MANGANARO 1991, p. 219.94 MANICALCO, MCCONNEL 2003; MANISCALCO 2008; ivi bibliografia.95 MANGANARO 1991, p. 215. Presso il fiume Tire (in Scizia) si indicava un’orma di Eracle,
grande due cubiti, impressa nella roccia: Hdt. IV 82,1. Le misure rimandano alla statura fuoridalla norma che i Greci attribuivano agli eroi; due cubiti era lungo anche il sandalo di Perseoconservato a Chemmi, in Egitto: Hdt. II 91,3.
96 In fondo in ambiente greco i bagni termali sono spesso associati ad Eracle. MARCONI 1999,pp. 298-301.
97 Diod. IV 24,4-5 parla dei ragazzi che si lasciavano crescere i capelli, fino a quando li dedi-cavano a Iolao; e delle relative conseguenze per chi si sottraeva al rito. Si tratta chiaramente diun rito di passaggio, di cui ritroviamo traccia nel culto di S. Filippo: ancora nei primi anni delXX secolo persisteva l’uso di dedicare capelli a S. Filippo Diacono. SINOPOLI p. 8; CIACERI 1911,pp. 286-287.
98 PASINI 1981; PASINI 1999; PASINI 2000.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.49 Pagina 313
molto radicato localmente; inoltre la figura dell’eroe che era andato nell’aldilà tor-nando vivo, si prestava particolarmente ad essere cristianizzata e assimilata a quel-la di un santo per il quale ha tanta importanza la lotta contro i demoni.99 Per duemiracoli può nascere il sospetto di contaminazioni eraclee (tra l’altro, entrambi gliepisodi appartengono alla tradizione orale, piuttosto che alle più antiche versionidella Vita). La topografia dei luoghi di culto può essere interessante.
La “Pietra di S. Filippo” richiama le orme di Eracle e dei suoi buoi. I tenta-tivi di localizzare la porta eraclea nell’area SE dell’abitato100 (o anche nell’area del
314
Il moscato di Dominique Vivant Denon
99 Il mito di Eracle viene usato in molti casi in contesti funerari, proprio con riferimento alsuo andare nell’aldilà tornando vivo. Cfr. BAYET 1921-1923. Per la cristianizzazione, ad esempio,può essere interessante richiamare un sarcofago del Museo Civico di Velletri, datato intorno allametà del II secolo. Il sarcofago è di fabbrica romana. Il committente, un importante senatoredella famiglia degli Ottaviani, deve avere influito direttamente nel definire il programma filoso-fico della decorazione scultorea. Sul retro e sui lati brevi del fregio superiore sono le fatiche diErcole. Altre scene sono ricche di richiami mitologici a vita dell’oltretomba e a ritorni dall’aldi-là. Alle scene pagane si mescolano motivi cristiani, come il Buon Pastore e Adamo ed Eva nel-l’atto di cogliere il frutto dell’albero del bene e del male. Cfr. JONGSTE 1992, p. 32, pp. 39-43,con bibl. ivi cit.
100 SINOPOLI, p. 44.
Fig. 19
Fig. 20
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.49 Pagina 314
castello)101 sono di pura fantasia: nessun riferimento a dati concreti. La cappelladella “Pietra di S. Filippo” (fig. 19), ottocentesca, è costruita appunto attorno aun gran masso che la tradizione indica come scagliato, dalla cima del castello, daS. Filippo in gara con i demoni; sulla superficie del masso si indica il segnolasciato dalle dita del santo (fig. 20).102 Dei tratti di necropoli di epoca ellenisticaindicano un limite per l’estensione della città verso nord. Un tratto di necropo-li del primo ellenismo è stato esplorato alle pendici settentrionali, nell’area tra lacirconvallazione e il castello (fig. 14, n° 4);103 doveva estendersi per una superfi-cie piuttosto vasta. Abbiamo accennato al tratto di necropoli ellenistica esplora-to in piazza Europa (fig. 14, n° 3). Più a ovest doveva essere il tratto di necro-poli ellenistica a carattere monumentale da cui proviene il cippo iscritto delMuseo Biscari:104 non si può ovviamente individuare il punto esatto, ma nonsiamo lontani dall’area in cui uno scavo recente ha individuato un tratto dinecropoli (fig. 14, n° 5).105 Meno interessante ai nostri fini, ma pur sempre indi-cativo, è un tratto di necropoli paleocristiana con tombe ad arcosolio, individua-to nell’area della Grotta di S. Filippo (fig. 14, n° 6)106 e che doveva occupare lebalze rocciose lungo il Vallone Ardensia. Leggendo in negativo lo sviluppo dellanecropoli e tenendo conto dell’orografia, si può agevolmente ipotizzare l’anda-mento di una cinta muraria che correva all’incirca lungo lo strapiombo tra (ser-vendoci per comodità della toponomastica attuale) via Vittorio Emanuele e laCirconvallazione, fino all’area di piazza Garibaldi; lì, alla sommità di via Roma,doveva aprirsi la porta Eraclea menzionata da Diodoro. Fuori, in prossimitàdella porta, erano i segni nella roccia, luogo di culto: è possibile che siano staticristianizzati nella “Pietra di S. Filippo” (fig. 14, n° 7).
Altro luogo indicato da una strana tradizione è la Fontana di Maimone, sededi un’altra epica lotta: S. Filippo, incatenato dal demonio, riuscì a liberarsiall’istante; mentre il demonio, legato con un capello del santo, rimase prigionie-ro e fu confinato dentro la voragine da cui scaturisce l’acqua.107 La vittoria sul-
315
Rosario P.A. Patané
101 FAVALORO 1922, pp. 58-59. Inutile sottolineare l’assurdità di voler localizzare nel castello,sulla vetta, una porta urbica da cui si raggiungeva un santuario extraurbano.
102 La Vita eusebiana al § 26 riporta l’episodio dei demoni che facevano rotolare giù pietre cheuccidevano i passanti, problema risolto grazie all’intervento di S. Filippo. Evidentemente si trat-ta di cosa ben diversa dalla gara di lancio tra S. Filippo e il demonio, che non risulta quindi docu-mentata nella Vita. PITRÉ 1900, pp. 34-35.
103 SCIBONA 1981; COTTONARO c.d.s.104 IG XIV 588.105 Scavo della Soprintendenza BB.CC.AA. in via Vittorio Emanuele, 2008-2009.106 MESSINA 2000, p. 71; MESSINA 2001, p. 120.107 Anche in questo caso, l’episodio non è riportato dalla Vita. Al § 12 la fonte Mamoniea
(Mamoniaian all’acc.) è citata per il miracolo della risurrezione di un giovane, morto dopo averebevuto acqua attinta da quella fonte.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.49 Pagina 315
l’avversario malvagio, ricordata dallafonte d’acqua, richiama alla memoria illago di Eracle. Ovviamente non possia-mo localizzare le leggende, ma la topo-grafia dei luoghi di culto può essereinteressante per riflettere su certe con-tinuità. La “Pietra di S. Filippo” si trovain un luogo compatibile con una cintamuraria e con la porta Eraclea menzio-nata da Diodoro; la Fontana diMaimone è esattamente un chilometro
ad ovest (fig. 14, n° 8), al di là della sella della Chianotta, “davanti alla città”: loca-lità ricca d’acqua, sulla strada antica verso Assoro ed Enna108. La localizzazionesulla cartografia del XVIII secolo109 risulta più immediata (fig. 21). C’è da chie-dersi se il temenos di Eracle non possa essere cercato da queste parti.
Sull’avventura siciliana di Eracle si è riflettuto molto; esistono diversi puntidi vista. Le imprese di Eracle in Occidente rappresentano certo la sistemazionemitologica dei contatti tra i Greci e le popolazioni locali; è stato evidenziato ilruolo di Stesicoro in tutto ciò.110 Il caso di Agira è particolarmente interessante:non fu colonia greca fino alla rifondazione di Timoleonte;111 ma presenta chiarisegni di contatti con l’ambiente coloniale almeno dal VI secolo a.C.112 Almenoin un altro caso il culto di Eracle è stato segnalato in un centro indigeno dell’in-terno, a Colle Madore, osservandone il ruolo di mediazione tra l’ambiente indi-geno e quello coloniale.113 In ogni caso è chiaro che Eracle ha un ruolo nei pro-cessi di acculturazione: è l’ “eroe civilizzatore”, che arriva, sbaraglia guerrierilocali e, prima di allontanarsi, lascia elementi di civiltà tra i barbari.114 IlLokalpatriotismus di Diodoro può aver influito nel localizzare ad Agira il mito di
316
Il moscato di Dominique Vivant Denon
Fig. 21
108 UGGERI 2004, pp. 242-243.109 DUFOUR 1995, tav. 12.110 MURRAY 1988-1989, part. pp. 11-12; D’AGOSTINO 1995. Cfr. anche GIANGIULIO 2003. Si
è anche parlato di uso strumentale del mito: Eracle come precursore della colonizzazione dori-ca. Ma è stato osservato che si muove regolarmente nei posti sbagliati; Agira tra l’altro non hanulla a che fare con la colonizzazione dorica.
111 PATANÉ 1992.112 L’esistenza di un tempietto con decorazione architettonica di tipo greco lascia supporre
che quanto meno l’élite locale avesse contatti abbastanza forti con l’ambiente coloniale. BERNABÒBREA 1947; VERONESE 2006, p. 226.
113 MARCONI 1999, part. pp. 303-305.114 Cfr. di recente le sistematiche osservazioni in MARTIN 1979; BURKERT 1992; MARCONI
1999.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.49 Pagina 316
origine dell’immortalità di Eracle e dei conseguenti onori divini;115 ma questo èun dettaglio ininfluente ai nostri fini.116
C’è stato tutto un filone di ricerca che ha visto nelle avventure di Eracle inOccidente un’eco dei contatti tra micenei e popolazioni locali.117 Ad Agira Eraclepromuove il culto eroico di Gerione, avversario sconfitto ma anche essere di natu-ra divina.118 E’ stato osservato che i nomi degli eroi locali sconfitti da Eracle nel-l’interno della Sicilia possono rinviare al lessico miceneo più che al lessico grecodi età classica; e in ogni caso non sono nomi propri ma appellativi: ad es.Léukaspis, “L’uomo con lo scudo bianco”, o Pediakràtes, “Il dominatore della pia-nura”.119 Di contro un’altra posizione ha negato la possibilità di collegare singolielementi della tradizione mitico-leggendaria a singoli fatti di frequentazione mice-nea documentati archeologicamente.120 Non è certo il caso di scendere al dettaglionel confronto della tradizione leggendaria con singoli fatti documentati archeolo-gicamente; ma sono ormai ben documentati archeologicamente i contatti miceneicon la Sicilia e la sopravvivenza di motivi egei in Sicilia in momenti ben successi-vi alla caduta dei regni micenei. Il mito di Eracle in occidente può anche esseresorto proprio intorno al VI secolo a.C., o non molto prima; ci sono però dellecoincidenze che possono indurre a ristudiare il problema.
Nell’ottica dei contatti egei con la Sikania121 è interessante un dato relativo allacostruzione del tempio delle Meteres ad Engyon. Il racconto diodoreo della leg-genda di Dedalo,122 mette in evidenza alcuni aspetti “siciliani”: la figura diDedalo e le sue opere in Sicilia; la morte di Minosse a Kamikos; l’insediamentodei Cretesi in Sicilia, a Minoa e ad Engyon. Il dato leggendario viene a corri-spondere con i risultati della ricerca archeologica: il racconto dei contatti traCreta e il regno sicano di Kokalos in età precedente alla colonizzazione storicatrova riscontro nelle scoperte archeologiche:123 a S. Angelo Muxaro, a Milena; ma
317
Rosario P.A. Patané
115 Altre versioni attribuivano lo stesso ruolo a Delfi e ad Atene.116 Strano l’atteggiamento spesso tenuto in proposito, tendente a non considerare proprio
l’episodio di Agira, visto come un aition di carattere locale; SJÖQVIST 1962, p. 119.117 MANNI 1962, pp. 6-29; SJÖQVIST 1962, pp. 117-123; MANNI 1963, pp. 29-49; MANNI 1969,
pp. 5-23; LÉVÉQUE 1973, pp. 43-66; BRACCESI 1977, p. 21; BRACCESI 1980, pp. 64-66.118 PAGE 1973; BRACCESI 1980, pp. 65-66; BRIZE 1988; D’AGOSTINO 1995, p. 10.119 SJÖQVIST 1962, pp. 120-121; JOURDAIN-ANNEQUIN 1988-1989, p. 161.120 GIANGIULIO 1983; GIANGIULIO 2003.121 Sul concetto di Sikania come zona centro-meridionale della Sicilia, con influenze egee, LA
ROSA 1989; LA ROSA 1999.122 IV 76-88.123 PUGLIESE CARRATELLI 1956, pp.89-103; RIZZA 1979, pp. 19-30; MUSTI 1988, pp. 21-36;
DE MIRO 1991; LA ROSA 1993-1994, pp. 9-47; TOMASELLO 1995-1996; S. Angelo Muxaro 1999,pp. 79 ss.; LA ROSA 2005; PALERMO 1999; PALERMO, TANASI, PAPPALARDO 2009.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.49 Pagina 317
anche in località interne come Sabucina e ora soprattutto Polizello.124 Dopo lamorte di Minosse, i Cretesi finiscono in Puglia;125 e quindi ad Engyon, nell’inter-no della Sicilia. Il racconto di Diodoro è il più dettagliato; ma negli stessi anniCicerone parla di santuario di origine cretese;126 e in seguito ne parla Plutarco.127
Le notizie sui Cretesi in Sicilia risalgono quanto meno a Timeo, e comunque afonti anche cretesi;128 e un’iscrizione da Creta riporta in ambito cultuale il nomedelle Meteres.129 Parlando del tempio delle Meteres ad Engyon, importante anco-ra ai suoi tempi, Diodoro dice:130 “(...) non avendo pietra adatta nel loro territo-rio, la importarono dai vicini, gli abitanti di Agira, sebbene le città fossero distan-ti circa cento stadi, e la strada per la quale necessariamente si dovevano traspor-tare i blocchi di pietra fosse aspra ed assolutamente impraticabile. Per questaragione, dopo aver costruito carri da trasporto a quattro ruote, con l’impiego dicento coppie di buoi trasportarono la pietra”. Può nascere il sospetto cheDiodoro, nel registrare la notizia, abbia cercato di spiegarsene le cause raziona-lizzando. Ad Agira ci sono buone cave; ma in un raggio di cento stadi, pocomeno di venti chilometri, non è che manchi la pietra da costruzione. Il difficiletrasporto del materiale per il tempio può essere dipeso da motivi ideologici,determinati dai rapporti tra i cretesi di Engyon e Agira. Tra l’altro non dimenti-chiamo che Agira non è solo la città natale di Diodoro; è un importante nodoviario: vi si incontra la direttrice est-ovest (che dalla Piana di Catania, attraversole montagne dell’interno, raggiunge la Sicilia occidentale) con la direttrice sud-nord (che collega l’area Agrigento-Gela con la costa settentrionale).131
Per l’identificazione della città di Engyon, due sono i punti di riferimento: a)cento stadi da Agira, b) non lontana da Apollonia, città della costa tirrenica.132 E’ovvio che, una volta tracciato un cerchio di circa cento stadi di raggio con cen-tro Agira, bisogna anche tenere conto delle città antiche note; d’altra parte, le
318
Il moscato di Dominique Vivant Denon
124 PALERMO 2006; PALERMO, TANASI 2006, 97-99.125 Dove l’archeologia conferma presenze micenee. Di recente: AMPOLO 1990; CULTRARO
2006, pp. 226-227; ivi bibliografia precedente.126 2Verr. III,103; IV,97-98; V,18.127 Marcello 20,3.128 STAVRIANOPOULOU 1993; ivi bibliografia.129 STAVRIANOPOULOU 1993.130 IV 80, 5.131 ADAMESTEANU 1962; BEJOR 1973, pp. 749-750, p. 756 ss.; PATANÉ 1992, p. 68.132 Timoleonte nel 342 a.C. liberò Engyon e Apollonia dal tiranno Leptine; quindi è poco
probabile che Engyon vada cercata a sud di Agira: Diod. 16, 72, 3-5. Il contesto non consentedi ricostruire percorsi e campagne militari; solo un vago riferimento ad azioni militari nei con-fronti di Lentini. Plutarco, Vita di Timoleonte 24, precisa che Leptine governava su Apollonia emolte altre città.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.49 Pagina 318
osservazioni basate sulla viabilità antica non possono essere molto precise. Sonostate proposte diverse identificazioni; nessuna definitiva.133 Se ci spostiamo unpo’ ad est, verso l’area etnea, nell’alta valle del Simeto ci imbattiamo in una con-sistente presenza di tombe a finta tholos, con datazioni che arrivano al VII seco-lo a.C. (fig. 22).134 Al Mendolito è un buon numero di tombe circolari, con dro-mos e con copertura a finta cupola (fig. 23);135 mentre non abbiamo elementi perl’alzato di altre strutture circolari, per le quali rimane quanto meno il dubbio del-l’influenza del tipo della tholos: Centuripe (fig. 24),136 Paternò.137 A contatti crete-si rimandano frammenti di una coppa in lamina di bronzo ed elementi di colla-na in vetro e ambra dal corredo di una tomba della tarda Età del Bronzo, XVII-XVI secolo a.C., nei pressi di Adrano (fig. 25).138 All’area etnea (forse proprioPaternò) è stato riferito un paio di doppie corna in argilla (fig. 26): una tipologia
319
Rosario P.A. Patané
Fig. 22
133 BEJOR 1989; MANGANARO 1991, pp. 211-213, con bibl. precedente.134 LA ROSA 2007.135 PELAGATTI 1964-1965, pp. 247-248; ORSI, PELAGATTI, 1967-68; ALBANESE PROCELLI
2003, p. 64.136 ORSI 1913, pp. 93-97; ALBANESE PROCELLI 2003, p. 64, p. 81.137 ALBANESE PROCELLI 2003, pp. 64-66, p. 81.138 CULTRARO 1989; CULTRARO 2006, p. 222, p. 225; CULTRARO 2007, pp. 76-79.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.49 Pagina 319
320
Il moscato di Dominique Vivant Denon
Fig. 23 Fig. 24
Fig. 25 Fig. 26
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.49 Pagina 320
tipica di Creta nel XII secolo a.C. (ma anche in epoche successive).139 In fondol’area in cui deve comunque ricadere Engyon comunica con la costa orientaleattraverso la valle del Simeto; e l’esistenza di un approdo miceneo nell’area trala foce del Simeto e la foce del San Leonardo sembra ormai accertata.140
Cicerone allude alla cognatio con Roma da parte di Segestani e Centuripini. PerSegesta il legame con la saga di Enea è evidente. Sempre nella tarda età repub-blicana si data un’iscrizione mutila da Centuripe, con il resoconto di una missio-ne diplomatica a Roma e a Lanuvio e il rinnovo della cognatio tra Centuripe eLanuvio; nella città siciliana, ellenofona, si traduceva ‘syngheneia’. Si parla diLanuvio come colonia di Centuripe, fondata da Lanoios, siciliano al seguito diEnea.141 Ho avuto modo di indagare diffusamente sui rapporti tra Centuripe-Lanuvio-Roma nel periodo tra la prima guerra punica e gli anni di Cicerone;142
ma anche in età imperiale, nel periodo della Seconda Sofistica e della valorizza-zione delle identità storico-culturali locali nell’ambito dell’Impero.143 Sulla sagaeneica e i contatti tra Egeo, Sicilia e Italia tirrenica sono stati versati fiumi d’in-chiostro.144 Per i rapporti tra Roma e la Sicilia, nell’ambito dell’espansionismoromano, possono avere sapientemente sfruttato un motivo tradizionale.Abbiamo visto però le finte tholoi; e materiali che fanno pensare a contatti egei.Possono essere solo coincidenze; ma ci si può anche chiedere se Lanoios nonadombri in realtà remoti contatti egei con l’area dell’alto Simeto.145
Eracle ad Agira, Engyon, Lanoios al momento per l’archeologia rimangonofantasmi; anche se un convergere di coincidenze può nutrire dubbi. Il culto diEracle nell’Agira ellenistico-romana comincia un po’ ad uscire dalle nebbie. Lafunzione del mito di Lanoios nella Centuripe di età romana si va ormai delinean-do con una certa chiarezza; ma questa è un’altra storia. Del resto, nel XVIIIsecolo non indagavano su Lanoios; non indagavano neanche sulle antichità diNicosia e Sperlinga, che oggi hanno una realtà archeologica.146
321
Rosario P.A. Patané
139 LA ROSA, MAZZOLENI, PEZZINO 2002.140 TANASI 2004, pp. 421-428.141 MANGANARO 1963; MANGANARO 1974.142 PATANÉ 2002; ivi bibliografia precedente.143 PATANÉ 2010.144 Cfr. quanto meno ZEVI 1989; ZEVI 1999.145 Non pare sufficientemente dimostrato, invece, il tentativo di spiegare la cognatio sulla base
dell’origine laziale di Sikelos (per usare il linguaggio del mito), dei legami peninsulari dei Siculi(pur evidenziati sia dall’archeologia sia dalla ricerca linguistica). LA MOTTA 2008, part. p. 110.
146 Per la ricerca archeologica cfr. SCIBONA 1993; VALBRUZZI 2009.
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.49 Pagina 321
BIBLIOGRAFIA CITATA
ABBATE 2001 = V. ABBATE, Wunderkammern e meraviglie di Sicilia, in V. ABBATE(ed.), Wunderkammer siciliana alle origini del museo perduto, Napoli 2001, pp. 17-46ADAMESTEANU 1962 = D. ADAMESTEANU, Note su alcune vie siceliote di penetrazione,in Kokalos VIII, 1962, pp. 199-209AGNELLO 1960 = G. AGNELLO, Il castello di Agira, in SicGymn, n.s. XIII, 1960, pp.226-241, ora in ID, L’architettura civile e religiosa in Sicilia nell’età sveva, Roma 1961AGNELLO 1968 = G. AGNELLO, Il Museo Archeologico di Siracusa e le poco note vicen-de della sua fondazione, in SicGymn, n.s. XXI, 1968, pp. 38-69ALBANESE PROCELLI 2003 = R.M. ALBANESE PROCELLI, Sicani, Siculi, Elimi.Forme di identità, modi di contatto e processi di trasformazione, Milano 2003ALBERTI 1995 = S.A. ALBERTI, Il castello di Agira, in C.A. DI STEFANO, A. CADEI(edd.), Federico e la Sicilia. Dalla terra alla corona, I, Archeologia e architettura, Palermo1995, pp. 528-543AMPOLO 1990 = C. AMPOLO, Storiografia greca e presenze egee in Italia. Una messa apunto, in PP, CCLIV, 1990, pp. 358-369ATTARDI 1742 = B. ATTARDI, Storia dell’integra città di S. Filippo d’Aggira, Palermo1742BAYET 1921-1922 = J. BAYET, Hercule funéraire, in MEFRA, 39, 1921-1922, pp.219-266; 40, 1923, pp. 19-102BEAUREPAIRE 2006 = P.-Y. BEAUREPAIRE, Grand Tour, République des Lettres ereti massoniche: una cultura della mobilità nell’Europa dei Lumi, in G.M. CAZZANIGA(ed.), La Massoneria (Storia d’Italia. Annali 21), Torino 2006, pp. 31-49BEJOR 1973 = G. BEJOR, Tucidide 7,32 e le vie nel settentrione dellaSicilia, in AnnPisa, s.III, III,3, 1973, pp. 741-765BEJOR 1984 = G. BEJOR, s.v. Agira, in Bibliografia Topografica della ColonizzazioneGreca in Italia e nelle Isole Tirreniche, III, Pisa-Roma 1984, pp. 60-66BEJOR 1989 = G. BEJOR, s.v. Engio, in Bibliografia Topografica della ColonizzazioneGreca in Italia e nelle Isole Tirreniche, VII, Pisa-Roma 1989, pp. 185-188BERNABÒ BREA 1947 = L. BERNABÒ BREA, Agira.- Terracotte architettoniche rinvenu-te entro il Castello Svevo, in NSc 1947, p. 250BOARDMAN 1997 = J. BOARDMAN, in LIMC, s.v. Pan, VIII Suppl., 1997, pp. 923-941
322
Il moscato di Dominique Vivant Denon
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.49 Pagina 322
MOESCH 2009 = V. MOESCH (ed.), La Villa dei Papiri, Napoli 2009BRACCESI 1977 = L. BRACCESI, Grecità adriatica, Bologna 19772
BRACCESI 1980 = L. BRACCESI, Trattazione storica, in E. GABBA, G. VALLET (edd.),Sicilia antica, Napoli 1980, pp. 53-86BRIZE 1985 = PH. BRIZE, Samos und Stesichoros. Zu einen früarchaischen Bronzeblech,in AM, C, 1985, 53-90, taff.15-24, Beil. 2BRIZE 1988 = PH. BRIZE, s.v. Geryoneus, in LIMC, IV, Zürich-München 1988, pp.186-190BURKERT 1992 = W. BURKERT, Eracle e gli altri eroi culturali del Vicino Oriente, in C.BONNET, C. JOURDAIN-ANNEQUIN (edd.), Héraclès. D’une rive à l’autre de laMéditerranée. Bilan et perspectives (Actes de la Table Ronde de Rome, 15-15 septembre1989), Bruxelles - Roma 1992, pp. 111-127CASTORINA 1998 = A. CASTORINA, “Copia grande di antichi sepolcri”. Sugli scavidelle necropoli in Italia meridionale tra Settecento e inizio Ottocento, in RIASA, ser. III,19-20, 1996-1997 (1998), pp. 305-344CATALANO 2007 = G. CATALANO, Musei invisibili. Idea e forma della collezione nell’ope-ra di Goethe, Roma 2007CESERANI 2000 = G. CESERANI, The charm of the Siren: the place of classical Sicily inhistoriography, in CH. SMITH, J. SERRATI (edd.), Sicily from Aeneas to Augustus. NewApproaches in Archaeology and History, Edinburgh 2000, pp. 174-193CHAVARRÍA ARNAU 2009 = A. CHAVARRÍA ARNAU, Archeologia delle chiese, Roma2009CIACERI 1911 = E. CIACERI, Culti e miti nella storia dell’antica Sicilia, Catania 1911CIURCINA 2008 = C. CIURCINA, Il Museo Civico ottocentesco e le vicende della sua istitu-zione, in A. CRISPINO, A. MUSUMECI (edd.), Musei nascosti. Collezioni e raccolte archeo-logiche a Siracusa dal XVIII al XX secolo, Napoli 2008, pp. 50-54CLUVERIUS 1619 = PH. CLUVERIUS, Sicilia antiqua, Lione 1619COMETA 1999 = M. COMETA, Il romanzo dell’architettura. La Sicilia e il Grand Tournell’età di Goethe, Roma-Bari 1999COTTONARO c.d.s. = M. COTTONARO, Agira: ricerche archeologiche nella necropoli divia Palazzo, in Note di viaggio. Quaderni della Soprintendenca BB.CC.AA. di Enna, 1,2010, c.d.s.CULTRARO 1989 = M. CULTRARO, Il Castellucciano etneo nel quadro dei rapporti tra
323
Rosario P.A. Patané
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.49 Pagina 323
Sicilia, penisola italiana ed Egeo nei secc. XVI e XV a.C., in Sileno, XV, 1989, pp. 259-282CULTRARO 2006 = M. CULTRARO, I micenei. Archeologia, storia, società dei Greci primadi Omero, Roma 2006CULTRARO 2007 = M. CULTRARO, La regione etnea fra Neolitico ed antica età delBronzo: dinamiche culturali e sviluppo crono-tipologico, in F. PRIVITERA, V. LA ROSA(edd.), In Ima Tartara. Prestoria e leggenda delle grotte etnee, Palermo 2007, pp. 57-80DACOS 1979 = N. DACOS, Arte italiana e arte antica, in Storia dell’arte italiana, 3,Torino 1979, pp. 5-68D’AGOSTINO 1995 = B. D’AGOSTINO, Eracle e Gerione: la struttura del mito e la sto-ria, in AIONArch, 1995, pp. 8-13D’ALCONZO 1999 = P. D’ALCONZO, L’anello del re. Tutela del patrimonio storico-arti-stico nel Regno di Napoli (1734-1824), Firenze 1999DE LACHENAL 1995 = L. DE LACHENAL, Spolia. Uso e reimpiego dell’antico dal III alXIV secolo, Milano 1995DE MIRO 1991 = E. DE MIRO, Eredità egeo-micenea e alto arcaismo in Sicilia, in D.MUSTI et alii (edd.), La transizione dal miceneo all’alto arcaismo. Dal palazzo alla città,Roma 1991, pp. 593-617DÍAZ-ANDREU 2008 = M. DÍAZ-ANDREU, A World History of Nineteenth-CenturyArchaeology. Nationalism, Colonialism and the Past, Oxford 2008DUFOUR 1995 = L. DUFOUR (ed.), La Sicilia disegnata. La carta di Samuel VonSchmettau 1720-1721, Palermo 1995FAVALORO 1922 = G. FAVALORO, Agyrion. Memorie storiche ed archeologiche, Catania1922FAZELLUS 1558 = TH. FAZELLUS, De rebus siculis decades duae, Palermo 1558FEDI 2006 = F. FEDI, Comunicazione letteraria e “generi massonici” nel Settecento italia-no, in G.M. CAZZANIGA (ed.), La Massoneria (Storia d’Italia. Annali 21), Torino2006, pp. 50-89FINO 2008 = L. FINO, La Sicilia. Vedute e ricordi di viaggio di fine '700, Sorrento(NA) 2008FIORENTINI 2005 = G. FIORENTINI, Monumenti e luoghi classici della Sicilia nelle testi-monianze dei viaggiatori stranieri tra la metà del XVIII e la metà del XIX secolo, in SiciliaAntiqua, II, 2005, pp. 193-218
324
Il moscato di Dominique Vivant Denon
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.49 Pagina 324
FISCHER-HANSEN 2001 = T. FISCHER-HANSEN, La conoscenza dell’Italia meridionalee della Sicilia greca in Danimarca nel Settecento. Il vescovo Frederik Münter e il cavaliereSaverio Landolina, in AnalRom, XXVIII, 2001, pp. 35-64FOTI 2004 = R.L. FOTI, Pietro Mineo. Un prete siciliano tra regalismo borbonico e filo-giansenismo, in R.L. FOTI, L. SCALISI (edd.), Agira tra XVI e XIX secolo. Studi e ricer-che su una comunità di Sicilia, Caltanissetta - Roma 2004, pp. 7-118FRUGONI 1984 = C. FRUGONI, L’antichità: dai Mirabilia alla propaganda politica, inS. SETTIS (ed.), Memoria dell’antico nell’arte italiana, I, Torino 1984, pp. 5-72GIANGIULIO 1983 = M. GIANGIULIO, Greci e non-greci in Sicilia alla luce dei culti edelle leggende di Eracle, in Forme di contatto e processi di trasformazione nelle società anti-che (CEFR 67), Pisa-Roma 1983, pp. 785-845GIANGIULIO 2003 = M. GIANGIULIO, Eracle in Sicilia occidentale. Ancora, in Quartegiornate internazionali di studi sull’area elima (Erice, 1-4 dicembre 2000), Pisa 2003, pp.719-725GIARRIZZO 1967 = G. GIARRIZZO, Ricerche sul Settecento italiano. Appunti per la sto-ria culturale della Sicilia settecentesca, in Rivista Storica Italiana, LXXIX, 1967, pp. 573-627GIARRIZZO 1981 = G. GIARRIZZO, Vico, la politica, la storia, Napoli 1981GIARRIZZO, PAFUMI 2009 = G. GIARRIZZO, S. PAFUMI (edd.), Oggetti, uomini, idee.Percorsi multidisciplinari per la storia del collezionismo, Pisa-Roma 2009GRINGERI PANTANO 1999 = F. GRINGERI PANTANO, Jean Hoüel, architetto, pittore,incisore e il “progetto Sicilia”, in F. GRINGERI PANTANO (ed.), Jean Hoüel e la Sicilia.Gli Iblei nel Voyage pittoresque 1776-1779, Palermo 1999, pp. 9-25GRINGERI PANTANO 2003 = F. GRINGERI PANTANO, Jean Hoüel. Voyage aSiracusa, Palermo 2003GRINGERI PANTANO 2009 = F. GRINGERI PANTANO, L’isola del viaggio, Catania2009GUALANDI 1978-1979 = G. GUALANDI, Neoclassico e antico, Ricerche di storia dell’ar-te 8, 1978-79, pp. 5-26GUALANDI 1984 = G. GUALANDI, Il collezionismo e le realizzazioni museali dall’anti-chità all’età neoclassica, in C. MORIGI GOVI, G. SASSATELLI (edd.), Dalla Stanza delleAntichità al Museo Civico. Storia della formazione del Museo Civico Archeologico diBologna, Bologna 1984, pp. 87-98HARTOG 1996 = F. HARTOG, Il confronto con gli antichi, in S. SETTIS (ed.), I Greci.
325
Rosario P.A. Patané
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.49 Pagina 325
Storia Cultura Arte Società, I. Noi e i Greci, Torino 1996, pp. 3-37HOUEL 1785 = J. HOUEL, Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malte et de Lipari,III, Paris 1785JONGSTE 1992 = P.F.B. JONGSTE, The Twelve Labours of Hercules on Roman sarcopha-gi, Roma 1992JOURDAIN-ANNEQUIN 1988-1989 = C. JOURDAIN-ANNEQUIN, Etre un grec enSicile: le mite d’Héraclès, in Kokalos XXXIV-XXXV, 1988-1989, pp. 143-166JOURDAIN-ANNEQUIN 1992 = C. JOURDAIN-ANNEQUIN, Héraclés en Occident, in C.BONNET, C. JOURDAIN-ANNEQUIN (edd.), Héraclès. D’une rive à l’autre de laMéditerranée. Bilan et perspectives (Actes de la Table Ronde de Rome, 15-15 septembre1989), Bruxelles - Roma 1992, pp. 263-291LA MOTTA 2008 = CH. LA MOTTA, Le identità dei Siculi, in S. LO PINZINO, G.D’URSO (edd.), Atti delle giornate di storia locale. Nicosia 2007-2008, Assoro 2008,pp. 97-110LANDOLINA 1802 = S. LANDOLINA NAVA, Dell’antico vino pollio siracusano, s.l.,1802; rist. a cura di C. Morrone e D. Scarfì, Siracusa 2000LA ROSA 1989 = V. LA ROSA, Le popolazioni della Sicilia: Sicani, Siculi, Elimi, in G.PUGLIESE CARRATELLI (ed.), Italia omnium terrarum parens, Milano 1989, pp. 3-110LA ROSA 1993-1994 = V. LA ROSA, Influenze di tipo egeo e paleogreco in Sicilia, inKokalos XXXIX-XL, 1993-1994, pp. 9-47LA ROSA 1999 = V. LA ROSA, Processi di formazione e di identificazione culturale edetnica delle popolazioni locali in Sicilia dal medio-tardo bronzo all’età del ferro, in M.BARRA BAGNASCO, E. DE MIRO, A. PINZONE (edd.), Magna Grecia e Sicilia. Statodegli studi e prospettive di ricerca. Atti dell’Incontro di Studi Messina 2-4 dicembre 1996,Messina 1999, pp. 159-185LA ROSA 2005 = V. LA ROSA, Creta in Italia, in R. GIGLI (ed.), MEGALAINHSOI Studi dedicati a Giovanni Rizza per il suo ottantesimo compleanno (SMAM 2),Catania 2005, I, pp. 273-290LA ROSA 2007 = V. LA ROSA, Di tradizione cretese alcune tombe protostoriche dell’areaetnea?, in CretAnt, 8, 2007, pp. 315-323LA ROSA, MAZZOLENI, PEZZINO 2002 = V. LA ROSA, P. MAZZOLENI, A.PEZZINO, Doppie corna di tipo cretese in una collezione siciliana, in CretAnt, 3, 2002, pp.247-253LÉVÉQUE 1973 = P. LÉVÉQUE, Colonisation grecque et syncrétisme, in Les syncrétismes
326
Il moscato di Dominique Vivant Denon
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.49 Pagina 326
dans les religions grecque et romaine. Colloque de Strasbourg (9-11 Juin 1971), Paris 1973,pp. 43-66LO IACONO, MARCONI 1997 = G. LO IACONO, C. MARCONI, L’attività dellaCommissione di Antichità e Belle Arti in Sicilia. Parte I 1827-1835 (QuadMusSalinas,Supplemento 3, 1997)LOSURDO 1987 = D. LOSURDO, Rivoluzione francese e immagine dell’antichità classica:da Constant a Nietzsche, in QuadStor, XIII,26, 1987, pp. 93-106MANGANARO 1963 = G. MANGANARO, Un Senatus consultum in greco dei Lanuvini eil rinnovo della cognatio con i Centuripini, in RendAccadNapoli, n.s. XXXVIII, 1963,pp.23-44MANGANARO 1968 = G. MANGANARO, s.v. Biscari, Ignazio Paternò Castello principedi, in Dizionario Biografico degli Italiani, 10, Roma 1968, pp. 658-660MANGANARO 1974 = G. MANGANARO, Una biblioteca storica nel Ginnasio diTauromenion e il P.Oxy 1241, in PP, CLVIII - CLIX, 1974, pp.389-409MANGANARO 1991 = G. MANGANARO, Note diodoree, in E. GALVAGNO, C. MOLÈVENTURA (edd.), Mito Storia Tradizione. Diodoro Siculo e la storiografia classica,Catania 1991, pp. 201-226MANISCALCO 2008 = L. MANISCALCO (ed.), Il Santuario dei Palici. Un centro di cultonella Valle del Margi, Catania 2008MANISCALCO, MCCONNEL 2003 = L. MANISCALCO, B.E. MCCONNEL, TheSanctuary of the Divine Palikoi (Rocchicella di Mineo, Sicily): Fieldwork from 1995 to2001, in AJA 107, 2003, pp. 145-180MANNI 1962 = E. MANNI, Minosse ed Eracle nella Sicilia dell’età del bronzo, inKokalos, VIII, 1962, pp. 6-29MANNI 1963 = E. MANNI, Sicilia pagana, Palermo 1963MANNI 1969 = E. MANNI, La Sicile à la veille de la colonisation grecque, in REA, 71,1969, pp. 5-22MARCONI 1999 = C. MARCONI, Eracle in terra indigena?, in S. VASSALLO (ed.), ColleMadore. Un caso di ellenizzazione in terra sicana, Palermo 1999, pp. 293-305MARTIN 1979 = R. MARTIN, Introduction à l’étude du culte D’Héraclès en Sicile, inRecherches sur les cults grecs et l’Occident, 1, Napoli 1979, pp. 11-17MARTINEZ LA RESTIA 1955-1956 = B. MARTINEZ LA RESTIA, Saverio Landolina –Nava fondatore del Museo Archeologico di Siracusa, in Arch.St.Sic.Or., LI-LII, l955-1956, pp. 94-111
327
Rosario P.A. Patané
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.49 Pagina 327
MAURICI 1992 = F. MAURICI, Castelli medievali in Sicilia. Dai bizantini ai normanni,Palermo 1992MAURICI 1997 = F. MAURICI, Federico II e la Sicilia. I castelli dell’imperatore, Catania1997MAURICI 2001 = F. MAURICI, Agira o San Filippo d’Argirò, in Castelli medievali diSicilia, Palermo 2001, pp. 184-186MESSINA 2000 = A. MESSINA, La grotta di S. Filippo, in S. Filippo d’Agira.Agiografia Storia Ambiente, Agira 2000, pp. 69-81MESSINA 2001 = A. MESSINA, Le chiese rupestri del Val Demone e del Val di Mazara,Palermo 2001MOMIGLIANO 1955 = A. MOMIGLIANO, Ancient History and the Antiquarian, inContributo alla Storia degli Studi Classici, I, 1955, pp. 67-93MOMIGLIANO 1979 = A. MOMIGLIANO, La riscoperta della Sicilia antica da T. Fazelloa P. Orsi, in AA.VV., Storia della Sicilia, I, Napoli 1979, pp. 767-780 = ID., in StudiUrbinati, 52, 1978, pp. 5-23 – ora in A. MOMIGLIANO, Settimo contributo alla storiadegli studi classici e del mondo antico, Roma 1984, pp. 115-132MOMIGLIANO 1984 = A. MOMIGLIANO, The Rediscovery of Greek History in theEighteenth Century: The Case of Sicily, in R. RUNTE (ed.), Studies in Eighteenth-CenturyCulture, 9, University of Wisconsin Press, 1979, pp. 167-187 – ora in A.MOMIGLIANO, Settimo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Roma1984, pp. 133-153MORGAN 1999 = C. MORGAN, The Archaeology of Ethnicity in the colonial World ofthe eighth to sixth centuries BC: Approaches and perspects, in Confini e frontiera nella gre-cità occidentale (Atti del trentasettesimo Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 3-6 ottobre 1997), Taranto 1999, pp. 85-145MOTTOLA MOLFINO 1991 = A. MOTTOLA MOLFINO, Il libro dei musei, Milano1991MOZZILLO 1979 = A. MOZZILLO, In Sicilia e altrove con Dominique Vivant Denon, inSettecento Siciliano, pp. 1-135MURRAY 1988-1989 = O. MURRAY, Omero e l’etnografia, in Kokalos, XXXIV-XXXV, 1988-1989, pp. 1-13MUSTI 1988 = D. MUSTI, La tradizione storica e l’espansione micenea in Occidente: que-stioni preliminari, in E. AQUARO et alii (edd.), Momenti precoloniali nel Mediterraneoantico, Roma 1988, pp. 21-36
328
Il moscato di Dominique Vivant Denon
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.49 Pagina 328
NAPOLEONE 2009 = C. NAPOLEONE (ed.), Scienza e arti all’ombra del vulcano. Ilmonastero benedettino di San Nicolò l’Arena a Catania (XVIII-XIX secolo), Catania2009Natura mito e storia nel regno sicano di Kokalos. Atti del Convegno, Sant’Angelo Muxaro25-27.10.1996, S. Angelo Muxaro 1999ORSI 1913 = P. ORSI, Sepolcri Siculi di Centuripe (Catania), in BPI, XXXIX, 1913,pp.92-98ORSI, PELAGATTI 1967-1968 = P. ORSI, P. PELAGATTI, Adrano e la città sicula delMendolito, in ArchStSir, XIII-XIV, 1967-1968, pp. 137-166OTTANI CAVINA 1982 = A. OTTANI CAVINA, Il Settecento e l’antico, in Storia dell’ar-te italiana, 6,2, Torino 1982, pp. 597-660PAFUMI 2006 = S. PAFUMI, Museum Biscarianum. Materiali per lo studio delle collezionidi Ignazio Paternò Castello di Biscari (1719-1786), Catania 2006PAGE 1973 = D. PAGE, Stesichorus: the Geryoneis, in JHS 93, 1973, pp. 138-154PAGNANO 2001 = G. PAGNANO, Le antichità del Regno di Sicilia. I plani di Biscari eTorremuzza per la Regia Custodia, Siracusa-Palermo 2001PALERMO 2006 = D. PALERMO, I santuari dell’area sicana, in C. GUZZONE (ed.),Sikania. Tesori archeologici dalla Sicilia centro-meridionale (secoli XIII-VI a.C.), Catania2006, pp. 89-96PALERMO, TANASI 2006 = D. PALERMO, D. TANASI, Diodoro a Polizello, in C.MICCIHÈ, S. MODEO, L. SANTAGATI (edd.), Diodoro Siculo e la Sicilia indigena,Caltanissetta 2006, pp. 89-102PALERMO 2009 = D. PALERMO, Polizello, in R. PANVINI, L. SOLE (edd.), La Siciliain età arcaica. Dalle apoikiai al 480 a.C. Contributi alle recenti indagini archeologiche,Palermo 2009, pp. 185-188PALERMO, TANASI, PAPPALARDO 2009 = D. PALERMO, D. TANASI, E.PAPPALARDO, Polizello. Le origini del santuario, in M. CONGIU, C. MICCHICHÈ, S.MODEO (edd.), EIS AKRA Insediamenti d’altura in Sicilia dalla Prestoria al III secoloa.C., Calatanissetta 2009, pp. 53-84PARUTA 1612 = F. PARUTA, La Sicilia descritta con medaglie, Palermo 1612PASINI 1981 = C. PASINI, Vita di S. Filippo attribuita al monaco Eusebio (OrientaliaChristiana Analecta 214), Roma 1981PASINI 1999 = C. PASINI, Edizione della Vita Pseudoatanasiana di San Filippo d’Agiravergata da Georgios Basilikòs nel codice Athen. Gennad. 39, in RStBiz, n.s. 36, 1999, pp.
329
Rosario P.A. Patané
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.49 Pagina 329
177-222PASINI 2000 = C. PASINI, La figura di Filippo d’Agira nella tradizione agiografica edinnografica italogreca, in S. Filippo d’Agira. Agiografia Storia Ambiente, Agira 2000, pp.7-25PATANÉ 1989 = R. PATANÉ, Agira. Storia e monumenti, Enna 1989PATANÉ 1992 = R. PATANÉ, Timoleonte a Centuripe e ad Agira, in CronA, XXXI,1992, pp. 67-82PATANÉ 2002 = R. PATANÉ, Centuripe in età ellenistica: i rapporti con Roma, in G.RIZZA (ed.), Scavi e ricerche a Centuripe (Studi e Materiali di Archeologia Mediterranea,1), Catania 2002, pp. 127-167PATANÉ 2010 = R. PATANÉ, Sui Colli Albani all’ombra della catachanna: imprendito-ria ed emigrazione d’élite nell’Impero Romano, in Forma Urbis, XV,1, gennaio 2010, pp.23-29PATANÉ c.d.s. a = R. PATANÉ, Leggendo Diodoro. Contatti egei nella Sicilia centrale?, inDai Ciclopi agli Ecisti. Società e territorio nella Sicilia preistorica e protostorica (XLIRiunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria. SanCipirello 16-19 novembre 2006), c.d.s.PATANÉ c.d.s. b = R. PATANÈ, ... Storiedi incontri tra Greci e Siculi, in Traffici, commerci e vie di distribuzione nel Mediterraneo traprotostoria e V secolo a.C. (Gela, 27-29 maggio 2009), c.d.s.PATERNÒ 1781 = I. PATERNÒ principe di Biscari, Viaggio per tutte le antichità dellaSicilia, Napoli 1781PECORAINO 1989 = M. PECORAINO (ed.), La Sicilia di Jean Houel all’Ermitage,Palermo 1989PELAGATTI 1964-1965 = P. PELAGATTI, in Kokalos X-XI, 1964-1965, pp. 245-252PIRRI 1733 = R. PIRRI, Sicilia sacra disquisizionibus et notitiis inlustrata, Palermo 1733PITRÉ 1900 = G. PITRÉ, Feste patronali nella Sicilia orientale, Palermo 1900POMIAN 2004 = K. POMIAN, Dalle sacre reliquie all’arte moderna, Milano 2004PUGLIESE CARRATELLI 1956 = G. PUGLIESE CARRATELLI, Minos e Cocalos, inKokalos, II, 1956, pp. 89-103RIZZA 1979 = G. RIZZA, S. Angelo Muxaro e il problema delle influenze micenee inSicilia, in CronA, 18, 1979, pp. 19-30RUSSO 1993 = S. RUSSO, Il viaggiatore curioso. Lettere di Denon e Houel a Landolina,
330
Il moscato di Dominique Vivant Denon
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.49 Pagina 330
Palermo 1993RUSSO 2007 = S. RUSSO, Saverio Landolina. La cultura dell’antico, Siracusa 2007SAINT-NON 1785 = R. DE SAINT-NON, Voyage Pittoresque ou Description desRoyaumes de Naples et de Sicile, Paris 1785SALMERI 1992 = G. SALMERI, L’antiquaria italiana dell’Ottocento e la sua variante sici-liana, in ID., Sicilia romana. Storia e storiografia, Catania 1992, pp. 61-96SALMERI 2001 = G. SALMERI, La Sicilia nei libri di viaggio del Settecento tra letteraturae riscoperta della grecità, in AnalRom, XXVIII, 2001, pp. 65-82A. SCHNAPP, La conquista del passato, Milano 1994SCHUBERT 2004 = K. SCHUBERT, Museo. Storia di un’idea. Dalla Rivoluzione Francesea oggi, Milano 2004SCIBONA 1981 = G. SCIBONA, Agira 1, in Arch.St.Messinese, III serie, XXXII,1981, pp. 333-359SCIBONA 1993 = G. SCIBONA, s.v. Nicosia, in Bibliografia Topografica dellaColonizzazione Greca in Italia e nelle Isole Tirreniche, XII, Pisa-Roma 1993, pp. 332-335SCINÀ 1827 = D. SCINÀ, Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo,Palermo 1827Settecento Siciliano = Settecento Siciliano. Traduzione del Voyage en Sicile di DominiqueVIVANT DENON illustratra da centotrenta tavole tratte dal Voyage Pittoresque ouDescription des Royaumes de Naples et de Sicile di Richard de SAINT-NON. Note e intro-duzione di Atanasio MOZZILLO, Georges VALLET. Traduzionbe e note al testo di LauraMASCOLI, Palermo – Napoli 1979SETTIS 1984 = S. SETTIS (ed.), Memoria dell’antico nell’arte italiana, Torino 1984SINOPOLI 1911 = P. SINOPOLI di Giunta, La Badia Regia di S. Maria Latina inAgira, Acireale 1911SINOPOLI 1926 = P. SINOPOLI di Giunta, Tabulario di S. Maria Latina di Agira, inArchStSicOr, XXII, 1926, pp. 135-190SJÖQVIST 1962 = E. SJÖQVIST, Heracles in Sicily, in ORom, 4, 1962, pp. 117-123SPATRISANO 1972 = G. SPATRISANO, Lo Steri di Palermo e l’architettura siciliana delTrecento, Palermo 1972STAVRIANOPOULOU 1993 = E. STAVRIANOPOULOU, Der MATERES-Kult inEleutherna und der MHTERES-Kult in Engyon: ein gemeinsamer Ursprung?, in PP,
331
Rosario P.A. Patané
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.49 Pagina 331
CCLXX, 1993, pp. 161-175.STOLBERG 2001 = FEDERICO LEOPOLDO CONTE DI STOLBERG, Reise inDeutschland, die Schweiz, Italien und Sizilien, Lipsia 1794; trad. it. Viaggio in Sicilia.Valdemone (con le “Esperidi”). Estratto dal Viaggio in Germania, Svizzera, Italia eSicilia, Caltanissetta 2001STORONI MAZZOLANI 1980 = L. STORONI MAZZOLANI, Il ragionamento del principedi Biscari a Madama N.N., Palermo 1980TANASI 2004 = D. TANASI, Per una rilettura delle necropoli sulla Montagna diCaltagirone, in V. LA ROSA (ed.), Le presenze micenee nel territorio siracusano, Padova2004, pp. 399-447TOMASELLO 1995-1996 = F. TOMASELLO, Le tombe a tholos nella Sicilia centro-meri-dionale, in CronA, 34-35, 1995-1996TRIGGER 1996 = B.G. TRIGGER, Storia del pensiero archeologico, Firenze 1996TUZET 1995 = H. TUZET, Viaggiatori stranieri in Sicilia nel XVIII secolo, Palermo19952
VALBRUZZI 2009 = F. VALBRUZZI, Il sistema insediativo antico e i beni archeologici, inC. MANCUSO, F. MARTINICO, F.C. NIGRELLI (edd.), I piani territoriali paesaggisticidella provincia di Enna (Urbanistica Quaderni. Collana dell’Istituto Nazionale diUrbanistica, XV), Roma 2009, pp. 86-92VALLET 1979 = G. VALLET, Vivant Denon, ou les leçons familières sur les antiquités sici-liennes, in Settecento Siciliano, pp. 137-170VERONESE 2006 = F. VERONESE, Lo spazio e la dimensione del sacro. Santuari greci eterritorio nella Sicilia arcaica, Padova 2006ZEVI 1989 = F. ZEVI, Il mito di Enea nella documentazione archeologica: nuove conside-razioni, in L’epos greco in Occidente (Atti del diciannovesimo Convegno di Studi sullaMagna Grecia, Taranto 1979), Napoli 1989, pp. 247-290ZEVI 1999 = F. ZEVI, Siculi e Troiani, in La colonisation grecque en Méditerranée occi-dentale, Actes rencontre G. Vallet, Rome-Naples 1995, Roma 1999, pp. 315-343
ZEVI 2005 = F. ZEVI, Demetra e Kore nel santuario di Valle Ariccia, in A. BOTTINI(ed.), Il rito segreto. Misteri in Grecia e a Roma, Milano 2005, pp. 58-67
332
Il moscato di Dominique Vivant Denon
Atti II Nicosia - Patane.qxp 08/08/2010 22.49 Pagina 332