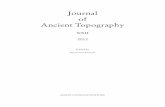Il lungo viaggio di Hilary Putnam
Transcript of Il lungo viaggio di Hilary Putnam
1
Il lungo viaggio di Hilary Putnam Realismo metafisico, antirealismo e realismo naturale 1 di Mario De Caro (Roma)
Chi è filosoficamente confuso è come un uomo in una stanza, che vuole uscirne, ma non sa come fare. Prova a passare dalla finestra, ma è troppo alta. Prova a passare per il comignolo, ma è troppo stretto. E se soltanto si guardasse intorno, si accorgerebbe che la porta è rimasta aperta. Ludwig Wittgenstein
Non è affatto azzardato ritenere che quando, tra qualche decennio, gli storici
della filosofia guarderanno retrospettivamente a questa fine di secolo, essi dedicheranno non poca attenzione al pensiero di Hilary Putnam. Nel delineare il pensiero di questo filosofo, la prima caratteristica che sottolineeranno sarà certamente la sua prodigiosa vastità di interessi e di competenze: Putnam, in effetti, ha offerto contributi decisivi in campi assai lontani tra loro come la filosofia della matematica e quella del linguaggio, la filosofia della logica e l'etica, la metafisica e l'epistemologia, la filosofia della mente e quella delle scienze fisiche. Inoltre, diversamente dalla maggior parte dei filosofi di for-mazione analitica, Putnam ha condotto le sue ricerche in costante riferimento alla storia della filosofia e agli sviluppi della cosiddetta “filosofia continentale”: di particolare rilievo in questo senso è il suo dialogo a distanza con Apel e Habermas, ma frequenti negli scritti putnamiani sono anche i riferimenti a Nietzsche, Husserl, Heidegger, Gadamer, Derrida, Foucault, persino Ortega y Gasset. Una tale ampiezza di interessi e di riferimenti si è tradotta in una produzione imponente: una bibliografia aggiornata al 1994 elenca dodici libri (più altri quattro di cui Putnam è curatore) e duecento tra articoli e saggi 2.
Versatilità e fecondità non sono i soli tratti distintivi dell’opera di Putnam. Molti commentatori insistono polemicamente sulla sua volubilità, sui suoi frequenti, talora radicali, cambiamenti di opinione. In effetti, all’inizio degli anni Ottanta Putnam ha abbandonato la metafisica fortemente realistica sostenuta sino allora per una teoria incentrata sulla concezione epistemica della
2
verità 3; altrettanto drastico il suo recente distacco dal funzionalismo, la teoria che ha dominato la filosofia della mente a partire dagli anni Sessanta, quando Putnam stesso la propose 4. La polemica sulla volubilità intellettuale di Putnam rischia però di fuorviare il giudizio sulla sua opera. Infatti, almeno a partire da Reason, Truth and History, e al di là di pur significativi assestamenti, la riflessione putnamiana si è costantemente sviluppata attorno a un solo, ambizioso disegno: delineare un approccio alla filosofia intermedio tra due concezioni, oggi dominanti eppure «ugualmente insoddisfacenti», ognuna delle quali è «l’immagine speculare dell’altra e dipende dall’idea che l’altra sia la sola alternativa» (DL, p. 457). Queste due concezioni, Scilla e Cariddi della riflessione putnamiana, sono il realismo dogmatico – che da Putnam viene detto ‘metafisico’ – e un altrettanto dogmatico antirealismo.
Renewing Philosophy e Words and Life illustrano assai bene i caratteri del filosofare putnamiano. La prima opera è un’agile ripresa delle Gifford Lectures, tenute da Putnam all’University of St. Andrews nel 1990; Words and Life è invece una ponderosa raccolta di saggi e articoli già pubblicati, quindici dei quali negli anni Novanta, dodici nel decennio precedente e due addirittura negli anni Settanta. Il secondo di questi volumi è un eccellente esempio della versati-lità di cui si diceva. Se nelle prime quattro sezioni di Words and Life Putnam ripensa alcuni momenti della storia della filosofia dei quali vuol fare tesoro in sede teoretica (l’epistemologia di Aristotele; il contributo di Reichenbach e del positivismo logico in generale; l'etica e l'epistemologia dei pragmatisti; il pensiero di Wittgenstein), nella successiva sezione discute di questioni semantiche, in un'altra di filosofia della mente e in un'altra ancora dell’idea di scienza. Vi sono poi saggi dedicati alla filosofia della matematica, al pensiero di Comte, alla filosofia della probabilità, al Pope filosofo newtoniano.
Anche in Renewing Philosophy emerge chiaramente la vastità di interessi di Putnam, che vi discute di intelligenza artificiale e di linguaggio religioso, di meccanica quantistica e del concetto di democrazia. Nondimeno questa è un’opera unitaria, organizzata intorno alla questione su cui nel corso degli anni più si è impegnata la riflessione putnamiana: il dilemma realismo-antirealismo. Se si segue il filo rosso rappresentato da questo tema, anche l’andamento ondivago di WL si rivela più apparente che reale.
1. Il realismo dell’Occhio di Dio
3
Negli scritti recenti di Putnam, e in particolare nelle opere qui discusse, si
sente spesso l’eco della concezione terapeutica della filosofia proposta da Wittgenstein nelle Ricerche filosofiche, dove si legge: «Il filosofo tratta una questione; come una malattia» 5. Analogamente Putnam considera il fondazionalismo metafisico dei realisti e il relativismo come «manifestazioni della stessa malattia» (RPh, p. 177). Una malattia dal carattere endemico, della quale occorre individuare con precisione la natura patologica e le cause scatenanti, se si vogliono poi avanzare proposte terapeutiche adeguate. Fuor di metafora: secondo Putnam non solo le tendenze realistico-metafisiche e quelle idealistiche, antirealistiche o relativistiche di tanta parte della filosofia contemporanea sono tra loro assai più affini di quanto comunemente si creda; esse sono addirittura complementari. Concezioni a prima vista tanto diverse sono in verità apparentate da alcuni assunti taciti, che proprio perché taciti sono filosoficamente assai nocivi.
Il realismo metafisico – contro il quale Putnam conduce una polemica ormai ventennale – è la concezione secondo la quale il mondo è ciò che è indipendentemente dal punto di vista di chi lo descrive e dalle possibilità di conoscerlo. Questa tesi si articola in alcuni punti specifici. In primo luogo il realismo metafisico si incentra su una ‘concezione radicalmente non-epistemica della verità’, secondo la quale la verità va interpretata in termini «di Corrispondenza ed è caratterizzata da Indipendenza (rispetto a ciò che gli esseri umani scoprono o potrebbero scoprire), Bivalenza e Unicità (non può esservi più di una descrizione completa e vera della Realtà)» 6. Secondo la prospettiva realista, inoltre, una linea netta separa le proprietà che ‘scopriamo’ nel mondo. C’è, perciò, «una totalità di ‘forme’ o ‘universali’ o ‘proprietà’, determinata una volta per tutte, e ogni possibile significato di una parola corrisponde all'una o l'altra di tali ‘forme’, ‘universali’ o ‘proprietà’. La struttura di tutti i possibili pensieri è già determinata – determinata dalle ‘forme’» (DL p. 448; cfr. anche pp. 463 n., 465, 514). E’ questa la concezione del “ready-made world”, del mondo bell’e fatto, del quale non può esistere che una descrizione corretta e completa.
E’ pressoché impossibile trovare un filosofo prima di Kant che non sia stato un realista metafisico. Con questa enunciazione un po’ ardita (e i concettualisti
4
medievali? e Vico?) 7, Putnam espone una tesi sostanzialmente condivisibile a proposito del ruolo decisivo svolto, nella storia della metafisica occidentale, dalle tesi che costituiscono il realismo metafisico (TRH, p. 57, trad. it. p. 65). Né d’altra parte si potrebbe sostenere che tale concezione sia ormai una mera reliquia filosofica: essa è ancora una presenza vitale, specialmente nella filosofia americana, ove è molto spesso coniugata con il materialismo. Per Putnam le versioni materialistiche del realismo metafisico si fondano su «pregiudizi che pretendono di essere ‘scientifici’, ma confondono il rispetto per la scienza con l'acritica accettazione di un'ideologia materialistica» (WL, p. vi). La tesi fondamentale di queste concezioni è che soltanto mediante la scienza possiamo conoscere ciò che veramente esiste (almeno ciò che ci è concesso conoscere): è la scienza, cioè, a fornire «le linee della ‘concezione assoluta del mondo’, le linee della metafisica ultima» (RPh, p. 35). Oggi molti autori si spingono persino oltre, ritenendo che l’accesso al reale ci sia garantito soltanto dalla fisica, alla quale le altre scienze possono essere ridotte (e ciò spiega come possa accadere che il termine ‘fisicalismo’ sia oggi considerato sinonimo di ‘materialismo’). In questa prospettiva, il ready-made world del realismo metafisico viene concepito come rigorosamente fisico. Le premesse di un simile atteggiamento intellettuale risalgono naturalmente indietro nei secoli, sino alla rivoluzione scientifica: «dal Seicento in poi, nella nostra cultura c’è una tendenza a considerare la fisica come la nostra metafisica, ovvero a vedere le scienze esatte come la tanto agognata descrizione della ‘natura vera e definitiva dell’universo’» (RTH, trad. it. p. 22). La specificità del realismo metafisico scientista oggi in voga è l’aver portato a compimento quella che nelle epoche precedenti era solo una tendenza. Non solo, infatti, tale concezione ha colonizzato campi così vari come la filosofia della mente (nel quale dominano le teorie riduzionistiche e quelle eliminazionistiche) e la teoria della percezione (in cui le cosiddette qualità secondarie vengono destituite di realtà, in linea naturalmente con una tradizione veneranda); essa si è propagata ormai anche all’etica (si pensi a Bernard Williams) e persino alla filosofia della matematica (per esempio con il ‘finzionalismo’ di Hartry Field e il ‘platonismo naturalistico’ di Penelope Maddy).
In Renewing Philosophy e in Words and Life Putnam prosegue la sua metodica critica del realismo metafisico intrapresa con Reason, Truth and
5
History, l’opera che della filosofia putnamiana rappresenta il manifesto pro-grammatico nonché, a mio giudizio, il risultato più significativo. In quella sede veniva deplorata la hybris metafisica ultrarealistica di chi ambisce a porsi dalla ‘prospettiva dell’Occhio di Dio’, ma per questo incorre in difficoltà concettuali insuperabili – come Putnam dimostrava per mezzo di un’impressionante batteria di argomenti critici. In generale, gli argomenti esposti contro il realismo metafisico nelle successive opere putnamiane, incluse quelle qui in discussione, presuppongono quelli presentati in Reason, Truth and History e assai spesso non ne sono che riprese e sviluppi: a quell’opera occorre costantemente guardare se si vogliono inquadrare opportunamente i termini della polemica di Putnam contro il realismo metafisico e i suoi sviluppi più recenti. In questo modo, tra l’altro, si constaterà come il pensiero di questo filosofo sia molto meno rapsodico e mutevole di quanto comunemente si creda.
Un chiaro esempio in questo senso è offerto, in Words and Life (saggio 18), dalla ripresa di alcuni argomenti contro il realismo metafisico che Putnam elaborò, a cavallo tra gli anni Settanta e gli Ottanta, estendono ai linguaggi non formali i risultati della teoria dei modelli. Secondo il più noto di questi argomenti, esposto proprio in Reason, Truth and History (cap. 2 e Appendice), è possibile assegnare un numero infinito di interpretazioni diverse ai predicati di un determinato linguaggio, senza alterare il valore di verità degli enunciati di quel linguaggio. Ciò dimostra che il riferimento di tali predicati è costitu-tivamente indeterminato: una conclusione esiziale per la tesi realistica secondo la quale tra parole e cose esiste una corrispondenza determinata. Con questo argomento Putnam si rifà esplicitamente alla dimostrazione data da Quine dell‘imperscrutabilità del riferimento’ sulla base dei cosiddetti ‘argomenti permutatori’ 8. Tanto secondo Quine quanto secondo Putnam, la costitutiva indeterminatezza del riferimento conduce alla ‘relatività ontologica’, ovvero all’idea che le questioni ontologiche non possono essere poste da un punto di vista ‘assoluto’, ma soltanto dal punto di vista di un determinato manuale di traduzione. Quine, com’è noto, accetta una tale conclusione; secondo Putnam invece «la relatività ontologica è una confutazione di ogni posizione filosofica che vi conduca». A suo giudizio, infatti, è insensato ritenere che il mondo consista di oggetti tali che ognuno di essi è un quark secondo un certo modello ammissibile, la Torre Eiffel secondo un altro e lo stesso Hilary Putnam secondo
6
un terzo modello, e tuttavia «intrinsecamente non è nessuno di questi più che qualunque altro» (WL, p. 280). L’argomento putnamiano – a differenza di quello di Quine – ha dunque la struttura di una reductio ad absurdum del realismo metafisico, essendo teso a confutare tale concezione proprio in quanto essa ha l’intollerabile effetto «di lasciarci senza alcun modo intelligibile di confutare la relatività ontologica» (WL, p. 280; cfr. anche il cap. 18).
2. Scientismo e realtà. Dicevo poc’anzi che il realismo metafisico contemporaneo si colora spesso di
scientismo: molte concezioni, infatti, al di là delle pur significative differenze, condividono al fondo l’idea che le scienze naturali – e solo le scienze naturali – possano descrivere il “mondo in sé”, il ready-made world dei realisti metafisici, in totale indipendenza dal punto di vista di chi lo osserva. Per dimostrare la correttezza di tale concezione occorre dimostrare, naturalmente, che l’ambito dell’intenzionale non costituisce un’eccezione al sistema della legalità naturale. E’ in considerazione di ciò che molti autori si propongono di dimostrare la riducibilità delle nozioni semantiche ai concetti non intenzionali delle scienze della natura.
Sono molti gli approcci di questo genere che Putnam discute in Renewing Philosophy e in Words and Life: dai programmi riduzionistici in Intelligenza Artificiale (RPH, cap. 1) e in filosofia della mente (WL, capp. 20-24) alla teoria causale del riferimento proposta da Jerry Fodor (RPh, cap. 3); dalla tesi, oggi molto popolare, secondo la quale la teoria dell’evoluzione può dar conto dell'intenzionalità del linguaggio e del pensiero (RPh, cap. 2) alla proposta di Bernard Williams che coniuga il realismo materialistico con il relativismo etico (RPh, cap. 5). Tutte queste concezioni condividono, più o meno esplicitamente, l’assunto secondo il quale «i problemi filosofici sono tali da ammettere una soluzione ‘scientifica’» (WL, p. 515). Contro questo tipo di posizioni Putnam non si limita ad apportare argomenti per dimostrare che il progetto di riduzione dell’intenzionale alle scienze naturali è assolutamente irrealizzabile, ma sostiene che persino lo strumentario concettuale di queste scienze partecipa dell’intenzionalità: «l'intenzionale si insinua persino nelle nostre descrizioni del
7
non-intenzionale... in qualche modo l'intenzionale... è ubiquo» (RPh, p. 59). La sua conclusione è che la realtà non può essere descritta astraendo dal punto di vista di chi la descrive, come presuppone l’ideologia scientista. L’obiettivo che Putnam si propone con questa sua polemica è dunque duplice: da una parte, dimostrare che la filosofia – che della questione dell’intenzionalità è investita per sua natura – ha un ambito di competenze che le scienze non potranno mai toglierle; dall’altra, provare che il realismo metafisico è fallimentare anche nelle versioni che ne dà il materialismo contemporaneo.
Per illustrare più nel dettaglio questi punti è utile soffermarsi sul saggio di Renewing Philosophy dedicato a Fodor, che è a mio giudizio uno dei più densi e significativi dell’ultimo Putnam (RPh, cap. 3; cfr. anche WL, cap. 21). Fodor appartiene all’ampia schiera di autori che ritiene possibile disinnescare gli argomenti contro il realismo metafisico tratti dalla teoria dei modelli, cui accennavo poco fa, ricorrendo a teorie causali del riferimento 9. L’idea è che la relazione di riferimento possa essere adeguatamente spiegata considerando i nessi causali che connettono le parole, e le rappresentazioni in genere, ai rispettivi referenti. Secondo questi autori, dunque, un’adeguata teoria causale del riferimento è in grado di sanare la frattura tra linguaggio e pensiero, da una parte, e mondo ‘esterno’, dall’altra – una frattura che nel realismo metafisico tradizionale è resa evidente dal ricorso alla concezione magica del riferimento. In questa prospettiva, si noti, le relazioni causali vengono interpretate come relazioni non intenzionali tra eventi nel mondo naturale; la riduzione delle categorie intenzionali, a cominciare da quella di riferimento, a connessioni causali equivale dunque al rifiuto di ogni specificità dell’intenzionale.
A tale proposito è però necessaria una precisazione: spesso infatti si afferma, erroneamente, che fu proprio Putnam (insieme a Saul Kripke) a presentare la prima ‘teoria causale del riferimento’, che venne poi ripresa da molti realisti metafisici. Secondo Putnam determinate categorie di parole possono essere usate referenzialmente solo se tra i parlanti e i tipi di cose a cui quelle parole si riferiscono c’è un’adeguata connessione causale (che può essere anche indiretta, mediata cioè da altri parlanti): «quello che possiamo dire sulle mele e sui campi è ... intimamente legato alle nostre transazioni non verbali con mele e campi» (RTH, trad. it. p. 17). E’ questa la prospettiva dell’‘esternalismo semantico’, secondo la quale il rapporto causale dei soggetti con il ‘mondo esterno’ con-
8
tribuisce in maniera decisiva alla determinazione del riferimento; ritenere, al contrario, che le nostre parole e le nostre rappresentazioni mentali si riferiscano intrinsecamente, essenzialmente, agli oggetti esterni, anche in assenza di un adeguato nesso causale, vuol dire aderire a ciò che Putnam chiama ‘teoria magica del riferimento’. Il punto cruciale, però, è che, al contrario dei realisti metafisici come Fodor, Putnam non pretende affatto di fornire una definizione del riferimento in termini causali: egli, detto altrimenti, non tenta di ridurre la nozione di riferimento a quella di causazione, ma si limita a rilevare che per alcune categorie di parole la connessione causale è condizione necessaria perché esse abbiano un riferimento (RPh, cap. 8; WL, p. 409) 10.
Veniamo dunque alla polemica di Putnam contro Fodor. Su un punto almeno, va premesso, questi due autori concordano: sull’idea, cioè, che lo strumentario concettuale delle cosiddette scienze speciali, come biologia, geologia, meteorologia, sia irriducibile (in linea di principio, non soltanto in linea di fatto) a quello della fisica. Putnam dissente invece completamente dalla tesi di Fodor che delle nozioni semantiche si possa dare conto per mezzo dei concetti rigorosamente non intenzionali delle ‘scienze speciali’. E’ per questa idea che Fodor può essere legittimamente considerato un realista metafisico (e anche uno dei più rappresentativi): egli afferma infatti che nel loro insieme la fisica e le scienze speciali descrivono il ‘mondo in sé’. Fodor è dunque un difensore del ‘naturalismo’, sempre che non si intenda tale termine, come spesso accade, quale sinonimo di ‘fisicalismo’.
La tesi riduzionistica che Fodor propugna nel suo A Theory of Content si incentra sulla nozione di ‘dipendenza asimmetrica’ 11. Consideriamo un enun-ciato del tipo:
(a) I gatti causano proferimenti della parola ‘gatto’. Un tale enunciato sembra ovvio; secondo Fodor esso è addirittura una legge
linguistica. L’idea che sottostà a questa proposta è che nei casi fondamentali le parole si riferiscono a ciò che ne causa il proferimento da parte dei parlanti: la nozione di riferimento, in tale prospettiva, si riduce a quella di causa. Il modello di legge che Fodor ha in mente è quello delle ‘scienze speciali’, nelle quali non si ambisce a raggiungere generalizzazioni universali che sostengano, senza
9
eccezioni, adeguati controfattuali (come accade con la fisica), ma soltanto generalizzazioni vere nella maggior parte dei casi. Con la terminologia oggi in voga, si può dire che nelle leggi di queste scienze figurano ineliminabilmente clausole ceteris paribus, le quali stabiliscono che le relazioni di dipendenza che in tali leggi sono menzionate valgono solo se non si danno condizioni particolari in cui compaiano fattori perturbanti; nondimeno, nella maggior parte dei casi, tali leggi sosterranno appropriati condizionali controfattuali.
Per Fodor, dunque, il riferimento delle parole è determinato dagli oggetti che ne causano il proferimento; tuttavia sono innumerevoli le cose che possono causare il proferimento di enunciati in cui compare, per esempio, la parola ‘gatto’: dalle riproduzioni di gatti agli animali che gatti non sono. Naturalmente Fodor non vuole sostenere che la parola ‘gatto’ si riferisce a tutto ciò che ne causa il proferimento, ma solo alla classe dei gatti 12. Egli deve dunque riuscire a dimostrare che nella definizione del riferimento di ‘gatto’ una legge come (a) è più fondamentale di un enunciato, pur vero, quale il seguente:
(b) Le immagini di gatto causano proferimenti della parola ‘gatto’. La soluzione di Fodor si basa sull’idea che tra (a) e (b) ci sia una relazione di
dipendenza asimmetrica, per la quale (b) dipende da (a), ma non viceversa. La dipendenza può essere espressa mediante un controfattuale:
(c) Se i gatti non causassero proferimenti della parola ‘gatto’, allora nem-
meno le riproduzioni di gatti li causerebbero. L’asimmetria invece, secondo Fodor, deriva dal fatto che non è vero il
seguente controfattuale: (d) Se le riproduzioni di gatti non causassero proferimenti della parola
‘gatto’, allora nemmeno i gatti li causerebbero. Se Fodor è nel giusto, le leggi come (a) sono quelle fondamentali e tutte le
altre ne dipendono. Sono esse dunque che determinano il riferimento delle parole.
10
A questa concezione Putnam muove molteplici obiezioni. Egli innanzi tutto che tra leggi del tipo (a) e leggi del tipo (b) non ci sia affatto l’asimmetria che pretenderebbe Fodor: non si vede infatti perché (d) dovrebbe essere falsa. Adoperando, per dare conto di quel controfattuale, la semantica dei mondi possibili (con la quale peraltro non simpatizza), Putnam nota che i mondi possibili più prossimi al nostro in cui le riproduzioni di gatto non causano proferimenti della parola ‘gatto’ sono quelli in cui tale parola ha un riferimento diverso da quello che ha presso di noi; ma in mondi di questo genere nemmeno i veri gatti causano quel proferimento. Di conseguenza il controfattuale (d) è vero, non falso, come pretende Fodor, e dunque la teoria della dipendenza asimmetrica cade e con essa il tentativo di ridurre una nozione intenzionale quale quella di riferimento al bagaglio concettuale delle scienze speciali.
Già questo sarebbe sufficiente a provare che la teoria di Fodor è errata, ma Putnam può addurre contro di essa una critica ancora più distruttiva. L’idea è che se anche accettassimo la tesi della dipendenza asimmetrica, le ambizioni riduzionistiche di Fodor non sarebbero affatto realizzate. Le nozioni che egli mutua dalle scienze speciali e sulle quali vorrebbe basare la riduzione dell’intenzionale al non-intenzionale (legge, causa, controfattuale) sono infatti del tutto inadeguate per questo compito, giacché esse stesse sono irriducibilmente intenzionali. Tali nozioni presuppongono infatti «gli interessi degli esseri umani e ciò che per essi è rilevante, e non uno ‘sguardo da nessun luogo’», come ritiene la tradizione realistico-metafisica (RPh, p. 58).
Prendiamo in esame a questo proposito la nozione di causa cui si rimanda con una legge come (a). Si tratta della nozione propria del linguaggio ordinario, oltre che delle ‘scienze speciali’, una nozione che è sensibile tanto al contesto quanto agli interessi del parlante 13. Alla domanda «Qual è la causa della caduta dell’impero romano?» non c’è una risposta univoca, indipendente dagli interessi di chi l’ha posta; analogamente accade con una domanda come «Che cosa ha causato l’infarto di Giovanni?». La predisposizione genetica, la pessima alimentazione, lo scarso allenamento fisico, l’inosservanza delle prescrizioni terapeutiche, persino l’insufficiente autorità del medico: la causa principale cambierà a seconda degli interessi che muovono chi pone la domanda (che sia Giovanni medesimo, il suo medico, il suo allenatore o il suo assicuratore). Ciò significa che le condizioni di verità di un enunciato causale dipendono dal
11
contesto e dagli interessi di chi lo proferisce. Avere un’interesse, si noti, è una nozione essenzialmente intenzionale: “[p]er essere interessato a qualcosa ... si deve essere in grado di pensare questa cosa – si deve essere capaci di riferirvisi nel pensiero o nel linguaggio». (RPh, p. 50) Ma ogni evento è sempre effetto di innumerevoli catene causali, che risalgono indefinitamente indietro nel tempo. Filosoficamente è assai ingenuo ritenere che la causa dei proferimenti della parola ‘gatto’ possa determinarne il riferimento, in astrazione dal contesto e dagli interesse dei parlanti: in tal modo, infatti, non si fa che concedere un indebito privilegio ad una particolare catena causale. (E’ interessante notare che anche questo argomento era già presentato in Reason, Truth and History (trad. it. p. 74), dove Putnam scriveva: «ci sono troppe catene causali perché il riferimento possa essere semplicemente una questione di catene causali»).
A questa obiezione Fodor non potrebbe replicare che ciò che conta nella determinazione del riferimento è la catena causale appropriata (per esempio, quella che ha come cause dei proferimenti i gatti, invece che le riproduzioni dei gatti): in questo modo, infatti, la capacità di riferirsi ai gatti, che è ciò che si deve spiegare, verrebbe presupposta. La nozione di causa utilizzata da Fodor si rivela dunque una nozione intenzionale e come tale è inutilizzabile ai suoi propositi. Analoga conclusione Putnam trae dall’analisi della nozione di condizionale controfattuale: si tratta anche in questo caso di una nozione che presuppone il nesso intenzionale tra noi e il mondo 14. In sostanza, dunque, «i condizionali controfattuali e le asserzioni causali presuppongono... ‘il punto di vista della ragione’» (RPh, p. 61). In conclusione, il realismo metafisico fodoriano, seppure non viziato dalla dogmatica fisicalistica, rappresenta per Putnam “uno spiacevole caso di scientismo» (RPh, p. 66).
Ma le obiezioni di Putnam contro il realismo metafisico non si fermano qui. A suo parere persino la nozione di oggetto dipende dagli interessi di chi descrive il mondo. Le immagini allo specchio, il cielo, gli eventi – la seconda guerra mondiale, la Grande Crisi – sono o non sono oggetti? (DL, pp. 449-452) A una tale domanda non c’è affatto una risposta univoca, perché per stabilire se qualcosa è un oggetto sono sempre legittimi criteri alternativi in funzione dei diversi interessi. Un altro chiaro esempio in questo senso si ottiene nel caso in cui si consideri legittimo l’approccio della mereologia (secondo il quale dati due oggetti particolari qualsiasi, esiste sempre un oggetto che è la loro somma): in
12
tal modo, infatti, il numero degli oggetti non è mai univocamente determinabile. Pensiamo ad un mondo di tre individui: da una parte, ovviamente, si può dire che in esso vi sono tre oggetti; dall’altra, seguendo Lesniewski e gli altri mereologi, di oggetti se ne possono contare sette 15. Infine, ricorda Putnam, la nozione realistico-metafisica di oggetto cade miseramente di fronte al fatto che nella maggior parte degli stati le particelle della meccanica quantistica non sono affatto in numero definito (DL, p. 451).
Si dimostra in tal modo la falsità di due assunti fondamentali del realismo metafisico: che la realtà possa essere descritta indipendentemente dal punto di vista di chi la descrive e che esista una descrizione corretta della realtà. Putnam è solito parlare a questo proposito di relatività concettuale (RPh, pp. 115-123). Chi ritenesse però che la relatività concettuale comporti la correttezza del relativismo commetterebbe un grave errore filosofico. Ed è proprio alle concezioni che compiono una tale errata inferenza che dobbiamo rivolgere ora la nostra attenzione.
3. Il mondo perduto Le difficoltà in cui si impania il realismo metafisico hanno dato grande
impulso a concezioni che, a vario titolo, comportano la ‘perdita del mondo’. Dal punto di vista dell’irrealismo difeso da Nelson Goodman, per esempio, del mondo è possibile dare molte diverse descrizioni che pur essendo vere sono tra loro incompatibili 16. Secondo Goodman ciò dimostra che esistono molti mondi diversi tra loro: una conclusione che secondo Putnam mina l’idea stessa che vi sia un mondo (RPh, cap. 6).
Nelle sue opere recenti Putnam si diffonde su molte posizioni antirealistiche oltre a quella di Goodman: dal decostruzionismo di Derrida (RPh, cap. 6), all’antirealismo di Dummett (DL, pp. 494-500), sino alla concezione deflazionistica della verità (WL, saggio 13). Secondo Putnam tutte queste concezioni, per molti aspetti assai diverse tra loro, sono accomunate dal fatto di essere reazioni filosoficamente esasperate alla crisi del realismo metafisico. Riprendendo una metafora abusata ma chiarificatrice, cara a Putnam, si può
13
affermare che la colpa degli antirealisti è quella di gettare, oltre all’acqua sporca, anche il bambino. L’acqua sporca è naturalmente la consunta ideologia realistico-metafisica, con tutta la sua dogmatica; il bambino è il realismo non metafisico, il realismo naturale del discorso quotidiano.
Tra i fautori dell’antirealismo l’obiettivo polemico preferito di Putnam è rappresentato da Richard Rorty, che di questa corrente è l’esponente forse più noto e certamente uno dei più oltranzisti (RPh, cap. 4; WL, capp. 14, 15, 17). Al realista che afferma l’esistenza di un ready-made world, un mondo bell’e fatto, Rorty ribatte infatti placidamente che il mondo non c’è affatto: “The World Well Lost” si intitola un suo celebre articolo – il mondo finalmente, definitiva-mente, perduto.17 Per Rorty è l’intero armamentario concettuale del realista a rivelarsi mera mitologia metafisica: ‘oggettività’, ‘accettabilità razionale’, ‘verità’, ‘riferimento’ sono nozioni tanto roboanti quanto vacue ed è ormai tempo di abbandonarle, insieme alla concezione che le ha generate. In questa prospettiva, il peccato originale della metafisica classica, quello da cui derivano tutti i suoi errori e le sue inaccettabili ipostatizzazioni, è l’idea che pensiero e linguaggio possano riflettere la Realtà, che viene concepita come totalmente indipendente dal linguaggio e dal pensiero. Questo, in verità, è nulla più di un dogma, seppur venerando: noi non abbiamo alcun accesso a una presunta Realtà non concettualizzata, né potremo mai averlo (come mostrano, tra gli altri, proprio gli argomenti di Putnam) 18. Ma così la magnifica fabbrica dei realisti cade in rovina: non resta infatti più nulla dell’idea – solo apparentemente perspicua – che linguaggio e pensiero rappresentino il ‘mondo in sé’; né della concezione della verità come corrispondenza tra le nostre credenze e i ‘fatti’; né, infine, del motivo dominante dell’epistemologia: la necessità di trovare una salda giustificazione per le nostre credenze. In tal modo per Rorty metafisica ed epistemologia non hanno più ragion d’essere e con esse tutte le ubbie che ne derivano (conosciamo alcunché? qual è la forma di giustificazione ideale per le nostre credenze? che cos’è la verità?). Per Rorty la filosofia in quanto tale – rinunciando a concepire se stessa come sede privilegiata del discorso razionale – deve dissolversi nella conversazione, alla stregua della critica letteraria.
Come s’è visto anche Putnam ritiene che la concezione del realista metafisico sia caduta in rovina; egli tuttavia non condivide affatto lo spirito filosoficamente rinunciatario della proposta rortiana. Secondo Putnam, anzi, paradossalmente
14
anche in Rorty si possano individuare le tracce di «un inappagato impulso realista-metafisico», ché il suo scetticismo rispetto alle categorie filosofiche non è altro che «il rovescio della smodata tensione verso un inintelligibile tipo di certezza» (WL, p. 299-300).
L’errore fondamentale di Rorty, e degli antirealisti in genere, è dunque di ritenere che realismo metafisico e antirealismo esauriscano lo spazio logico delle possibili opzioni ontologiche e semantiche; in base a un tale presupposto, infatti, dal fallimento del realismo metafisico essi possono derivare la correttezza all’antirealismo. D’altro canto chi continua ad aderire al realismo metafisico lo fa spesso proprio perché tale concezione viene vista come un argine al relativismo e allo scetticismo degli antirealisti: «...sotto molti rispetti, tra il realismo metafisico e i relativismi alla moda c’è una relazione simbiotica; per sostenersi le illusioni filosofiche sono necessarie l’una all’altra» (WL, p. v). Anche in questo caso la polemica di Putnam riprende un motivo di Reason, Truth and History (trad. it. p. 155): in quella sede, infatti, egli rilevava lo stretto nesso tra le attuali fortune dell’antirealismo e la tendenza a dare un’interpretazione esageratamente realistica della scienza, come se questa fosse l’Unica Teoria Vera, l’unico mezzo di cui disponiamo per dischiudere i segreti dell’universo.
Per un aspetto, tuttavia, la riflessione recente di Putnam assume toni piuttosto diversi da quelli che aveva in Reason, Truth and History. E’ ben noto che in quell’opera Putnam difendeva un originale posizione filosofica, il realismo interno. Quella proposta incorporava la cosiddetta concezione epistemica della verità, secondo la quale tale nozione è un’idealizzazione dell’accettabilità razionale: in tale prospettiva, dunque, un’asserzione è vera se, e solo se, è giustificato accettarla in condizioni epistemiche ideali (o ‘sufficientemente buone’, come talora Putnam preferiva esprimersi). Il realismo interno veniva presentato come un’alternativa tanto al realismo metafisico quanto all’irrealismo: da una parte, infatti, tale concezione conservava la nozione di verità oggettiva; dall’altra, la ‘relatività concettuale’ veniva riconosciuta come un fenomeno onnipervasivo e la verità stessa interpretata come una nozione epistemica.
Oggi Putnam, non ritenendo più soddisfacente quella proposta, ne avanza un’altra dal più accentuato carattere realistico: non nel senso del realismo
15
metafisico, naturalmente, ma nel senso del realismo diretto (la concezione detta anche realismo ingenuo o realismo naturale). Putnam oggi insiste molto sul fatto che la terminologia filosofica nasce nel linguaggio ordinario; sull’idea cioè che nozioni come ‘rappresentazione’, ‘realtà’, ‘oggettività’, ‘verità’ ricevono il loro senso originario dal discorso quotidiano. E’ proprio del senso ordinario, prefilosofico di queste nozioni – un senso non ancora impregnato della ‘smodata tensione verso un inintelligibile tipo di certezza’ – che la filosofia deve riappropriarsi. Abbandonando le mitologie filosofiche, che pretendono di sublimare le categorie della filosofia (anche soltanto per negarle, come nel caso di Rorty), occorre dunque recuperare la lezione di Wittgenstein: «...se le parole ‘linguaggio’, ‘esperienza’, ‘mondo’, hanno un impiego, esso dev’essere terra terra, come quello delle parole ‘tavolo’, ‘lampada’, ‘porta’») 19. Ciò che occorre conseguire, secondo Putnam, è una sorta di ‘consapevole ingenuità’ (WL, p. 284).
Con questo richiamo siamo però giunti alla riflessione putnamiana più recente, che è abbozzata in un paio di saggi di Words and Life e sviluppata più in dettaglio nelle recentissime Dewey Lectures.
4. Il mondo ritrovato Negli ultimi anni Putnam ha mostrato un crescente interesse per la questione
della percezione. A questo proposito egli ha elaborato un’interessante ipotesi storiografica riguardo alla genesi dell’antinomia realismo metafisico–antirealismo. All’origine di tali concezioni ci sarebbe dunque una visione del tutto inadeguata della percezione: «è proprio da un consenso assai vasto, ancorché vago, rispetto alla natura della percezione che dipende il nostro attuale modo di considerare quali siano le potenziali opzioni filosofiche» (DL, p. 456).
In questo senso, ritenere – in constrasto con il senso comune – che la percezione non ci permetta di attingere direttamente al mondo è errore filosoficamente assai grave. Tale errore è ingenerato dall’idea che tra noi e la realtà esterna si interponga un qualche tipo di medio rappresentazionale, qualcosa che funge da «interfaccia tra noi e il mondo»: l’esempio più noto in questo senso è rappresentato dai dati di senso della tradizione empiristica (DL,
16
487). In questa prospettiva l’intera nostra esperienza si svolge nella mente: la percezione è perciò indiretta, nel senso che gli oggetti ‘esterni’ si limitano a causare esperienze ‘interne’. E’ questa la teoria causale della percezione, che Putnam così descrive: «In questa teoria, gli oggetti che noi percepiamo danno origine a catene di eventi, che comprendono stimolazioni dei nostri organi di senso, e infine ai ‘dati di senso’ nelle nostre menti» (DL; 467). Questa impostazione, tuttavia, comporta ineluttabilmente il sorgere della questione scettica.
L’esposizione più coerente di questa posizione è offerta nei Problems of Philosophy di Russell: « Il tavolo reale, se ce n’è uno, non è lo stesso di cui abbiamo immediata esperienza attraverso la vista, il tatto o l’udito. Il tavolo reale, se ce n’è uno, non è affatto da noi immediatamente conosciuto, ma deve esserci un’inferenza a partire da quanto è immediatamente conosciuto. Emergono in questo modo due questioni molto difficili: (1) C’è un tavolo reale? (2) E nel caso che un tavolo vi sia, che genere di oggetto è?” 20. E’ evidente che sottesa a questa impostazione c’è la metafisica realistica: fuori dalla mente c’è il mondo in sé, il mondo bell’e pronto. Ma come possiamo noi essere certi di averne conoscenza, giacché lo percepiamo solo indirettamente ? Come possiamo sapere a cosa si riferiscono veramente i nostri dati di senso? La questione scettica è connaturata a questa concezione della percezione e al realismo metafisico che la adotta.
Nelle filosofie fisicalistiche contemporanee, nelle quali gli eventi cerebrali prendono il posto dei ‘dati di senso’, sorgono problemi analoghi. Così, per esempio, si esprime Quine: «Disponendo soltanto dei dati dei nostri sensi, come arriviamo alla nostra teoria del mondo? I corpi non sono dati nelle nostre sensazioni, ma da esse soltanto inferiti» 21. Analogamente, secondo l’approccio funzionalista – che ora Putnam rinnega, ma che gli deve la nascita – alcuni eventi cerebrali, gli outputs dei processi percettivi, vengono interpretati come ‘rappresentazioni mentali’ che svolgono la funzione di dati per la mente (che è interpretata come un computer cerebrale). Questi approcci contemporanei non sono che variazioni sul tema della percezione indiretta: al fondo, infatti, le concezioni materialistiche sono «sorprendentemente simili alla teoria dei dati di senso» e ne ereditano le insuperabili difficoltà epistemologiche (WL, p. 281; DL, pp. 475-487). A ben guardare, nota Putnam, persino gli antirealisti
17
condividono questa idea della percezione: è proprio perché la percezione così concepita rende l’accesso al ‘mondo in sé’ un’impresa irrealizzabile, infatti, che essi al mondo rinunciano del tutto. Anche rispetto alla questione della percezione, dunque, realismo metafisico e antirealismo si dimostrano complementari, offrendo soluzioni opposte, ma ugualmente insoddisfacenti.
Oggi, come ho accennato, Putnam non ritiene più che il ‘realismo interno’ rappresenti un’alternativa soddisfacente a tali concezioni (DL, pp. 461-465). Lo stesso termine ‘interno’ è fuorviante, perché evoca il dogmatico dualismo di mente e mondo. Una scelta terminologica sfortunata, certo, ma anche rivelatrice, poiché in verità anche il realismo interno è compromesso con l’epistemologia tradizionale (DL, pp. 453 n., 454 n.). A testimonianza di ciò, Putnam ricorda che in Reason, Truth and History tale concezione veniva presentata come complementare alla visione funzionalistica della mente, che come s’è appena visto è nulla più di una versione aggiornata delle classiche teorie epistemologiche incentrate sui ‘dati di senso’ (DL, pp. 463-465). Questo argomento di Putnam non pare però particolarmente convincente: tra il funzionalismo e la concezione epistemica della verità, che è il fondamento del realismo interno, non c’è infatti alcuna necessaria connessione concettuale; non si vede dunque perché le insufficienze epistemologiche della prima concezione dovrebbero ricadere sull’altra (che queste due concezioni siano logiamente indipendenti è dimostrato, tra l’altro, dal fatto che lo stesso Putnam per un certo periodo ha continuato a difendere il realismo interno pur avendo abbandonato la visione funzionalistica della mente) 22.
Il realismo interno incorre però in un’ulteriore, più grave difficoltà. Come abbiamo visto, l’epistemologia tradizionale rende estremamente problematico spiegare «come possiamo avere accesso referenziale alle cose esterne»: esattamente lo stesso problema, nota Putnam, sorge nel caso del nostro accesso referenziale alle ‘condizioni epistemiche ideali’. Nel realismo interno, in sostanza, «il modo di concepire una situazione epistemica era, al fondo, proprio quello dell’epistemologia tradizionale. Il mio modo di porre la questione incorporava ancora la premessa fondamentale di un’interfaccia tra il soggetto conoscente e tutto ciò che c’è ‘fuori’» (DL, 462). Nessuna concezione che presupponga una qualche versione, sia pure aggiornata, dell’epistemologia tradizionale – come accade con il realismo interno – può sfuggirne le aporie.
18
Nondimeno, secondo Putnam, tutte queste difficoltà possono essere superate adottando un punto di vista naturale rispetto alla percezione.
Per questa sua nuova svolta filosofica, Putnam riconosce il proprio debito nei confronti di un variegato drappello di autori. In primo luogo verso i pragmatisti, in particolare James e Dewey, che ci hanno insegnato che «ciò che ha peso nelle nostre vite dovrebbe avere peso anche in filosofia» (DL, p. 517) 23. In secondo luogo nei confronti di Austin, per la devastante critica dei fondamenti dell’epistemologia tradizionale offerta in Sense and Sensibilia («uno dei classici più ingiustamente negletti della filosofia analitica» (DL, p. 470)). Inoltre verso il secondo Wittgenstein, che per Putnam non fu affatto un antirealista, come normalmente si crede (WL, saggio 13; RPh, capp. 7, 8). Tra i contemporanei, infine, Putnam riconosce un debito particolare nei confronti di John McDowell, per le sue tesi sulla percezione e sull’intenzionalità (WL, saggi 14 e 15).24
La strada che Putnam sta esplorando oggi consiste dunque nel recuperare un atteggiamento naturale rispetto alla percezione, «a second naiveté», che ci permetta di tornare a comprendere che «le cose ‘esterne’ – i cavoli, i re – possono essere esperite » (e non meramente causate) (DL, pp. 458, 464). Se si rinuncia alla concezione tradizionale della percezione e si ammette che di norma noi percepiamo direttamente il mondo, i problemi dell’epistemologia tradizionale svaniscono. E’ importante notare, però, che la rinuncia agli intermediari mentali nella spiegazione della percezione non significa che Putnam postuli una sorta di ‘contatto immediato’ tra la mente e gli oggetti (in questo modo non farebbe che riproporre la ‘teoria magica del riferimento’). Il punto, piuttosto, è che in questa prospettiva la stessa distinzione interno/esterno non ha più ragion d’essere: la mente, infatti, non viene più considerata come un organo, materiale o immateriale, che elabora informazioni che vengono dall’esterno; essa piuttosto è vista come un sistema di abilità cognitive, dipendente sia dagli eventi cerebrali sia dalla nostra interazione con il mondo e descrivibile soltanto per mezzo di un vocabolario intenzionale (DL, 453, 483; WL, saggio 15). In tale ottica anche la percezione è l’esercizio di un’abilità cognitiva. Percepire un oggetto, spiega Putnam, non è un processo bipartito, in cui a un’interazione non cognitiva tra oggetti e apparato percettivo faccia seguito l’elaborazione cognitiva da parte del cervello. Ad essere cognitivo è il processo percettivo nella sua interezza.
19
Una tesi di questo genere si radica con evidenza nella tradizione pragmatista: «gli eventi cerebrali sono una parte della mia attività cognitiva e percettiva solo perché io sono una creatura con un certo tipo di ambiente normale, e con una certa storia di interazioni individuali e di specie con quell’ambiente». In tal modo, secondo Putnam, né gli eventi cerebrali né i fenomeni percettivi sono intrinsecamente cognitivi: «[c]ome avrebbe detto John Dewey, ciò che è cognitivo è l’interazione» (WL, p. 289).
Ancora una volta, dunque, il pensiero di Putnam è a una svolta. Va
sottolineato, però, che questo suo nuovo progetto filosofico è ancora in fieri e le sue nuove tesi non sono ancora soddisfacentemente elaborate. Sarebbe dunque prematuro, e anche ingiusto, rilevare che l’una o l’altra di tali tesi non è sufficientemente elaborata o che le diverse componenti che Putnam vuole assemblare nella sua nuova concezione (la relatività concettuale; il ‘realismo naturale’ rispetto alla percezione; la polemica antiscientistica e quella antirelativistica; la concezione della mente come sistema di abilità) non formano ancora un insieme sufficientemente coeso.
Su un punto almeno un giudizio si può tuttavia esprimere. Con l'adesione al realismo naturale, Putnam dichiara concluso il suo itinerario filosofico, «un lungo viaggio che dal realismo è partito e che al realismo è tornato» (DL, 494). Il rigore della sua riflessione e le nuove prospettive che nel corso degli anni egli ha dischiuso stanno a dimostrare che questo suo travagliato viaggio non è stato affatto infecondo.
20
NOTE 1 A proposito di: H. Putnam, Renewing Philosophy, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1992, pp. 234 + 12 e Words and Life, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1994, pp. 531 + 76. 2 Questa bibliografia è in appendice a H. Putnam, Pragmatism. An Open Question, Oxford, Blackwell, 1995. 3 Per il Putnam realista metafisico cfr. Meaning and the Moral Sciences, London, Routledge & Kegan Paul, 1978, trad. it. di A. La Porta, Verità ed etica, Milano, Il Saggiatore, 1982. Già nella quarta parte di quel libro, tuttavia, si manifestano i segni della conversione di Putnam alla concezione epistemica del realismo interno, culminata in Reason, Truth and History, Cambridge, Cambridge University Press, 1981, trad. it. di A.N. Radicati di Brozolo, Ragione, verità e storia, Milano, Il Saggiatore, 1985. Per una presentazione autobiografica degli sviluppi del pensiero di Putnam, cfr. le sue Dewey Lectures, tenute alla Columbia University nel 1994 e pubblicate con il titolo Sense, Nonsense and the Senses. An Inquiry into the Powers of the Human Mind («Journal of Philosophy», 91, 1994, pp. 445-517). D’ora in poi, per brevità, indicherò nel testo i riferimenti alle opere di Putnam più frequentemente richiamate, usando le seguenti abbreviazioni: Renewing Philosophy = RPh; Words and Life = WL; Reason, Truth and History = RTH; Dewey Lectures = DL. 4 Putnam difende il funzionalismo nei saggi di Mind, Language, and Reality. Philosophical Papers, vol. II, Cambridge, Cambridge University Press, 1975; trad. it. di R. Cordeschi, Mente, linguaggio e realtà, Milano, Adelphi, 1987. Per le critiche che Putnam ha inseguito mosso a tale concezione cfr. Representation and Reality, Cambridge (MA), MIT Press, 1988, trad. it. di N. Guicciardini, Rappresentazione e realtà, Garzanti, Milano 1993 e Self-Portrait, in S. Guttenplan (ed.), A Companion to the Philosophy of Mind, Oxford, Blackwell, pp. 507- 513. 5 L. Wittgestein, Philosophische Untersuchungen, Oxford, Blackwell, 1953, parte I, §§ 255;, trad. it. di M. Trinchero, Ricerche filosofiche, Torino, Einaudi, 1967, p. 121. 6 Representation and Reality, cit., p. 107 (trad. mia). 7 In RTH, trad. it. p. 66-67, Putnam discute un altro caso apparentemente insidioso per questa sua tesi storiografica: quello di Berkeley, la cui filosofia è da Putnam interpretata come una reductio ad absurdum degli assunti del realismo metafisico.8 Cfr., per esempio, il saggio eponimo in Ontological Relativity and Other Essays, Columbia University Press, 1969, pp. 26-68, trad. it. di M. Leonelli, La relatività ontologica e altri saggi, Roma, Armando, 1986, pp. 59-93. 9 R. Boyd, Materialism without Reductionism: What Physicalism Doesn’t Entail, in N. Block (ed.), Readings in the Philosophy of Psychology, I, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1980, pp. 67-106; M. Devitt, Realism and Truth, Princeton,
21
Princeton University Press, 1984; J. Fodor, A Theory of Content, Cambridge (MA), MIT Press, 1990. Putnam discute di queste concezioni in RPh, cap. 2 e 3 e in WL, saggi 14, 15, 18. 10 Tra le categorie di parole in cui la possibilità del riferimento presuppone una connessione causale con i rispettivi referenti, Putnam discute in particolare dei termini che denotano ‘generi naturali’, come ‘ mela’ o ‘ rame’ (The Meaning of Meaning, in Mind, Language and Reality, cit., pp. 215-271); altri casi sono quelli degli indicali e dei nomi propri. Che per Putnam la nozione di riferimento non si riduca a quella di ‘connessione causale adeguata’ è mostrato dal fatto che rispetto alla determinazione del riferimento delle parole di ‘genere naturale’ egli attribuisce un ruolo fondamentale al giudizio degli esperti (per esempio, sono i chimici a stabilire l’estensione precisa di un termine come ‘oro’): a questo proposito Putnam parla di ‘divisione del lavoro linguistico’. Si noti che nemmeno a Kripke è corretto attribuire la volontà di ridurre la nozione di riferimento a quella di causa (cfr. Naming and Necessity, in D. Davidson - G. Harman (eds.), Semantics of Natural Languages, Dordrecht, Reidel, 1972, pp. 253-355, trad. it. di M. Santambrogio, Nome e necessità, Torino, Boringhieri, 1982). 11 J. Fodor, A Theory of Content, MIT Press, Cambridge (MA), 1990. 12 Putnam nota che in questo modo al realista metafisico si presenta comunque una difficoltà, in quanto egli assume la nozione di classe: per essere coerente con il suo progetto il realista dovrebbe dunque spiegare cosa sono le classi senza ricorrere a nozioni intenzionali (cfr. RPh, p. 207, n.). 13 Per questo punto, Putnam (RPh, p. 47) rimanda alla classica analisi di H.L.A. Hart e A.M. Honoré, Causation in the Law, Oxford, Clarendon Press, 1959. 14 Sulla concezione putnamiana della causalità e dei controfattuali, cfr. anche Is the Causal Structure of the Physical Itself Something Physical?, in Realism with a Human Face, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1990, pp. 80-95 e The Many Faces of Realism, La Salle, Open Court, 1987 pp. 37-40. 15 The Many Faces of Realism, cit., pp. 18-20. 16 Sorprende, a questo proposito, che Putnam attribuisca a Donald Davidson una posizione analoga. Secondo la ricostruzione di Putnam, Davidson sosterrebbe che «il fenomeno delle descrizioni equivalenti, che la scienza ha riscontrato a partire dalla fine dell’Ottocento, dà luogo in qualche modo a una contraddizione logica» (RPh, p. 119). Il riferimento è al celebre saggio di Davidson The Very Idea of a Conceptual Scheme (in Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford, Oxford University Press, 1984, pp. 183-198, trad. it. di R. Brigati, Verità e interpretazione, Bologna, Il Mulino, 1992, pp. 151-167), dove tuttavia si sostiene una tesi ben diversa, riferita peraltro agli schemi concettuali, non alle descrizioni: secondo Davidson schemi concettuali radicalmente diversi, incommensurabili, non possono darsi, pena l’impossibilità stessa dell’interpretazione; ogni interpretazione presuppone anzi l’applicazione del
22
principio d’indulgenza, secondo il quale interpretare i proferimenti di un parlante richiede che gli si attribuiscano il maggior numero di credenze corrette (secondo i nostri criteri di correttezza, ovviamente). Se dunque la tesi di Davidson ha un senso rispetto al tema qui in discussione, sarà che le descrizioni equivalenti non possono dare luogo a contraddizioni logiche. 17 R. Rorty, The World Well Lost, «Journal of Philosophy», 69, 1972, pp. 649-665. 18 Sull’interpretazione rortiana del Putnam antimetafisico, cfr. Putnam and the Relativist Menace, «Journal of Philosophy», 90, 1993, pp. 443-461; la risposta di Putnam è in WL, saggio 15. Da notare che Rorty presenta gli argomenti antirealistici che Putnam trasse dalla teoria dei modelli, di cui ho discusso sopra, come una dimostrazione delle rispettive controtesi di carattere relativistico. A questo proposito Putnam riafferma con decisione che in quel caso si trattava di una reductio ad absurdum del realismo metafisico in quanto tale. Per il dibattito tra Putnam e Rorty, cfr. anche, rispettivamente, Putnam on Truth e Truth, Activation Vectors and Possession Conditions for Concepts, in «Philosophy and Phenomenological Research», 52, 1992, alle pp. 415-18 e 431-47. 19 Philosophische Untersuchungen, cit., parte I, § 97, trad. it. cit. p. 63 (cit. in WL, p. 310 n.).20 B. Russell, The Problems of Philosophy, p. 47. 21 W.V.O. Quine, The Roots of Reference, Open Court , La Salle, 1974, p. 1 22 Cfr. Representation and Reality, cit. 23 Sull’interpretazione putnamiana del pragmatismo, cfr. Pragmatism. An Open Question, cit. 24 J. McDowell, Mind and World, Harvard, Harvard University Press, 1994.