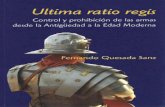La treccia di Putnam. Ultima fermata della filosofia analitica
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of La treccia di Putnam. Ultima fermata della filosofia analitica
Proprietà letteraria riservata© libreriauniversitaria.it edizioni
Webster srl, Padova, Italy
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamentototale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfi lm e le copie fotostatiche)
sono riservati per tutti i Paesi.Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsivoglia forma senza l’ autorizzazione scritta dell’ Editore, a eccezione di brevi citazioni incorporate in recen-
sioni o per altri usi non commerciali permessi dalla legge sul copyright. Per richieste di permessi contattare in forma scritta l’ Editore al seguente indirizzo:
ISBN: 978-88-6292-391-0Prima edizione: luglio 2013
Il nostro indirizzo internet è:www.libreriauniversitaria.it
Per segnalazioni di errori o suggerimenti relativi a questo volume potete contattare:
Webster srlVia Stefano Breda, 26Tel.: +39 049 76651
Fax: +39 049 766520035010 - Limena PD
Sommario
Archeoproemio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Lezione del 10 novembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Lezione del 11 novembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Lezione del 12 novembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Lezione del 17 novembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Lezione del 18 novembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Lezione del 19 novembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Lezione del 24 novembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Lezione del 25 novembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Lezione del 26 novembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Lezione del 27 novembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Lezione del primo dicembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Lezione del 3 dicembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Lezione del 9 dicembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Lezione del 10 dicembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Lezione del 16 dicembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Lezione del 17 dicembre 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Lezione del 12 gennaio 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
4
Sommario La treccia di Putnam
Lezione del 13 gennaio 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Lezione del 14 gennaio 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Lezione del 19 gennaio 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Lezione del 21 gennaio 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Lezione del 26 gennaio 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Lezione del 27 gennaio 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Sinossi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Archeoproemio
Nell’ anno accademico 2003-2004 ho tenuto un corso incentrato su lettura e com-mento dell’ ultimo volume di Hilary Putnam tradotto in italiano: Mente, corpo, mondo (Il Mulino, Bologna 2003). Il titolo originale del libro è, tradotto alla lettera, La triplice corda e il sottotitolo è Mente, corpo e mondo (Th e threefold cord: mind, body and world, 2001). Peccato che il titolo originale sia sparito dall’ edizione ita-liana e sia stato conservato solo il sottotitolo.
Se “triplice corda” non intendeva alludere banalmente a tre corde messe una accanto all’ altra sul pavimento, si trattava allora di una corda fatta di tre capi o trefoli, che io chiamo, in italiano, treccia, in inglese braid, come quelle che Obelix si fa ai capelli o come quelle che servono per irrobustire i cavi. Ci sono molti tipi di treccia e hanno a che fare con i molti modi in cui si può fare un nodo. Sapevate che c’ è anche una teoria matematica dei nodi e delle trecce? Me ne sono anche interessato quando volevo farne uno strumento per avvicinare in modo un po’ di-verso dal solito i bambini delle elementari al pensiero matematico, tant’ è che più di vent’ anni fa tenni un seminario orientato in questo senso per gli insegnanti delle scuole Montessori. All’ idea matematica di treccia mi sono ispirato nell’ avanzare la proposta di un naturalismo “intrecciato” (entwined) in un lavoro che uscì proprio nel 2004 sugli Annali del dipartimento di cui faccio parte (non faccio parte degli Annali). Diciamo quindi che verso la triplice corda di Putnam avevo un forte fee-ling – di simpatia – e allo stesso tempo avevo bisogno di chiarire alcune diff erenze.
Le lezioni del 2003-2004 erano esecrabilmente tenute a braccio, senza neppure una scaletta, se non quella costituita dal dover seguire l’ ordine delle pagine nel li-bro di Putnam. Per giunta, la durata delle lezioni era mutevole: la regola voleva due ore, che si potevano contrarre o estendere in funzione delle circostanze e spesso si protraevano fi no all’ esaurimento delle risorse psicofi siche dei presenti. Non sarei mai stato in grado di ricostruire il discorso svolto una lezione dopo l’ altra, quin-
6
Archeoproemio La treccia di Putnam
di, se proprio ci tenevo, avrei dovuto mettermi lì a riscrivere da zero le rifl essioni suscitate dalla lettura del testo. Nel 2003, e poi negli anni successivi, altri impegni hanno avuto la precedenza.
Se esiste questo testo è perché la fortuna, o la sfortuna, ha voluto che l’ intero ci-clo di lezioni 2003-2004 fosse registrato su nastro dagli studenti. Molto tempo dopo mi furono date le relative cassette audio, unitamente a una raccolta di appunti presi durante le lezioni, da una ex-studentessa di cui, mea culpa, non ricordo il nome. Due giovani dottorandi che collaboravano con me, Duccio Manetti e Silvano Zipoli Caiani, sbobinarono le cassette audio e ne estrassero un testo che solo nell’ estate del 2012 ho preso in mano e ho rivisto. A Manetti e Zipoli Caiani sono molto grato per l’ impegno con cui hanno realizzato la trascrizione. Sono altrettanto grato allo stesso Zipoli, così come ad Alberto Binazzi e Andrea Sani, ma in particolare a Marco Tra-pani, per aver letto con certosino scrupolo il testo delle lezioni individuando i refusi e suggerendo più che opportune modifi che alla forma espressiva.
Quanto segue è dunque il risultato di una revisione che con vari anni di ritardo ho condotto sul testo sbobinato delle lezioni, mentre la conclusiva sinossi degli ar-gomenti appare, con pochi accorgimenti sintattici, così come era stata predisposta nel 2003 per gli studenti del corso.
La revisione si deve essenzialmente a tre motivi. Il primo è che alcune lezioni non erano state registrate e, per quelle registrate, la registrazione era incompleta e così alcuni passaggi si potevano capire ugualmente, altri no. Il secondo motivo è che, per certi tratti di una lezione, il nastro era danneggiato e così restavano solo gli appunti presi dagli studenti, appunti non sempre precisi ma almeno in parte precisabili. Il terzo motivo è che il parlato non si presta a essere trasferito diretta-mente in forma scritta.
Per colmare le lacune più piccole ho cercato di inserire un po’ di frasi esplica-tive laddove sono riuscito a immaginare cosa potevo aver detto al tale punto della tale lezione. Quando questo non si è verifi cato, ho mantenuto il più possibile il testo sbobinato così com’ era. Le parti mancanti che sono rimaste anche dopo la revisione sono contrassegnate da […]. Mi sono preso un po’ più cura dell’ italia-no, senza esagerare, altrimenti il tono vivo delle lezioni sarebbe andato perso. Ho lasciato le date delle lezioni così com’ erano indicate anche se spero che nessuno consideri rilevante un eventuale errore al riguardo.
Sporadicamente ci sono lacune più grandi, corrispondenti come dicevo a le-zioni non registrate o a molti minuti in cui la registrazione si interrompeva e non c’ erano neppure gli appunti scritti per poter ricostruire cosa avevo detto e colmare in qualche modo la lacuna. A questo proposito, la sinossi degli argomenti è utile non solo come riassuntino e come spiegazione del signifi cato di molti termini uti-lizzati; è utile anche perché è una spia di quanto manca.
7
Archeoproemio
Non ho voluto articolare un argomento meglio di quanto avevo fatto a lezio-ne, per esempio entrando nel merito della molteplicità di alternative possibili in rapporto alle questioni via via discusse. Non ho voluto approfondire i rimandi che Putnam fa a questo e quel fi losofo né ho fatto un riferimento più che occasionale a lavori che il testo di Putnam non menziona ma che allora come oggi conside-ro importanti per farsi un quadro adeguato dei problemi inerenti alla “treccia” formata da mente, corpo e mondo. Né, infi ne, ho voluto aggiungere alcunché di quello che nel 2003-2004 mi frullava per la testa e che poi ho esposto in articoli e libri sugli stessi temi, anche se qua e là mi capita di fare una minima segnalazione al riguardo, prendendo spunto dal tema di volta in volta toccato: si tratta sempre di brevissimi accenni, rimasti tali e quali erano durante le lezioni: semplici inviti a una ulteriore rifl essione, rivolti a quelli che tra gli studenti che avevo davanti a me in aula mi sembravano desiderosi di saperne di più, non a colleghi supernavigati. Se fra il pubblico presente c’ era qualche prof. e qualche dottorando, quegli accenni venivano sviluppati in conversazioni dopo ogni lezione, al bar o in uffi cio o nel chiostro dell’ ex-convento di Santa Trinita, in via Parione 7 a Firenze (la sede in cui si svolgevano le lezioni). Come si può immaginare, non c’ è nessun nastro di quelle conversazioni.
Il testo venuto fuori dal lavoro di revisione conserva dunque il carattere didat-tico-espositivo proprio delle lezioni da cui è nato. In virtù di tale carattere, credo che possa essere utile a chi si avvicina per la prima volta al pensiero di Putnam e, più in generale, credo che possa servire a chiunque sia interessato a comprende-re le ragioni che stanno dietro ad alcuni temi nodali della fi losofi a analitica, così come le ragioni per cui aff ermavo che il libro di Putnam ne fosse l’ ultima fermata. Da allora lo so anch’ io, grazie, che sono usciti libri e articoli che si collocano nel solco analitico, sono riconosciuti come importanti contributi, e in vari punti giun-gono a conclusioni simili al libro che scelsi come oggetto del corso. Senza nulla togliere alla qualità di lavori destinati ad allungare un addio, Mente, corpo, mondo resta per me ugualmente paradigmatico.
E poi… questa raccolta di lezioni può essere utile in un senso più ampio, in quanto permette di entrare in contatto con alcuni grandi temi della fi losofi a tout court. Onde evitare equivoci, l’ utilità cui mi riferisco non deriva tanto da una ri-costruzione storica del dibattito sui temi trattati – ricostruzione che qui manca o è oltremodo stringata – quanto da una ricostruzione argomentativa: si fa l’ analisi di un problema e si fa l’ analisi delle sue soluzioni, o meglio: di alcune, perché l’ una e l’ altra analisi sono condotte sempre attraverso una lente particolare, ovvero, la lente fornita da Putnam così come la presenta in Mente, corpo, mondo.
I motivi per cui scelsi questo testo per fare una cosa per me più che insolita, cioè tenere un corso organizzato in forma di lettura-e-commento, erano molteplici
8
Archeoproemio La treccia di Putnam
e alcuni di essi del tutto contingenti. Ce n’ è uno, tuttavia, che mi preme ricordare. Nei confronti di Putnam avevo un debito: alla fi ne degli anni Settanta, la lettura dei tre volumi dei suoi Philosophical papers ebbe su di me un eff etto liberatorio e tuttora considero Putnam uno dei più rappresentativi fi losofi della seconda metà del Novecento – indipendentemente dal fatto di essere o no d’ accordo con lui su questo o quel punto.
Infi ne, per i curiosi: il titolo allude all’intreccio di mente, corpo e mondo, che secondo Putnam dovrebbe esserci ma che, stando agli argomenti addotti, non si capisce come faccia a esserci, e così, invece di una treccia, abbiamo solo tre corde adiacenti l’ una all’ altra (proprio come nell’ immagine in copertina); nel sottotitolo, l’ aggettivo “ultima” è intenzionalmente ambivalente, perché sta a signifi care sia la fermata “più recente” (nel 2003) sia una fermata che, se condivisa fi no in fon-do, comporta l’ uscita dalla fi losofi a analitica e, più in generale, dalla fi losofi a così come è stata prevalentemente intesa e coltivata in Europa e in America negli ultimi due secoli. Le ragioni che stanno dietro a questa seconda accezione sono sparse lungo tutto l’ arco del discorso svolto, dalla prima lezione all’ ultima.
Lezione del 10 novembre 2003
La metafi sica aristotelica sta alla base del realismo elaborato dalla scolastica me-dioevale. Putnam vuole confutare questo tipo di realismo e comincia la serie di conferenze raccolte in questo libro partendo proprio dall’ individuazione della tesi di fondo del realismo, una tesi che articola in due sotto-tesi, cioè, la descrive come la congiunzione di due tesi distinte, da considerarsi l’ una indipendente dall’ altra. Cosicché potreste fare un primo esercizio: immaginare un realismo in cui sia pre-sente solo una delle due sotto-tesi. (Non vi chiedo di fare subito quest’ esercizio.)
Non vorrei che il rimando alla scolastica fosse fuorviante: la formulazione del realismo che trovate all’ inizio del libro è molto generale: copre numerose versioni del realismo che si sono presentate nel corso della storia della fi losofi a, sia prima del Medioevo sia dopo. L’ idea di Putnam è che dietro ci sia sempre e comunque l’ impronta di Aristotele, un’ impronta che trovò il suo pieno sviluppo nella scolastica.
Ecco quali sono i due ingredienti della tesi di fondo del realismo scolastico:
1. il mondo è organizzato in una struttura gerarchica di forme e proprietà na-turali;
2. il mondo è una totalità ben defi nita.
Ogni cosa, ogni oggetto, ogni creatura, ogni “ente”, ha il suo specifi co posto nell’ ordine cosmico; e la questione di cosa faccia parte del mondo e cosa non ne faccia parte, di cosa sia reale e cosa non lo sia, ha una risposta univoca (o è desti-nata ad averla).
Putnam giustamente distingue le due sotto-tesi e in queste prime pagine riesce a fornire una descrizione del realismo che, pur essendo sintetica, è particolarmente effi cace. La congiunzione delle due sotto-tesi è appunto la tesi di fondo ed è una
Lezione del 10 novembre 2003 La treccia di Putnam
10
tesi metafi sica che si può in eff etti far risalire ad Aristotele. La metafi sica aristote-lica non si limitava però a enunciare un tale principio: specifi cava anche come era fatta la gerarchia di generi e specie. Prendendo le distanze dalla metafi sica aristo-telica, Putnam rinuncia anche al presupposto che esista ab initio una ben defi nita totalità di forme naturali. Potrebbe anche trattarsi di una totalità non data tutta quanta in un momento: in questo caso a essere data sarebbe la gamma totale delle forme e proprietà naturali possibili. E allora viene messo in questione anche un altro assunto: che esista l’ insieme di tutte le verità, come totalità ben defi nita, siano esse verità eff ettive o verità possibili.
Raccontata così, potrà sembrare una problematica un po’ vecchiotta. Com’ è che si è confi gurata nella fi losofi a del Novecento? A p. 16 si comincia a far cono-scenza con il modo in cui la metafi sica del realismo si è ripresentata in una nuova cornice, quella off erta dalla fi losofi a del linguaggio, ovvero all’ interno della fi loso-fi a analitica.
Beh, ci sono anche altri modi di fare fi losofi a del linguaggio, ma l’ impostazio-ne detta “analitica” è quella che nei paesi di lingua inglese ha dominato la scena nell’ ultimo secolo. Si dice “analitica” intendendo che è basata sull’ analisi logica del linguaggio, ma non dovete pensare all’ analisi logica che probabilmente vi hanno insegnato a scuola. Si tratta di un’ analisi di tipo diverso, basata sulla logica mate-matica. Su quest’ analisi ci soff ermeremo più avanti e non quanto sarebbe necessa-rio per fare le cose davvero per bene, perché porterebbe via troppo tempo.
Cosa vuole dirci Putnam? La risposta è abbastanza semplice; il modo in cui la risposta viene off erta, un po’ meno. La sua idea è che nel Novecento il realismo me-tafi sico si è riciclato sotto forma di una teoria del signifi cato, e in virtù dei rapporti fra linguaggio, mondo e mente, il realismo metafi sico è fi ltrato dal piano semanti-co, riguardante il signifi cato, al piano dell’ esperienza conoscitiva, anzi dalle parole alle cose, da quel-che-diciamo-che-c’ è a quel-che-c’ è, all’ esterno di noi o all’ inter-no di noi. Insomma, per quanto sia cambiato il lessico dal Medioevo a oggi, la tesi di fondo non è uscita di scena e continua invece a dar voce a un’ idea ingenua della realtà, con la diff erenza che il realismo contemporaneo prende vita a partire da un’ idea ingenua del signifi cato invece che da un’ idea ingenua del mondo.
L’ idea ingenua del signifi cato prevede che si sottoscrivano due assunzioni. Le due assunzioni riguardano in senso stretto il signifi cato dei nomi comuni che stan-no per classi, generi, specie ecc., ma poi fi niscono per infettare tutto quanto il linguaggio.
Assunzione 1. Il signifi cato di un nome comune (sintagma nominale, predicato) è una proprietà condivisa da tutte le cose alle quali il nome si riferisce.
Esempio: il signifi cato del termine “cavallo” è quella proprietà che tutti gli ap-partenenti alla classe dei cavalli possiedono, a prescindere dalle eventuali diff eren-
Lezione del 10 novembre 2003
11
ze tra un cavallo e l’ altro. Parlare di una cosa come la classe (o l’ insieme) dei cavalli presuppone che sia data una certa proprietà comune, una proprietà che qui defi -nisce appunto la totalità dei cavalli, come quella cosa ai cui singoli elementi ci rife-riamo quando diciamo “Questo è un cavallo”, ove questo si riferisce a un particolare esemplare (un individuo) e cavallo esprime una certa proprietà che l’ esemplare ha in comune con tutti gli altri. In eff etti, il signifi cato di cavallo non consiste di una sola proprietà ma di tante: quadrupede, ruminante, ecc..
Assunzione 2. Le parole che usiamo per riferirci a categorie, classi, generi e specie [ma, come sopra, l’ assunzione riguarda non solo singole parole] rimandano a una totalità ben defi nita, fatta di oggetti specifi ci con le loro specifi che proprietà.
Esempio: il termine “cavallo” si riferisce all’ insieme di tutte quelle cose che hanno una certa proprietà (che può risultare dall’ unione di diverse caratteristiche).
Una volta specifi cato il riferimento dei termini, si può capire quali proposizio-ni sono vere e quali sono false intorno agli oggetti di cui parliamo – ciò cui i ter-mini si riferiscono – intendendo “oggetto” in senso lato, in modo da coprire ogni entità cui ci riferiamo, ivi compresi gli animali, le piante e quant’ altro.
Secondo Putnam il vecchio realismo di derivazione aristotelica si è riciclato in questi due assunti concernenti il linguaggio. Dunque, una tesi metafi sica sul mon-do è diventata una tesi di fi losofi a del linguaggio e in eff etti, più che una tesi esplici-ta, è un’ assunzione, duplice, che resta sullo sfondo di tanta fi losofi a del linguaggio. Questa duplice assunzione dal primo Novecento giunge fi no ai nostri giorni. […]
Ma cos’ è che possiamo sensatamente considerare come oggetti? I singoli eventi sono oggetti? Le classi di fatti di uno stesso tipo (come, per esempio, le nevicate) sono oggetti? I numeri sono oggetti? I colori sono oggetti? I pensieri sono oggetti? Anche se rispondiamo di sì, gli eventi, i tipi di fatti ecc. sono forse oggetti così come lo sono le pietre e i tavoli? Non pare. Inoltre, le categorie di oggetti in cui segmentiamo il mondo hanno davvero una proprietà che li defi nisce? Hanno cioè una proprietà che è condizione necessaria e suffi ciente per dire se qualcosa rientra in quella categoria o no?
Per esempio, esiste davvero una proprietà che tutti i campioni di oro hanno in comune? Potremmo dire che da situazioni di incertezza semantica si esce sfruttando una defi nizione scientifi ca, che in questo caso rimanda alle proprietà degli atomi di oro. Ma la parola italiana “oro” non è sinonima (non ha lo stesso signifi cato) delle proprietà atomiche dell’ elemento chimico Au. La maggior parte delle persone che parlano l’ italiano non conoscono la struttura fi sico-chimica dell’ oro, eppure usano il termine con relativo successo nella vita di tutti i giorni. Analogamente usano cor-rentemente la parola “acqua” anche senza sapere come sono fatte le molecole di H2O.
Se anche tutti i campioni di oro hanno in comune la proprietà di essere una particolare specie di isotopo con numero atomico 79, questo – osserva Putnam –
Lezione del 10 novembre 2003 La treccia di Putnam
12
non può essere il signifi cato della parola “oro”. Se lo fosse, infatti, tutte le persone che usano la parola “oro” potrebbero e dovrebbero sostituirla in una qualunque frase, senza modifi carne il signifi cato, con “elemento con numero atomico 79”. (In ciò si sfrutta un principio generale, cioè, che se due espressioni sono sinonime, si può sostituire l’ una all’ altra senza che cambi il signifi cato della frase in cui una di esse compare.) Ma una simile sostituzione non è praticabile, come di nuovo attesta il fatto che molte persone parlano di oro (si riferiscono all’ oro) senza sapere lon-tanamente che l’ oro è composto di atomi con quel particolare numero atomico. Analogamente, se state per morire di sete nel deserto e incontrate un beduino, gli chiederete dell’ acqua e non 6 ∙ 1024 molecole di H2O.
Questo tipo di esempi manifesta la diffi coltà di individuare un insieme ade-guato di proprietà condivise da ogni possibile campione di una sostanza come l’ oro. Normalmente diciamo che l’ oro è un metallo giallo, ma il colore giallo non dovrebbe essere considerato come una qualità condivisa da ogni campione di oro. L’ oro infatti, in mancanza di impurità, è una sostanza che appare di colore bianco. E anche ammettendo come esempi legittimi di oro i lingotti gialli (dunque di oro non purissimo), non tutti gli esempi avrebbero esattamente le stesse proprietà – al-cuni possono avere una certa tonalità di giallo, altri una leggermente diversa (spia della presenza di residui in percentuale diversa).
Dunque – conclude Putnam – il signifi cato della parola “oro” non può essere identifi cato come il suo riferimento scientifi camente precisato e più in generale con una proprietà ben defi nita, o con un insieme ben defi nito di oggetti. In altre parole, non è possibile specifi care una lista univoca di caratteri in base alla quale dire “Quello è oro” (e quell’ altro no). La stessa cosa vale per ogni altro sostantivo che indica un genere naturale (un tipo di sostanza, una specie vegetale o una specie animale). Ma la cosa fi nisce qui o ha una portata più generale?
Non fi nisce qui. Si pensi alla diffi coltà di defi nire a che cosa si riferisce esatta-mente la parola “gioco”. È stato uno dei maggiori fi losofi del Novecento, Ludwig Wittgenstein, a richiamare l’ attenzione proprio su questa diffi coltà. Secondo la concezione del realismo, il signifi cato della parola “gioco” dovrebbe indicare una proprietà o un insieme di proprietà che tutti i possibili giochi condividono. Ma qual è questa benedetta proprietà (o quest’ insieme di proprietà)? La presenza di un avversario? Il numero dei giocatori? Cos’ ha in comune il gioco degli scac-chi con una partita di calcio? L’ avere un vincitore e un vinto? Anche le guerre ce l’ hanno e non sono un gioco. Un gioco è forse una guerra simulata? Ma ci sono giochi che non prevedono confl itto. Sembra dunque diffi cile individuare una proprietà unica e universale condivisa da tutte le forme di gioco, mentre non ci sembra aff atto diffi cile usare la parola “gioco” e anzi la usiamo con successo in tante frasi.
Lezione del 10 novembre 2003
13
C’ è poi un secondo problema, correlato al precedente, e riguarda l’ assunzione secondo cui la realtà è defi nita (vedi realismo aristotelico-scolastico) non solo da una prefi ssata totalità di oggetti, ma anche dall’ insieme, non meno prefi ssato, delle loro proprietà. Invece, l’ esperienza umana suggerisce che non si può supporre che la somma totalità degli oggetti + totalità delle proprietà degli oggetti sia fi ssata una volta per tutte. Con il procedere della conoscenza aggiungiamo, o togliamo, ogget-ti e proprietà dal mondo a seconda delle informazioni che via via raccogliamo e a seconda dei nostri quadri interpretativi. Mentre, se il mondo è quel che è – cioè, una fi ssata totalità di oggetti con le loro fi ssate proprietà – un simile aggiungere-e-togliere dovrebbe fare arrabbiare il mondo: appropriazione indebita di mobili, furto, violazione di domicilio…
Nel Seicento si pensava che fossero reali le streghe. Nel Settecento si pensava che il responsabile della combustione fosse il fl ogisto. “Questa è l’ opera di una strega”, “Non è bruciato perché c’ era poco fl ogisto”: aff ermazioni del genere oggi riteniamo che non si possano sottoscrivere. Dal mobilio del mondo sono spariti gli oggetti dei quali quelle aff ermazioni presupponevano l’ esistenza. E quel che è successo alle streghe e al fl ogisto può succedere di nuovo. (Lo so, questa cosa po-trebbe non piacervi.)
Morale: non c’ è alcuna buona ragione per credere che esista un insieme di proprietà e oggetti fi ssati ab-initio, senza possibilità di modifi ca. E questo depone contro tutte le forme tradizionali di realismo, che vorrebbero farci credere che ha senso parlare di una totalità fi ssa di tutti gli oggetti che possiedono una proprietà e che ha senso parlare di proprietà che univocamente defi niscono una totalità. È sempre in azione la vecchia idea secondo la quale, a decidere se quel che diciamo è vero o falso, sono gli oggetti e le proprietà cui si riferiscono le nostre parole.
Detto a quelli di voi che sanno un po’ di matematica: qui, è anche in gioco un principio basilare della teoria degli insiemi, ovvero l’ Assioma di Comprensione: per ogni proprietà P esiste l’ insieme di tutti e solo gli x che godono della pro-prietà P. Putnam, piuttosto che ridisegnare una semantica mediante una discus-sione critica di questo assioma, preferisce contestare il suo impiego metafi sico. Un’ altra cosa che a questo stesso proposito poteva fargli comodo è il carattere paradossale del concetto di insieme totale. L’ ipotesi che esista un insieme V che comprende tutto quanto va incontro a un piccolo problemino: se per ogni insie-me M ce n’ è uno più grande, perché si può dimostrare che l’ insieme Sub(M) dei sottoinsiemi di M ha sempre un numero più grande di elementi, allora Sub(V) dovrebbe essere più grande di V, contro l’ ipotesi che V sia l’ insieme totale. Inve-ce, Putnam anche in tal caso prende un’ altra strada. Evidentemente non ha (più) voglia d’ impelagarsi in arditi collegamenti fra logica, metafi sica e fondamenti della matematica.
Lezione del 10 novembre 2003 La treccia di Putnam
14
Ah, in caso a qualcuno di voi fosse venuto in mente: Putnam non è un proni-pote di Eraclito, non vi vuole convincere che tutto scorre, che la realtà è un fl uido e che dobbiamo fl uidifi carci il cervello se vogliamo capirla. Il nostro cervello cam-bia, d’ accordo, ma non può diventare un gel senza smettere di funzionare come cervello.
Qui gli preme insistere su un altro punto: che la nozione di oggetto, e di realtà come insieme di oggetti, non è univoca. Nel nostro comune uso del linguaggio, infatti, ci riferiamo a tipi quanto mai eterogenei di cose, alle quali ascriviamo re-altà in modi diversi. Putnam menziona l’ opinione di Donald Davidson secondo la quale gli eventi sono oggetti (cioè, entità che esistono nel mondo) e fa a questo proposito un esempio: possiamo anche parlare di guerre e dunque possiamo rife-rirci a esse come se fossero oggetti facenti parte della realtà. Così, se ci capita di dire che è nato un bambino, ci capita anche di dire che è scoppiata una guerra; oltre a dire che ci sono molti bambini, possiamo dire che ci sono molte guerre. Insom-ma, quando parliamo delle guerre, pensiamo che quel che diciamo può essere vero o falso esattamente come quando parliamo di corpi animati o inanimati. Riguardo alla Seconda Guerra Mondiale, possiamo aff ermare che è stata persa dalla Germa-nia o che è stata vinta dalla Germania e riteniamo corretto, oltre che sensato, giu-dicare vera la prima aff ermazione e falsa la seconda: le guerre sono eventi, quindi anche le guerre sono oggetti, mobilio del mondo.
Ma quale criterio possiamo indicare per identifi care oggetti come gli eventi? Il punto della questione non è tanto che il criterio dovrebbe essere diverso da quello adottato dai fi sici per identifi care una particella o dai chimici per identifi care le molecole di un composto. Siamo di fronte a una questione d’ altro ordine: parliamo di cose per le quali non disponiamo di precisi criteri d’ identità. Invece di dire che facciamo male a parlarne senza un criterio preciso, Putnam si preoccupa di come dar conto del fatto che non c’ è niente di male.
Un esempio banale: dov’ è che ci troviamo? A Firenze, ovviamente. Ci capita di fare frequenti aff ermazioni riguardo a questa città: “Firenze è una città pulita”, “A Firenze c’ è il campanile di Giotto”, “L’ Arno attraversa Firenze”, ciascuna delle quali può essere vera o falsa (sapete bene quale è falsa). Se vero è ciò che corrisponde alla realtà, Firenze è un oggetto che fa parte della realtà. La cosa non sembra crearci alcun problema. Quante volte al giorno pronunzieremo il nome di questa città? Ma dispo-niamo di un criterio adeguato per determinare il signifi cato dell’ espressione “Mi tro-vo a Firenze”? Chi saprebbe defi nire con esattezza dove inizia e dove fi nisce Firenze?
Per caso sentiamo la mancanza di un criterio univoco, al decimo di millime-tro? Eppure, il fatto di non saper defi nire con esattezza i confi ni di Firenze non ci impedisce di parlarne né ci impedisce di riconoscere la diff erenza tra aff erma-zioni vere e aff ermazioni false su Firenze. Quindi sarebbe fuorviante pensare di
Lezione del 10 novembre 2003
15
rispondere consultando la mappa dei comuni limitrofi e calcolare le coordinate del punto in cui ci troviamo. Le città non sono i comuni. L’ assenza di un criterio che defi nisca esattamente l’ estensione di una città non comporta l’ impossibilità di utilizzare in maniera più che sensata la parola “Firenze”. Dunque, la nostra com-petenza linguistica circa il signifi cato di un termine non può esigere una lista ben defi nita di proprietà, stabilite una volta per tutte, e alle quali dovrebbe ancorarsi il termine – che qui è il nome proprio di una città invece di un sostantivo come “oro” o come “acqua”, ma la morale è la stessa.
Modifi cabilità della nostra immagine del mondo e assenza di criteri univoci per l’ uso delle parole sono due argomenti che servono a smantellare le assunzioni che compongono la tesi di fondo del realismo ereditata dalla fi losofi a del Nove-cento (o meglio: da una parte della fi losofi a analitica del Novecento). Questi due argomenti mostrano, infatti, che la concezione ingenua del signifi cato è sbagliata. Si tratta dunque di due argomenti contro la trasposizione moderna del realismo metafi sico, ovvero, contro l’ idea che il mondo sia una totalità defi nita una volta per tutte, una totalità formata dagli oggetti (“enti”) che ne fanno parte e organizzata in una gerarchia di forme naturali, una immodifi cabile cassettiera in cui ogni oggetto trova il suo posto in un cassetto (i cui confi ni sono netti).
Ci sono anche altri esempi che Putnam presenta al fi ne di rendere evidenti le pecche di una simile concezione ingenua: dalla vaghezza del termine “cielo” a quel-la relativa alla possibilità di riferirsi a oggetti che sono l’ immagine rifl essa di altri, per non parlare dei problemi legati all’ impiego di termini che si riferiscono a og-getti immaginari, oppure a oggetti del desiderio. Un caso reso famoso da Alexius Meinong (e dalla replica di Bertrand Russell) un secolo fa è quello che riguarda l’ ipotetica montagna d’ oro. Io che sono portato a credere alle favole potrei anche mettermi a cercarla e dirvi “Sto cercando una montagna tutta d’ oro” e voi non direste che uso male l’ italiano solo perché quel che cerco non esiste. Inoltre, potrei mettermi a cercare qualcosa senza bisogno di supporre che quel che cerco abbia caratteristiche fi ssate una volta per tutte. Il fatto che non ci sia nessuna montagna d’ oro e che le montagne non abbiano dei confi ni precisi non obbliga a giudicare falsa la proposizione “Sto cercando una montagna d’ oro”.
Nel linguaggio non ci sono solo nomi e aggettivi. In italiano, per esempio, ci sono anche le preposizioni (di, a, da,…), che un signifi cato ce l’ hanno anche se nella realtà sembra non esserci alcun oggetto al quale esse si possano riferire. Ah, su questo ci sarebbe da dire molto di più in una buona analisi logica, ma vi farebbe perdere il fi lo. Restiamo dunque alla categoria dei nomi. I personaggi dei romanzi sono oggetti che di norma non hanno alcun corrispettivo nella realtà, eppure su di essi si possono fare aff ermazioni circa le quali ha perfettamente senso dire che sono vere o che sono false. Prendete, per esempio, la proposizione “Don Abbondio