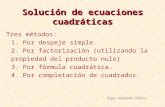’Amor che movi’ alle origini dell’immaginazione analitica
Transcript of ’Amor che movi’ alle origini dell’immaginazione analitica
137
‘Amor che movi...’ alle originidell’immaginazione analitica
JUAN VARELA-PORTAS DE ORDUÑA
Come affermato da Vincenzo Pernicone,
Nella canzone Amor che movi c’è come un ripensamento di D.sulla vera natura diAmore, che porta a conclusioni diverse rispettoa quanto era stato detto nelle due canzoni dottrinali, e alla stessateoria guinizzelliana della canzone Al cor gentil (Pernicone 1970:217).
Ora, Amore è concepito «come principio attivo necessario perché di-venti operante nell’uomo dotato di nobiltà la potenzialità all’eserciziodelle virtù morali e intellettuali» (Ibidem). Accanto all’amore d’animo diPurgatorio XVII, 91-139, e all’appetito d’animo di Convivio IV, XXII,questo amore opera nel cuore a priori rispetto all’esperienza amorosa verae propria nobilitandolo in modo che sia in grado di percepire la bellezzanelle singole cose, tra le quali una giovane donna entratagli nella mente(Ibidem). Infatti, questa concezione si trova già in un certo senso in Voiche ‘ntendendo, come ha spiegato Enrico Fenzi:
L’amore di cui egli prova la vertù, insomma, è iscritto nell’oriz-zonte di una intelligenza trascendente che lo riceve direttamente da
138
LA BIBLIOTECA DE TENZONE GRUPO TENZONE
Dio e a sua volta lo trasmette al creato e, in particolare, all’uomo,sì che proprio di qui, dalla forza nuova e propositiva dei primi versidella canzone, occorre muovere per la vicina Amor che movi tuavertù dal cielo, e per l’amore cosmico che nelle petrose informa disé l’intero universo (Fenzi 2009: 45).
Amor che movi deve essere così situata fra Voi che ‘ntendendo e le ‘pe-trose’ nella via nella quale l’amore diventa una forza universale che tra-pela dal mondo intelligibile a quello sensibile pervadendolo in tutte ledimensioni, fino ad arrivare a «l’amor che move il sole e l’altre stelle»della Commedia. Questa via – continua Fenzi – suppone di «proiettare ilrapporto amoroso entro la sfera dell’intellezione» (Ibidem),1 ed è in questosenso che Amor che movi controrisponde tematicamente a Donna meprega. Le tracce di questa risposta sono molto evidenti nelle riprese les-sicali di quest’ultima, esaminate recentemente da Carla Molinari (Moli-nari 2009: 130-132), e nella collocazione ideologica dell’amore nell’ambito della luce, anzi, nel considerarlo, nella sua fondante identifica-zione col sole, come «cosmocrator», secondo le parole di Giorgio Stabile(Stabile 2007a: 47). Comunque, anche se pensiamo che gli aspetti tematicidella controrisposta dantesca – e cioè i rapporti argomentativi fra Donname prega e Amor che movi – possono essere ancora approfonditi (ma sivedano in questo volume i contributi di Enrico Fenzo e Raffaele Pinto),non ci soffermeremo su questo punto, ma sul fatto, a nostro avviso impor-tantissimo, che Amor che movi è anche – e forse soprattutto – una contro-risposta di tecnica poetica, anche questa schiettamente ideologica.Infatti, anche Carla Molinari, seguendo la scia lasciata da Domenico De
Robertis in un suo articolo di 2003 (De Robertis 2003), si occupa soprat-tutto delle divergenze conDonna me prega nella stesura del discorso, perle quali
Amor che movi intende o almeno finisce per contrapporsi aDonname prega, alla sua serrata e implacabile griglia ritmico-ragionativa,persino con la costruzione del discorso, in particolare nelle dueprime stanze, con lo sviluppo «praticamente all’infinito» che le di-stingue, come ha detto De Robertis nella sua magistrale illustra-
139
JUAN VARELA-PORTAS Alle origini dell’immaginazione analitica
zione [De Robertis 2003: 194], ed è tale «da quasi perdere di vistala norma della sintassi», sebbene non la partizione metrica dellastrofa (Molinari 2009: 132).
Così, di fronte al discorso sull’amore in termini razionali e scientificisvoltosi in Donna me prega, Dante «adotta a contrasto un approccio af-fatto diverso, ricalcato sullo schema invocativo dell’oratio cristiana, comeha spiegato De Robertis [2003]» (Molinari 2009: 130). Stabile, invece,situa lo slancio invocativo «sul piano dell’etica feudale e cortese» (Stabile2007a: 58), specificamente su quella etica del dono (Stabile 2007a: 64-65)che anni dopo sarà la chiave ideologica diDoglia mi reca: «Di fatto, tuttala canzone può essere letta come una expositio epistolare [cfr. Foster-Boyde 192] di un suddito al suo legittimo signore, da cui invoca aiuto, ri-scatto e giustizia» (Stabile 2007a: 58). Anche se le due fondamentaideologiche e retoriche della struttura invocativa non sono affatto incom-patibili, il contrasto fra le due posizioni risulta dal fatto che per Stabile lacanzone ha una rigorosa struttura argomentativa:
E il Dunque dell’attacco [v. 46] indica – sul piano retorico – l’ap-prossimarsi della conclusione di un processo di cui la argumentatiodantesca ha ripercorso le fasi: posto il potere assoluto e beneficantedel signore (I stanza), se un suo servo è degnamente soggetto epredisposto al suo potere, acquisendo così motivo di «mercede»(II stanza), e se un ministro o delegato di questo potere lo esercitacon tanta efficacia e forza da porlo in rischio di morte (III stanza),Dunque spetta al signore – in nome della subiecto del servo e dellamercede acquisita – di corrispondere ai meriti, intervenendo comedetentore di bontà e giustizia a ristabilire i limiti della delega e asalvare il suo servo (Stabile 2007a: 58).
Secondo noi, comunque, l’aspetto con cui Dante si confronta più deci-samente con Cavalcanti è il fatto che questa costruzione argomentativa sirealizza soprattutto attraverso similitudini, nel senso che Dante non ri-nuncia a un discorso razionale e scientifico sull’Amore, ma con Amor chemovi fa un passo avanti importantissimo nella trasposizione o nella tra-sformazione di questo tipo di discorso in linguaggio poetico, cioè, in
140
LA BIBLIOTECA DE TENZONE GRUPO TENZONE
quello che deve coinvolgere prima di tutto i sensi e l’immaginazione in-tegrandoli in una struttura argomentativa razionale. Perciò Dante, nellaparte argomentativa della canzone (le tre prime stanze), usa ben sei simi-litudini (26 su 45 versi), lasciando per la parte conclusiva (le due ultimestanze) il discorso invocativo ed espositivo. A nostro avviso, è appuntol’uso sistematico di similitudini all’interno di una struttura argomentativa– e, vedremo, il modo in cui vengono usate – quello che costituisce lavera – e forte – risposta poetica a Cavalcanti.
Sappiamo da Contini – nel saggio «Cavalcanti in Dante» (in Contini1970: 433-445) – che una delle differenze fondamentali fra la poesia diGuinizzelli e Dante, da una parte, e Cavalcanti, d’altra, risiede nella pre-senza-assenza di quello che Contini chiama il metodo analogico. Nel con-vegno cavalcantiano di Barcellona del 2001, Raffaele Pinto ha spiegatocon meticolosità le origini ideologiche di questa divergenza:
l’uso poetico della simiglianza è incompatibile con una concezionedualistica del rapporto fra l’anima intellettiva e il corpo. La fratturadella personalità che tale dualismo implica, impedisce l’uso di unostrumento espressivo la cui finalità, sul piano poetico, è appuntoquella di ricucire il lato sensibile ed il lato intellettuale della mente.Ciò spiega innanzitutto la sistematica assenza di analogie nei testidi Guido, la cui esegesi del desiderio si basa sulla natura esclusi-vamente patologica e passionale di esso: tanto assurdo sarebbeaspettarsi da un innamorato una simiglianza, quanto da un folle unsillogismo. Essa però spiega anche l’altrettanto sistematico uso dianalogie in Guinizzelli e in Dante, poiché quella formulazione puòessere perfettamente ribaltata invertendone i termini concettuali:l’uso poetico della analogia presuppone una concezione integratadel rapporto fra l’anima e il corpo, cioè fra intelletto e sensibilità(Pinto 2004: 33).
Dante si presenta in Amor che movi non soltanto come un innamoratoche costruisce una struttura sillogistica e genera un bel manipolo di simi-litudini significative, ma come innamorato che è capace di farlo appunto
141
JUAN VARELA-PORTAS Alle origini dell’immaginazione analitica
perché è innamorato, cioè grazie alla virtù che l’amore gli conferisce, o,con più precisione, conferisce alla sua immaginazione:
tanto lo ‘nmaginar che non si posal’adorna nella mente ov’io la porto;non che da sé medesmo sia sottilea così alta cosa,ma dalli tua vertù di quel ch’ell’osaoltre ‘l poder che natura ci ha porto (vv. 33-38).
L’analisi delle similitudini della canzone sarà per tutto ciò fondamen-tale, non soltanto per valutare la risposta che Dante dà a Donna me pregadal punto di vista – tutto ideologico – della prassi poetica, ma anche perincominciare a chiarire le origini – i primi passi – della strada che lo por-terà alla grande costruzione immaginaria e analitica della Commedia.Da un punto di vista teorico, possiamo dividere le sei similitudini della
canzone in due gruppi, non tanto per il grado di complessità ma piuttostoper il grado di analiticità presente in esse.2 Dobbiamo chiarire che tutte esei sono similitudini filosofiche – oggi diremmo scientifiche, cioè di fi-losofia naturale – e rispondono già alle caratteristiche che C. S. Lewis at-tribuiva ai metaphysical similes, quelli che per lui sono nella Commediale similitudini specificamente dantesche. Le similitudini di Amor che movisono metaphysical similes dal momento in cui «things compared are notyonked together by a momentary poetic analogy [...] but by a profoundphilosophical analogy or even identity» (Lewis 1966: 71), in modo daprodursi «the intellectual rather than emotional connexion between thismaterial and the thing compared with it» (Lewis 1966: 72). In esse Dantesfrutta al limite le possibilità scientifiche implicite nel fenomeno naturaleche funge da termine della similitudine, la quale, come spiega Stabile, ècosì caratterizzata «da un saldo dominio della norma naturale che a quelfenomeno presiede, e della capacità di impiegarne appieno, sul piano delsimbolo e della similitudine (suo istituto retorico) il potere coordinante edermeneutico» (Stabile 2007a: 38).3
142
LA BIBLIOTECA DE TENZONE GRUPO TENZONE
Il primo gruppo di similitudini sarebbe composto da quelle che possonoessere chiamate similitudini guinizzelliane, non solo perché sono varia-zioni rispetto a similitudini di Al cor gentil rempaira sempre amore, masoprattutto perché hanno un modo di significare uguale a quello di Gui-nizzelli, senza importanti innovazioni qualitative. Parliamo di ‘variazioni’nel senso musicale, cioè della costruzione con gli stessi o con elementi si-milari di un discorso diverso, con un significato differente. Si tratta dellesimilitudini dei versi 1-4, 5-7, 16-17 e 39-45. In esse, vengono individuatii due termini del paragone, mentre il significato della similitudine scatu-risce dal tertium comparationis, il quale resta implicito nella similitudinedei versi 5-7 e 16-17, ma si dichiara esplicitamente nelle similitudini deiversi 1-4 (nei versi 3-4) e 39-45 (nei versi 43-45).Similitudini del secondo gruppo sarebbero invece quelle che non hanno
un chiaro intertesto guinizzelliano ma appartengono decisamente alcampo dell’ottica – come si sa, uno dei più sofisticati e sviluppati all’in-terno della scienza medievale e, da Giacomo da Lentini e dai poeti dellacorte federiciana, in stretto rapporto con la poesia –, e nelle quali, comecaratteristica più importante, vengono coinvolti più di uno o due elementimateriali, in un processo fisico più complesso di quelli descritti nelle altrequattro similitudini. Sono già perciò, secondo noi, similitudini analitichein cui l’attenzione non è attirata soltanto dal tertium comparationis e lesue derivazioni filosofiche, ma anche da elementi impliciti ed esplicitiche segmentano il comparato e il comparante in tratti distintivi da sé si-gnificanti, per cui le risonanze semantiche e gnoseologiche vanno moltopiù lontano di quelle delle similitudini guinizzelliane e coinvolgono l’in-tera struttura della canzone. Parliamo delle similitudini dei versi 11-15 e24-30.
Partendo dunque da questa impostazione teorica, vedremo come l’ana-lisi delle similitudini ci porterà non soltanto a una comprensione più ap-profondita del contenuto filosofico – e psicologico – della canzone, maanche a capire che i principi fondanti di questo contenuto filosofico stanno
143
JUAN VARELA-PORTAS Alle origini dell’immaginazione analitica
alla base della nuova teoria poetico-gnoseologica su cui si impernia lacanzone. In altre parole, se la canzone narra il processo d’innamoramentocome una assimilazione fra mente e immaginazione – accomunate dal-l’amore –, essa allo stesso tempo dimostrerà nella prassi che l’immagina-zione, nelle mani di un innamorato, può essere strumento dell`argomentazione.Nella prima stanza, la canzone spiega perché l’amore non porta alla
viltà e alla follia, come voleva Cavalcanti, ma, al contrario, fa passare dapotenza ad atto le capacità morali e intellettuali dell’uomo. E lo spiega ap-punto attraverso similitudini.Nella prima di esse si paragona Amore col sole e la sua virtù con lo
splendore dell’astro:
Amor che movi tua vertù dal cielocome ‘l sol lo splendore,che là s’apprende più lo suo valoredove più nobiltà suo raggio trova (vv. 1-4).
È evidente variante de Al cor gentil..., 3-7:
né fe’ amor anti che gentil core,né gentil core anti ch’Amor, natura:ch’adesso con’ fu ‘l sole,sì tosto lo splendore fu lucente,né fu davanti ‘l sole (Guinizzelli 2002: 23).
La differenza è notevole nel tertium comparationis usato per significare– esplicitato comunque nei due casi –, oltre al fatto importantissimo chementre in Guinizzelli il sole si identifica col cor gentil, e lo splendore conl’amore che da esso nasce, in Dante l’amore-sole è l’origine della virtù-splendore, con cui viene compresa in un’immagine la differente conce-zione dell’amore spiegata da Pernicone con la quale abbiamo iniziatoqueste riflessioni.4 Non ci soffermeremo sulle conseguenze filosofiche emetafisiche dell’inclusione dell’amore nell’ambito solare; vorremmo sol-tanto richiamare l’attenzione sul fatto che i due elementi del tertium com-
144
LA BIBLIOTECA DE TENZONE GRUPO TENZONE
parationis – cioè il rapporto di provenienza implicito in’ splendore’ e ‘rag-gio’ (secondo Convivio II, VI, 9; III, VII, 3; III, XIV, 5) e quindi la conce-zione di virtù come potenza emanata da un «fontale principio» chetrasmette l’essere, in-forma, e cioè dà valore; e la nozione di apprehensio,termine tecnico «per indicare l’esercizio di un potere attivo di una qualitàsull’altra e il dominio che ne consegue» (Stabile 2007a: 48), e cioè la ri-cezione di quella virtù proveniente dal cielo – sono tutte nozioni pura-mente filosofiche che diventano così, per il fatto di essere state chiarite,realtà sensibili. Dal punto di vista contenutistico, ci troviamo davanti a unattacco fortissimo perché in esso si presentaAmore non come «accidentein sustanza», ma come una essenza formatrice che risiede nel cielo, cioènel mondo intellettuale, e da esso esercita il suo influsso (muove la suavirtù).La seconda similitudine,
e’ com’el fuga oscuritate e gelocosì, alto signore,tu cacci la viltà altrui del core (vv. 5-7)
è variante di Al cor gentil..., 31-32:
Fere lo sol lo fango tutto ‘l giorno:vile reman, né ‘l sol perde calore.
Ma soprattutto è risposta a Donna me prega, 15-18:
In quella parte dove sta memoraprende suo stato, sì formato comediaffan da lume, d’una scuritatela qual da Marte vène e fa demora.
I termini di questa similitudine vengono ribaltati in quella dantesca, ecosì, se in Cavalcanti l’oscurità (cioè con tutta probabilità l’umor nerodella malinconia) fa passare l’amore da potenza ad atto – come fa il lumecol diafano –, in Dante l’oscurità e il gelo esemplificano appunto l’indi-sposizione, la privazione, l’imperfezione e la potenzialità della materia,
145
JUAN VARELA-PORTAS Alle origini dell’immaginazione analitica
in contrasto con la potenza solare, come viltà e ira sono, di fronte al-l’amore, lo stato di totale assenza di forma (Stabile 2007a: 49). La cosainteressante del contrasto tra i versi di Donna me prega e quelli di Amorche movi è che, anche se a tutte e due sottostanno le nozioni filosofichedi potenza-atto, in Cavalcanti l’amore è paziente (passa da potenza adatto) e l’oscurità agente, mentre in Dante l’amore è agente (fa passare dapotenza ad atto) e l’oscurità paziente, e così se in Cavalcanti un apparenteparadosso (paragonare la luce con l’oscurità) nasconde un tratto di somi-glianza, in Dante invece la similitudine segna la radicale dissomiglianzafra amore e viltà, sole e oscurità.L’ultima similitudine di questa stanza, non più di tipo guinizzelliano,
ci porta a una comprensione più approfondita del modo in cui agisce lavirtù formatrice dell’amore:
senza te è distruttoquanto avemo in potenza di ben farecome pintura in tenebrosa parte,che non si può mostrarené dar diletto di color né d’arte (vv. 11-15).
Per la comprensione di quest’ultima, bisogna chiamare in causa tutta lateoria medievale della luce e del colore, le sue polemiche – che mettevanoa confronto averroisti con non averroisti – e le sue implicazioni gnoseo-logiche. Il paragone, come dicevamo, è composto di varie corrispondenzeimplicite ed esplicite, nelle quali gli elementi paragonati sono messi inrelazione in virtù di un primo ed evidente rapporto di potenza-atto, mate-ria-forma:
Quanto avemo in potenza > pinturadi ben fare > diletto di color e d’arte
[contenuto della pintura][amore] > [luce]anima sensitiva > tenebrosa parte[anima intellettuale] > [parte illuminata]
146
LA BIBLIOTECA DE TENZONE GRUPO TENZONE
Si parte, com’è risaputo, dalla luce come principio attivo che facevapassare il colore – e il diafano – da potenza ad atto, ma non è soltantoquesto tertium comparationis che la similitudine ci spinge ad applicare,in virtú del contesto, al paragone luce-amore, anima sensitiva-tenebra, ilche ha conseguenze importanti in relazione con la questione averroista equindi come risposta a Cavalcanti, specificamente aDonna me prega 15-18 e 63-68.La luce fa passare il colore da potenza ad atto perché non è un’inten-
zione, ma un’essenza. Dice Tommaso: «Lux non videtur per aliquam si-militudinem sed per essentiam suam informat oculum» (ST I, q. 56, a. 3;vid. anche I, q. 67, a. 3, resp.).5 È per questo che la luce si percepisce solonei suoi effetti: «omnis qui illuminatur percipit illuminationem ex parteobiecti, non semper autem ex parte principii» (ST I, q. 111, a. 1, ad 3). Seapplichiamo queste caratteristiche – che, a nostro avviso, derivano im-mediatamente e necessariamente dalla similitudine – all’amore, vediamoche, prima di tutto, Dante discute con l’immagine la condizione acciden-tale dell’amore, il quale, infatti, «non si può conoscer per lo viso» (Donname prega 63), cioè come figura o sembianza, ma non per il fatto di essereun accidente bensì addirittura un’essenza formatrice. Dante, con l’imma-gine, ammette che l’amore cade «in mezzo scuro» (Donna me prega 68),in tenebrosa parte, cioè nell’anima sensitiva, ma non che «luce ‘e rade»(Donna me prega 68), ma che, tutt’al contrario, la sua presenza fa chel’anima passi da potenza ad atto (da oscurità a luce, da materialità aforma), cioè da anima sensitiva a anima intellettuale, che è quella che,trasformando il desiderio sensitivo in volontà razionale, produce il «benfare», il quale provoca una «recta dilectio», cioè un diletto allo stessotempo sensitivo («di color») e razionale («d’arte»)6. L’anima sensitivadunque non è contraria all’amore come, secondo Tommaso e contraria-mente alle idee averroiste, l’oscurità non è contraria alla luce ma assenzadi luce. Dice Tommaso: «Accidit luci quod non habeat contrarium, in-quantum est qualitas naturalis primi corporis alternantis, quod est contra-rietate elongatum» (ST I, q. 67, a. 3, resp.)7. Quindi, se l’anima sensitivaè tenebra, mezzo oscuro, non lo è – dice Dante con la sua immagine – per
147
JUAN VARELA-PORTAS Alle origini dell’immaginazione analitica
sé, per la sua natura, ma appunto per assenza di amore («Senza te... », v.11). Invece, quando l’amore esercita la sua virtù formatrice sull’animasensitiva (sensi, immaginazione) si produce il passaggio all’atto e quindiil ben fare, cioè gli effetti che sono l’unico modo di percepire veramentel’amore – come la luce può essere solo percepita ex parte obiecti. Co-munque, la risposta a Cavalcanti sarebbe ancora più forte se, come cre-diamo, nell’immagine della pittura in tenebrosa parte ci sono echi dellamolto diffusa e combattuta immagine averroista del colore su un murocome somiglianza delle specie intelligibili sull’anima umana. Comespiega De Libera: «Le type d’union existant entre l’âme humaine qui con-tient les images et l’intellect posible, qui contient leur espèces intelligiblesest la même qu’entre le mur qui contient une couleur et la vue qui contientl’espèce de cette couleur» (De Libera 1997: 69). Secondo la concezioneaverroista l’azione dell’intelletto agente sulle immagini non rivelate perfarle diventare specie intelligibili è come quella della luce che rivela i co-lori su un muro per farli diventare specie sensibili. Se accostiamo questasimilitudine a quella dantesca che esaminiamo vediamo che in fondoDante cerca implicitamente un parallelismo fra amore, luce e intellettoagente. In questo modo, si suggerisce il fatto che nel passaggio dalle po-tenziali capacità morali all’atto del ben fare si produce un processo d’in-tellettualizzazione, causato dall’amore, simile a quello nel quale leimmagini passano a intelligibili grazie all’azione dell’intelletto agente.Crediamo perciò che l’immagine contenuta in questa similitudine servadecisamente all’inclusione dell’amore nella sfera del mondo intellettuale.
Se nella prima stanza l’azione dell’amore era stata descritta in un sensogenerale, nelle stanze seconda e terza si descrive il particolare processod’innamoramento del poeta, cioè il modo particolare in cui la sua potenzadi ben fare potrebbe passare ad atto.La similitudine dei versi 16-17:
Fèremi ne lo cor sempre la tua lucecome raggio in la stella
148
LA BIBLIOTECA DE TENZONE GRUPO TENZONE
è variante della seconda stanza de Al cor gentil... (vv. 11-20), e di nuovoin essa il processo amoroso è capovolto in relazione alla seconda stanzadella canzone guinizzelliana, nella quale l’amore è conseguenza finale diun processo in cui in primo luogo la natura rende gentile il cuore, e poi ladonna esercita la sua virtù su di esso provocando l’amore, allo stessomodo che prima il sole rende la pietra gentil cosa tirando via da essa ciòche le è vile, e poi la stella le dà il valore necessario perché la pietra pro-duca la sua virtù.Comunque, questa similitudine di Amor che movi è interessante soprat-
tutto perché introduce elementi impliciti fondamentali per la compren-sione della canzone: innanzitutto, la proportio fra amore-sole ecuore-stella – maggiore o minore secondo il grado di nobiltà del cuore,come hanno previamente chiarito i versi 3-4 –, per cui il processo amorosouniversale è parallelo a quello umorale interno al corpo in cui il cuorefunziona come un piccolo sole, secondo la brillante spiegazione di Stabile(Stabile 2007a: 51-53), nella quale, però, non restano chiaramente delimi-tati, a nostro avviso, il piano del comparante (sole-stella) e quello delcomparato (amore-cuore), in modo che in realtà il cuore non viene iden-tificato con il sole, come vuole lo studioso, ma con la stella. In ogni modo,la similitudine, così precisata, serve ancora meglio a determinare il rap-porto di proportio ma anche quello formativo nella catena virtù-valore.Ma c’è pure implicito il modo in cui il «disio di rimirar ciascuna cosa
bella» (vv. 20-21) nasce dal cuore come effetto della riflessione in essodella virtù dell’amore, come la luce della stella è luce solare ripercossa.Si tratta di nuovo di un processo di in-formazione, come si sa da ConvivioII, XIII, 15 («del suo lume [del sole] tutte l’altre stelle s’informano»), e sipuò così capire facilmente la forza filosofica dell’immagine dantesca: difronte al desiderio travolgente e distruttivo di Cavalcanti, un desiderioprodotto dalla potenza formatrice, perfettiva, dell’amore-sole, ultimoanello in una catena di perfezione:
Amore > virtù > cuore > desiderioSole > raggio > stella > splendore.
149
JUAN VARELA-PORTAS Alle origini dell’immaginazione analitica
Infatti, considerare il desiderio di bellezza come conseguenza dellavirtù formatrice dell’amore sull’anima sensitiva è una risposta proprioforte al desiderio oscuro e ‘difformante’ di Cavalcanti, ma crediamo checon questa similitudine, come nei versi 20-22, Dante offra a Guido ancheuna risposta metapoetica: perché se quello che desta nel cuore l’amore èappunto una «dolce favella» e la capacità di «rimirar», e cioè immaginare,è ovvio che la poesia può solo essere conseguenza dello slancio amoroso,e perciò si deve sviluppare non soltanto in un ragionare dolce (maturo,temperato, secondo l’analisi che Stabile applica alla giovane donna manon allo stile – «dolce favella» – della canzone: Stabile 2007a: 61-64), maanche in immagini che, come quella della similitudine, facciano dellaparte sensitiva un ambito di luce, cioè di conoscenza.Arriviamo dunque alla similitudine con la quale si spiega il passaggio
da un “astratto” desiderio di bellezza, formato dall’amore nell’anima sen-sitiva e perciò ancora tutto sensitivo, a un desiderio effettivo verso unaconcreta «cosa bella», il quale non è più sensitivo ma un desiderio dellamente, e quindi il modo specifico in cui la «tenebrosa parte» del poetadiventa luminosa. Si tratta forse della più importante e complessa simili-tudine della canzone, quella che ha fatto scrivere a Giorgio Stabile:
Nucleo tematico e genetico della canzone è, a nostro avviso, la si-militudine del v. 27: «com’acqua per chiarezza fiamma accende»,similitudine che è, al tempo stesso, enunciato di un fenomeno na-turale e costituzione di esso a funzione poetica e simbolica digrande potenzialità strutturante (Stabile 2007a: 31).
Per capirla bene bisogna leggere attentamente i versi 24-30:
Per questo mio guardar mi è nella menteuna giovane entrata, che m’ha preso,ed halli un foco accesocom’acqua per chiarezza fiamma accende,perché nel suo venir li raggi tuoi,con li quali mi risplende,saliron tutti su negli occhi suoi.
150
LA BIBLIOTECA DE TENZONE GRUPO TENZONE
L’analisi di Stabile è eccezionale dal punto di vista metodologico (so-prattutto se si pensa che è stata fatta nei primi anni settanta) perché egliintende perfettamente che Dante usa la similitudine non come strumentoornamentale, ma per «formalizzare in linguaggio una fitta stesura di datidottrinali» (Stabile 2007a: 31). Tutta l’analisi perciò è tesa a mettere in ri-lievo le implicazioni gnoseologiche dell’immagine che, secondo lui, strut-tura l’intera canzone. In questo modo si vedrà come in questi versi,
mediante le strutture percettive e concettuali del fenomeno, Danteistituisca una similitudine-simbolo, cioè un complesso tipico di re-lazioni, capace di verificare rapporti omologhi svolgentisi su di-versi piani di realtà – naturale (generazione e vita), umana (amoree rapporti sociali) o divina (creazione, salvazione e grazia) – e direcuperare al contempo valori e temi provenienti dai primordi dellaciviltà medievale (Stabile 2007a: 45).
Questi rapporti impliciti, spiegati a lungo da Stabile, sono, in modosintetico, i seguenti:a) Ci troviamo davanti a un fenomeno naturale eccezionale, un adyna-
ton, cioè un fenomeno in cui la natura completamente contraria dei dueelementi implicati, acqua e fuoco, esige «una completa trasmutazione del-l’uno nell’altro» in un caso che è praeter naturam, evento mirabile (Sta-bile 2007a: 31-33);b) È un fenomeno che implica tre elementi, un agente come causa ef-
ficiente (la luce), un mediatore come causa strumentale (l’acqua) e unaconseguenza (il foco) (Stabile 2007a: 39-42);8
c) Il fenomeno implica, da una parte «una proportio di natura tra agentee paziente che renda questo ultimo disposto a subirne l’azione ed esserneassimilato» (Stabile 2007a: 46), il che suppone la presenza in ambeduedelle stesse qualità elementari;d) D’altra parte, implica «una opposizione elementare tra mediatore e
agente che quanto più è forte tanto più moltiplica gli effetti dell’azione»(Stabile 2007a: 46) e «il variare delle condizioni dell’agente o del media-
151
JUAN VARELA-PORTAS Alle origini dell’immaginazione analitica
tore (sole occiduo o invernale, acqua che si scalda) perché l’azione si de-biliti e si temperi e il paziente non venga consunto dall’ignitio» (Stabile2007a: 46).Speriamo che, così sintetizzate, vengano evidenziate le implicazioni
per la comprensione del fenomeno amoroso che Dante riesce a concen-trare in una sola immagine. Ciononostante, queste implicazioni potreb-bero essere non sufficientemente valutate se non vengono stabilite conprecisione le corrispondenze che costituiscono la similitudine. Stabileidentifica la struttura triadica luce-agente (causa efficiente), acqua-me-diatore (causa strumentale) e panno-paziente con la triade amore-donna-amante (Stabile 2007a: 46), ma in realtà il testo specifica con molta curai luoghi e i modi in cui si produce la ignitio.9 Prima di tutto, non èl’amante, in modo complessivo, il paziente che subisce la ignitio ma piùconcretamente la sua mente, come indica chiaramente l’avverbio locativo«li» del verso 26: «e halli un foco acceso». Inoltre, il mediatore che vienecomparato con l’acqua non è propriamente la donna ma, tra l’altro conmolta più esattezza, l’immagine della donna entrata nella mente. È questoun punto decisivo, ed è per questo che l’autore usa tre versi per chiarirlo.È evidente che la ignitio si produce dopo l’entrata della donna nellamente, ma il testo spiega anche che è appunto tale entrata ciò che ha pro-vocato il passaggio dalla tradizionale riflessione negli occhi della donna(«con li quali mi risplende», v. 29) alla non tanto comune rifrazione pro-dotta all’interno dell’immaginazione dell’amante:
perché nel suo venir li raggi tuoi,con li quali mi risplende,saliron tutti su negli occhi suoi (vv. 28-30).
Cioè: Il fuoco nella mia mente si accese perché con l’entrata della [im-magine della] donna in essa («nel suo venir»), i raggi dell’amore, che nor-malmente lei – come donna «verace» – riflette verso di me, si sonoconcentrati tutti nella mia mente attraverso i suoi occhi. Viene in questomodo spiegato il processo che serve da base della, di per sé non moltochiara, similitudine, identificandolo palesemente come una rifrazione che,
152
LA BIBLIOTECA DE TENZONE GRUPO TENZONE
come ben si sa, risulta dalla concentrazione dei raggi di luce e produceperciò una intensità luminosa e calorica molto più forte di quella prodottadalla riflessione, nella quale i raggi vengono dispersi.Altri argomenti possono assecondare questa lettura, e ribadire dunque
che la mediatrice nel processo di ignitio mentis non è la donna ma la suaimmagine sigillata nell’immaginazione.L’entrata dell’immagine nella mente intesa come una salita o ascen-
sione è tutt’altro che estranea in Dante. Ad esempio, E’m’incresce di me,vv. 43-44: «L’immagine di questa donna siede / su nella mente ancora»,con un uso avverbiale di «su» molto simile: «siede su» - «saliron su».Non è neanche estranea in Dante la rappresentazione dell’immagine e
dell’immaginazione come acqua non fluente, basata sulla capacità di que-sto elemento di riflettere le immagini e sulla sua vicinanza per ciò allanozione di ‘specchio’. Un caso molto chiaro è quello di Paradiso III, 11,cha abbiamo analizzato in Varela-Portas 1999, ma anche, per proporre unaltro esempio, in Purgatorio XXXIII, 67 l’acqua del fiume Elsa, piena dicarbonato di calcio, è paragonata con «li pensieri vani [cogitationesvanas] intorno alla tua mente» (Purgatorio XXXIII, 68) che non sonoaltro che le false «immagini di ben» seguite da Dante nel suo ‘travia-mento’.Finalmente, a ulteriore conferma che sia l’immagine a produrre la ri-
frazione, sta il modo contrastivo in cui il verso successivo torna a parlaredella donna verace:10 «Quanto è nell’esser suo bella e gentile / negli attied amorosa» (vv. 30-31). Se prima si trattava dell’immagine adesso sitratterà, per un attimo, dell’«esser suo», al modo dell’«essere verace» diPurgatorio XVIII, 22 (si veda infra). De Robertis parla della «corrispon-denza chiastica “nell’esser suo” – “nella mente”» (De Robertis, nota a vv.33-34, in Alighieri 2005: 86).In questo modo il processo psicologico dell’innamoramento resta molto
più chiaro, e mostra un parallelismo davvero vicino a quello che in sedeteorica spiega Virgilio a Dante nel canto XVIII del Purgatorio, con unadisposizione da causa a conseguenza molto rigorosa in ambedue i casi.
153
JUAN VARELA-PORTAS Alle origini dell’immaginazione analitica
All’inizio c’è una particolare disposizione all’amore, spiegata in Amorche movi come l’azione della virtù formatrice dell’amore sull’anima sen-sitiva (cuore), nella similitudine che abbiamo già analizzata:
L’animo, ch’è creato ad amar presto
(Purgatorio XVIII, 19);
Feremi ne lo cor sempre tua lucecome raggio in la stella,poi che l’anima mia fu fatta ancelladella tua podestà primeramente (vv. 16-19).
In conseguenza a questa disposizione nasce dall’anima sensitiva, comeriflesso (splendore), un desiderio “astratto”, che si proietta su una «cosa»concreta e piacevole («che piace»):
ad ogni cosa è mobile che piace,tosto che dal piacere in atto è desto
(Purgatorio XVIII, 20-21);
onde ha vita un disio che mi conducecon sua dolce favellain rimirar ciascuna cosa bellacon più diletto quanto è più piacente (vv. 20-23).
Questa «cosa che piace» o «cosa bella» entra come immagine o inten-zione nella mente della persona:
Vostra apprensiva da essere veracetragge intenzione, e dentro a voi la spiegasì che l’animo ad essa volger face
(Purgatorio XVIII, 22-24);
Per questo mio guardar m’è nella menteuna giovane entrata (vv. 24-25).
154
LA BIBLIOTECA DE TENZONE GRUPO TENZONE
In modo che il desiderio “astratto” di bellezza diventa amor concretoche lega o prende l’innamorato:
e se, rivolto, inver di lei si piega,quel piegare è amor, quell’è naturache per piacer di novo in voi si lega
(Purgatorio XVIII, 25-27);
(...) che m’ha preso (v. 25);
(...) l’animo preso
(Purgatorio XVIII, 31);
Allora, l’animo «entra in disire» come il fuoco va verso l’altura, ovverola mente si accende:
Poi, come ‘l foco movesi in alturaper la sua forma ch’è nata a salirelà dove più in sua matera dura,così l’animo preso entra in disire,ch’è moto spiritale, e mai non posafin che la cosa amata il fa gioire
(Purgatorio XVIII, 28-33);
e halli un foco acceso (v. 26).
Nella stanza successiva a quest’ultima similitudine, e soprattutto con lasimilitudine dei versi 39-45, Dante spiegherà in quale senso l’accendersinella mente del desiderio verso un oggetto concreto sia un «moto spiri-tale» che «mai non posa», cioè un movimento de «lo ‘nmaginar che nonsi posa» (v. 33).11 Nei versi 31-38, la canzone spiega che, una volta accesala mente, l’immaginazione ha nuove capacità – appunto, come conse-guenza dell’adynaton, prater naturam – non solo per ricevere ma ancheper ri-creare l’immagine bella, gentile ed amorosa della donna: «tanto lo‘nmaginar che non si posa / l’adorna nella mente ov’io la porto» (vv. 33-34). E questa bellezza ri-creata, cioè non soltanto ricevuta ma anche ge-
155
JUAN VARELA-PORTAS Alle origini dell’immaginazione analitica
nerata, prodotta, dall’immaginazione, diventa prova del valore del-l’amore, nella similitudine dei versi 39-45:
È sua biltà del tuo valor conforto,in quanto giudicar si puote effettosovra degno suggetto,in guisa ch’è del sol segno di foco,lo quale a lui non da né to’ vertute,ma fallo in altro loconell’effetto parer di più salute.
La quale è variante de Al cor gentil..., 8-10:
e prende amore in gentilezza lococosì propriamentecome calore in clarità di foco.
Entrambe le similitudini condividono un ruolo fondamentale nellacomprensione di un elemento implicito, il fuoco, e quindi la presenza ditre elementi nel comparante e nel comparato, struttura che in Guinizzelliserviva a mostrare i rapporti fra amore e gentilezza e fra gentilezza e «corgentil» attraverso la consustanzialità della clarità e del calore con il fuoco:
[foco] > clarità > calore
[cor gentil] > gentilezza > amore
Dante, come abbiamo visto nei casi precedenti, usa qui elementi similia quelli di Guinizzelli ma li combina in modo diverso per produrre un si-gnificato completamente differente. Se intendiamo il controverso verso 42nel senso che crediamo che possieda, cioè «in guisa ch’è [effetto] del solsegno di foco»12, allora la triade del paragone risulta:
sole – [foco] – segno di foco
amore – [mente accesa] – «biltà» dell’immagine della donna.
156
LA BIBLIOTECA DE TENZONE GRUPO TENZONE
La giusta considerazione dell’elemento implicito (fuoco-mente accesa)diventa così imprescindibile per capire che, come indica De Robertis,«Prova della potenza d’amore non è insomma la bellezza di lei, bensìquello che esso ne fa nella mente dell’innamorato» (De Robertis, adlocum, inAlighieri 2005: 87). Il «degno suggetto» dell’amore, allora, nonsarà l’amante, così genericamente, come vuole Stabile (2007a: 57), macon più precisione la sua mente, per cui la similitudine spiega che l’ardoreo desiderio della mente provoca come effetto («segno») la nuova capacitàdell’immaginazione di produrre immagini belle. In questo modo, vienechiarita la intensità dei rapporti fra amore, mente «in disire» e immagina-zione creatrice: l’amore produce un desiderio nella mente («foco») chespinge l’immaginazione a creare immagini belle («segno di foco»). Inquesto senso, ci pare molto significativo il termine «segno» – in sostitu-zione di «clarità» che appariva nella canzone guinizzelliana – perché seovviamente può intendersi solamente come ‘effetto’, è anche vero che ilsuo rapporto stretto con ‘sigillo’13 ci porta immediatamente all’ambitodelle intenzioni e delle immagini.
A questo punto deve risultare evidente che quello che Dante sta qui de-scrivendo, ma anche analizzando, è un processo psicologico che po-tremmo denominare, per opposizione alla tradizionale immoderatacogitatio dell’amore hereos, come elevata cogitatio, con la quale l’im-maginazione dell’uomo, grazie all’effetto dell’amore sulla mente – ilquale, attuando su di essa appunto attraverso la propria immaginazione,l’accende di desiderio –, viene potenziata praeter naturam in modo chemoltiplichi la sua capacità di generare immagini belle senza perdere ilsenso della realtà (vv. 31-34).
In questi aspetti fondamentali risiede la risposta, a livello di contenuto,a Cavalcanti. Ricordiamo succintamente le tesi di fondo di Cavalcanti inDonna me prega:–l’amore è un accidente (v. 2), e non una virtù (v. 29), che appartiene
completamente all’anima sensitiva (vv. 15-18, 29-31);
157
JUAN VARELA-PORTAS Alle origini dell’immaginazione analitica
–l’amore sconvolge il senso della realtà perché l’essere intenzionale –l’immagine – diventa la guida della ragione, per cui la capacità di giudiziosi trova «for di salute» (vv. 32-34);–l’amore non ha effetti possibili nel mondo intellettuale, visto che que-
sto si trova radicalmente staccato dal mondo del «diletto» e della «simi-glianza», cioè dall’anima sensitiva in cui l’amore agisce esclusivamente(vv. 24-28).Vediamo adesso come le caratteristiche fisiche naturali del fenomeno
fisico che funge da termine della similitudine dei versi 24-30 di Amor chemovi, come ricostruite da Giorgio Stabile, se applicate al processo psico-logico soggetto della similitudine, e a ognuno dei suoi elementi analitica-mente differenziati, cioè amore (sole), immagine (acqua), mente indesiderio (fiamma), rivelino una concezione del suddetto processo deci-samente capovolta riguardo a quella cavalcantiana, sia nella considera-zione del processo amoroso in sé, sia nei rapporti fra anima sensitiva eanima intellettuale sui quali si fonda:–L’amore è un’essenza formatrice (una luce), non un accidente, ed eser-
cita perciò una virtù informante tanto sull’anima sensitiva, predisponen-dola alla bellezza (vv. 16-23), quanto sulla mente, accendendo in essa ildesiderio per cose concrete belle e piacevoli.–L’amore è perciò causa efficiente dell’accendersi del desiderio nella
mente, e l’immaginazione è il suo strumento (causa strumentale), comel’acqua è strumento della luce e questa è causa efficiente della ignitio.Non è quindi la bellezza della donna a risvegliare l’amore, che risiede inpotenza nel cuore dell’innamorato – come in Guinizzelli o nella Vitanova –, ma l’amore a rivelare la bellezza della donna nell’immaginazione.–Se è vero che l’amore condivide con l’anima sensitiva caratteristiche
essenziali (proportio) e perciò può esercitare su di essa la sua virtù forma-trice – come il sole sulla stella (vv. 16-23) –, è altrettanto vero che esisteanche una proportio di natura tra l’amore e la mente, come agente e pa-ziente della ignitio, in modo che il paziente-mente possa subire l’azionedell’agente-amore ed esserne assimilato. L’amore dunque si concepisce
158
LA BIBLIOTECA DE TENZONE GRUPO TENZONE
come un’esperienza “totale” che coinvolge sia l’anima sensitiva (cuore),sia l’immaginazione, sia l’intera anima intellettuale (mente). In questomodo, viene ribadita la sua natura intellettuale – come essenza che, dalcielo, esercita la sua virtù – e l’azione sull’intera mente dell’uomo.
–All’inizio del processo di ignitio mentis si produce un’opposizioneelementare fra mediatrice-immaginazione e agente-amore, visto che l’im-maginazione appartiene ancora all’anima sensitiva – anche se nei suoi“livelli” più “alti”, alla “frontiera” con l’intelletto – e l’amore è di naturaintellettuale, ma durante il processo d’innamoramento le condizioni del-l’immaginazione variano, e, come l’acqua che produce la rifrazione si il-lumina e si scalda, l’immaginazione diventa più atta a ricevere la lucedell’amore, o, in altre parole, diventa più adatta alla bellezza, ovvero s’in-tellettualizza.
–Si spiega in questo modo la chiave principale del processo fisico –nel termine della similitudine – e di quello psicologico – nel termine com-parato –, cioè il fatto che tra immaginazione-acqua e mente accesa-fuocosi dia, per riprendere le parole di Stabile supra riportate, «una completatramutazione dell’uno nell’altro» (Stabile 2007a: 33), in modo che sipossa produrre una reciproca influenza – che va al di là della propria na-tura – fra mente e immaginazione: l’immaginazione è strumento nellaignitio mentis, e a sua volta la mente accesa potenzia la capacità immagi-naria, per cui nella mente può bene agire la somiglianza, e la mente può,a sua volta, elargire somiglianza, per giocare con le due letture possibilidiDonna me prega, v. 28.Anima sensitiva e mondo intellettuale non sonoormai lontani e alieni, ma tale vicinanza non suppone confusione fra in-tenzione e ragione, visto che il senso della realtà non viene mai perso eche l’immaginazione, potenziata dall’ardore della mente, riproduce ladonna verace «tanto quanto» ella è, nel mondo esteriore, bella, gentile edamorosa («Quanto è nell’esser suo (...) tanto lo ‘nmaginar (...) l’adornanella mente», vv. 31-34).
159
JUAN VARELA-PORTAS Alle origini dell’immaginazione analitica
Abbiamo cercato di mettere in rilievo con la nostra analisi non soltantoche la concezione dell’amore in Amor che movi è ormai già radicalmenteopposta a quella di Cavalcanti, in quanto l’amore porta da una parte alben fare, d’altra a una elevata cogitatio nella quale immaginazione emente si trovano fianco a fianco – accomunate dal desiderio di bellezzache l’amore provoca –, ma soprattutto il modo in cui tale opposizione ditipo contenutistico viene trasmessa attraverso una struttura argomentativa,cioè razionale, anche se fondata su similitudini. La similitudine, e quindil’immaginazione, si dimostra in Amor che movi uno strumento privile-giato del raziocinio, ma per questo l’immaginazione deve essere uno stru-mento analitico che serva a collegare elementi del termine dellasimilitudine (sole-acqua-fiamma) ad elementi del contenuto per sé indi-viduabili, e a fare scaturire da questo collegamento caratteristiche conte-nutistiche del rapporto fra cotali elementi. La similitudine diventa cosìuna risorsa retorica ed ideologica che non solo mostra ma anche dimostradi fatto l’errore gnoseologico e poetico di Cavalcanti. La risposta a Caval-canti non è dunque soltanto teorica ma anche pratica perché i contenuti fi-losofici sulla natura di amore si affidano non solo a un «naturaldimostramento» (Donna me prega, v. 8), ma soprattutto a delle immaginianalitiche. “Guarda – sembra dire Dante a Guido tra le righe – è così chesi trasforma la filosofia in poesia, non con l’asciutto e secco stile tuo, nonanalogico, ma con l’umido e caldo e temperato e dolce stile mio, attraversoimmagini e non con concetti astratti; ed è così proprio perché nel mio poe-tare mi muove amore, che porta – e porterà molto di più ancora – la miaimmaginazione oltre la sua natura”.
160
LA BIBLIOTECA DE TENZONE GRUPO TENZONE
NOTE
1 In un senso analogo, Selene Sarteschi considera che Dante «inizia a sentirela necessità di riproporre quel “nodo” che continuava a tenere in vita un “modo”poetico (quello suo più d’ogni altro) che si era nutrito di due componenti essen-ziali, amore e intelletto» (Sarteschi 2004: 316). L’articolo della Sarteschi ha comefinalità esaminare, sulla scia di Pernicone, «la novità di Amor che movi (...) tantorispetto alla concezione d’amore del primo Guido, quanto rispetto al momento ditale concezione in Dante, nel corso del tempo» (Sarteschi 2004: 317). Per lei,«Dante, sulla scorta di un pensiero che nasce sulle fondamenta di una visionearistotelico-tomistica cui si sovrappone una prospettiva di carattere neoplatonicoe mistico, sta fondando un concetto d’Amore che diverrà una delle basi su cui co-struire parte del sistema filosofico-teologico della Commedia» (Sarteschi 2004:324). Adesso, «Amore per Dante (...) è quello che incrementa la capacità del-l’uomo a compiere il bene: sementa di felicità, non di miseria o avvilimento. Equesto è il messaggio di Amor che movi che (...) si trasferirà nella Commedia»(Sarteschi 2004: 331).
2 Sull’analiticità delle similitudini nella Commedia, si veda López Cortezo1994 e 1998, e Varela-Portas 2002: 31-57. Di recente, abbiamo parlato di «alle-goria analitica» in Varela-Portas 2011. Si può comprovare che la metodologiaspiegata in questo articolo è di base la stessa che serve ad analizzare infra la si-militudine dei versi 24-30.
3 Isabelle Battesti dice sulla similitudine iniziale della canzone: «la comparai-son est-elle un instrument “total”, fonctionnant simultanément comme ornementet comme énoncé scientifique» (Battesti 2008: 129).
4 Senza inoltre trascurare che, come spiega Battesti, «Dans la canzone 37, lanature est mise d’emblée hors-jeu: entre le troisième ciel et le coeur de l’amantil n’y a plus rien. Cette médiation disparue équivaut, dès la première strophe, àun reclassement ontologique de l’amour: celui-ci n’est pas un phénomène naturelmais antérieur à la nature elle-même» (Battesti 2008: 131). Selene Sarteschi, in-vece, vede già nella Vita nova questa autonomia di amore rispetto alla natura:«In Amor che moviDante sta rifondando la sua concezione d’amore con l’intentodi riavvicinarsi al pensiero della Vita nova, ossia all’idea della potenza dell’amoree della sua autonomia da ogni condizionamento che provenga in modo determi-nistico da natura, perché si evidenzi che l’unica variabile che possa condizionare
161
JUAN VARELA-PORTAS Alle origini dell’immaginazione analitica
amore è quella che appartiene al singolo, dotato di una sua innata libertà: ed è inquesto modo che si può ripresentare anche l’importanza del nesso ‘amore-ra-gione’» (Sarteschi 2004: 322-323). La studiosa fondamenta la sua affermazionein Vita novaXXI, 1: «Poscia che trattai d’Amore ne la soprascritta rima, vennemivolontade di volere dire anche in loda di questa gentilissima parole per le qualiio mostrasse come per lei si sveglia questoAmore, e come non solamente si sve-glia là ove dorme, ma là ove non è in potenzia, ella, mirabilmente operando, lofa venire». E aggiunge: «Siamo di fronte alle stesse idee che Dante espone inAmor che movi, distanziandosi così sia dal primo Guido sia da se stesso, consi-derando che a questa altezza cronologica il poeta non ha più bisogno dell’avalloguinizzelliano per ‘tutelarsi’ da Guittone e Cavalcanti e per esplicitare la sua con-cezione amorosa che ormai può superar, d’emblée, il pensiero di Al cor gentil»(Sarteschi 2004: 323, n. 37). Resta però evidente che in Amor che movi, di frontealla Vita nova, la autonomia di amore non è soltanto rispetto alla natura ma ancheal ruolo mediatrice della donna, la quale nella canzone non sveglia l’amore ma,al contrario, è identificata come oggetto amoroso grazie all’effetto di amore sulcuore del poeta.
5 Citiamo da Tomás de Aquino 1951-1956.6 Questo diletto collegato al ben fare sarà più avanti teorizzato nelMonarchia
come diletto che scaturisce dalla propria realizzazione personale, dalla propriaazione o «operazione» come agente: «Adhuc, ille qui potest esse optime dispo-situs ad regendum, optime alios disponere potest: nam in omni actione principa-liter intenditur ab agente, sive necessitate nature sive voluntarie agat, propriamsimilitudinem explicare. Unde fit quod omne agens, in quantum huiusmodi, de-lectatur; quia, cum omne quod est appetat suum esse, ac in agendo agentis essequodammodo amplietur, sequitur de necessitate delectatio, quia delectatio rei de-siderate semper annexa est» (Monarchia I, XIII, 1-2). Resta in questo modo spie-gato il senso del verso 10 («per lo qual si travaglia il mondo tutto»), visto che latendenza naturale di ogni essere è quella dell’autorealizzazione, del proprio «benfare», il che sta alla base del movimento teleologico del universo verso Dio. Co-munque, sarà la canzone “sorella” Io sento sì d’Amor la gran possanza quella chetratterà specificamente il rapporto dell’amore col ben fare e il diletto che da que-sto rapporto nasce.
7 D’altra parte, l’identificazione luce-amore punta, a nostro parere, sulla noncorporeità della luce, secondo la confutazione che Tommaso fa della teoria dellaluce corporale di Roberto Grossatesta (vid. ST I, q. 67, a. 2), e quindi sulla non
162
LA BIBLIOTECA DE TENZONE GRUPO TENZONE
corporeità dell’influsso amoroso. Punta cioè sulla questione dibattuta in Donname prega 63-68, dandone una risposta diremmo magistrale perché, anche se am-mette che l’amore non si può rappresentare attraverso una figura corporale, comeaveva argomentato Cavalcanti nei suddetti versi (e quindi ammette la necessitàdi superare le prosopopee della Vita nova, giustificate nel capitolo XXV), nonesclude che si possa rappresentare attraverso la non corporeità visibile della luce.
8 Per la distinzione in Dante fra causa efficiente e causa strumentale, si vedaConvivio I, XIII, 4 e IV, IV, 12. In questo senso, non ci potremo sottrarre alla sug-gestione, stimolata anche dall’incipit della canzone, di mettere in rapporto Dio-Amore-causa efficiente-causa prima, da una parte, e d’altra cielo-immaginazione-causa seconda-causa strumentale (Cfr. Maierù 1970: 747-748).
9 Lontana dalla lettera del testo l’identificazione da parte di Battesti dell’acquacon il cuore dell’amante: «Une eau limpide entre deux lentilles transparentes, telest le coeur noble vers lequel converge et se concentre dans toute sa puissance lerayonnement du troisième ciel, y provoquant un embrasement (“hagli un focoacceso”) dont l’occasion est la dame, mais dont l’origine n’est pas de ce monde»(Battesti 2008: 132).
10 Usiamo qui «verace» nel senso in cui si usa in Vita nova XXIII, PurgatorioXVIII, 22, ecc., cioè per designare l’essere materiale di fronte all’essere inten-zionale o immaginario, quello che entra nell’immaginazione ed è protagonista disogni, visioni, ecc.
11 Si devono evitare le letture non tecniche di ‘spiritale’ che identificano il suosignificato con l’attuale senso, tutto impregnato di idealismo, di ‘spirituale’.«Moto spiritale» vuole dire semplicemente ‘moto dell’immaginazione’.
12 Partiamo dalla lettura scelta da De Robertis, presa dall’edizione critica diBarbi-Pernicone. L’integrazione di Stabile, seguendo FrancescoAgosti, non cam-bia il senso: «in guisa che [effetto] del sol segno di foco» (Stabile 2007a: 56, n.55). Resta comunque ormai rifiutata la lettura «in guisa ched è ‘l sol segno difoco».
13 Vid. la voce «segno» nella Enciclopedia dantesca (Consoli 1976: 129) dovesi percorrono gli esempi di «segno» come «traccia visibile», «impronta», e quelli«in relazione con l’immagine del sigillo e della cera», tra i quali vale la pena ri-cordare – per il parallelismo che abbiamo messo in rilievo fra la nostra canzonee PurgatorioXVIII, 22-39 – appunto la conclusione della spiegazione di Virgilio,nella quale l’immagine sulla quale punta la «mente in disire» viene nominata
163
JUAN VARELA-PORTAS Alle origini dell’immaginazione analitica
metaforicamente col termine ‘segno’: «Or ti puote apparer quant’è nascosa / laveritate a la gente ch’avvera / ciascun amore in sé laudabil cosa; / però che forseappar la sua matera / sempre esser buona, ma non ciascun segno / è buono, ancorche buona sia la cera”» (Purgatorio XVIII, 34-39).