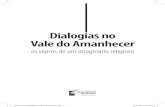Nigra Sum Sed Formosa: il turismo religioso come occasione di sviluppo?
Un carme religioso attribuito a Petrarca
Transcript of Un carme religioso attribuito a Petrarca
ACCADEMIA PETRARCA DI LETTERE ARTI E SCIENZE
DI AREZZO
*
STUDI PETRARCHESCHI
Nuova serie
XXII
(2009)
a cura di gino belloni,
† giuseppe billanovich, giuseppe frasso,
giuseppe velli
EDITRICE ANTENORE
ROMA-PADOVA · MMIX
Direttore responsabile:
Giulio Firpo
Autorizzazione del Tribunale di Arezzo
n. 11/2000 R.S.
Segreteria di redazione:
Claudio Griggio, Carla Maria Monti
ISBN 978-88-8455-657-8
Tutti i diritti riservati - All rights reserved
Copyright © 2009 by Editrice Antenore S.r.l., Roma-Padova. Sono rigo-
rosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, anche par-
ziale o per estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, com-
presi la copia fotostatica, il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc.,
senza la preventiva autorizzazione scritta della Editrice Antenore S.r.l.
Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.
SOMMARIO
Í. Ruiz Arzálluz, Terencio, Landolfo Colonna, Petrarca 1
A. Zago, Un carme religioso attribuito a Petrarca 19
A. Malanca, La « Vita di Petrarca » di Pietro da Castelletto 43
F. Forner, La diffusione manoscritta delle opere petrarche-
sche oltre le Alpi: Dresda 95
A. Torre, Fragmenta emblematici: un percorso di ricerca
(tavv. i-iv) 121
Miscellanea
A. Balduino, Petrarca e le “contraddizioni” del Canzoniere 153
A. Pancheri, Una prima testimonianza della fortuna del
codice degli abbozzi (tav. v) 161
Recensioni 175
Indice dei nomi, a cura di E. Valseriati 211
Indice dei manoscritti e dei documenti d’archivio, a cura di
E. Valseriati 000
Anna Zago
UN CARME RELIGIOSO
ATTRIBUITO A PETRARCA*
Nel 1976 Gilberto Pizzamiglio pubblicava, con il titolo Gli epigram-
mi inediti del Petrarca in un codice del Correr, quattro brevi carmi latini
contenuti in un foglio di guardia del codice Morosini-Grimani 46
(V) della Biblioteca del Civico Museo Correr di Venezia.
1
Il primo
epigramma, in effetti già noto, è l’epitaffio per Tommaso Caloiro
(inserito in Fam., iv 10), riportato nel codice veneziano in una ver-
sione non priva di lezioni interessanti; seguono gli inediti veri e pro-
pri, due dei quali in distici elegiaci: un polemico epitaffio per un
ignoto gentiluomo romano (inc. Ira furor rabies pariter cecidere dolusque)
e altri versi che secondo Pizzamiglio si potrebbero annoverare tra
quelli composti dal Petrarca per la propria sepoltura (inc. Quod mihi
nascenti dederat Florentia corpus). L’ultimo epigramma, anch’esso inedi-
to, è una preghiera di undici esametri, rubricata Eiusdem ad Virginem
Mariam:
2
Pizzamiglio osserva al riguardo che « la stringatezza epi-
grammatica degli epitaffi precedenti qui si allenta e lascia il posto a
un componimento di piú ampio respiro, che nella struttura del ver-
so e nel tono dell’invocazione riecheggia le strofe della canzone Ver-
gine bella, che di sol vestita ».
3
Il breve corpus di inediti ha avuto sorte non felicissima: i due epi-
* Desidero ringraziare il prof. Claudio Ciociola, che mi ha indirizzata e costante-
mente seguita nella stesura di questo lavoro; un ringraziamento va anche al prof.
Vincenzo Fera, che ha gentilmente accettato di discutere con me alcune questioni in
una fase preparatoria. Per spunti e suggerimenti assai utili sono inoltre debitrice alla
prof.ssa Silvia Rizzo, alla dott.ssa Giuliana Crevatin e al dott. Ernesto Stagni.
1. G. Pizzamiglio, Gli epigrammi inediti del Petrarca in un codice del Correr, in Petrarca, Ve-
nezia e il Veneto, a cura di G. Padoan, Firenze, Olschki, 1976, pp. 93-100.
2. L’incipit compare con il num. 3980 in L. Bertalot, Initia humanistica latina. Band i.
Poesie, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1985, con un riferimento al codice Morosi-
ni-Grimani e un errore di trascrizione (difficile pensare a una congettura: O superum
matrona invece del tradito matura).
3. Pizzamiglio, Gli epigrammi inediti, cit., p. 99. L’interpretazione del carme come
preghiera alla Vergine è l’aspetto piú problematico del componimento: una piú este-
sa discussione sarà affrontata nelle note al testo (in particolare al v. 1).
taffi hanno ricevuto qualche attenzione in piú tra gli editori e i com-
mentatori,
4
mentre l’ultimo componimento è rimasto sostanzial-
mente ignorato dopo la segnalazione di Pizzamiglio.
5
Una novità
importante fu apportata da Milagros Villar, la quale, nell’ambito del
censimento dei codici petrarcheschi conservati in Spagna, ritrovò il
componimento nel codice 5 3 27 della Biblioteca Colombina di Sivi-
glia (S) e ne segnalò la presenza in un codice della Biblioteca Co-
munale di Poppi (P).
6
Anche Michele Feo, nel catalogo della mostra
Petrarca nel tempo, accenna al gruppo di componimenti « tramandato
dal cod. di Venezia, Museo Civico Correr, Morosini-Grimani 46, al
quale fa parzialmente riscontro il codice di Siviglia, Bibl. Capitular y
Colombina, 7 2 24 [si legga 5 3 27], sec. XV».
7
4. L’epitaffio Ira furor rabies è stato incluso con il titolo Un nemico pubblico da F. Rico
nella raccolta Gabbiani (Milano, Adelphi, 2008, pp. 39-41 e 79-81), con traduzione di
G. Crevatin. Per quanto riguarda l’auto-epitaffio Quod mihi nascenti, Villar ne segnala
la presenza nel codice 5 3 27 della Biblioteca Colombina di Siviglia e fa riferimento
anche al codice veneziano, senza menzionare però il nostro epigramma O superum. . .
(M. Villar, Petrarca en la biblioteca manuscrita de Hernando Colón, in El libro antiguo espa-
ñol. Actas del segundo Colóquio Internacional (Madrid), a cura di M.L. López-Vi-
driero e P.M. Cátedra, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca-Bi-
blioteca Nacional de Madrid-Sociedad Española de Historia del Libro, 1992, pp. 457-
73, in part. pp. 459-60).
5. I pochi cenni a questi versi, sulla cui attribuzione nessuno si è pronunciato, sono
limitati all’informata monografia di I. Ruiz Arzalluz, El hexámetro de Petrarca, in
« Quaderni petrarcheschi », a. viii 1991, pp. 382-83 e al commento a Rvf, 366, di M.
Santagata (Francesco Petrarca, Canzoniere, edizione commentata a cura di M. San-
tagata, Milano, Mondadori, 1996
1
, ed. aggiornata 2004, p. 1402; non se ne fa cenno
invece nel commento di R. Bettarini: Francesco Petrarca, Canzoniere. Rerum vulga-
rium fragmenta, a cura di R. Bettarini, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2005). I nostri
versi non compaiono infine nel ricchissimo volume Estravaganti, disperse, apocrifi petrar-
cheschi. Gargnano del Garda (25-27 settembre 2006), a cura di C. Berra e P. Vecchi
Galli, Milano, Cisalpino, 2007.
6. Villar, Códices Petrarquescos en España, Padova, Antenore, 1995, pp. 257-61 (il riferi-
mento al codice di Poppi è tratto da U. Chevalier, Repertorium Hymnologicum. Catalo-
gue des chants, hymnes, proses, sequences, tropes en usage dans l’eglise latine depuis les origines jus-
qu’a nos jours, Louvain, Lefrevre, 1892-1921, vol. iii p. 449 num. 31070). Nel censimento
dei codici spagnoli la Villar lascia intendere (p. 257 n. 1) che il componimento sia con-
tenuto anche nei codici perugini citati da G. Billanovich in Petrarca letterato I. Lo scrit-
toio del Petrarca, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1995 (rist. anast. della prima edi-
zione 1947), p. 368 n. 2. A quanto ho potuto constatare, i manoscritti (rispettivamente
C 1 e I 25 della Biblioteca Comunale Augusta di Perugia) non riportano i nostri versi.
7. Petrarca nel tempo. Tradizione lettori e immagini delle opere. Catalogo della mostra
20 anna zago
1. I codici
Venezia, Biblioteca del Civico Museo Correr, Morosini Grimani 46
(ex 382) (= V).
Cart., cc. 61 (mm 148 « 208), numerazione moderna a matita nel margine
superiore destro; in basso tracce di numerazione in inchiostro rosso, visibi-
li ad esempio alle cc. 2r (12), 4r (14), 5r (15). Datazione nell’explicit al 1456. Tra
il foglio di guardia e la prima carta è inserito un foglio pergamenaceo di di-
mensioni leggermente inferiori (mm 139 « 203), non numerato, che contie-
ne i quattro epigrammi (tutti esplicitamente attribuiti a Petrarca), vergati da
una mano diversa da quella che ha trascritto il codice, in un inchiostro piú
scuro e una grafia piú corsiva ma coeva. Il foglio presenta tracce di una pie-
gatura in senso verticale lungo la metà; numerose macchie, prove di penna,
rasure, incisioni; lo stato di conservazione nel complesso è buono. Legatu-
ra settecentesca.
Contiene il De vero cultu, sesto libro delle Divinae Institutiones di Lattanzio,
qui erroneamente attribuito ad Agostino.
G. Mazzatinti-A. Sorbelli, Inventari dei manoscritti delle biblioteche d’Italia, Firenze, Olsch-
ki, 1939, vol. lxviii pp. 28-29; P.O. Kristeller, Iter Italicum. A finding list of uncatalogued or in-
completely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries, Leiden,
Brill, 1992, vol. vi p. 277;
8
Pizzamiglio, Gli epigrammi inediti, cit., in part. pp. 93-95.
Siviglia, Biblioteca Capitular y Colombina, 5 3 27 (olim E AA Tab.
139 n
o
35) (= S).
Il codice 5 3 27 della Biblioteca Colombina di Siviglia è un manoscritto mi-
scellaneo databile alla seconda metà del XV secolo, vergato da varie mani in
corsiva gotica e umanistica.
9
Il codice consta di cc. 261 (le cc. 1 e 261 sono fo-
gli di guardia), di mm 216 « 148; ogni carta contiene dalle 22 alle 25 righe. Le-
gatura in pergamena risalente al XVIII secolo. Secondo Kristeller, il mano-
scritto è stato vergato in Spagna; secondo la Villar, invece, l’origine è da in-
dividuare nell’Italia Settentrionale.
10
(Arezzo, Sottochiesa di S. Francesco, 22 novembre 2003-27 gennaio 2004), a cura di
M. Feo, Pontedera, Bandecchi & Vivaldi 2003 (in part. pp. 309-13).
8. Qui il foglio è descritto come « a fly leaf »: in effetti esso è rilegato con il primo fa-
scicolo del codice; il tallone della pergamena è visibile al termine del fascicolo (c. 10v).
9. Alcune indicazioni di carattere materiale (numero di fogli, dimensioni, etc.) dif-
feriscono lievemente nelle varie descrizioni reperibili. Non avendo potuto visionare
il codice di persona, mi sono attenuta in linea di massima ai dati forniti da Villar, Có-
dices Petrarquescos en España, cit., pp. 257-61.
10. Cosí annota con sicurezza in Petrarca en la biblioteca manuscrita de Hernando Colón,
cit., p. 458, e di nuovo in Códices Petrarquescos en España, cit., p. 261.
un carme religioso attribuito a petrarca 21
Il contenuto, esclusivamente latino, è assai vario: la copertina reca il tito-
lo Opera vari[a] / Petrarchae / et Xenofontis Ms. Tra gli autori trascritti, Ildeber-
to di Lavardin, Guarino Veronese, Pier Paolo Vergerio, una traduzione del
De tyrannide di Senofonte (ovvero il dialogo Gerone) attribuita a Leonardo
Bruni,
11
il dialogo An seni sit uxor ducenda attribuito a Poggio Bracciolini, e
una costellazione di epitaffi, molti dei quali recano l’attribuzione (vera o
presunta) a Petrarca. Il nostro componimento è alla c. 103v, preceduto dalla
rubrica Carmina eiusdem Francisci ad beatam Virginem; interessante la presenza
dell’epitaffio per Tommaso Caloiro (c. 103v), di quello per il prepotens et per-
niciosus Romanus (c. 154v), e dell’auto-epitaffio (c. 154v): in sostanza S riporta
in due carte separate i medesimi quattro componimenti che in V compaio-
no nel foglio pergamenaceo allegato al codice. Non è da trascurare, alle cc.
104r-113v (subito dopo la preghiera Ad beatam Virginem, quindi), la presenza
del Geta di Vitale di Blois, contenuto anche in P.
12
Kristeller, Iter Italicum, cit., 1989, vol. iv p. 615; Villar, Petrarca en la biblioteca manuscrita de
Hernando Colón, cit., pp. 458-60; J. Solís, El diálogo ‘An seni sit uxor ducenda’ de Poggio (ms. Colom-
bino 5 3 27), in «Habis », a.xxiv 1992, pp. 193-206;Villar, Códices Petrarquescos en España, cit., pp.
257-61; J.F. Sáez Guillén, Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Colombina de Sevilla, Sevilla, In-
stitución Colombina-Cabildo de la S.M. y P.I. Catedral de Sevilla, 2002, pp. 178-82.
Poppi, Biblioteca Comunale Rilliana, 31 (= P).
Il cod. 31 della Biblioteca Comunale Rilliana di Poppi (Arezzo) è un carta-
ceo composito, di mm 307 « 222; consta di 74 carte + un foglio di guardia ini-
ziale e uno finale. Testo e glosse sono in lettera bastarda, vergati da piú ma-
ni e con inchiostri di diverse gradazioni. Decorazioni in rosso alla c. 1r (let-
tera iniziale) e dalla c. 65r (lettere rubricate). Legatura di restauro recente, in
piatti di legno ricoperti di pelle, con dorso nervato. Il codice proviene dalla
biblioteca del Convento di San Francesco in Assisi: alla c. 1r rimane traccia,
nel margine inferiore, del cartellino ex libris asportato. Alle cc. 62v e 72v so-
no presenti colofoni; il primo ci fornisce il nome del possessore (« Hic liber
est Petri Butini de Luceria »), mentre il secondo recita: « [. . .] Hic libellus est
Petri Vutini de regno Sicilie quem Mantue scripsit currente anno Domini
m°ccc°lxxxxviiii° inditione septime (sic) [. . .] ». Alle cc. 1r-62v il codice ri-
porta le Heroides ovidiane secondo la vulgata medievale, cioè interrotte alla
lettera di Cidippe (xxi 12). Dopo un intervallo di due carte (le cc. 63r-64v so-
11. Su questo testo, che conta circa 200 esemplari manoscritti, si veda M. Bandini,
Il ‘Tyrannus’ di Leonardo Bruni: note su tradizione e fortuna, in Tradurre dal greco in età umani-
stica: metodi e strumenti. Atti del Seminario di Studio (Firenze, Certosa del Galluzzo, 9
settembre 2005), a cura di M. Cortesi, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo,
2007, pp. 35-44.
12. La presenza della commedia elegiaca in entrambi i codici sarà discussa oltre (in
part. n. 16).
22 anna zago
no bianche), le cc. 65r-72v sono occupate dal Geta di Vitale di Blois. Le ulti-
me due carte, infine, riportano vari componimenti latini vergati dalla stessa
mano che ha trascritto l’opera precedente: vi sono esametri In fortunam (inc.
Improba cur totiens variarum turbine rerum),
13
un Epitaphyum magistri Petri de
Mantua (inc. Egregium natura virum meritisque verendum), e infine, nel fondo
della c. 74v, i primi 8 versi del nostro epigramma, rubricato Oratio metrica
senza alcuna attribuzione. I vv. 9-11 sono trascritti nella parte superiore del
margine destro, “spezzati in due”, per un totale di 6 brevi righe. Quasi tutte
le carte del codice sono macchiate o rovinate dall’umidità: il guasto è note-
vole alla c. 74v,
14
e ci priva di parte dei vv. 5-8 del componimento.
Mazzatinti-Sorbelli, Inventari dei manoscritti delle biblioteche d’Italia, cit., 1896, vol. vi p. 132;
O. Fanfani, Inventario dei manoscritti della Biblioteca comunale di Poppi, Firenze, Tip. Giunti,
1925, pp. 14-15; Bénédictins du Bouveret, Colophons des manuscrits occidentaux des origines au
XVI
e
siècle, Fribourg, Éditions universitaires, 1979, vol. v num. 15380; C. Cenci, Bibliotheca
manuscripta ad sacrum Conventum Assisiensem, Assisi, Regione dell’Umbria-Sacro Convento
di Assisi, 1981, voll. i-ii p. 522 num. 1731; I manoscritti della Biblioteca Comunale di Poppi (secoli
XII-XVI). Un esperimento di catalogazione diretto da E. Casamassima, revisione del catalogo a
cura di G. Bartoletti e I. Pescini, Firenze, Giunta Regionale Toscana-Editrice Biblio-
grafica, 1993 (« Inventari e Cataloghi Toscani », 42), pp. 26-27 tavv. xxvii e xxviii; I mano-
scritti datati della provincia di Arezzo, a cura di M.C. Parigi e P. Stoppacci, Firenze, SISMEL-
Edizioni del Galluzzo, 2007 (« Manoscritti datati d’Italia », 15), num. 51 pp. 58-59 (e tav. 9).
L’analisi dei testimoni risulta determinante nel cercare di colloca-
re il nostro epigramma in un ambiente e in un’epoca il piú possibile
delimitati. Sembra opportuno partire da P, senza dubbio il codice
piú antico: come abbiamo già visto, esso reca alla c. 74v, appena pri-
ma dell’oratio metrica, l’epitaffio per Pietro da Mantova (inc. Egregium
natura virum meritisque verendum). Si tratta di Pietro Alboini, perso-
naggio attivo fra Padova (dove era presente nel 1389) e Bologna fino
al 1399 o 1400, anni in cui è da collocare la sua morte.
15
Tutto induce
13. Gli esametri, inediti a mia conoscenza, sembrano sviluppare la tematica dei ri-
volgimenti del fato con riferimenti alle guerre civili e alla morte di Pompeo. La se-
conda parte, però (da c. 74r, col. 2 rr. 13-14: Iam tunc Oceano rutilantes aera currus), ha co-
me destinatario dell’invocazione un dulcissime vates, fino all’explicit Semper honoratum
vivet per secula nomen / docte tuum nulloque evo violabile carmen (c. 74v). I versi meritereb-
bero uno studio piú approfondito, volto anche a stabilire un eventuale legame con
l’epitaffio per Pietro Alboini immediatamente successivo nel codice. Un punto in
comune con il nostro carme sarà invece esposto nel commento al v. 4.
14. Il guasto è in realtà di tutto il codice, ma è stato riparato con altra carta solo a
partire da c. 72r.
15. Dati utili alla biografia del personaggio in C. Salutati, Epistolario, a cura di F.
Novati, Roma, Forzani e C., 1896, vol. iii pp. 318-22; C. Vasoli, Pietro Alboini da Man-
un carme religioso attribuito a petrarca 23
a pensare che il manoscritto di Poppi sia un libro di scuola: lo con-
fermerebbero la presenza delle Heroides, del Geta di Vitale di Blois
16
e lo stesso epitaffio per il magister mantovano. Nessuna notizia ci vie-
ne purtroppo dal possessore: un Petrus Butini/Vutini da Lucera
tova “scolastico” della fine del Trecento e un’epistola di Coluccio Salutati, in « Rinascimento »,
a. iii 1963, pp. 3-21; Th.E. James, A fragment of an Exposition of the first letter of Seneca to Lu-
cilius attributed to Peter of Mantua, in Philosophy and Humanism: Renaissance essays in honor
of P.O. Kristeller, edited by E.P. Mahoney, Leiden, Brill, 1976, pp. 531-41; D.A. Lines,
Aristotle’s ‘Ethics’ in the Italian Renaissance (ca. 1300-1650). The Universities and the Problem of
Moral Education, Leiden, Brill, 2002, p. 397; S. Marcucci, Su Pietro da Mantova e il suo
commento, in Seneca: una vicenda testuale, a cura di T. De Robertis e G. Resta, Firenze,
Mandragora, 2004, p. 231; R. Avesani, La « pandetta » in onore di Ramo Ramedelli: livelli
di cultura a Mantova fra Tre e Quattrocento, in Filologia, Papirologia, storia dei testi: giornate di
studio in onore di Antonio Carlini (Udine, 9-10 dicembre 2005), Pisa, Fabrizio Serra Edi-
tore, 2008, pp. 131-73 (in part. pp. 156-65). La data di morte non può essere stabilita con
certezza: nel codice Magl. VIII 1390 (per cui vedi Kristeller, Iter Italicum, cit., vol. i
1963, p. 133) alle cc. 132r–134r è riportata una lettera di Arcangelo della Pergola a Pie-
tro Turchi, nella quale si allude chiaramente alla morte del Mantovano (cc. 132r-v)
come già avvenuta nel 1400. L’epitaffio contenuto nel manoscritto di Poppi consenti-
rebbe apparentemente di retrodatare la morte del Maestro all’anno precedente: va ri-
cordato, però, che i versi sono trascritti nell’ultima carta del codice, che non necessa-
riamente risale al momento in cui è stata vergata la nota di possesso « Hic libellus est
Petri Vutini [. . .] ». Su Pietro Turchi, corrispondente del Salutati, si veda C. Griggio,
Il codice berlinese lat. fol. 667. Nuove lettere di Francesco Barbaro, in Umanesimo e Rinascimen-
to a Firenze e Venezia. Miscellanea Vittore Branca, Firenze, Olschki, 1983, vol. iii to. i pp.
133-76 (in part. pp. 162-63).
16. Vitale di Blois, Geta, a cura di F. Bertini, in Commedie latine del XII e XIII secolo,
Genova, Istituto di Filologia Classica e Medievale, 1980, vol. iii pp. 139-242. Sulla com-
media di Vitale di Blois cfr. inoltre W. Schmidt, Untersuchungen zum ‘Geta’ des Vitalis
Blesensis, Ratingen-Kastellaun-Düsseldorf, A. Henn Verlag, 1975; sulla tradizione ma-
noscritta, oltre agli studi dei singoli editori (il primo fu Angelo Mai nel 1833), tra cui
spicca il Paeske (Der ‘Geta’ des Vitalis von Blois. Kritische Ausgabe, vorgelegt von A. Pae-
ske, Köln, Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophi-
schen Fakultät der Universität zu Köln, 1976), sono da ricordare D. Bianchi, Mano-
scritti del ‘Geta’ conservati in Italia, in « Accademie e Biblioteche d’Italia », a. xxxi 1963, pp.
433-50; R. Avesani, Quattro miscellanee medioevali e umanistiche, Roma, Ed. di Storia e
Letteratura, 1967, pp. 83-88; A. Perosa, Un nuovo codice del ‘Geta’ di Vitale di Blois, in Kon-
tinuität und Wandel. Lateinische Poesie von Naevius bis Baudelaire. Franco Munari zum 65. Ge-
burtstag, Hildesheim, Weidmann, 1986, pp. 391-409; da ultimo R. Black, Humanism
and Education in Medieval and Renaissance Italy, Cambridge, Cambridge University
Press, 2001, passim. Il codice di Siviglia non è mai stato considerato nella storia della
tradizione manoscritta del Geta, come già notava Villar, Códices Petrarquescos en Espa-
ña, cit., p. 259. Il manoscritto di Poppi è egualmente ignoto agli editori di Vitale: da una
prima collazione esso appare assai vicino alla famiglia di codici che Paeske denomina
m, nonché al codice II C 1 della Civica Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friu-
li, testimone utilizzato per la prima volta da Bertini e da lui indicato come D.
24 anna zago
non risulta ad esempio fra gli studenti padovani di fine XIV secolo.
17
Il codice era probabilmente destinato all’uso universitario, come
provano le numerose note, le chiose e gli argumenta. Il volume è
completato da due pagine finali di versi sparsi (come gli esametri In
fortunam), tutti privi di attribuzione. L’area geografica entro cui si
colloca è quella dell’Italia settentrionale, la stessa in cui operava l’Al-
boini; non possiamo escludere quindi un legame fra i due ambienti
culturali, tra la cultura accademica e quelli che Vasoli definisce « li-
beri studiosi umanisti ».
18
Anche il codice di Siviglia (S) sembra avere origine in Italia set-
tentrionale, e segnatamente in zona veneta: il manoscritto raccoglie
numerose opere scolastiche (le Regulae grammaticales di Guarino, il
Liber Faceti, di nuovo il Geta di Vitale di Blois) mescolate a una ric-
chissima serie di epitaffi e componimenti brevi, quali epistole e car-
mina spesso di carattere religioso.
19
In questo caso, però, non è diffi-
cile mettere in relazione il codice 5 3 27 con la tradizione petrarche-
sca: esso risulta infatti strettamente imparentato ai quattro esempla-
ri che ci restituiscono « los epigramas y cármenes que Petrarca im-
provisaba y guardaba para sí en un cuadernillo que fue salvado y di-
fundido por Pier Paolo Vergerio ».
20
17. A. Gloria, Monumenti dell’Università di Padova (1318-1405), Padova, Tip. del Semi-
nario, 1888; il nome di Pietro da Mantova compare invece nel vol. i p. 512 e nel vol. ii
p. 229. Anche analoghi riscontri per l’Università di Bologna hanno dato esito negati-
vo. Per questa segnalazione e piú in generale per il prezioso aiuto ringrazio il dott.
Francesco Piovan, del Centro per la Storia dell’Università di Padova.
18.Vasoli, Pietro Alboini da Mantova “scolastico”, cit., p. 18. La lettera del Salutati « Ma-
gistro Petro Albuino de Mantua » è datata 26 agosto 1398 (in C. Salutati, Epistolario, a
cura di F. Novati, cit., vol. iii pp. 318-22; Novati fornisce in quella sede dettagliate no-
tizie sul maestro mantovano, mostrando anche di conoscere l’epitaffio contenuto nel
codice di Poppi). Sull’insegnamento e la lettura dei classici nelle università di Bologna
e Padova si vedano L. Gargan, Scuole di grammatica e università a Padova tra Medioevo e
Umanesimo, in « Quaderni per la storia dell’Università di Padova », a. xxxiii 2000, pp. 9-
27, e Id., La lettura dei classici a Bologna, Padova e Pavia, in I classici e l’università umanistica. At-
ti del convegno di Pavia (22-24 novembre 2001), a cura di L. Gargan e M.P. Mussini
Sacchi, Messina, Centro Interdipartimentale di Studi Umanistici, 2006, pp. 459-85.
19. Nelle carte comprese tra 103v e 154v trovano spazio ben ventisette componi-
menti: eccettuate tre opere (l’Amphitryon sive Geta e le traduzioni di Leonardo Bruni
di Xenophontis de tirannide e Ad nepotes di San Basilio), i testi in genere non superano in
estensione le due carte.
20. Villar, Petrarca en la biblioteca manuscrita de Hernando Colón, cit., p. 459. Si tratta
un carme religioso attribuito a petrarca 25
I codici S e V, del resto, sembrano inserire l’epigramma in un pic-
colo corpus di disperse pseudo-petrarchesche, tutte di dubbia attri-
buzione se si eccettua l’epitaffio per Tommaso Caloiro.
21
Per il fo-
glio di guardia del manoscritto Morosini-Grimani la questione è in
realtà piú complicata: il fatto che l’unico epitaffio di paternità certa
sia “isolato” sul recto del foglio e gli altri siano trascritti sul verso po-
trebbe indurre qualche sospetto.
22
Gli elementi a favore di un’eventuale attribuzione a Petrarca dei
nostri esametri poggiano dunque tutti sulla constatazione che il
componimento viene a far parte di un piccolo corpus petrarchesco:
23
e a questo dobbiamo limitarci. Per contro, si oppongono all’attribu-
zione la qualità non eccezionale della versificazione, e non da ulti-
mo qualche problema di interpretazione che coinvolge l’intero
componimento. La stessa brevità dell’oratio rende d’altronde proble-
matico ogni discorso attributivo. Dobbiamo accontentarci di con-
cludere che i versi sono stati composti in pieno XIV secolo, con ogni
probabilità in un ambiente universitario dell’Italia Settentrionale
nel quale riecheggiano tanto le letture dei classici quanto le letture di
autori medievali. Nel commento al testo si sono citati i riferimenti a
Petrarca che sembrassero degni di nota, anche a prescindere dalla
questione attributiva. Tra i passi citati non figurano paralleli signifi-
cativi né stringenti: sembra potersi ammettere la conoscenza dell’A-
frica, ma non si registrano altri riferimenti certi. Il componimento
potrà considerarsi dunque un esercizio (“esercizio scolastico” suo-
nerebbe forse riduttivo e troppo lontano dall’idea del cuadernillo di
improvvisi cui abbiamo accennato): se volessimo istituire un para-
gone con testi di sicura paternità petrarchesca, potremmo indicare
del celebre ms. 509 di Olomouc e dei codici C 1 e I 25 della Biblioteca Comunale Au-
gusta di Perugia; il quarto codice è infine il nostro Morosini-Grimani 46 (V).
21. Una ricerca codicologica sul Morosini-Grimani 46 (V) può fornire ben pochi
elementi, poiché il foglio che reca i versi in questione è allegato a un manoscritto di
tutt’altra natura.
22. Analizzando il foglio, non sembrerebbe tuttavia di poter individuare due mo-
menti diversi nella trascrizione.
23. Un corpus piú limitato (i quattro componimenti nel foglio superstite) in V, piú
esteso in S, che in totale conta sette carmi, sei dei quali attribuiti esplicitamente a Pe-
trarca.
26 anna zago
quel saggio di versificazione a carattere religioso che è rappresenta-
to dal carme per Maria Maddalena contenuto in Sen., xv 15.
24
2. Edizione e traduzione
Dato l’esiguo numero dei testimoni e la mancanza di errori signifi-
cativi, non è possibile tracciare uno stemma o stabilire parentele certe
fra i codici, fatta salva l’individuazione di un probabile errore d’arche-
tipo discusso nelle note al testo (v. 1). In apparato si segnalano errori
(come eternasque di V al v. 1), omissioni o aggiunte, lacune (tutte in P)
o varianti degne di considerazione (come rapide S al v. 8); alcune va-
rianti puramente ortografiche saranno discusse nelle note al testo.
P = Poppi, Biblioteca Comunale Rilliana, 31, c. 74v (rubr. Oratio metrica), cir-
ca 1399
V = Venezia, Biblioteca del Civico Museo Correr, Morosini-Grimani 46
(olim 382), c. iv (rubr. Eiusdem ad Virginem Mariam),
25
sec. XV.
S = Siviglia, Biblioteca Capitular y Colombina, 5 3 27 (olim E. AA Tab. 139
N
o
35), c. 103v (rubr. Carmina eiusdem Francisci ad Beatam Virginem), sec.
XV
2
.
1 O superum Natura parens eternaque semper,
cunta movens rapidi pereuntia secula mundi,
astrorumque opifex totumque emissa per orbem
lumina diffundens patulas lustrantia terras,
5 luminibusque infunde meis tua sancta tueri
numina, monstriferi delere piacula fati.
Cumque aderit supprema dies lassataque rumpent
stamina fatales rapido revoluta sorores
1 matura codd. eternasque V seper S 3 -rum om. S add. S
2
offert opifex P inter
scribendum 4 l[ ]mina P 5 luminibusque i- fere periit P 6 numina monstri-
periit P 7 aderis V cumque aderit supprema d- periit P la[ ]sataque P 8
stamina fatales rapido re- periit P rapide S
24. Il carme è presente tra l’altro in S (cc. 153v-154v). Alcuni versi hanno un’intona-
zione assai simile al nostro epigramma, in predicazioni come « immortale decus lu-
menque habitura per evum » o nel racconto della fine gloriosa: « Hic hominum non
visa oculis, stipata cathervis / angelicis, septemque die subvecta per horas, / celestes
audire choros alterna canentes / carmina [. . .] » (Petr., Sen., xv 15 6, ed. Nota).
25. Da notare che le lettere -d Virginem nella rubrica sono vergate dalla stessa mano
sopra una rasura.
un carme religioso attribuito a petrarca 27
impetu et extreme peragam dispendia vite,
10 angelicis sociare choris, pater optime divum,
digneris piceis animamque avertere flammis.
11 animam S annectere V flamis S
*
O Natura, madre degli dei, sempiterna,
tu che tutto muovi, le stirpi mortali
26
del mondo che scorre,
27
tu che hai creato gli astri, e ti spandi su tutta la terra
e diffondi le luci che ne rischiarano le vaste plaghe,
28
infondi ai miei occhi la capacità di vedere il tuo santo
nume e di cancellare le colpe del fato mostruoso.
E quando giungerà il giorno supremo, e le fatali sorelle
romperanno gli stami a lungo filati riavvolgendoli con rapido
impeto e percorrerò la fine del lungo e penoso cammino della vita,
29
26. Per il significato da attribuire a secula mundi, rimando al commento al v. in que-
stione.
27. La traduzione separa cunta. . . pereuntia secula mundi per rendere lo “stacco” di cun-
ta movens in apertura di verso.
28. I vv. 3-4 presentano una seconda possibilità di traduzione, sintatticamente piú
complessa: si tratta di concordare eterna con cunta ai vv. 1 e 2 e allo stesso modo emissa
con lumina ai vv. 3 e 4. La traduzione che si ottiene è la seguente: « O Natura, madre
degli dei, tu che sempre muovi tutte le cose eterne e le stirpi mortali del mondo che
scorre, tu che hai creato gli astri e diffondi le luci che si spandono su tutta la terra, ri-
schiarandone le vaste plaghe ». Pur essendo questa interpretazione perfettamente
plausibile, suscita qualche perplessità l’asindeto poco scorrevole del v. 2 (cuncta movens
– rapidi pereuntia secula mundi, solo in parte simile a quello del v. 6) e la serie di partici-
pi dei vv. 3-4 (diffundens reggerebbe lumina emissa, che a sua volta reggerebbe lustran-
tia). Il parallelo assai raro per il nesso emittere lumen individuabile in un carme di Pro-
spero (« ut lumen ab alto / emissum indigna nollet requiescere sede » in De ingratis,
305-6, PL, li col. 112B) non sembra decisivo per l’interpretazione dei nostri versi. Si è
scelto quindi di conservare la struttura “conclusa” di ogni verso che compone la pri-
ma parte della preghiera (fino appunto al v. 4), dove vengono enunciati per accumu-
lazione gli epiteti e le virtutes della Natura parens: la struttura dei vv. 1 e 3 risulta cosí
parallelamente bipartita e coordinata dall’enclitica -que (Natura parens – eternaque sem-
per; astrorum(que) opifex – totumque emissa per orbem), mentre i vv. 2 e 4 sviluppano in
forma participiale (movens. . . pereuntia secula; lumina diffundens. . . lustrantia) le predica-
zioni nominali dei versi precedenti.
29. Ho tradotto cosí il verso sviluppando la metafora di perago in nesso con dispen-
dia, un’idea tratta da Luc., viii 2: « Haemoniae deserta petens dispendia silvae [. . .] ».
L’idea della vita come cammino, e quindi della morte come « estremo passo », è pre-
sente anche in Petrarca (cfr. Rvf, 366 105-7, ed. Santagata: « Vergine, in cui ò tutta mia
28 anna zago
degnati, sommo padre degli dei, di unire la mia anima ai cori degli angeli
e di sottrarla alle picee fiamme.
3. Note all’edizione
30
1. O superum Natura parens: la correzione Natura parens sul tradito matura ci
restituisce, nella sua economicità, un nesso piuttosto diffuso che ben si adat-
ta al tono dell’invocazione, come vedremo nelle note di commento. Se al-
l’apparenza i nostri versi possono sembrare rivolti a Maria, a una lettura piú
attenta emerge una serie non trascurabile di incongruenze rispetto alla tito-
latura (davvero facilior) fornita dai testimoni S e V. Il brusco cambiamento di
destinatario che si verifica fra i vv. 1-6 e 7-11 (dall’invocazione alla matura pa-
rens si passerebbe al pater optime divum, con scarto non impensabile ma quan-
to meno difficile in una manciata di versi) è comunque trascurabile rispet-
to alla difficoltà di alcuni epiteti riferiti alla Vergine. La presentazione di
Maria come mater o parens non ha ovviamente nulla di insolito di per sé,
31
speranza / che possi et vogli al gran bisogno aitarme, / non mi lasciare in su l’extre-
mo passo »). Un approfondimento sull’uso di questa immagine sarà esposto nel com-
mento al v. 9.
30. Si è ritenuto piú funzionale tenere distinte le note filologiche da quelle pro-
priamente esegetiche: in questo primo commento, perciò, saranno discussi piú nel
dettaglio i problemi relativi alla costituzione del testo. Nel corso del lavoro per le ci-
tazioni saranno impiegate le seguenti abbreviazioni, seguite quando necessario dal
numero del volume: Anal. Hymn. = G.M. Dreves-C. Blume-H.M. Bannis-H.A. Da-
niels, Analecta hymnica Medii Aevi, Frankfurt a.M., Minerva, 1961, 55 voll. (rist. anast.
dell’ed. Leipzig 1886-1922); CC Ser. Lat. = Corpus Christianorum. Series Latina, Turn-
hout, Brepols, 1953-; CC Cont. Med. = Corpus Christianorum. Continuatio Medievalis, ivi,
id., 1966-; MGH Poetae Latini Medii Aevi = Monumenta Germaniae Historica. Poetae latini
medii aevi, Berolini, Weidmann 1880-1899, 8 voll.; PL = J.-P. Migne, Patrologiae cursus
completus. Series Latina, Paris, Garnier, 1844-1855 e 1862-1865, 221 voll.; Walther = H.
Walther, Initia Carminum ac Versuum Medii Aevi Posterioris Latinorum. Alphabetisches
Verzeichnis der Versanfänge mittellateinischer Dichtungen (2., durchgesehene Auflage mit
Engänzungen und Berichtigungen zur 1. Auflage), Göttingen, Vandenhoeck & Ru-
precht, 1969. Le abbreviazioni delle opere del Petrarca sono quelle usate nelle edi-
zioni « Petrarca del Centenario » della Commissione per l’Edizione Nazionale delle
Opere di Francesco Petrarca.
31. Un eccellente modello potrebbe essere, a titolo di esempio, un passo dell’Anti-
claudianus di Alano di Lilla, che godette di un’enorme fortuna dal XIII secolo in poi,
soprattutto come testo didattico nelle scuole di retorica: « Virgo parens rerum, supe-
rum germana meique / filia, celestis ortu, tamen incola terre, [. . .] » (Alan., Anti-
claud., vi 382-83). Un’invocazione a Maria in un contesto assai simile al nostro è con-
tenuta nell’epitaffio che Petrarca dettò per la propria tomba: anche in questi tre versi
l’anima viene affidata dopo la morte proprio alla Vergine parens: « Frigida Francisci
lapis hic tegit ossa Petrarce / Suscipe virgo parens animam sate virgine parce / Fessa-
un carme religioso attribuito a petrarca 29
ma il nesso matura parens non sembra essere ripreso da fonti note: nella let-
teratura cristiana attestazioni di virgo matura riferite a Maria compaiono in
un’accezione completamente diversa, poiché si descrive la Vergine come
una giovane in età adatta al matrimonio.
32
A mettere in dubbio un’inter-
pretazione “mariana” del nostro carme è però soprattutto l’epiteto astrorum
opifex che apre il v. 3, un unicum nella poesia mariologica e non solo. La rari-
tà dell’espressione è duplice: innanzitutto l’accostamento dei due termini
non ha precedenti nella letteratura in lingua latina a noi nota;
33
in secondo
luogo, le non rarissime espressioni con opifex che si possono individuare
nella produzione cristiana
34
non sono mai riferite a Maria. Scorrendo gli
epiteti tributati alla Vergine,
35
non mancano certo i riferimenti ai corpi ce-
lesti (« astrum occidentis luminis mundi » per sant’Anselmo d’Aosta, « stel-
la quae solem dedit » in sant’Eleuterio, « firmamentum in quo Deus posuit
solem » nei sermoni di san Bernardo di Chiaravalle): ciò non risolve co-
munque del tutto la difficoltà presentata da un attributo certamente piú
adatto a un Dio creatore. Un sostegno, anche se non del tutto persuasivo,
potrebbe venire dalla poesia in volgare: nel componimento 13 delle Laude
cortonesi la strofe iii recita « O Maria, cum’ t’adornasti, / a Dio piacent’asutil-
liasti, / ke sovra i cieli a lui mandasti / per trarer inde nova stella! » (Laud.
Cort., 13 11-14).
36
Un’analoga predicazione di Maria compare anche in un
componimento del Laudario della compagnia di San Gilio: « Stella, tu se’ ke
portasti / l’alto sole, che molto amasti » (Laud. Fior., 44 31-32, ed. Del Popo-
lo).
37
Questi passi attestano soltanto la visione di Maria come creatrice del-
que iam terris celi requiescat in arce » (cit. da U. Dotti, Vita del Petrarca, Roma-Bari,
Laterza, 1992, p. 439).
32. Un uso di questo tipo è nel centone virgiliano falsamente attribuito a Celio Se-
dulio e databile al V secolo: « Virgo matura fuit iam plenis nubilis annis » (Anth. Lat.,
719 11, Riese).
33. L’unica occorrenza che si è potuta reperire è nel Liber sacerdotalis seu Scutum fidei,
un Liber ad usus quotidianos sacerdotum composto da Conrad Boppert (1750-1811), mo-
naco benedettino attivo a St. Paul in Lavanttal (il testo è nell’edizione Bruxellis, E
typographia H. Goemaere, 1855, Pars Prior, p. 571).
34. Un esempio significativo è l’insistito gioco etimologico nel sermone cxliii di
Pietro Crisologo (CC Ser. Lat., xxiv B): « Venit ad virginem deus, hoc est, ad opus
suum opifex, creator ad creaturam suam ».
35. Anche se un inventario completo non è mai stato realizzato, risulta utile come
punto di partenza la sezione in PL, ccxix 502-22, In qua alphabetice exhibentur varia no-
mina quibus SS. Patres et Scriptores ecclesiastici B. Mariam vocaverunt.
36. Laude Cortonesi dal secolo XIII al XV, a cura di G. Varanini, L. Banfi e A. Ceru-
ti Burgio, Firenze, Olschki, 1981, vol. i.i. I versi sono cosí spiegati dall’editore: « O
Maria, come ti adornasti (di virtú) e (spiritualmente ti) affinasti (rendendoti) piacen-
te a Dio (tanto) da (poter) ricorrere a lui, sopra i cieli, per trarne una nuova stella ».
37. Laude fiorentine. Il laudario della compagnia di San Gilio, a cura di C. Del Popolo,
Firenze, Olschki, 1990.
30 anna zago
la nova stella, ovviamente in riferimento a Cristo; le occorrenze, seppur in-
teressanti, non riescono comunque a spiegare in modo convincente l’uso
del plurale astrorum nel nostro carme.
38
La correzione Natura, invece, ripristina un nesso piuttosto comune nella
letteratura latina soprattutto medievale: un esempio su tutti è la massima
aristotelica Deus et Natura nihil faciunt frustra (tratta da De caelo, i 4 [271a]), va-
riamente ripresa da San Tommaso nella Summa Theologiae (iii 48 2 3), nel
commento al De caelo et mundo (i 12 4 e i 18 9), ma anche nelle Auctoritates Aris-
totelis (iii 18) e nel Liber Disputationis Petri et Raimundi di Raimondo Lullo (iv
403, CC Cont. Med., lxxviii). Il binomio Natura – Dio assume nella poesia
religiosa una connotazione piú vicina a quella del nostro componimento,
come nel carme In notarium di Ausonio: « Natura munus hoc tibi / Deusque
donum tradidit » (Aus., Ephem., vii 33-34). In questi versi Dio e Natura com-
paiono come un unicum la cui azione è contemporanea e inscindibile, pro-
prio come nel nostro carme la natura parens e il pater optime divum vengono
invocati senza soluzione di continuità; l’azione congiunta di Dio e Natura
torna spesso anche nell’opera di Dante, proprio in riferimento alla massima
aristotelica già citata: si vedano Mon., i 3 3 e i 10 1 (ed. Ricci), o, nella Quae-
stio de aqua et terra, « cum Deus et natura semper faciat et velit quod melius
est » (Quaest., 28, ed. Mazzoni). Tra le non poche occorrenze in Petrarca, si
può citare «“Non bene” ait “sentis”: “Deus hoc Naturaque sanxit / legibus
eternis [. . .]”» (Petr., Afr., i 465-66, ed. Festa).
È evidente che la correzione di matura in Natura presuppone che tutti i te-
stimoni a disposizione siano accomunati da un errore di archetipo che abbia
generato, nei soli S e V, una rubrica evidentemente “fuorviata” da una pri-
ma lettura del verso corrotto. Di contro, la generica rubrica Oratio metrica
tradita da P fa pensare a una sopravvivenza piú fedele almeno della titolatu-
ra nel testimone piú antico.
39
2. cunta movens: si è scelta la grafia “evoluta” cunta, presente nel codice di
38. Lo stesso si può dire di alcuni passi tratti dall’appendice di testi latini che Del
Popolo aggiunge all’edizione delle laude; due sequenze in particolare presentano
l’immagine della Vergine-stella che dà vita a un altro astro, ben piú lucente: « Ange-
lus consilii / natus est de Virgine, / sol de stella; [. . .]. / Sicut sydus radium, / profert
Virgo filium / pari forma » (In nativitate Domini sequentia [app. C, Testi Latini, v] vv. 7-
15); piú semplicemente il secondo componimento: « Genuisti prolem, / novum stel-
la solem / nova genitura » (Sequentia beate Marie virginis [app. C, Testi Latini, xvi] vv.
18-20). Quest’ultima sequenza è compresa anche in Anal. Hymn., vol. 54 num. 216.
39. Non si deve concludere per questo che il titolo originario del componimento
sia quello che compare in P: certamente, però, esso desta minori sospetti di una ap-
posizione a posteriori e conferma indirettamente la ricostruzione della genesi del-
l’errore.
un carme religioso attribuito a petrarca 31
Poppi (S e V danno cuncta) e ordinariamente adottata nelle edizioni delle
opere latine di Petrarca:
40
la semplificazione da -nct- a -nt-, comune già nel
latino tardo,
41
è frequente nelle iscrizioni di tutte le regioni e si afferma de-
cisamente nel latino medievale e umanistico.
3. astrorumqueopifex totumqueemissa: il verso presenta a brevissima distanza
una doppia sinalefe; piú in generale, nell’epigramma troviamo 5 casi di si-
nalefe di -que in 11 versi (due volte al v. 3, una ai vv. 5, 7 e 11). Secondo Ruiz
Arzalluz,
42
esametri di questo tipo « no dejan de sorprender al lector con un
número anormalmente alto de sinalefas de -que y con dos claúsulas del tipo
“armentaque nostra”, cosas ambas que dan qué pensar sobre la paternidad
petrarquesca de los versos ».
43
5-6. luminibusque infunde meis tua sancta tueri / numina, monstriferi delere piacu-
la fati: suscita qualche dubbio l’enclitica -que impiegata senza una reale fun-
zione coordinante. L’unico legame che unisce questi versi è il poliptoto lu-
mina/luminibus, con i due sostantivi intesi in sensi differenti (‘luci’ il primo,
‘occhi’ il secondo), ma la struttura sintattica non è tale da giustificare una co-
ordinazione con -que a introdurre il verbo (infunde) della proposizione prin-
cipale. Piú facile forse pensare al fenomeno del -que pleonastico, assai diffu-
so nel latino non classico. Un caso molto simile al nostro è ad esempio in un
tropo medievale: « Pontifex o Christe qui sanguine tuo nos redemisti / et
pro nobis miseris in cruce pependisti / et a tartaris inferni nos eruisti, / no-
bisque in aeuum pacem tribue ».
44
La costruzione di infundere con completiva, soprattutto all’infinito, è assai
rara nel latino classico; si ritrova nel Sacramentarium Veronense, un testo litur-
gico formatosi tra il V e il VI secolo, erroneamente attribuito a Leone Ma-
gno (di qui Leonianum): « infundis totis tibi mentibus supplicare nec huma-
nis opibus sed tua virtute confidere » (Sacr. Leon. Mense Julio, xvi 27-31); in
40. Si veda a questo proposito la nota dell’editore in F. Petrarca, Le Familiari, Edi-
zione critica per cura di V. Rossi, Firenze, Sansoni, 1933-1942, vol. i pp. clxiv-clxix.
41. A titolo esemplificativo, si rimanda a V. Väänänen, Introduzione al latino volgare,
Bologna, Patron, 1982, par. 116, con le relative indicazioni bibliografiche.
42. Ruiz Arzalluz, El hexámetro de Petrarca, cit., pp. 382-83.
43. Il riferimento è ai casi di eternaque semper (v. 1) e lassataque rumpent (v. 7). Secon-
do lo spoglio di Arzalluz, l’incidenza del fenomeno nelle tre grandi opere esametri-
che di Petrarca è del 3,45% per l’Africa, del 2,97% per il Bucolicum Carmen (con un pic-
co del 6,56% nel x libro) e del 2,02% per le Epistole. Se possiamo considerare rappre-
sentativo un campione di 11 versi, nel nostro caso siamo di fronte a una percentuale
del 9,09%, certo anomala rispetto a quelle sopra riportate.
44. Corpus troporum ii. Prosules de la messe. 1. Tropes de l’alleluia. Edition critique des tex-
tes par O. Marcusson, Stockholm/Sweden, Almqvist & Wiksell International,
1976, num. 36 4, 6-9. L’esempio è citato in P. Stotz, Handbuch zur lateinischen Sprache des
Mittelalters, München, Beck, 1996-2004, x 21.8 (= vol. iv p. 471, in part. n. 257), cui si ri-
manda per approfondimenti e indicazioni bibliografiche.
32 anna zago
due Libri Sacramentorum di VIII secolo (Liber Sacramentorum Engolismensis,
1839 4-5, CC Ser. Lat., clix C = Liber Sacramentorum Gellonensis, 2080 4-5, CC
Ser. Lat., clix): « Infunde sensibus nostris apostolica dogmata retenere ».
Una corruttela può essersi generata anche al v. 6: la clausola piacula fati, pur
non priva di paralleli (come vedremo nel commento), può far pensare a pia-
cula facti, espressione tipica della poesia cristiana per indicare il peccato ori-
ginale. Ne offre un’attestazione un carme di Alcuino: « infandi et gemuit
condigna piacula facti » (Alcuin., Carm., 69 3, MGH Poetae Latini Medii Ae-
vi, i); il nesso ricorre anche nei versi anonimi che precedono l’Adversus Mar-
cionem tertullianeo: « Olim pascha Dei verum quaerentibus agnum, /
ostendit tandem venisse piacula facti, / qui delicta suo multorum sanguine
solvat » (Carmen adversus Marcionitas, ii 112-14). La relativa diffusione della
clausola (che non compare però nel Petrarca latino) non induce tuttavia a
emendare il testo; è da precisare infine che non sono attestati nessi del tipo
monstriferum factum o monstriferum fatum nella letteratura latina a noi nota.
7. Cumque aderit supprema dies [. . .]: a fronte della lacuna in P, che ci tra-
manda il testo solo a partire da dies, V presenta al v. 7 la variante aderis contro
aderit di S. Quest’ultima lezione appare preferibile per evitare di dover in-
tendere supprema dies come un vocativo: tale costruzione, infatti, pur non
essendo impossibile, appesantirebbe il periodo con tre invocazioni diffe-
renti nell’arco di undici versi (due delle quali all’interno della sola subordi-
nata temporale introdotta da cumque).
7-9. lassataque rumpent / stamina fatales rapido revoluta sorores / impetu: le le-
zioni tradite sono rapide di S e rapido di V. Pur essendo entrambe plausibili
dal punto di vista metrico, si è scelta a testo la lezione di V per due ragioni:
l’ablativo impetu, privato di una specificazione, risulterebbe poco “armoniz-
zato” nel sintagma di riferimento (poiché a stamina revoluta sarebbero riferi-
ti due complementi di modo espressi in forme diverse); la lezione rapido, i-
noltre, consente di conservare l’enjambement, fenomeno che percorre tut-
ta la seconda parte dell’epigramma (a partire dai vv. 5-6 e 6-7) e che trova
qui naturale continuazione.
11. digneris piceis animamque avertere flammis: il testo di V presenta al v. 11 la
lezione annectere, da scartare non solo per la concordanza di S e P in avertere,
ma per il problema di senso che verrebbe a creare. L’errore non è inspiega-
bile da un punto di vista paleografico: gli scambi r/c e u/n (o anche uno solo
di questi) possono aver generato anectere da auertere, con successivo ripristino
di nn.
4. commento
1. O superum Natura parens: la natura è definita già da Plinio « parens illa ac
divina rerum artifex» (Nat. Hist., xxii 117). Il nesso natura parens è piuttosto
un carme religioso attribuito a petrarca 33
comune: « sic iussit natura parens discurrere Nilum / sic opus est mundo »
in Lucano (x 238-39); « veterem qua lege tumultum / discrevit natura pa-
rens » in Claudiano (De raptu, i 249-50); « quo nihil maius parens / Natura
gemuit » nell’Octavia ([Sen.], Oct., 385-86). Un’invocazione molto simile è
sempre in Seneca, in un brano per certi aspetti vicino ai nostri versi: « O ma-
gna parens, Natura, deum / tuque igniferi rector Olympi, / qui sparsa cito
sidera mundo / cursusque vagos rapis astrorum / celerique polos cardine
versas » (Sen., Phaedr., 959-63). L’idea della natura madre che tutto governa è
espressa con un lessico assai simile nella poesia cristiana, come vediamo in
Prospero d’Aquitania: « Natura omnipotens una est, quae cuncta creavit »
(Prosp., Epigr., 55 1, PL, li col. 514C)
45
, ma anche con una certa frequenza
nell’Anticlaudianus di Alano (vi 45; vii 40 e viii 201) o nell’Architrenius di Gio-
vanni di Hauvilla (i 226). Alcune occorrenze pertinenti anche in Petrarca,
come la « natura parens optima » di Rem., i 57 4 (ed. Carraud), o « stat ter-
minus evi, / quem fixit natura parens » (Ep., ii 14 290-91, ed. Schönberger).
2. cunta movens: sulla posizione di rilievo del nesso si è già detto nelle note
relative alla traduzione. Un procedimento analogo è operato nell’epistola
metrica per Luchino Visconti, in una descrizione della città di Roma: « [. . .]
validoque ingens stat poplite Roma / cunta movens rerumque caput »
(Petr., Ep., ii 11 47-48, ed. Schönberger);
46
sempre nelle Epistole metriche
troviamo un passo che ricorda da vicino il nostro componimento: « Alme
parens solus qui cunta gubernas » (Ep., i 2 8, ed. Schönberger). In riferi-
mento alla divinità, il nesso è assai frequente nella poesia latina, soprattutto
cristiana: « cuncta movens secum momenta et pondera rerum » in Venan-
zio Fortunato (vii 12 5); insieme all’epiteto opifex in Paolino di Nola (« Sic
Deus omnisonae modulator et arbiter unus / Harmoniae, per cuncta mo-
vet quam corpora rerum, / et naturae opifex Deus omnis, et artis » in Carm.,
45. Proprio a questo verso fa riferimento Pietro da Parma per “difendere” l’epiteto
omnipotens riferito alla Natura in Afr., i 132, iunctura che non piaceva a Coluccio Salu-
tati. Si veda a questo proposito V. Fera, Antichi editori e lettori dell’Africa, Messina,
Centro di Studi Umanistici, 1984, pp. 50-51 e 122. La menzione di questi autori apre la
complessa questione del rapporto fra Petrarca e la poesia d’ispirazione cristiana. An-
che se la sua analisi è limitata ai nomi “canonici”, va ricordato quanto scrive Velli (la
sua constatazione si può estendere anche a poesia di incerta attribuzione come la no-
stra): « Quello che comunque importa rilevare è che manca ogni serio tentativo di
cogliere il senso della poesia cristiana, di vedere come si attua in essa il rapporto for-
ma/contenuto. I pur diversi Prudenzio, Sedulio e Prospero sono semplicemente rac-
colti in un’indifferenziata categoria esemplare » (G. Velli, Petrarca e i poeti cristiani, in
« Studi petrarcheschi », a. vi 1989, pp. 171-78).
46. Una predicazione analoga, sempre in apertura di verso, si ritrova in un’invo-
cazione della Canzone alla Vergine: « Vergine d’alti sensi, / tu vedi il tutto, [. . .] »
(Petr., Rvf, 366 100-1, ed. Santagata).
34 anna zago
27 79-81, PL, lxi coll. 650 A-B). Un’invocazione piú articolata è in Boezio
(« O qui perpetua mundum ratione gubernas, / terrarum caelique sator,
qui tempus ab aevo / ire iubes stabilisque manens das cuncta moveri » in
Cons., iii 9 1-3). pereuntia secula: nella traduzione abbiamo reso pereuntia se-
cula come ‘stirpi mortali’: l’alternativa è il piú letterale, da un punto di vista
romanzo, ‘secoli destinati a perire’. Rifacendosi a uno studio di Stadtmül-
ler,
47
lo Stotz delinea l’evoluzione del termine con particolare attenzione
all’età medievale: dall’originario ‘stirpe, discendenza, generazione’ il termi-
ne subisce nel latino cristiano, come aiòn nel greco biblico, lo slittamento
verso il significato di ‘mondo terreno’.
48
Il plurale ha invece un’evoluzione
in un certo senso indipendente: saecula è inteso nel senso di ‘tempi, scorrere
dei tempi’, uso che prevale per tutta l’epoca medievale, anche cristallizzato
in Schlußformeln come in saecula saeculorum. Nel nostro caso, l’impressione di
“classicità” che questo epigramma vuole comunicare fa propendere per
un’accezione piú comune nel latino pre-cristiano, quella di ‘generazione,
stirpe’. A confermare questa impressione concorre inoltre la specificazione
mundi, che verrebbe a creare ridondanza se saecula fosse letto nel senso di ‘vi-
cende mondane’. Il nesso si ritrova in un poema di Bernardo di Cluny:
« Qui tua nuncia per pereuntia secula clament » (De contemptu mundi, iii
697); in riferimento a Maria, salvezza per « il mondo destinato a perire », un
singolare riscontro è in una delle sequenze raggruppate sotto il nome di
Adamo di San Vittore: « Peperisti medicinam, / non humanam, sed divi-
nam, / pereunti saeculo » (lxxv 7-9). Per quanto concerne la produzione la-
tina del Petrarca, notevole la somiglianza del v. 2 con l’esordio dell’epistola
metrica Ad seipsum, componimento che anche in altri punti presenta qual-
che affinità con l’oggetto del nostro studio: « Video pereuntis tempora
mundi / precipiti transire fuga » (Petr., Ep., i 14 2-3, ed. Schönberger).
secula mundi: la clausola si ritrova nella traduzione dei Phaenomena aratei di
Germanico (« Aurea pacati regeres cum saecula mundi, / Iustitia inviolata
malis, placidissima virgo » Germ. Arat., Phaen., 103-4): la destinataria del-
l’invocazione in questo passo è la Giustizia, regina degli aurea saecula: l’inte-
ro contesto, però, si presta con facilità a una re-interpretazione in favore di
un’altra divinità. Piú in generale, la clausola s(a)ecula mundi è piuttosto diffu-
sa in tutta la poesia esametrica: ne troviamo esempi ancora in Venanzio
Fortunato (« Ecce caduca volant praesentia saecula mundi » iv 24 3) e Pro-
spero (Provid., 417, PL, li col. 625C). Anche Petrarca utilizza quest’espressio-
ne, sempre in clausola, nel discorso di Ennio nel ix libro dell’Africa; qui il
nesso assume un valore temporale: « Tempore crescet honos perque ultima
secula mundi / clarus eris. [. . .] » (Petr., Afr., ix 43-44, ed. Festa).
47. G. Stadtmüller, Saeculum, in « Saeculum », a. ii 1951, pp. 152-56.
48. Stotz, Handbuch zur lateinischen Sprache des Mittelalters, cit., v 3.3 (= vol. ii p. 9).
un carme religioso attribuito a petrarca 35
3. astrorumque opifex: sulla rarità del nesso abbiamo già detto nelle note al
testo. Espressioni simili sono comunque piuttosto frequenti nella poesia
cristiana: significative le occorrenze « rex, opifex rerum, hominumque re-
demptor et auctor / salvator Christus » (Alcuin., Carm., lxva v 20-21,
MGH Poetae Latini Medii Aevi, i) e « Ipse opifex mundi, terram mare sidera
fecit » (Prud., Hamart., 116, CC Ser. Lat., cxxvi). Nella produzione latina di
Petrarca non mancano epiteti di questo genere, sempre riferiti a Dio e va-
riamente declinati: « opificem illum solis ac lune » (Rem., i 40 6, ed. Car-
raud); « astrorum creator ac regnator » (Rem., i 112 36, ed. Carraud); « crea-
tor solis et siderum rerumque omnium » (Vit. Sol., ii 2 4, ed. Carraud);
« unum omnipotentem, omnia creantem, omnia regentem, opificem re-
rum Deum » (Inv. med., iii 1 10, ed. Bausi); sotto forma di invocazione come
« o celi regnator, o creator temporum, o siderum moderator » (Petr., Sen., i
3 15, ed. Rizzo). Piú raro trovare qualifiche simili riferite alla natura:
49
un
esempio è « optima quondam / rerum opifex natura » in Sidonio Apollina-
re (Carm., vii 140-41); in Petrarca invece la natura è definita « mater » in due
passi del Rem. (ii 83 73 e ii 93 10, ed. Carraud).
4. lumina . . . lustrantia terras: il verso richiama nessi piuttosto comuni nella
poesia latina dall’epoca classica a quella tardoantica, ad esempio in un passo
di Silio Italico: « Dum caelum rapida stellas vertigine volvet, / lunaque fra-
terno lustrabit lumine terras » (Sil. It., Pun., viii 173-74).
50
Un parallelo tan-
to significativo quanto difficile da valutare è negli esametri che precedono
il nostro componimento nel codice P (si veda a questo proposito la n. 13): a
c. 74r, col. 2 rr. 18-20 leggiamo « totumque per orbem / sparserat et gelidas
lustrantia lumina terras ». La somiglianza delle strutture e del lessico (totum-
que per orbem sparserat e totumque . . . per orbem . . . diffundens; gelidas lustrantia lu-
mina terras e lumina . . . patulas lustrantia terras) e il ricorrere di alcuni sintagmi
49. Si veda a questo proposito la trattazione di P. Dronke, Intellectuals and poets in
medieval Europe, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1992, pp. 41-61 (già in « Jour-
nal of the Warburg and Courtauld Institutes », a. xliii 1980, pp. 16-31).
50. Non si può non accennare in questa sede alla nota questione riassunta da Mar-
tellotti in uno studio significativamente intitolato Petrarca e Silio Italico. Un confronto im-
possibile, che cosí esordisce: « Le Puniche di Silio Italico furono scoperte da Poggio
Bracciolini durante il Concilio di Costanza (1414-1418), e il Petrarca non le conobbe;
se avesse potuto leggerle [. . .], probabilmente non avrebbe scritto la sua Africa, evi-
tando di mettersi in una gara troppo diretta con un antico » (G. Martellotti, Petrar-
ca e Silio Italico. Un confronto impossibile, in Miscellanea Augusto Campana, Padova, Ante-
nore, 1981, vol. ii pp. 489-503). A questo proposito si vedano inoltre C. Santini, Ulte-
riori accertamenti sull’ipotesi di raffronto tra Silio e Petrarca, in Preveggenze umanistiche di Pe-
trarca. Atti delle giornate petrarchesche di Tor Vergata (Roma/Cortona, 1-2 giugno
1992), Pisa, ETS, 1993; G. Brugnoli-C. Santini, L’ ‘Additamentum Aldinum’ di Silio Ita-
lico, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1995 (in part. pp. 55-98); L. Cassata, Si-
lio Italico in Petrarca, in « Filologia antica e moderna », a. xv 1998, pp. 55-97.
36 anna zago
(totumque per orbem, lumina lustrantia terras) potrebbero portarci a ipotizzare,
pur con la debita prudenza, un legame assai stretto (forse il medesimo au-
tore?) tra i componimenti anonimi del codice di Poppi.
5-6. luminibusque infunde meis tua sancta tueri / numina: richiama la nostra at-
tenzione il poliptoto fra i vv. 4 e 5, sottolineato dalla posizione a inizio di
verso e dalla presenza dei due composti di fundo (lumina diffundens / lumini-
busque infunde). Locuzioni con infundo + dativo sono presenti anche nel Pe-
trarca latino: con oculis si possono citare « ita se oculis fidelium divine lucis
radii infundunt » (Ot., i 4 195, ed. Goletti) e « oculis se se infundens fulgida
veritas » (Fam., xxii 10 7, ed. Rossi). L’uso di lumina come ‘occhi’ è assai ben
attestato nella letteratura latina di ogni età, ma in quella cristiana in partico-
lare compare nelle narrazioni del miracolo di Gesú che ridona la vista al cie-
co, riferimento che potrebbe essere sotteso anche all’invocazione del no-
stro epigramma: alcuni esempi in Arnobio (« Incessum ille claudis dedit, vi-
sum luminibus caecis » in Adv. nat., i 50 7) e in Prudenzio (« perennibus te-
nebris iam sepulta lumina » in Cath., ix 34, CC Ser. Lat., cxxvi). Colpisce il
medesimo uso di infundere proprio con luminibus in un passo di Stazio, un’in-
vocazione al Sonno: « Inde veni! Nec te totas infundere pennas / luminibus
compello meis » (Stat., Silv., v 4 17-18).
51
6. numina monstriferi: il nesso monstriferi fati, di sapore decisamente “classi-
co”, presenta un parallelo in un passo assai simile di Claudiano, ove ritro-
viamo l’uso di numina in enjambement seguito dall’aggettivo monstrifer che in-
troduce una nuova proposizione: « Procul inportuna fugantur / numina,
monstriferis quae Tartarus edidit antris: [. . .] » (Claud., De consul. Stilich., ii
109-10).
52
piacula fati: il termine piacula indica qui i dolori della vita terre-
na e le sofferenze del mondo, in opposizione alla beatitudine sperata dopo
la morte. La clausola con fati non ha antecedenti notevoli per il nostro car-
me: si ritrova soltanto in Valerio Flacco (« urgentis post saeva piacula fati »
Argon., iv 252) e in un carme epigrafico (« cur me perdideris, expende piacu-
la fati » Carm. Lat. Epigr., 1178A 5).
7. supprema dies: il nesso è già in Lucano: « occurrit suprema dies, natura-
51. Va ricordato che all’altezza cronologica cui si colloca il nostro componimento le
Silvae con ogni probabilità non erano conosciute: si veda a questo proposito P. de
Nolhac, Pétrarque et l’humanisme, nouvelle édition, remaniée et augmentée, Paris,
Champion, 1965 (prima ed. Paris, Bouillon, 1892), p. 198.
52. Per la lettura che Petrarca fece di Claudiano un punto di riferimento è il lavoro
di de Nolhac, Pétrarque et l’humanisme, cit., in part. vol. i pp. 202-4; piú recentemente
si è occupata della questione L. Chines, Per Petrarca e Claudiano, in Verso il Centenario.
Atti del seminario di Bologna (24-25 settembre 2001), a cura di L. Chines e P. Vecchi
Galli, in « Quaderni petrarcheschi », a. xi 2001, pp. 43-72 (con un ricco inventario di
fonti e di passi paralleli). Ulteriori elementi in M. Fiorilla, Marginalia figurati nei codi-
ci di Petrarca, Firenze, Olschki, 2005, passim (ma si vedano in part. pp. 67-73).
un carme religioso attribuito a petrarca 37
que solum / hunc potuit finem vaesano ponere regi » (Bell. Civ., x 41-42).
L’idea del giorno supremo torna ricorrente nell’innologia cristiana (cfr.
Anal. Hymn., vol. 50 num. 73 vv. 21-22), ma anche nella produzione latina di
Petrarca: dalla sententia dell’Africa « plus homines suprema dies quam cete-
ra terret » (Afr., iv 11, ed. Festa) alla descrizione ben piú patetica, in parte
simile a quella del nostro componimento,
53
nell’epistola metrica Ad ami-
cum transalpinum: « Post ubi longaevo finem factura labori / affuerit supre-
ma dies, solamen et ipsum / mortis erit, tanti in gremio lachrymantis ami-
ci / lassatum posuisse caput, manibusque sepulchro / invectum iacuisse
piis: [. . .] » (Petr., Ep., iii 27 87-91, ed. Schönberger). lassataque. . . stami-
na: l’uso di stamen con riferimento al mito delle Parche è assai comune nel
Petrarca latino, e in particolare un passo del primo libro dell’Africa si presta
a un confronto con i nostri versi. In esso si descrive la rapidità delle Parche:
« Nondum plena colis iam stamina nostra Sorores / destituunt fesse, iam
Mors sua signa relinquit » (Petr., Afr., i 239-40, ed. Festa). I due passi pre-
sentano una trama di consonanze lessicali: i lassata stamina sono qui plena,
mentre l’aggettivo si “sposta” alle Sorores fesse; l’idea della rapidità, chiara-
mente espressa da rapido impetu, è qui veicolata dall’iterazione di iam e da
nondum. Altrettanto notevole è l’eco di un verso dell’epistola metrica Ad
seipsum, già incontrata altrove: « staminaque immites properant abrumpere
Parce » (Petr., Ep., i 14 25, ed. Schönberger). Una delle molte possibili re-
miniscenze classiche è presente in una delle Familiari, indirizzata a Carlo
IV di Boemia. Qui Petrarca inserisce, dopo una prima citazione da Stazio,
un secondo passo tratto da Theb., vii 774-75: « Et eundem: Immites scis nulla
revolvere Parcas / stamina? » (Petr., Fam., xxiii 2 13, ed. Rossi).
54
Da notare la
presenza del nesso revolvere stamina (cfr. revoluta stamina al v. 8), anche se con
un senso completamente diverso: in questo contesto significa ‘svolgere al-
l’indietro, in senso contrario’, prolungando e idealmente raddoppiando il
corso della vita. I termini in cui è descritto il lavoro delle Parche ritornano
anche in Lucano (« vix operi cunctae dextra properante sorores / suffi-
ciunt, lassant rumpentis stamina Parcas » in Bell. Civ., iii 13-14): colpisce in
questo caso soprattutto l’uso di lassare immediatamente accostato a rumpere
stamina (nello stesso ordine sono impiegati i tre termini nel nostro compo-
nimento). fatales. . . sorores: il nesso è presente nell’Anth. Lat., 792 Riese
(« Tres sunt fatales quae ducunt fila sorores: / Clotho colum baiulat, La-
chesis trahit, Atropos occat »), distico ripreso con minime variazioni nel
53. Numerosi i richiami presenti nel nostro testo: l’immagine della suprema dies, lon-
gaevo finem factura labori, che è risolta nel nostro componimento con lassataque rumpent
stamina; l’uso di adsum (affuerit v. 88 – aderit v. 7 del nostro epigramma); l’aggettivo las-
satum al v. 9 (lassata v. 7); il longaevus labor del v. 87 contro i dispendia vite del v. 9.
54. La fortuna di Stazio all’epoca di Petrarca è delineata sempre in de Nolhac, Pé-
trarque et l’humanisme, cit. (in part. vol. i pp. 196-202).
38 anna zago
Graecismus di Eberardo di Béthune: « Tres quoque fatales quae ducunt fila
sorores, / Clotho colum portat, Lachesis trahit, Atropos occat » (vii 44-
45).
55
L’epiteto fatales ha una certa diffusione, come testimonia Nigello di
Longchamp (« Ibant tres hominum curas relevare sorores / quas nos fata-
les dicimus esse deas » in Speculum Stultorum, 3215-16), fino a divenire pro-
verbiale (Walther, num. 2879b).
56
Le sorores compaiono anche nei Rerum
vulgarium fragmenta, sempre con la caratterizzazione della crudele rapidità
(sí repente. . . troncaste come rumpent. . . rapido impetu): « Invide Parche, sí re-
pente il fuso / troncaste, ch’attorcea soave et chiaro / stame al mio laccio,
[. . .] » (Petr., Rvf, 296 5-7, ed. Santagata).
8-9. rapido revoluta sorores / impetu: la metafora della vita come stamen filato
con rapidità dalle Parche rientra nella ricca galleria di immagini topiche,
usate tra gli altri anche da Petrarca per designare lo scorrere degli anni; in
una Senile indirizzata a Guido Sette (proprio sul tema de mutatione temporum)
troviamo una metafora ancor piú icastica, quella del tempo quale grande
ruota, rapido acta impetu proprio come gli stamina del nostro epigramma:
« neque enim minus, rapido acta impetu, rota ingens volvitur quod formica
interim per illam segnis incedit » (Petr., Sen., x 2 48, ed. Nota).
9. dispendia vite: la tematica dei dispendia vitae considerati come perdite o
danni da riparare in prossimità della morte è topica nella poesia cristiana an-
tica, ma soprattutto medievale. Il nesso ricorre ad esempio negli Anal.
Hymn., vol. 25 num. 66 (In 3. Nocturno, Responsoria): « Ut post huius / vitae
dispendia / Tecum sempre / fruamur gloria »; nella Visio Wettini di Walafri-
do Strabone, in riferimento alle sofferenze prese su di sé da Cristo: « con-
grediens huius sumpsit dispendia vitae » (Walahfr. Strab., Vis Wett., 808);
in Matteo di Vendôme: « Fructus amicitiae redimit dispendia vitae » (To-
bias, 817); in un poemetto agiografico di Ildeberto di Lavardin: « Suppleo
preterite scelus et dispendia vite » (Hild. Cenom., Vita Beate Marie Egiptiace,
631, CC Cont. Med., ccix).
57
La clausola si ritrova anche in un altro poema
noto al Petrarca, e per di piú in un contesto in cui compare la Natura: « Ne-
scit, ut humanae redimat dispendia vitae, / quam modicum Natura petat:
producere vitam / sola Ceres Nereusque potest » (Ioh. Hauv., Architr., ii
55. Anche il secondo verso del distico sembra essere passato in proverbio, come si
verifica in Walther, num. 2943.
56. Cfr. inoltre Myth. Vaticani, i 109 (De tribus fatis) e ii 22 (De parcis Plutonis), in CC
Ser. Lat., xci C.
57. Ildeberto era noto anche a Petrarca, come testimonia un passo della Collatio lau-
reationis. Nell’elogiare le virtú dell’alloro, il poeta cita (con una leggera variazione) il
primo verso del poemetto di Ildeberto: « Secunda de tribus proprietatibus, ultima,
est arboris huius eterna viriditas, de qua non ineleganter ait quidam: Sicut hiems lau-
rum non ledit, nec rogus aurum» (Coll. Laur., 16, ed. Godi).
58. Che Petrarca conoscesse il poema è dimostrato da questo sprezzante giudizio,
un carme religioso attribuito a petrarca 39
180-83).
58
Presenta invece una piú fitta trama di consonanze un passo della
commedia elegiaca Rapularius: « O deus omnipotens, qui solus cuncta crea-
sti, / [. . .] / te rogo, summe deus, qui cuncta creata gubernas, / ne solita pri-
ves me pietate tua. / [. . .] / Hactenus huc misere patior dispendia vite, / de-
precor ergo, deus, amodo verte vices! » (Rapularius, ii 31-40).
59
Pochi sono
però i paralleli che si possono individuare per l’uso di dispendia nell’idea di
cammino, percorso lungo e difficile, veicolata dal verbo peragere; un’imma-
gine di questo tipo è in un passo di Alano: « gressum / aggreditur, superat-
que viae dispendia gressu » (Alan., Anticlaud., vii 403-4).
60
10. angelicis sociare choris: se non stupisce la frequenza del nesso angelicus
c(h)orus nella produzione cristiana, l’idea di entrare a far parte delle schiere
degli angeli come sinonimo di beatitudine risulta in realtà poco comune.
Un’attestazione molto simile è in un’opera teologico-didattica di Smarag-
do: « Novit ad aeternum monachos perducere regnum, / et sociare choro
dulciter angelico » (Smarag., Comm. in regulam Sancti Benedicti, Praef., 38-39,
PL, cii col. 690 B); un’occorrenza è anche nel Corpus orationum, in un com-
ponimento tradito da codici di IX e X secolo « [. . .] ut, sicut hic eum vera fi-
des iunxit fidelium turmis, ita eum illic tua miseratio societ angelicis cho-
ris » (CC Ser. Lat., clxc 2613 4-5); infine negli Anal. Hymn., vol. 11 num. 185
vv. 15-16: « ut sociemur angelicis choris / ejus amore ». Interessante quanto
difficile da valutare è inoltre il parallelo che ritroviamo in un carme di Alfa-
no in laudem monachorum Casinensium, dove è Maria a fungere da “interme-
diaria” fra le anime e i cori angelici del regno eterno: « Regis aeterni Virgo
mater excipit / et statim choris sociat angelicis » (Alfanus, Carm., 39 49-50).
pater optime divum: la clausola, evidentemente una ripresa classica, è presen-
te con una leggera variazione in Stazio, nel celebre episodio di Capaneo:
« Ille vocat. Nunc tempus erat, sator optime divom! » (Stat., Theb., xi 248).
Un’attestazione piú antica però è già in Lucilio (« nemo sit nostrum, quin
aut pater optimus divum / aut Neptunus pater, Liber, Saturnus pater, Mars,
/ Ianus, Quirinus pater siet ac dicatur ad unum » Sat. Frag., 20-22, p. 4 ed.
Marx), citato da Lattanzio (Div. Inst., iv 3 12). Inoltre i versi di Aen., i 65-66
« namque tibi divum pater atque hominum rex / et mulcere dedit fluctus et
in cui viene incluso anche Alano di Lilla: « Quid sibi igitur vult Gallus? An non videt
quid alienigene quoque de se ipsis et de nostris senserint? Sufficiat sibi Anticlaudianus
Alani sui, paulo minus tediosus Architrenio. Poete ambo barbarici multum pariter se
diffundunt, multum frustra se torquent, mirum nisi etiam multum sudent » (Petr.,
Inv. mal., 253, ed. Berté).
59. Nella stessa opera, qualche verso prima, si legge: « Ut sibi protelet misere dis-
pendia vite » (Rapularius, ii 11).
60. Colpisce la relativa frequenza del nesso dispendia vi(a)e, che in effetti potrebbe
adattarsi (anche se non metricamente) al nostro testo, per un ulteriore sviluppo del-
l’idea di vita come cammino.
40 anna zago
tollere vento »,
61
citati tra l’altro in Macrobio (Sat., v 4 1), sono ripresi in Fam.,
xii 11 2 (ed. Rossi). L’invocazione al pater optimum, infine, sembra topica in
Petrarca: tra le altre, « Te fatum tacuisse meum, pater optime, miror » (Afr.,
ii 535, ed. Festa); « o michi luce / carior, atque ideo multum, pater optime,
frustra / exoptate, veni » (Ep., i 4 111-13, ed. Schönberger).
11. digneris. . . avertere: per l’uso di dignor, qui in congiuntivo esortativo, si ve-
da il passo dell’Oratio quotidiana citato in relazione a supprema dies del v. 7.
piceis flammis: il nesso è assai poco attestato e generalmente è impiegato in
senso concreto, come nell’Ylias di Giuseppe di Exeter: « [. . .]. Surgentia pas-
sim / exalant piceas incensa piralia flammas » (Iosephus Iscanus, Ylias, i
506-7).
62
Un uso in ambito religioso è in Anal. Hymn., vol. 55 num. 234 vv. 31-
32: « Caesa, / flammis usta piceis », in una sequenza ritmica De sancta Marga-
reta. animamque avertere flammis: il nesso richiama forse un passo della Far-
salia, dove la preghiera di Corso esprime il timore che la sepoltura non sia
abbastanza onorevole per il morto: « manes animamque potentem / offi-
ciis averte meis » (viii 762-63). L’estrema richiesta di salvare l’anima dalle
fiamme infernali ci offre forse un richiamo all’invocazione che conclude
l’Africa. I versi di apostrofe all’opera stessa costituiscono probabilmente il
parallelo piú significativo che si possa istituire tra il nostro epigramma e la
produzione latina del Petrarca. Le due invocazioni presentano singolari
analogie lessicali (oltre al nesso avellere flammis, corrispondente ad avertere
flammis al v. 11, si confrontino fata, rapidosque dies, secula, e piú in generale l’in-
tonazione solenne e partecipe di entrambe le preghiere): « Si iuvenem iu-
veni mediis avellere flammis / contigit incolumem tumidasque efferre per
undas, / per te ipsam iam facta senex, precor, ista cavere / post mea fata ve-
lis, quodque omnia proterit unum / tempus edax rapidosque dies solem-
que vorantem / secula et Invidie tristes contemnere morsus » (Petr., Afr., ix
478-83, ed. Festa).
63
*
Il carme religioso O superum natura parens, già pubblicato nel 1976 sulla
base di un solo manoscritto (Venezia, Biblioteca del Civico Museo Cor-
rer, Morosini-Grimani 46), viene qui riedito con l’aggiunta di due nuovi
61. Virgilio utilizza qui uno stilema enniano: « Tum cum corde suo divom pater at-
que hominum rex / effatur » (Enn., Ann., vi xviii, ed. Skutsch).
62. Giuseppe di Exeter fu probabile modello anche per Petrarca: si veda a questo
proposito G. Velli, Note Ermeneutiche a Petrarca, in « Studi Petrarcheschi », a. xxi 2008,
pp. 219-24.
63. Su questi versi cfr. Fera, La revisione petrarchesca dell’Africa, cit., pp. 459-60, in par-
ticolare per le varianti del v. 483.
un carme religioso attribuito a petrarca 41
testimoni (Siviglia, Biblioteca Capitular y Colombina, 5 3 27; Poppi, Bi-
blioteca Comunale Rilliana, 31). A uno studio essenziale dei tre codici,
due dei quali recano l’attribuzione a Petrarca, segue l’edizione degli undi-
ci esametri e la discussione dei principali problemi testuali ed esegetici del
carme; si fornisce infine un breve commento, in cui si evidenziano le af-
finità con testi latini medievali e opere di sicura paternità petrarchesca. La
contestualizzazione storica e culturale sembra indicare un esercizio scola-
stico composto in pieno Trecento in un ambiente universitario dell’Italia
Settentrionale; mancano invece elementi probanti per attribuire a Petrar-
ca i versi in questione.
The religious poem ‘O superum natura parens’, published in 1976 on the basis of
a single manuscript (Venice, Biblioteca del Civico Museo Correr, Morosini-Grimani
46), is republished here together with two new witnesses (Siviglia, Biblioteca Capi-
tular y Colombina, 5 3 27; Poppi, Biblioteca Comunale Rilliana, 31). A concise
study of the three manuscripts (two of them attributed to Petrarch) is followed by the
edition of the eleven hexameters and by a discussion of the main textual and exegetic
questions. A short comment follows which underlines some affinities with Medieval
Latin texts and with works by Petrarch. The historical and cultural background
strengthens the opinion that this poem can be considered a school exercise written in a
northern Italy university in the fourteenth century.
42 anna zago