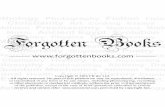Petrarca, Buc. carm. VI: Pastorum pathos
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Petrarca, Buc. carm. VI: Pastorum pathos
L’egloga1 la si dà comunemente come scritta entro il 17 novembre 1347, e cioè pri-ma della partenza di Petrarca per l’Italia, incaricato da papa Clemente VI di una mis-sione presso Mastino della Scala, il signore di Verona2. La data, però, va abbassata ve-risimilmente agli anni conclusivi del papato di Clemente, morto nel dicembre 1352.Ciò innanzitutto per ragioni ex silentio che hanno, nel caso, gran peso: non c’è trac-cia, infatti, del tentativo di Cola che si sviluppò nella seconda metà del ’47 e che tan-to da vicino ha toccato Petrarca, mentre, dall’altra parte, l’affidamento della missioneveronese e, il 29 ottobre dell’anno precedente, l’importante nomina a canonico del-la cattedrale di Parma testimoniano di rapporti ancora buoni con il papa. L’eglogainoltre riprende, seppur in forme indirette, il tema di un possibile ritorno del papatoa Roma, che al tempo di Cola anche Petrarca, pour cause, aveva messo in ombra, sì daspostare l’egloga, semmai, verso le due lettere, Fam. XI, 16 e 17, indirizzate nel 1351alla commissione cardinalizia incaricata di porre mano alla riforma del governo diRoma: ma soprattutto mostra evidenti punti di contatto con le lettere Sine nomine chesviluppano una violenta polemica proprio contro Clemente, a partire dalla 5 (1° apri-le 1352); la 6, dell’ultimo giorno di marzo dello stesso anno; la 8 (inverno 1351-1352); la 9 e la 10 (fine 1351); la 11 (inizio 1352); la 13 (aprile 1352), e infine la 12,scritta subito dopo l’elezione del successore di Clemente, Innocenzo VI, il 18 dicem-bre 13523. In quest’ultima si ripetono i giudizi sul precedente papa, e insieme si di-pinge il nuovo come suo degno successore, fatto della medesima pasta: «Eripuisti [Id-dio] nos iugo gravi et pessimo et obsceno. Quid nobis ex eodem stipite iugum im-portabile reimponis», proprio come il personaggio di Panfilo (san Pietro) dichiaranell’egloga, v. 170, ripetendo lo stesso giudizio di fondo: «Quem talem, nisi te geni-tum fortasse, minaris?»4. Ma in questo passo, per la verità, non tutto è chiaro, e unabreve sosta è necessaria.
Come ho accennato sopra, l’egloga sembra scritta negli anni 1351-1352, mentre ivv. 166-169, che mettono in bocca a Mizione (Clemente VI) la profezia della sua vi-
341
ENRICO FENZI
Note di lettura all’egloga di Petrarca «Pastorum pathos» (Buc. Carm.VI)
cina morte, avvenuta il 6 dicembre 1352, sarebbero stati inseriti dopo l’insediamentodel successore, Innocenzo VI, avvenuto il 18 dello stesso mese:
MitioSuccedet michi forte aliquis, nec longius hinc iam(augurio nisi fallor) abest, qui tristis inersquemitia preduris excuset facta repulsis,alvernasque ferat Romana in pascua sordes5.
Ora, l’inserzione riguarda precisamente l’intervento di Mizione, che è certamen-te post factum ma che conferma la data proposta perché riporta a un tempo non trop-po lontano dalla morte del papa («nec longius hinc iam […] abest»). C’è tuttavia unasfasatura tra questi versi e la risposta che ad essi dà Panfilo. Riassumendo, Mizionevuole ironicamente consolare Panfilo e, fedele al suo personaggio e coerente con tut-ta la sua filosofia e il suo stile argomentativo, in sostanza gli dice: ‘non ti agitare trop-po, ché tra non molto avrò un successore che mi sarà opposto in tutto, e semmai as-somiglierà a te, triste e inerte e troppo duro verso i peccati veniali, miei (di Mitio: mi-tia facta), ma anche dei cardinali, e che, infine, porterà nella Curia la grettezza e losquallore del suo paese d’origine’. Sin qui la diagnosi è perfetta: tutte le fonti sonoconcordi nel segnare un salto di questo genere tra il fastoso Clemente VI e il ‘triste eduro’ Innocenzo VI, che tra l’altro suscitò l’immediato malumore dei cardinali per lesue collere moralizzatrici6. Ma proprio per questo la risposta di Panfilo suona strana,perché non coglie in alcun modo l’esatta previsione di Mizione che caratterizza il pa-pato del successore come assai diverso dal suo, ma suppone invece qualcosa del tipo:*‘io morirò fra non molto, e avrò un successore che sarà peggiore ma non diverso dame’. Solo così, infatti, si spiegano le parole di Panfilo, il quale dà per scontato che ilsuccessore di Clemente VI sia semplicemente uno ex eodem stipite, diremmo7, cioè unoche semplicemente ne aggrava i vizi e i difetti, le cui colpe non saranno quindi d’al-tra natura rispetto a quelle che già ora sono le sue. Insomma, per concludere sul pun-to, mi sembra che il testo porti i segni di una sutura non perfetta tra le parole di Mi-zione e quelle di Panfilo, e che si possa essere sicuri che effettivamente i vv. 166-169siano il frutto di una rielaborazione avvenuta dopo l’elezione al papato di StefanoAubert, in un momento in cui era possibile darne un primo giudizio complessivo.Resta, come sempre, qualcosa. In particolare, non mi spiego quell’aggettivo ‘alvernia-te’ (alvernas sordes), quando l’Aubert era limosino, di Beyssac, nel dipartimento dellaCorrèze, e Petrarca, che tra l’altro l’aveva conosciuto cardinale, avrebbe dovuto sa-perlo. E sarà invece da osservare che tutto sommato il giudizio sul nuovo papa cor-risponde a quello che Petrarca darà più tardi, nel 1359, nell’ultima delle Sine nomine,la 19, diretta al Nelli e contenente un’esortazione all’imperatore Carlo IV affinché ri-porti la sede papale a Roma: «Pastorem illum et senio et sopore et mero gravidumnunquam sponte latebris et amatis fornicibus egressurum solus manu prehensum etverbis increpitum et verberibus castigatum in antiquum penetrale restitues»8, mentreva anche detto che Innocenzo VI fu il papa con il quale Petrarca ebbe una particola-
ENRICO FENZI
342
re e personale incompatibilità, sin da quando l’Aubert, ancora cardinale, si era acco-dato a chi aveva accusato il poeta di necromanzia, e che non la superò mai del tutto,a dispetto dei tentativi in tal senso dei cardinali Elie de Talleyrand e Guy de Boulo-gne9.
Sembra che in un primo momento questa egloga e la seguente, con la quale com-pone un dittico anti-avignonese, dovessero formare un testo unico, ma poi si divise-ro e, per dir così, si specializzarono: restò il personaggio di Mitio (papa Clemente VI),ma Panfilo (san Pietro) fu sostituito da Epy (la Curia), che qui già compare ai vv. 148e 205. Benvenuto da Imola, infatti, scrive, introducendo l’egloga VII: «Nota quod istaseptima egloga erat una cum precedenti; sed, quia videbatur longa, autor fecit ex ip-sa duas, et in ista presenti autor introducit duos pastores, quorum unus est Mitio pa-pa Clementis et alius pastor Epy» (ma la ragione dello sdoppiamento difficilmente sa-rà stata quella dell’eccessiva lunghezza)10. Come s’è accennato, della vicenda di Coladi Rienzo e delle responsabilità di chi ha soffocato il tentativo repubblicano e pa-triottico del tribuno qui si tace: in primo piano è invece l’attacco contro la corru-zione morale della Chiesa avignonese e in particolare di papa Clemente VI, del restofamoso per la magnificenza della quale si circondava, sì che, quanto ai contenuti, l’e-gloga a tutti gli effetti fa corpo con le lettere del Liber sine nomine sopra citate. Si par-ta per esempio dalla quinta (scritta nel 1352 a Lapo da Castiglionchio): tutta la pri-ma parte contiene un violento attacco alla Curia nel quale ritroviamo il tema ‘infer-nale’ di Avignone / Babilonia, e quello della distanza che divide l’antico modello dal-la corrotta realtà presente, ampiamente sviluppato a partire dalle battute iniziali:«Nunc me gallicus orbis habet et occidentalis Babilon, qua nichil informius sol videt,et ferox Rodanus estuanti Cocyto vel tartareo simillimus Acheronti, ubi piscatoruminops quondam regnat hereditas, mirum in modum oblita principii», ecc.11. Di qui sisnoda il filo di quella indignatio che tutte le percorre, e che ha prodotto pagine me-morabili che offrono a ogni passo larghi riscontri con il nostro testo. E per quanto ri-guarda personalmente Clemente VI, con l’egloga non si possono non leggere la Sinenom. 6, ove il papa è Giuliano l’Apostata tornato dall’inferno; la 8, con la 10 forse lapiù ‘infernale’ e violenta, ove il papa, nell’una e nell’altra, è Nembrod, e Semiramideè la sua amante Cécile de Comminges, contessa d’Urgel (vd. la nota al v. 70); la 13,ove la contessa è ancora Semiramide, e il papa è il tiranno Dioniso di Siracusa …
Una volta detto tutto questo, e si mettano pure nel conto tanti altri testi che sa-rebbe facile citare, dall’Epyst. III, 22 ai sonetti 136-138 dei Rvf, ai passi pertinenti del-le Familiares, resta che l’egloga ha un tono affatto speciale: un carattere tutto suo, chela rende particolarmente interessante. La cosa spicca immediatamente se solo si con-frontino le maschere via via assunte da Clemente VI nelle Sine nomine (le abbiamo vi-ste: Giuliano l’Apostata, Nembrod, Dionisio) con quella che assume nell’egloga. Qui,Mizione in parte trae il suo nome dall’aggettivo mitis (equivalente di clemens), ma so-prattutto lo ricava da un personaggio della commedia Adelphoe (I fratelli) di Terenzio,Micione, il quale ha un fratello, Demea, del quale ha adottato lo scapestrato figlioEschino, mentre l’altro figlio, Ctesifone è rimasto con il padre. Della trama, basata in
L’egloga di Petrarca «Pastorum pathos» (Buc. Carm.VI)
343
maniera assai fine sulle vicende amorose dei giovani fratelli, non mette conto di par-lare, ma sì dell’opposto carattere dei due vecchi, Micione e Demea, ai quali è dedi-cato l’intero primo atto: quanto Micione è tollerante, comprensivo e generoso, tantoDemea è il rigido e polemico moralista, fautore di uno stile di vita severo, che natu-ralmente cerca di imporre al figlio rimasto con lui. Ora, è curioso che Petrarca nonsi limiti alla ripresa del nome, ma che nel contrasto tra il suo Mizione e Panfilo inqualche modo egli riproduca (seppur con molta libertà, e adattandolo al nuovo con-testo) quello tra Micione e Demea. È curioso, ripeto, almeno per due motivi: il pri-mo, sta nel fatto che così facendo egli contamina vistosamente il livello ‘tragico’ del-l’argomento, al quale ben corrispondevano le altre maschere, con il livello ‘comico’intrinseco al personaggio di Terenzio (e ciò provoca, a mio parere, qualche frizioneall’interno dell’egloga). Il secondo, nel fatto che all’origine tale personaggio è indub-biamente assai simpatico nella sua accomodante moralità: e anche di ciò l’egloga diPetrarca trattiene più di una traccia. Ma non basta, ché anche la dimensione teatraleriesce a farsi sentire, non solo nel modo in cui Mizione e Panfilo reciprocamente sivedono come tipi fortemente caratterizzati e idiosincrasici, ma proprio nel modo conil quale Petrarca costruisce lo spazio del dialogo. Quando Micione vede Demea chegli si avvicina, mormora tra sé e sé, creando un esclusivo canale di comunicazione congli spettatori (cito per comodità solo la traduzione): «Ha un’aria arrabbiata, a quantovedo: al solito, immagino, mi insulterà », e poi ad alta voce, senza soluzione di conti-nuità: «Demea, sono felice di vederti in buona salute!» (Ad. 79-81). E alle immediatelamentele di Demea per i comportamenti del figlio Eschino, riprende tra sé: «Nonl’avevo forse detto?», e poi, di nuovo a voce alta: «Che cosa ha fatto?» (Ad. 79-81 e83-84). Si vada ora all’egloga: la partitura essenziale dei primi scambi tra Mizione ePanfilo, per quanto dilatata, è la medesima. Panfilo s’avanza brontolando, e Mizionese lo vede davanti e mormora tra sé: ‘ecco quel vecchio rompiscatole … cercherò diprenderlo con le buone / Da dove vieni, Panfilo …?’, ecc. E dopo la prima sfuriatadi Panfilo contro di lui, Mizione ancora borbotta prima di rispondergli: ‘I suoi insul-ti non mi giungono inaspettati, dentro di me già me li ero immaginati … / Panfilo,è facile prendersela con gli altri!’, ecc. Si potrebbero citare altri momenti: per esem-pio là dove Micione, sempre rispondendo alle acide contestazioni del fratello, affer-ma di accettare di buon animo tutto ciò che non è in suo potere di modificare, oquando, nel finale, Demea contrappone al suo carattere, duro e intrattabile, quello ri-lassato e sorridente del fratello, e tutti gli amici che costui ha al suo isolamento: «il-lum amant, me fugitant» (Ad. 737-741, e 862 e sgg.: vedi, nell’egloga di Petrarca, v.198). Ma non è questa la sede per andare oltre nell’analisi, e basti dunque aver se-gnalato come la ben nota ammirazione di Petrarca per Terenzio12 trovi una straordi-naria applicazione pratica, che non trovo sia stata sin qui segnalata, e come proprio ilmodello classico sia in gran parte responsabile del tono dell’egloga, che a prezzo diqualche sfasatura potremmo definire come il tentativo di trasferire la tragica indigna-zione delle Sine nomine in una partitura dialogica di stile misto e a tratti decisamente‘comico’ che lascia al personaggio negativo tutta la sua verità e la sua forza argo-mentativa, e che di questa verità e di questa forza dispiegate sino al paradosso (se-
ENRICO FENZI
344
condo l’accattivante e perversa logica di Mizione, Cristo sarebbe stato un ‘avaro’!) fal’arma medesima con la quale si condannano da sé. Che è, poi, quanto Petrarca cer-cherà di fare con ancora maggiore coerenza nell’egloga successiva, nella quale scom-pare la voce positiva di Panfilo, e con essa l’esplicita alternanza bene/male, e uniches’accampano le voci del male senza altro principio di condanna al di fuori di quelloche esse stesse riescono dialetticamente a evocare. E questa strategia – ritrarre la vo-ce del bene e lasciare il campo a quella del male affinché parli e si denunci da sola –è appunto quella che già tiene il campo in questa sesta egloga, nella quale non a ca-so si ha l’impressione che Mizione parli assai più a lungo di Panfilo (in realtà, la dif-ferenza si riduce a dieci versi, ma il fatto è che è lui a condurre il gioco e a teneresotto scacco Panfilo, costretto ripetutamente a difendersi: vd. vv. 57 e sgg. e 132 esgg.), e che si precisa nella settima, secondo la linea di sviluppo ch’era in nuce nellaprecedente. Con ciò, è possibile che si sia anche risposto a quanto già François eBachmann hanno osservato, scrivendo che: «Rien ne permet de penser que Pétrar-que propose Pamphile comme un modèle incontestable […] Dans Pastorum pathos ildemeure étranger à l’un comme à l’autre des interlocuteurs». Ma così è forse troppo,né mi sentirei di accogliere la loro pur acuta interpretazione, che merita di essere ri-ferita, secondo la quale Panfilo non è tout court san Pietro, ma un interlocutore assaipiù discutibile e ambiguo e insomma per qualche verso pur esso condannabile: «sesoutrances de langage, et aussi cette annonce menaçant du retour d’un Dieu justicieret vengeur le rapprochent, semble-t-il, de ces ‘fraticelles’ imprégnés de doctrinesmillénaristes, finalement combattus et condamnés comme hérétiques» (p. 129). Ora,non c’è dubbio che essi abbiano ben colto il fatto che il rapporto tra i due perso-naggi non è così lineare e pacifico come si poteva credere, ma io penso che a com-plicare tale rapporto non siano i supposti tratti negativi di Panfilo (il quale, va ribadi-to, è senza dubbio un’incarnazione di san Pietro), quanto piuttosto il realismo e dun-que la forza squilibrante che assume la figura di Mizione, che supera i limiti di unaastratta e subordinata figura del male e diventa l’inquietante figura del disincanto edel cinismo e dunque, in ultima analisi, della più desolata e ‘vera’ sapienza mondana.
NOTE
1 Il testo, da Il Bucolicum carmen e i suoi commenti inediti, a cura di A. Avena, Padova, Società Coope-rativa Tipografica [Padova in onore di Francesco Petrarca, MCMIV, 1], 1906, pp. 119-26, ricontrollatosu quello di D. Di Venuto, Il Bucolicum carmen di Francesco Petrarca. Edizione diplomatica dell’autografo Vat.Lat. 3358, Pisa, ETS, 1990, pp. 101-09. Ho anche fatto ricorso all’edizione francese diffusamente anno-tata: Pétrarque, Bucolicum carmen. Texte latin, traduction et commentaire par M. François et P. Bachmann,avec la collaboration de F. Roudaut. Préface de J. Meyers, Paris, Champion, 2001. La traduzione, mia, hainevitabilmente tenuto conto di quella elegante e scorrevole di Luca Canali, in Francesco Petrarca, Bu-colicum carmen, a cura di L. Canali, collaborazione e note di M. Pellegrini, Lecce, Manni, 2005, pp. 98-115. Cito dall’ed. Avena, pp. 216-20, il testo del commento di Benvenuto da Imola conservato nel co-dice della Bibl. Laurenziana, 33 Plut. 52, e, pp. 272-75, quello di Francesco Piendibeni da Montepulcia-no, conservato nel codice Vaticano Pal. 1729. L’egloga non è compresa nell’ed.parziale (comprende leegloghe 1-5, 8 e 11) di M. Berghoff-Bührer, Das Bucolicum Carmen des Petrarca. Ein Beitrag zur Wirkungs-
L’egloga di Petrarca «Pastorum pathos» (Buc. Carm.VI)
345
geschichte von Vergils Eclogen, Bern-Berlin [...], Peter Lang, 1991.2 Si trattava di una missione che metteva Petrarca in una delicata posizione, ai limiti del doppio-gio-
co, visto l’appoggio che egli sino a quel momento aveva dato a Cola di Rienzo: si trattava infatti di sol-lecitare il signore di Verona, ma anche Mantova, Bologna e il patriarca di Aquileia, affinché impedisse ilpassaggio delle truppe di Luigi d’Ungheria dalle quali Cola, a Roma, attendeva aiuto. Vd. per ciò C. Ci-polla, Sui motivi del ritorno di Francesco Petrarca in Italia nel 1347, «Giornale storico della lett. italiana»,XLVII, 1906, pp. 253-65, e da ultimo, con ulteriore bibliografia, E. Fenzi, Per Petrarca politico: Cola di Ri-enzo e la questione romana in Bucolicum carmen V, «Pietas pastoralis», «Bollettino di Italianistica», VIII,2011, pp. 49-88. Per la tradizionale datazione della nostra egloga, vd. N. Mann, The making of Petrarch’sBucolicum carmen: a Contribution to the History of the Text, IMU, 20, 1977, pp. 127-82: p. 132.
3 Citerò le Sine nomine dalla recente edizione di L. Casarsa: F. Petrarca, Liber sine nomine, traduzionee cura di L. Casarsa. Introduzione di U. Dotti, Torino, Nino Aragno, 2010, rinviando implicitamente an-che alle ricche note. Si ricordi che dell’eccezionale memoria attribuita a Clemente VI, volgarmente spie-gata con un gran colpo in testa subìto quand’era giovane Petrarca parla nei Rer. memorandarum libri II,14. 1-3: «Clemens VI, egregius nunc romulei gregis pastor, tam potentis et invicte memorie traditur, utquicquid vel semel legerit oblivisci etiam si cupiat non possit», ecc. Il contesto non è particolarmenteelogiativo, neutro piuttosto (Petrarca si preoccupa di precisare che, pur avendo avuto a che fare con ilpapa, di tale sua qualità non s’era mai accorto), sì che non è possibile contrapporre questa relativamen-te giovanile testimonianza ai giudizi più tardi, come fa per esempio, con qualche malizia, G. Mollat, Lespapes d’Avignon, Paris, Letouzey & Ané, 1950, p. 92. Su Petrarca anti-avignonese e sulle Sine nomine inparticolare la bibliografia è vasta, e agevolmente ricavabile sia dal volume della Casarsa che dai commentia Rvf 136-138. Ma si veda in ogni caso E. Pasquini, Il mito polemico di Avignone nei poeti italiani del Tre-cento, in Aspetti culturali della società italiana nel periodo del papato avignonese, Todi, Accademia Tudertina,1981, pp. 257-309; F. Suitner, L’invettiva antiavignonese del Petrarca e la poesia infamante medievale, «Studi pe-trarcheschi», n.s. II, 1985, pp. 201-10, e ora M. Berisso, «Già Roma or Babilonia» (appunti su Rerum vulga-rium fragmenta CXXXVI-CXXXVIII), «Per leggere», 21, 2011, pp. 7-24. Per quanto riguarda le Sine no-mine, con il saggio di E. Raimondi, Un esercizio satirico del Petrarca, in Id., Metafora e storia, Torino, Einau-di, 1970, pp. 189-208, vd. ora l’ampio studio compreso nel volume di G. Baldassari, Unum in locum. Stra-tegie macrotestuali nel Petrarca politico, Milano, LED, 2006, pp. 29-120; C. Bianca, Petrarca e la sua percezionedi una storia della Chiesa, in Petrarca politico. Atti del Convegno […], Roma, Istituto storico italiano per ilmedio evo, 2006, pp. 27-41, e l’ancor più recente e bel capitolo dedicato al Liber da R. L. Martinez, inPetrach. A Critical Guide to the Complete Works. Ed. by V. Kirkham & A. Maggi, Chicago and London, TheUniversity of Chicago Press, 2010, pp. 291-99.
4 Rispett. Sine nom. 12, 19: «Ci hai strappati a un giogo pesante e tristissimo e turpe. Perché ci imponi dinuovo un identico e intollerabile giogo fatto con lo stesso legno?», e Buc. VI, 170: «Quel tale che ci minacci chi sa-rà, se non un figlio tuo?».
5 «Mizione. Dopo di me verrà qualcuno (non manca poi molto, se le mie previsioni non sbagliano) che squal-lido e inerte com’è farà perdonare i miei comportamenti accomodanti con le sue severissime proibizioni, e introdurrànei pascoli di Roma le meschinità dell’Alvernia».
6 Addirittura pare avesse minacciato proprio il ritorno a Roma, come forma di punizione verso diloro (che però «poco se n’amendarono»): vedi Matteo Villani, IV, 86; E. Dupré Theseider, I papi di Avi-gnone e la questione romana, Firenze, Le Monnier, 1939, pp. 114-15, ma anche i giudizi di Benvenuto ePiendibeni riferiti nelle note
7 In queste parole si può probabilmente vedere anche (ma non solo) un’allusione implicitamentespregiativa alla comune nazionalità francese (Pierre Roger de Beaufort era il nome di Clemente VI).
8 Sine nom. 19, 12: «Quel pastore appesantito dalla vecchiaia e dalla sonnolenza e dal vino, quel pastore chedi sua volontà non uscirà mai dai suoi nascondigli e dai suoi amati bordelli, tu solo dopo averlo preso per mano erimproverato e frustato potrai restituirlo all’antica dimora». Questo icastico ritratto ha molto in comune conquello di Benedetto XII, il predecessore di Clemente VI, così com’è descritto in Sine nom. 12-13.
9Vd. Fam. IX, 5, 15; Sen. I, 4, 2-11; U. Dotti, Vita di Petrarca, Roma-Bari, Laterza, 1987, pp. 243-44.
ENRICO FENZI
346
10 Sul piano generale della composizione, è stato osservato che le egloghe sesta e settima occupanoil centro del Bucolicum carmen: «The allegorical representation of the Church as a wore, arrogantly aver-se to evangelical spirituality and Christianity’s ailing flock, seems in sum to constitute the center of theBucolicum carmen as a whole». Così S. Carrai, nel citato volume Petrarch. A Critical Guide, p. 168. Un in-teressante tentativo di cogliere la struttura interna del Bucolicum carmen inteso come un tutto, come il ti-tolo al singolare invita a fare, è quello di J. L. Charlet, L’architecture du Bucolicum carmen de Pétrarque,«Res publica litterarum. Studies in the Classical Tradition», XXVII, 2004, pp. 30-41. Per lo studioso, lecui proposte meritano d’essere ulteriormente sviluppate e discusse, sono le quattro egloghe centrali V-VIII a costituire il nocciolo politico dell’opera (vd. in particolare pp. 37 e sgg., e l’allegata tavola dellecorrispondenze tra egloga ed egloga).
11 Sine nom. 5, 2: «Mi trattengono qui quel mondo gallico e quella Babilonia d’occidente di cui il sole non ve-de nulla di più caotico, e il Rodano feroce quanto mai simile al ribollente Cocito e al tartareo Acheronte, sul qualeregna, totalmente dimentico del passato, l’erede di quel povero pescatore di una volta».
12 Per il rapporto di Petrarca con Terenzio entro la storia della trasmissione dei testi vd. i lavori fon-damentali di C. Villa, La «lectura Terentii», I, Padova, Antenore, 1984; Ead., Petrarca e Terenzio, «Studi pe-trarcheschi», VI, 1989, pp. 1-22: in part. pp. 11-14. Per il giudizio di Petrarca vd. la nota di M. Petolettiin F. Petrarca, Le postille del Virgilio Ambrosiano […], Padova, Antenore, 2006, II, p. 650, e E. Fenzi, Servio,Simone Martini, Petrarca: un percorso attraverso il Virgilio Ambrosiano, in Servius et sa réception de l’Antiquité àla Renaissance. Sous la direction de M. Bouquet et de B. Méniel, Rennes, PUR, 2011, pp. 409-41: p. 436.In entrambi questi studi si citano le intense parole che Petrarca ha posto alla fine della sua Vita Terrentiiriassumendone le qualità: «Humanorum morum exacta notitia et ordo narrationis ab ipso etiam Cice-ronis laudatus et stili iocunditas ac gratia», ora leggibili nella bella edizione critica che del testo ha datoÍñigo Ruiz Arzalluz, LaVita Terrentii de Petrarca, Padova, Antenore, 2010, pp. 147-48 (di Cicerone vd.De inv. 27 e De orat. II, 326-328).
Sexte Egloge titulus: Pastorum PathosCollocutores Pamphilus et Mitio
PamphilusQuis nemus omne vagis lacerandum prebuit hircis?Quid silve meruere mee, quas rore supernoIupiter, et rivis spumantibus horrida coniunx,impiger atque olim Pyreos Phaniosque rigarunt?Que rabies furtim, segetes dum carpit acerbas, 5spes et oper turbavit agri? Cui pulcer Hiberus,delitie nostrumque decus, sub tempus aratrinon timuit prunas crepitantibus addere lauris,quis prope consumptus, dextram nisi noster Apolloporgere afflicto montesque efferret in altos? 10
MitioPastorum sors dura nimis! Date frena capellis,indomitos cohibete greges, simul ubera multolacte fluant semper … magicas non novimus artes!Et nunc iste ferox lites et iurgia secum
L’egloga di Petrarca «Pastorum pathos» (Buc. Carm.VI)
347
instruit ac, saxum et nodosa repagula gestans, 15quot maledicta parat, poterit maledicta mereri,ense perire suo, quod fert reperire venenum.Blanditiis tamen aggrediar: ‘Quo Pamphile et unde?quosve locos habitas? serum tua claustra revisis?quid fremis? inque gravi qui fervet spiritus ore?’ 20
PamphilusFurcifer hic, Mitio? Nec te durissima sontemsorbet adhuc tellus? Iam iam mirabile nullum est,si nemus et messes atque omnia, versa retrorsum,spem lusere meam. Cui proh! custodia culticredita ruris erat? cui grex pascendus in erba? 25Intempestivis perierunt mortibus agni;defessi periere boves, hircique supersunt,immundique sues, quos luxus et otia tendunt:turba nociva satis, nulla que lege per agrosspargitur insultans, virgultaque dentibus urit; 30iam montes infecit odor, nostramve quietem.
MitioHaud inopina quidem patior convitia; dudumsingula nam tacitus tractans sub pectore mecumvaticinatus eram. ‘Iam turbidus ille redibit,nec servi tergo, nec amici parcere fame 35doctus, nec rigida pietatem admittere fronte’.Pamphile, quam facile est alienam carpere vitam!quam durum servare suam! Te forte magistrosegnior haud gregibus mors ac lupus ingruat albis?Nequicquam baculoque minax vultuque venires; 40nil tibi tristis hiems (quamquam cessura rigoriilla tuo), nil ver dubium, nil morbidus auster,nil tibi de proprio violenta remitteret estas;non volucres segeti, non mitibus umbra racemis,non caper arboribus, non bucula parceret herbis. 45
PamphilusNonne ego pastor eram, dum trux, turpissime rerum,Nereus, adverso pascens in vertice tauros,transversum deiecit humi, et pecus omne parabatvi rapere? obluctor, donec violentior illeexuit hirsutam tunicam nudumque reliquit. 50
MitioQuid potius tractare velim quot, tempore parvo,tunc nostri cecidere greges? Est sanguine vallispinguis adhuc; cecis raptim congesta cavernis,
ENRICO FENZI
348
ossa iacent; horrore ferit locus ipse tuentes.Non tibi, non aliis licuit mandare macello 55membra boum; sparsere lupi, sparsere leones!
PamphilusDii tibi sint hostes! At non iacuere magistri;non rauci siluere canes; quod seva sinebatextremum fortuna, fuit: spoliare cadenteset niveas urbi dominoque remittere pelles. 60Tu michi quid servas nisi cornua dempta iuvencis?
MitioServo aurum teneris quod compensavimus agnis;servo habiles scyatos, et agresti urgere labellumsubere non dignor, rudium miseretque parentum.Adde quod ars, duce me, multum pastoria crevit: 65discolor en talos thirreno ex more coturnuscircumit; effulgens obnubit tempora iaspis;candida sydonio ter murice vellera tinxi,et magnos peperi pro munere lactis amicos.Sponsa nitet gemmis collumque monilibus ambit, 70et mecum fusca secura recumbit in umbra;non glacie nivibusque rigens, nec solibus usta,qualis erat tua turpis anus dum rura tenebas;regia, si spectes, non nostra videbitur uxor.Tum passim herbosis ludunt in vallibus edi, 75inque volutabris segnes innata voluptasconglomerat versatque sues; non humida pastorfortior antra subit. Sedeo iaceoque supinus,multa canens que dictat amor nec crastina curans;commissique gregis ludos et prelia cerno. 80Tu querulus tristisque mane; tu dente canino,qua rabies tulerit, semper mordere paratus.
PamphilusErgo, impure, tuum nostris cum sentibus aurumiungis? ut indignos habitus tibi preferat uxor,rebus honusta suis? Ut tu meliore cubili 85membra loces somnumque animo vigilante fugacemexcipias oculis et turbida visa fatigent?Concilient ut vasa sitim, causasque timendiinveniant, et forma domus et cara supellex?Heu! Labor insanus precio cumulare periclum; 90Heu! Furor extremus nupte parere furenti.Turpis, adulteria et thalami tot probra pudendiDissimulare potes? Nempe hi, quos fingis amicos,coniugis inceste facile rapuere pudorem,
L’egloga di Petrarca «Pastorum pathos» (Buc. Carm.VI)
349
insidiasque parant etiam tibi; lumina tolle 95immodico depressa mero; lupus instat ovili,antraque pervigiles circumstant ditia fures.
MitioFuribus est mecum contractum sanguine porcifedus, et inferni descriptum regis in ara;invisum superis sacrum fortasse profundis 100acceptum sed iure deis, quibus ere litatum est.Non ego, ieiune confringant pinguia tygressepta licet totoque fremens ruat ethere grando,armentisque satisque necem ferat acrior annus,pauper ero: tantum scrobibus commissimus atris! 105
PamphilusTolle ferum, scelerate, sacrum, quod Iupiter et Solerubuit potuitque Iubar …! Sed acerba relatupretereo; qui pastor eras, per litora gazasconvehis, et neutrum perages feliciter. Audelinquere iam silvas urbesque videre remotas, 110pandere vela nothis, tumidas tentare procellas;uxor enim ignotis iampridem in collibus erratet, patrium limen thalamumque egressa pudicum,illa sequetur ovans meretrix famosa, procosquesecum aget ardentes et olentes turpiter hircos, 115herba peregrine quibus est iam grata paludis.
MitioQuid, pater, obscuris animos ambagibus imples?Longaque nunc seris quid litibus otia frangis?Desine iam mestis alacres incessere verbis.Dic, age; dic breviter quicquid fert impetus et mens. 120
PamphilusEs meritus post vincla crucem, post verbera ferrum.Supplicium breve! Quin potius sine fine dolorescarceris eterni, vel si quid tristius usquam est,serve infide, fugax, dominoque ingrate benigno.
MitioCrude senex, gestare crucem, tolerare cathenas 125si nescis, sors ipsa tua est. Vulgata per omnesfabula iam saltus, Nerei terrore superbidestituisse gregem, medio nisi tristis Apollosistere calle gradum, non vertere terga iuberet.Cetera nam sileo, domino quam fidus in arctis 130casibus, ut possint deserte ignoscere caule.
ENRICO FENZI
350
PamphilusEt fugi, et redii. Timui Pastoris iniquiverbera; nulla metum facile damnaverit etas.Flumine mox lavi maculas pallorque recessit.Que tibi causa fuge? cur claustra quieta relinquis? 135Cur, longinqua sequens, quercus contemnis avitas?Quo claves, vesane, rapis? Quin, abice, rerum tantarum si cura premit; per menia saltuerrantes cogentur oves sub tecta reverti.
MitioIam michi magna placent; inopis num semper ovilis 140servus ero? Dulcem cantando nactus amicam,formosus fieri studeo; solemque perosus,antra umbrosa colo frontemque manusque recentifonte novans. Speculum Coridon bizantius istud,quo michi complaceo, dono dedit; omnia novit 145et patitur coniunx, quoniam sua multa vicissimdura fero. Vos ignotas iactetis amicas,me mea perpetua foveat complexibus Epy.
PamphilusInfamis mulier multisque infausta maritis,te foveat demens! Prior Epycus ille, profanos 150lapsus in amplexus, cecinit per rura, per urbesquam coniunx generosa sibi; prior ipse puellamnactus ad irriguos secum traduxerat ortos;ludibrioque habitus vivens moriensque, iacentemexedere canes et perminxere sepulcrum. 155Letior haud aliis post hunc; sed adultera fortefida tibi; fruere et speculum Coridonis habeto.Eternum gemat ille miser, pastoribus aulequi primus mala dona dedit! Formosus haberidum petis, et capiti circumdas serta nivoso, 160(ignotum tot pondus avis) dum floribus antrum,dumque pedum, delire, rosis silvestribus ornas,omnia depereant. Quando impia sidera celo,impia fors terris superant, intercidat unacura gregis; rurisque labor, studium peculi. 165
MitioSuccedet michi forte aliquis, nec longius hinc iam(augurio nisi fallor) abest, qui tristis inersquemitia preduris excuset facta repulsis,alvernasque ferat Romana in pascua sordes.
L’egloga di Petrarca «Pastorum pathos» (Buc. Carm.VI)
351
PamphilusQuem talem, nisi te genitum fortasse, minaris? 170En tua tota fides! En laudum summa tuarum!Peiorem si terra parit, tunc optimus ipse,inque nocens Mitio. Sic crimen crimine purgas?Vive late, gaude vitii maioris ad umbram.
MitioLetus agam moriarque dolens. Tu, tristis utrumque, 175nescio quid confusa tibi tua somnia servent.
PamphilusPar fuerat meminisse, quibus bonus ille periclisista paravit herus. Laniatum vepribus asprisvidimus. Heu, quanti miserans armenta redemitperdita, sublimi veniens mercator Olimpo! 180Quam tenuis victus, quam nulla superbia verumruris habet dominum! Tu luxuriaris in arvisillius; ipse sua sitiens ac sobrius aula est.
MitioImmemor ille sui et, verum fateamur, avarus!Perdere pauca timet, cum possit perdere multa. 185Impiger horrisonis pastores vocibus implet;hinc didicisse potes semperque in fontibus egrasmersat oves, tondere iubens, ne vellera lappeintricent, prohibens ipsis a sepibus hircos;ostentaque rubos itidem sterilesque miricas 190(pascua dura feris) famulos macieque geluqueconficit, ac tolerare famem somnumque sitimqueedocet, adiungitque minas atque intonat ore;dulcia cunta vetat, iubet aspera; culta cavebis,avia lustrabis, montes superabis iniquos, 195et pedibus nudis tribulos calcabis acutos,moribus his hominum quisquam de sanguine natumdixerit? aut raros illi miretur amicos?Contra ego, me memini domino servire potenti;perdere magnificum; multis placuisse decorum. 200Vis ubi nulla premit, quis tot consumet aristas?quod pecus assiduo peraget tot gramina morsu?lascivos errare greges hircosque procacesconiugio gaudere sinas. Simul ipse iocabordum mea me coniunx, dum me mea suspicit Epy. 205Vos vestros servate, meos michi linquite mores.
ENRICO FENZI
352
PamphilusInfelix, sic noscis herum? Dum tutus in umbrastare putas aderit, prevertens gaudia luctu.
MitioMen verbis terrere paras? Presentia fortesdespiciunt: timidos etiam distantia terrent. 210
Egloga sesta: Affanni pastorali.Interlocutori: Panfilo e Mizione
Panfilo. Chi ha lasciato che l’intero bosco fosse devastato dalle scorrerie dei caproni? Hanno for-se meritato questo destino le mie selve, che Giove sollecitamente bagnò di celeste rugiada, e dispumeggianti ruscelli la sua severa consorte, e Pireo e Fanio? [5] Quale furtiva rabbia, strap-pando le messi non ancora mature, sconvolge le speranze riposte nei prodotti dei campi? queicampi per amore dei quali il nobile Ibero, onore e delizia nostra, al tempo dell’aratura non eb-be paura di aggiungere carbone agli allori già crepitanti, che l’avrebbero consumato se il nostroApollo non avesse porto la destra al martire e non l’avesse portato in alto sui monti? [11] Mi-zione. Troppo dura la sorte del pastore: tieni a freno le caprette! riunisci le greggi ribelli! fai scor-rere sempre abbondante il latte dalle loro mammelle… non siamo maghi! E ora questo scorbu-tico si sta preparando tra sé a litigare e a insultarci, e quante mai maledizioni prepara agitan-do la sua pietra e i suoi complicati chiavistelli! Possano ricadere su di lui: crepi della sua stessaspada, e ricrepi del veleno che si porta dietro! In ogni caso l’affronterò con parole gentili … Dadove arrivi, Panfilo, e dove sei diretto? e perché fremi? che pensieri ribollono sulla tua faccia in-cupita? [21] Panfilo. Ci sei tu qui, Mizione, pendaglio da forca?! La terra implacabile non haancora inghiottito te e i tuoi peccati? Non mi meraviglio se il bosco e le messi e tutto il resto èandato a catafascio e ha tradito le mie speranze. Ahimè, a chi era stata affidata la custodia deicampi ben coltivati? a chi il gregge da far pascolare nei prati?Gli agnelli sono morti prima deltempo; i buoi, sfiniti, sono stramazzati: sopravvivono invece i caproni e i luridi maiali occupatidalla lussuria e dall’ozio, che senza regola alcuna si spargono in massa a far danno per i cam-pi mandandoli in rovina e distruggendo a morsi i virgulti. La loro puzza è arrivata a contami-nare i nostri monti e la nostra quiete. [32] Mizione. Proprio gli insulti che mi aspettavo mitocca di sopportare. Già da un po’, infatti, ripassandoli tutti in silenzio tra me e me l’avevo pre-visto: Ora tornerà quello sconvolto che non ha ancora imparato a rispettare le spalle del servo el’onore dell’amico, né a mostrare qualche segno di pietà sul suo volto insensibile … Panfilo, èfacile prendersela con la vita degli altri! e difficile, invece, salvaguardare la propria. Con te a gui-darle, credi che la morte e i lupi assalirebbero con minore slancio le bianche greggi? Anche tuverresti a minacciare inutilmente con il tuo bastone e la tua faccia. Nulla di quello ch’è suo ticederebbe il gelido inverno (sempre perdente in confronto al tuo rigore!), né l’instabile primave-ra né l’austro malsano o la torrida estate. Gli uccelli non si terrebbero lontani dalle messi nél’ombra dai grappoli teneri né il caprone dagli alberi o la giovenca dall’erba. [46] Panfilo. Nonero forse io il pastore quando il truce Nereo, la più turpe delle creature, mi gettò riverso a terra
L’egloga di Petrarca «Pastorum pathos» (Buc. Carm.VI)
353
mentre sull’opposta collina portavo al pascolo i tori, preparandosi a strapparmi a forza tutto ilbestiame? Ho lottato, ma egli, più forte di me, mi ha spogliato della ruvida tunica e mi ha la-sciato nudo. [51] Mizione. Vogliamo dire, invece, quante nostre greggi morirono in poco tem-po? Ancora adesso la valle è imbevuta del loro sangue, e le loro ossa giacciono sparse in oscurecaverne: e il luogo suscita spavento in chi lo guarda. Ma non sei stato tu né altri a mandare almacello le membra dei buoi: sono stati i lupi, sono stati i leoni a farne scempio! [57] Panfilo.Che gli dei ti diano addosso! I mandriani però non si sottomisero, né rimasero zitti i cani conla loro rauca voce, e ci rimase quello che la crudeltà della fortuna alla fine ci permise: tosare lepecore morte e mandarne le bianche pelli al padrone, in città. Tu invece che cosa hai salvato ol-tre alle corna tolte ai giovenchi? [62] Mizione. Ho salvato l’oro con il quale ho scambiato i te-neri agnelli; ho messo in salvo vasellame elegante … io mi rifiuto di accostare le labbra a cop-pe di legno, e mi fanno pena i miei rozzi genitori. Di più, sotto la mia guida l’arte dei pasto-ri è assai migliorata: secondo la moda tirrena, sandali di vario colore mi stringono le caviglie;diaspro fulgente copre le mie tempie; tre volte ho tinto le bianche lane con porpora fenicia, e do-nando il mio latte mi sono procurato l’amicizia dei grandi. La mia sposa brilla di gemme e av-volge il collo di monili, e giace tranquilla con me in ombrosi recessi senza tremare per il ghiac-cio o la neve e senza ustionarsi al sole, come faceva la tua brutta vecchia mentre eri tu a gover-nare questi campi. [74] Guardala, sembra una regina, e non la moglie di un pastore! Intanto icapretti ruzzano qua e là per le valli erbose, e il naturale piacere fa che i pigri maiali si am-massino e si rivoltino nel brago. Nessun altro pastore, per quanto forte, entrerà nel mio frescoantro ove siedo o giaccio supino cantando ciò che amore mi detta, e non penso al domani men-tre osservo i giochi e le lotte del gregge che mi è stato affidato. Tu resta pure triste e lamentoso,sempre pronto ad azzannare con i tuoi denti da cane là dove la rabbia ti avrà trascinato. [83]Panfilo. Così, spudorato, paragoni il tuo oro con le mie spine? E tutto affinché tua moglie ca-rica di tutte le sue gemme possa ostentare davanti a te abiti indecenti? affinché tu possa disten-dere le membra in un letto migliore e chiudere gli occhi in un breve sonno mentre l’animo restasveglio, turbato com’è da inquiete visioni? affinché le coppe calmino la tua sete, mentre la bellacasa e le suppellettili preziose ti procurano motivi di paura? Oh, è lavoro da pazzi procurarsiil pericolo a prezzo d’oro! ed è l’ultima delle pazzie ubbidire a una moglie irritata. Riesci for-se a dissimulare gli adultèri e le tante infamie del tuo turpe, vergognoso talamo? In verità, quel-li che vuoi immaginare come amici hanno corrotto il fragile pudore della tua dissoluta sposa, etramano agguati anche contro di te. Alza gli occhi appesantiti dal troppo vino: il lupo minaccial’ovile e occhiuti ladri circondano i tuoi ricchi rifugi. [98] Mizione. Con i ladri ho stretto unpatto suggellato con sangue di porco e firmato sull’altare del re infernale: un patto forse invisoagli dei del cielo, ma giustamente gradito a quelli degli abissi presso i quali è stato propiziatopagando il dovuto. Anche se tigri affamate annientassero i miei grassi recinti, e se la grandineprecipitasse rumoreggiando da tutto il cielo, e se un’annata più dura facesse morire gli armentie le colture, ebbene, non per questo sarò povero, tanto è l’oro che ho nascosto in oscure fosse.[106] Panfilo. Scellerato, cancella l’infame sacrificio che ha fatto arrossire di vergogna Giove eil Sole e persino la stella del giorno, Lucifero … Ma lasciamo ciò che fa troppo male a dirlo. Tu,da pastore che eri, adesso trasporti ricchezze per ogni dove, e non fai bene né l’una né l’altracosa. Coraggio dunque! abbandona le selve e visita città lontane, spiega le vele ai venti e sfidale furenti tempeste. Già da tempo tua moglie se ne va per colli che non sai e, una volta abban-
ENRICO FENZI
354
donata la casa natale e l’onesto talamo, da famosa meretrice qual è ti verrà dietro tripudiante eporterà con se i proci che spasimano per lei e i caproni che puzzano in maniera immonda, aiquali già piace l’erba delle paludi vicine. [117] Mizione. Padre, perché mi riempi l’animo dioscure ambiguità? Perché rompi i miei lunghi ozi con questioni vecchie? Smettila di investirecon parole deprimenti chi si dà da fare. Dimmi, su, dimmi in breve quanto ti suggerisce il cuo-re e la mente. [121] Panfilo. Dopo le catene meriti la crocifissione, e la spada dopo le frustate.Supplizi sempre troppo brevi! Piuttosto, i dolori senza fine della prigione eterna, e ancora qual-cosa di peggio, ammesso che esista, servo infedele e fuggiasco, ingrato verso un padrone benigno.[125] Mizione. Vecchio crudele, se tu non lo sapessi, toccherebbe proprio a te di portare la cro-ce e trascinare la catena. È una storia che sanno dappertutto, che per paura del superbo Nereoavresti abbandonato il gregge se quel malaugurato di Apollo non ti avesse ordinato di fermartia mezza strada, di non voltare le spalle. E taccio il resto, cioè quanto tu sia fedele al padronenelle circostanze difficili, sì che le caprette abbandonate possano perdonarti. [132] Panfilo. So-no fuggito, ma sono tornato. Sì, ho avuto paura delle frustate del malvagio pastore: la mia etànon poteva dominare un terrore tanto naturale. Ma ho lavato le mie macchie con un fiume dilacrime, e il pallore della paura se n’è andato. Ma tu, perché sei fuggito? perché abbandoni i tuoiquieti recinti? perché disprezzi le querce avite e insegui ciò ch’è lontano? Dove porti, pazzo chesei, le tue chiavi? Buttale piuttosto, se troppe sono le preoccupazioni che ti opprimono. Le pe-core che adesso errano per i prati e lungo i recinti saranno costrette a tornare all’ovile. [140] Mi-zione. Ormai amo la magnificenza. Dovrò forse essere sempre lo schiavo di un povero ovile?Con il canto ho conquistato una dolce amica: ora cerco di diventare bello. Evito il sole, me nesto sotto ombrosi ripari, rinfresco fronte e mani in acqua corrente. Il bizantino Coridone mi hafatto dono di questo specchio nel quale mi compiaccio di me, e ben lo sa e l’accetta mia moglie,dal momento che a mia volta sopporto le sue molte asperità. Voi gloriatevi pure di amiche cheneppure conoscete, pur che la mia Epy mi riscaldi con i suoi interminabili abbracci. [149] Pan-filo. Allora ti riscaldi, pazzo! quella donna famigerata, sventura di molti mariti. Per primo quelfamoso Epico, caduto nei suoi impuri amplessi, cantò per campi e città quanto la sposa fosse ge-nerosa con lui: era stato lui, infatti, il primo a incontrarla fanciulla e a portarla con sé negli or-ti irrigui, e di ciò fu schernito sia da vivo che moribondo e, morto, i cani ne hanno rosicchiato ilcadavere e pisciato sopra la tomba. Dopo di lui non ha portato migliore fortuna agli altri: maforse a te quell’adultera resterà fedele! E tienti pure e usa lo specchio di Coridone: e soffra ineterno quel disgraziato che per primo offrì ai pastori pericolosi doni regali. Mentre cerchi di pa-rere bello e circondi di corone la testa imbiancata (peso sconosciuto agli avi) e da perfetto dementeorni di fiori la tua tana e di rose silvestri la verga da pastore, tutto vada pure in rovina mentrele stelle malefiche vincono in cielo e un destino di sventura vince in terra. Muoia insieme la cu-ra del gregge, il lavoro dei campi e la buona amministrazione. [166] Mizione. Dopo di me ver-rà qualcuno (non manca poi molto, se le mie previsioni non sbagliano) che squallido e inerte co-m’è farà perdonare i miei comportamenti accomodanti con le sue severissime proibizioni, e in-trodurrà nei pascoli di Roma le meschinità dell’Alvernia. [170] Panfilo. Quel tale che ci mi-nacci chi sarà, se non un figlio tuo? Ecco la tua vera lealtà e la più grande delle tue lodi! Se laterra partorisse uno peggiore di te, eccoti diventato un Mizione ottimo e innocente! Così, lavi ilcrimine con il crimine, vivi alla grande e godi al riparo di una colpa più grave della tua. [175]Mizione. Vivrò felice e mi spiacerà di morire. Tu, triste in entrambi i casi, non capisco cosa t’a-
L’egloga di Petrarca «Pastorum pathos» (Buc. Carm.VI)
355
spetti dalle tue confuse farneticazioni. [177] Panfilo. Sarebbe stato giusto che tu avessi ricor-dato con quali pericoli quel buon padrone ti ha procurato questi beni: l’abbiamo ben visto stra-ziato da spine pungenti! A che prezzo, ahimè! venuto come misericordioso mediatore dall’altodell’Olimpo, ha riscattato le greggi smarrite! Che scarso cibo, che poca superbia ha colui che è ilvero padrone dei campi! e sui suoi campi tu vivi nel lusso mentre egli ha sete e fame in casasua. [184] Mizione. Il fatto è che lui non si ricorda di essere quello che è, ed è avaro- diciamola verità! Ha paura di perdere il poco quando potrebbe benissimo spendere molto. Senza sostaintrona i pastori di parole che incutono spavento. Lo puoi vedere da ciò, che sempre immerge lepecore malate nell’acqua delle fonti, e le fa tosare perché il vello non s’impigli nelle lappole; tie-ne lontani i caproni dalle siepi e sottopone loro rovi e sterili tamarischi, cibo duro persino per lebelve; [191] strema con i digiuni e il freddo i suoi servi, e insegna loro a sopportare la fame, ilsonno, la sete, e ci aggiunge minacce che declama a piena voce; proibisce ogni dolcezza; imponel’insopportabile: starai alla larga dalle comodità, percorrerai sentieri impraticabili, scavalcheraimontagne maledette, e a piedi nudi calpesterai rovi spinosi … Con tali modi di fare, chi mai lopotrebbe definire come un essere nato da sangue umano? o si meraviglierà se ha pochi amici?[199] Io, al contrario, mi ricordo di essere al servizio di un potente signore. È magnifico spen-dere e spandere, ed è bello piacere a molti. Quando non c’è guerra, chi mai riuscirà a consuma-re tante spighe? quale gregge brucando senza sosta consumerà tutta l’erba? Lascia pure che legreggi se ne vadano spensierate e che i caproni lussuriosi godano ad accoppiarsi. Anch’io giocheròcome loro finché la mia compagna, la mia Epy, non avrà occhi che per me. Tenetevi le vostre abi-tudini, e lasciate a me le mie. [207] Panfilo. Sventurato, è così che conosci il padrone? Mentrecredi di startene sicuro all’ombra, egli verrà e capovolgerà la gioia in pianto. [209] Mizione.Vuoi spaventarmi con le parole? I forti disprezzano i mali presenti; i vili hanno paura anchedi quelli futuri.
1. vagis … hircis: sono gli hirci e gli immundi sues dei vv. 27-28, e cioè il clero avigno-nese che devasta la realtà e l’immagine della Chiesa. Benvenuto (Avena, p. 216): «quisest iste qui commisit omne regnum lacerandum lascivis animalibus, seu cardinalibusseu prelatis?» [chi è che ha affidato tutto questo regno ad animali lascivi, cioè a cardinali e pre-lati, affinché lo devastassero?]. In tutta l’egloga è operante la distinzione tra le ‘pecore’del gregge di Cristo e i caproni del demonio, sulla base di Mt 25, 32-33: nel giudiziofinale «et congregabuntur ante eum omnes gentes, et separabit eos ab invicem, sicutpastor segregat oves ab haedis, et statuet oves quidem a dextris suis, haedos autem asinistris» [davanti a Lui si raduneranno tutte le genti, ed Egli separerà gli uni dagli altri comeil pastore separa le pecore dai caproni, e metterà le pecore alla sua destra, e i caproni alla sini-stra].
2-4. Quid silve … Phaniosque rigarunt?: la Chiesa è stata fecondata dalla grazia divina(la ‘rugiada’ di Dio) e irrigata dal sangue versato dai suoi martiri, tra i quali si nomi-nano qui san Paolo e santo Stefano protomartire. Il primo è chiamato Pyreus dal gre-co pyr, ‘fuoco’ (Benvenuto, in Avena, p. 216: «dicitur Paulus Pireus a pir quod ignis,quasi accensus igne Dei»). Il secondo Phanios per aferesi della prima sillaba, Ste-. Non
ENRICO FENZI
356
ha riscontro l’affermazione di Piendibeni (in Avena, p. 272) che sia chiamato così «aloco unde fuit»: Stefano era infatti di Gerusalemme. Può essere invece che la formasia stata autorizzata da Terenzio, che ha un Phania tra i personaggi secondari dell’An-dria (ma vedi anche Heaut. 169, e Hecyra 458), e una Phanius tra quelli del Phormio.Secondo la tradizione le sue reliquie, portate a Roma, sarebbero state unite a quelledi san Lorenzo per liberare dal demonio Eudosia, figlia dell’imperatore Teodosio (ve-di la vicenda nella Legenda aurea di Jacopo da Varagine, ed. Maggioni, pp. 715-16: quianche, p. 766, le speciali ragioni per le quali «beatus Laurentius post beatum Stepha-num inter ceteros martyres primatum tenere dicitur»). Vedi Fam. VI, 2, 13: «hic assa-tus Laurentius; hic sepultus venienti Stephano locum fecit» [qui fu arrostito Lorenzo equi, nel sepolcro, egli fece posto a Stefano, quando arrivò]. La clausola rore superno è in Ve-nanzio Fortunato, Carm. spur. 1, 49: «quemque pluunt nubes iustum de rore superno»(vd. Ovidio, Fast. I, 311: «celesti rore»; Ambrogio. Expl. psalm. XXXV 18, 3: «infususrore caelesti»). Nei classici è ricorrente l’espressione spumantibus undis: vd. Catullo,LXIV, 155, e LXVIII, 3; Virgilio, Aen. III, 268; Lucano IX, 117.
5. segetes … acerbas: è un’immagine di impaziente, ingorda avidità, che anticipa le ac-cuse che seguono (vedi anche avanti, v. 30).
6. pulcer Hiberus: san Lorenzo, originario della Spagna, martirizzato sulla graticola du-rante la persecuzione di Valeriano nel 258, godeva a Roma di un culto affatto spe-ciale.
7. sub tempus aratri: al tempo della Chiesa primitiva, quando si arava e seminava per lagrandezza della Chiesa futura.
8. non timuit … lauris: con plurimo gioco allusivo tra il nome del santo, Laurentius, el’alloro, laurus, e il fatto che l’alloro era l’albero sacro ad Apollo (vd. la nota che se-gue). Nella Legenda aurea, CXIII, De sancto Laurentio, ed. Maggioni, p. 760: «prunissuppositis eum cum furcis ferreis compresserunt». Virgilio, Aen. V, 103: «subiciunt ve-ribus prunas».
9-10. quis prope … in altos?: allude insieme sia al salvataggio dei suoi resti mortali, sot-tratti al fuoco da due fedeli e sepolti con grande onore, sia all’apoteosi della sua ani-ma beata, accolta in cielo (montes in altos) da Cristo. Per l’equazione: Cristo / Apollo,vedi già Buc. I, 66: Giovanni Battista «lavit Apollineos ad ripam gurgitis artus», e quiavanti, v. 128 (vd., con la nota relativa), ove Mizione, in evidente opposizione conPanfilo, ricorda a quest’ultimo come di fatto fosse stato proprio l’apparizione e il dia-logo con Cristo, tristis Apollo, a causarne la morte. Per Cristo che ‘porge’ la destra sal-vatrice, vd. Sine nom. 8, 9: «quod Cristo dexteram porrigente non despero» (ma è mo-tivo frequente, nel Secretum come nei Psalmi penitentiales).
L’egloga di Petrarca «Pastorum pathos» (Buc. Carm.VI)
357
11-18. Pastorum sors … tamen aggrediar: queste sono parole pronunciate da Mizionetra sé e sé a beneficio degli ascoltatori, prima di interpellare Panfilo, così come fa l’at-tore che interrompe l’azione e si rivolge direttamente agli spettatori. E così sarà an-cora avanti, vv. 32-36. In effetti il dibattito ha qualcosa di teatrale, soprattutto per ilmodo con il quale Petrarca fa degli interlocutori altrettanti ‘tipi’ ben caratterizzati se-condo i loro reciproci e opposti punti di vista (vedi per ciò il ‘cappello’ introduttivo).
12. indomitos … greges: così Tibullo, II, 4, 57: «ubi indomitis gregibus Venus afflat amo-res».
14. ferox: vale per ‘severo’, ‘indomito’, ma anche, in bocca al raffinato e cinico Mi-zione, per ‘rozzo’, ‘incivile’. In Fam. XI, 6, 7, san Pietro è «sanctus ille rigidusque pi-scator» (vedi Buc. VII, 61-62).
15. saxum … gestans: sia la pietra che i chiavistelli (repagula) identificano Panfilo consan Pietro, rimandando alle famose parole di Cristo al santo: «Et ego dico tibi quia tues Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non prae-valebunt adversus eam, et tibi dabo claves regni caelorum, et quodcumque solverissuper terram erit solutum et in caelis» (Matth. 16, 18-19).
21. Furcifer hic …: questo pendaglio da forca sei proprio tu, Mizione …?! Panfilo evi-dentemente da sempre conosce il ‘tipo’ qui incarnato da Mizione, e sa ogni volta ri-conoscerlo. Onde si tratterà qui di esclamative piuttosto che di interrogative, comeinvece era sopra, nelle sue prime parole. L’insultante Furcifer ricorre nelle commediedi Plauto e Terenzio: Amph. 285 e 539; Asin. 485 e 677; Andria 618; Eun. 797 e 988(ma vedi pure Orazio, Sat. II, 7, 22), ed è amato da Petrarca: vd. AfricaVII, 1095 (Sci-pione ad Annibale); Rer. mem. II, 57, 1; Fam. XX, 13, 23 e XXII, 12, 9; postilla a Li-vio, XXII, 60, 7, nel cod. Parigino lat. 5690, f. 190r, e soprattutto la postilla a CurzioRufo, X, 1, 34, cod. Parigino lat. 5720 f. 80r: «Ah furcifer».
22. sorbet … tellus: nell’Aletheia di Claudio Mario Vittore, I, 290, la terra sorbet, ‘in-ghiotte’ i fiumi.
26-27. agni … boves: Benvenuto, in Avena, p. 217: «boni homines mortui sunt antetempus et viri fortes fatigati non habuerunt locum, sed yrci supersunt» [i buoni sonomorti prima del tempo e i forti, stancati, non hanno trovato posto, e sono i caproni a sopravvi-vere].
27-28. hircique supersunt … otia tendunt: vedi sopra, v. 1. Giustamente, François etBachmann vedono nel tendunt una forte connotazione erotica, che le feroci invettivecontro gli ozi e i lussi dei prelati della curia avignonese che sono nelle Sine nominenon possono che confermare. Gli immundi sues sono virgiliani, Georg. I, 400. Per «lu-xus et otia», vedi Claudiano, De tertio cons. Honorii 40-41: «marcida luxu / otia».
ENRICO FENZI
358
30. insultans: Virgilio, Georg. IV, 10-11: «neque oves haedique petulci / floribus insul-tent».
31. iam montes … quietem: con Benvenuto s’intenda che il puzzo è salito al cielo, con-taminandolo (in Avena, p. 217: «odor, idest infamia, venit ad aras et ad me Petrum etalios»). Si ricordi il Rifeo dantesco, che «non sofferse / da indi il puzzo più del paga-nesmo» (Par. XX 124-125). Vedi avanti, v. 115.
32-36. Haud inopina … admittere fronte: come già sopra, vv. 11-18, anche qui Mizio-ne parla tra sé e sé prima di affrontare direttamente Panfilo. Per l’espressione tacito pec-tore, vedi Ovidio, Ars I, 110; Epist. XXI, 203; Lucano I, 247; Stazio, Theb. II, 410, ecc.Per quella parcere famae (‘rispettare’), vedi Properzio, I, 16, 11; Ovidio, Am. III, 14, 36:«si dubitas famae parcere, parce mihi».
35-36. nec servi tergo … fronte: François e Bachmann segnalano la rete allusiva di que-sti versi, con i quali Mizione precisa il suo velenoso attacco a Panfilo / Pietro, ricor-dando il carattere impulsivo dell’apostolo che taglia l’orecchio al servo Malco (Joh.18, 10) e rinnega Cristo (Matth. 26, 69-75; Mc. 14, 66-72; Lc. 22, 56-62; Joh. 18, 25-27), e che, specialmente nella seconda delle sue Epistole, abbonda in esecrazioni e mi-nacce contro quei futuri falsi maestri colpevoli di ogni vizio nei quali Mizione nonpuò non sentirsi intruppato. Per un altro forte attacco di Mizione contro il suo in-terlocutore, vedi avanti, vv. 126-129.
38-45. Te forte magistro … parceret herbis: queste parole racchiudono il senso ultimodella posizione morale di Mizione: le cose sono quelle che sono e nessuno, nemme-no san Pietro, può farci nulla … Si capisce allora che sopravvivere, e sopravvivere be-ne, è il massimo che si possa fare e di cui si possa essere fieri (vedi vv. 51-56; 62 esgg., ecc.). Virgilio, Aen. VIII, 515-517: «Sub te tolerare magistro / militiam […] ad-suescat» (Orazio, Carm. III, 11, 1; Ovidio, Ex Ponto III, 3, 69). Per il topico tristis hiems,vedi Virgilio, Georg. IV, 135; Ovidio, Ars I, 409;Trist. III, 19, 9; Ibis 201, ecc. Il morbi-dus auster è l’aria malsana dell’austro, vento caldo e umido dal sud: vd. l’egl. VIII, Di-vortium, 70: «mestissimus auster» (l’intero verso manca nell’ed. Avena che però lo ri-porta in fine volume, p. 286, e in quella di François e Bachmann, che lo riportano ap. 342 nota 24, e manca del tutto nell’ed. di Canali). Vd. Gautier de Châtillon, Alex.III, 511: «seu morbidus influat aer» (ma il morbidus aer è già in Lucrezio, VI, 1097: evd. l’umbra nocens nell’egloga VIII, 71). Per la bucula, cioè la ‘giovenca’, vd. Virgilio,Georg. I, 375.
47. Nereus: si tratta di Nerone e della persecuzione da lui scatenata nel 64, dopo l’in-cendio di Roma, della quale lo stesso san Pietro fu vittima nel 67. ~ adverso in vertice:il Campidoglio, ritenuto la residenza degli imperatori, contrapposto alla parte dellacittà oltre il Tevere, nella quale il santo organizzava e governava le prime comunitàcristiane.
L’egloga di Petrarca «Pastorum pathos» (Buc. Carm.VI)
359
50. exuit … reliquit: la persecuzione ridusse i cristiani allo stremo, privandoli di tutto.Ma è dato cogliere anche un sottinteso polemico: proprio quella Chiesa primitiva,povera e oppressa aveva in sé tutte le qualità per vincere, come Panfilo orgogliosa-mente rivendica poco avanti. Vedi (ma le citazioni possibili sono molte) Sine nom. 5,6: «O hirsuti ieiunique senes! quibus laborastis! quibus agrum dominicum sevistis!quibus sata rigantes sacrum sanguinem effudistis!» [O vecchi irsuti e digiuni! Per chi ave-te lavorato! Per chi avete seminato il campo del Signore! Per chi avete versato sangue sacro perirrigare i seminati!].
51-56. Quid potius tractare … sparsere leones!: occorre intendere che Mizione, con abi-le mossa, interrompa Panfilo, per tirare sùbito l’acqua al suo mulino. È infatti chiaroche il discorso su quelle persecuzioni gli torna comodo, per insinuare una forte con-trapposizione tra quella Chiesa povera, perseguitata e senza potere e la Chiesa attua-le ricca e potente e dunque a parer suo infinitamente preferibile, e per confermarequanto ha detto già, e cioè che neppure san Pietro sarebbe stato in grado di impe-dirne le ricorrenti difficoltà, visto che proprio sotto di lui i cristiani furono mandatia morte. Nell’ultima frase l’espressione ‘mandare le membra dei buoi al mercato’ (ma-cello) la si dovrà intendere come: ‘dare adeguata sepoltura ai martiri cristiani’ (unachiosa del Marciano lat. XII 18 citata da Avena, p. 273, dà, a macello: ‘sepulture debi-te’), sì che nel complesso si direbbe: ‘né a te né ad altri è stato permesso di dare se-poltura ai martiri, perché i tiranni (lupi e leoni) hanno voluto che i loro resti fosserodispersi’. Ma potrebbe esserci tra le righe anche un’assoluzione non richiesta e abba-stanza perfida nei confronti di Panfilo, incolpevole per impotenza (‘non è stata colpatua quanto è accaduto, ma sì dei lupi e dei leoni’), assoluzione che (sarà chiaro pocoavanti) comporta un’implicita e altrettanto forte auto-celebrazione, in quanto capo diuna Chiesa che non è più pensabile di ridurre in quello stato, quali che siano i dan-ni che potrà eventualmente subire.
57. magistri: i ‘pastori’, e cioè i capi delle comunità cristiane.
58. non rauci … canes: i predicatori, benché a voce più bassa, soffocata dalle persecu-zioni, continuarono a far sentire le loro parole. Che i canes siano, nel travestimentobucolico, i predicatori è chiosa unanime degli antichi commentatori: del resto, i do-mini canes erano appunto i domenicani, cioè l’ordine dei predicatori fondato da sanDomenico nel 1216. In Virgilio, Aen. XI, 458, rauci sono i cigni; in Stazio, Theb. XI,26, gli orsi.
60. et niveas … pelles: Benvenuto, in Avena, p. 217 : «et remictebamus animas albas etpuras deo et celesti civitati» [e rimettevamo le anime candide e pure a Dio e alla città cele-ste].
61. nisi cornua dempta iuvencis: Benvenuto, in Avena, p 217: «tu nichil reportas ad deosnisi cornua, seu cappellos cardinalium qui reddunt ipsos cornutos», ma più precisa-
ENRICO FENZI
360
mente la chiosa del Marciano, in Avena, p. 273: «cornua: galeros, mitrias, seu redditusac beneficia locupletia et divitias que sunt cornua, idest superbie». Questa spiegazio-ne è accolta da François e Bachmann, che la specificano rinviando alle varie ‘voci’sotto le quali la Curia tassava pesantemente le rendite che passavano, in caso di mor-te, da un prelato all’altro. Può essere, ma ciò implica appunto che le ricchezze fosse-ro effettivamente devolute alla Chiesa di Pietro, e cioè impiegate per fini giusti e san-ti. Potrebbe dunque valere una spiegazione assai più semplice, che dica: ‘tu non mi daiche le corna degli animali sacrificati, cioè la parte non commestibile, la meno pre-giata’. Insomma, dei trofei appariscenti com’erano le corna, ma nulla di sostanziale. Edel resto, Mizione, rispondendo, confuta le parole di Panfilo proprio dicendo: «Servoaurum …». Ma è possibile anche integrare questa spiegazione con un’allusione d’al-tro tipo, che recupera l’accenno che abbiamo appena visto nella chiosa Marciana, e sibasa su Rvf 138, 10, ove della Chiesa si dice: «contra’ tuoi fondatori alzi le corna» (alsuo fondatore san Pietro la Chiesa riserverebbe dunque solo la sua superbia, dellaquale l’alzare le corna è appunto simbolo: vedi la nota di Santagata nella sua ed., p.675, e l’egl. IX, 6).
62. Servo aurum: è uno dei motivi conduttori dell’egloga. Vd. Sine nom. 10, 9 e sgg.:in Avignone /Babilonia «Una salutis spes in auro est. Auro placatur rex ferus, auro im-mane monstrum vincitur, auro salutare lorum texitur, auro durum limen ostenditur,auro vectes et saxa franguntur, auro tristis ianitor mollitur, auro celum panditur. Quidmulta? Auro Cristus venditur» [L’unica speranza di salvezza è nell’oro. Con l’oro si placail feroce sovrano; con l’oro si sconfigge l’immane mostro; con l’oro si tesse il filo della salvezza;con l’oro si mostra la dura soglia; con l’oro si spezzano sbarre e massi; con l’oro si corrompe ilvecchio portinaio; con l’oro si apre il cielo. A che molte parole? Con l’oro si fa mercato di Cri-sto]. ~ teneris … agnis: i teneri agnelli sono i fedeli, ma il verbo è poco chiaro. Si vor-rà dire che con la presente gestione della Chiesa le sue ricchezze sono in giusta pro-porzione con l’accresciuto numero dei fedeli? Oppure che proprio essi sono usati invario modo come merce di scambio a fini di arricchimento? Vedi sotto, v. 69.
63. habiles scyathos: si tratta, propriamente, di mestoli da vino (Orazio, Carm. I, 29, 8,ecc.). La grafia corretta è cyathus, e François e Bachmann pensano a un incrocio conscyphus: ‘coppa’ (Orazio, Carm. I, 27, 1; Epod. 9, 33). Gli stessi riferiscono del ricco va-sellame d’oro che Clemente VI possedeva e amava in modo particolare. Habiles valeper ‘maneggevoli’, come in Virgilio, Aen. I, 318 (h. arcum); IX, 305 (ensem h.); IX, 365(galeam h.); Tibullo, I, 9, 7 (h. aratro).
64. rudium miseretque parentum: tra i quali, va da sé, sta proprio Panfilo.
65. duce me: si contrappone al «Te forte magistro» del v. 38, ed è soprattutto pregnantenei confronti della forte partitura antitetica dell’intera egloga, che vede da una parteil ferox san Pietro e la sua rozza e primitiva e oppressa Chiesa, e dall’altra il raffinatopapa moderno e la sua Chiesa ricca, potente e coltivata. Vedi anche avanti, v. 73.
L’egloga di Petrarca «Pastorum pathos» (Buc. Carm.VI)
361
67. iaspis: diaspro, pietra dura per lo più di colore verde o ceruleo screziata di rosso(Plinio, Nat. Hist. XXXVII, 115-118). Qui sta per ‘pietra preziosa’ in generale, e in-dica la tiara pontificia. «La tiare, d’abord bonnet rond, élevé, ayant une couronne à sabase, reçut sa deuxième couronne sous le règne de Boniface VIII, sa troisième souscelui de Jean XXII. Depuis lors, elle a gardé cette triple couronne, pour désigner latriple royauté du chef de l’église catholique sur les âmes, sur les états romains, sur lerois» (François-Bachmann). Vedi vv. 160-161. Vd. sotto, nota 70, per Semiramide, cioèla contessa d’Urgel, che indossa la tiara dell’amante e ne usurpa le funzioni.
68. candida … tinxi: Sidonio Apollinare, Carm. XV, 127-128: «palla Iovis rutilat, cuiusbis coctus aeno / serica sidonius fucabat stamine murex».
69. et magnos … amicos: si tratterà in particolare del re di Francia, più volte autorizza-to a incamerare le decime «in subsidium terre sanctae», per un’eventuale e mai in-trappresa nuova crociata, e in ogni caso destinatario di grossi prestiti. In qualche ma-niera, qui si completa quanto è detto sopra, v. 62: là si alludeva, in essenza, alla politi-ca delle entrate; qui, a quella delle uscite.
70. Sponsa: la Chiesa, naturalmente. Ma c’è una probabile allusione anche all’amantedel papa, la contessa di Urgel, la Semiramide delle Sine nom. 8, 3; 10, 4 e soprattutto13, 6, ove se ne denuncia l’arroganza e il suo sostituirsi al papa stesso: «Video qua tia-ra virum mentita Semiramis frontem tegit ingenioque oculos prestringit astantium etincestis polluta complexibus viros calcat» [Vedo con quale tiara si copre la fronte Semira-mide fingendo d’essere il suo uomo, con quali astuzie abbaglia gli astanti e, contaminata da am-plessi incestuosi, calpesta gli uomini], ove sono notevoli le plurime corrispondenze conespressioni di questa egloga. Sulla contessa e sulle testimonianze antiche, specie diMatteo Villani, III 43, circa i suoi rapporti con il papa, e sui vizi e le prodigalità diquest’ultimo (tra l’altro Matteo lo dice «poco religioso»), vd. la lunga nota di P. Piural passo appena citato in Petrarcas ‘Buch ohne Namen’ und die päpstliche Kurie, Halle,Niemeyer, 1925, pp. 376-77.
71. fusca … in umbra: la spiegazione del Piendibeni (in Avena, p. 273) non soddisfa:«umbra: quia in ocio secum maneo plenus divitijs et omni excellentia», perché non dàconto dell’aggettivo, che insinua semmai l’idea di un rapporto adulterino, di qualco-sa che va tenuto nascosto. Può interessare che altrove Petrarca affermi di trovare qual-cosa di ‘fosco’ nel rapporto tra Achille e Patroclo (Fam. XIII, 10, 6: «et Achillee ne-scio quid amicitie aliquid fuscum inest»), e soprattutto che ‘fosco’ abbia connotazio-ni infernali in Buc. I, 82 (per ciò, vedi avanti, vv. 98-101). Per questo stare ‘nell’om-bra’ vedi avanti, vv. 206-207. Stazio, Theb. II, 55: «fusca […] obsitus umbra».
72. solibus usta: si ricordi la vecchia contadina di Valchiusa, e la sua «vere solis ab ar-doribus adustam faciem» (Fam. XIII, 8, 3). L’espressione, in Ovido, Her. V, 112.
ENRICO FENZI
362
73. qualis erat … tenebas: la contrapposizione (il dum rura tenebas vale un *duce te: ve-di sopra, v. 65) è di nuovo chiara. La Chiesa antica è una turpis anus, in confronto al-la ‘regina’ attuale.
74. nostra: sembra un plurale di cortesia, per un più esplicito tua.
75-77. Tum passi … versatque sues: Piendibeni (in Avena, p. 273): «edi: Cardinales la-scivi qui lasciviendo ludunt in locis eorum amplis et delectabilibus. Lascivia ex ocioprovenit et ex divitijs quia isti cardinales ita sunt divitijs et delectationibus pleni quodocio marcent et in lascivijs se commaculant, sicut sues sature se ceno volvunt» [edi: icardinali lascivi che vanno facendo giochi erotici nei loro possedimenti ampi e pieni di delizie.La lascivia deriva dall’ozio e dalle ricchezze, e questi cardinali sono talmente pieni di ricchez-ze e piaceri che marciscono nell’ozio e s’insozzano nelle lascivie, così come i grassi maiali si ri-voltano nel fango]. Vedi Virgilio, Georg. II, 526: «inter se adversis luctantur cornibus hae-di», e III, 411-412: «saepe volutabris pulsos silvestribus apros / latratu turbabis».
77-78. non humida … subit: nessun altro pastore cerca di entrare in queste umide sel-ve, per insidiare il mio potere. Si tratta dell’interpretazione tradizionale, che mi pareancora preferibile a quella data da François e Bachmann, per i quali Mizione direb-be che un pastore come lui, ormai ricco e potente (fortior) non è più costretto ad abi-tare dimore disagiate, poco confortevoli (‘umide’).
79. canens que dictat amor: Ovidio, Am. II, 1, 38 : «carmina purpureus quae mihi dic-tat Amor» (vedi anche Her. 20, 29-31); Venanzio Fortunato, Carm. IX, 6, 14: «scriben-ti mihi dictat Amor mostratque Cupido», e infine, naturalmente, Dante, Purg. XXIV52-54. ~ nec crastina curans: App. Virg., Copa 37: «pereat qui crastina curat!».
80. commissique … cerno: questo compiaciuto distacco si basa sulla certezza della sicu-rezza raggiunta (vedi avanti, vv. 102-105).
81. dente canino: comune a partire da Gerolamo (Apol. ad libr. Ruf. II, 27; Epist. 50, 1)presso i padri della Chiesa.
83. tuum … aurum: ancora la dura opposizione che governa l’egloga, qui tra ‘le no-stre spine’ (quelle di Cristo e della Chiesa primitiva), e il ‘tuo oro’.
84-85. Ut indignos … honusta suis?: è la sponsa carica di gemme (v. 70) che si avvia adessere presentata come una meretrice. Vedi per ciò v. 114.
87. turbida visa: Piendibeni interpreta questi incubi come prodotti degli stravizi ali-mentari: «Ex nimio cibo et potu repleti, stomacus anxietate emictit vapores ad cere-brum et inde somnia terribilia dormientibus emergunt» [eccessivamente pieni come sonodi cibo e bevanda, lo stomaco oppresso emette vapori che arrivano fino al cervello e procurano
L’egloga di Petrarca «Pastorum pathos» (Buc. Carm.VI)
363
sogni terribili a chi dorme] (Avena, pp. 273-74), sì che hanno qualcosa da spartire conquelli dell’occupatus, nella prima parte del De vita solitaria (Prose, p. 316). Ma è ancheopportuno sollevarsi dal piano della lettera, e intendere che Mizione ha una confusae notturna percezione dei pericoli che lo minacciano, a dispetto della sicurezza al-quanto incosciente che egli ostenta (vedi infatti poco avanti, vv. 93-97). Nella Sinenom. 1, 2, Petrarca attribuisce una buona dose di irresponsabilità anche al predecesso-re di Clemente VI, Benedetto XIII, che «sereno nimium fidit demens» [da stolto, si fi-da troppo del sereno]. Vd. per l’espressione Virgilio, Aen. V, 851 e 870.
88. causasque timendi: Ovidio, Met. IX, 557, in clausola: «tantum sit causa timendi».
92-93. Turpis … dissimulare potes: la domanda è in qualche relazione con gli incubinotturni, significando che Mizione in realtà non può non essere consapevole delle ef-fettive condizioni della Chiesa, e del suo presente degrado.
93-95. Nempe hi … etiam tibi: può ben alludere al re di Francia, che ha ormai così al-largato il suo controllo sulla Chiesa da averla sottratta al potere del pontefice.
95-96. lumina tolle … mero: questa insistenza sul vino (v. 63 e v. 88) è un topos del-l’invettiva anti-curiale (Petrarca afferma, per esempio nell’invettiva Contra eum, che icardinali non vogliono tornare a Roma per paura di non poter più essere riforniti diBorgogna), più che una personale accusa a Clemente VI. Semmai, secondo la vocecomune, avrebbe potuto essere rivolta al predecessore, Benedetto XII, che in Sinenom. 1, 3, è definito come il timoniere «vino madidus» della navicella della Chiesa.Vedi Orazio, Carm. I, 13, 10-11: «immodicae mero / rixae».
96. lupus instat ovili: le due ultime parole sono scritte su rasura, probabilmente qualeimmediata correzione di un calco meccanico da Virgilio, Aen. IX, 59: «lupus insidia-tus ovili» (De Venuto, Bonus pastor, p. 22, nota 28). Per Benvenuto come per Piendi-beni il lupus è il re di Francia (in Avena, pp. 218 e 274).
98-101. Furibus est mecum … litatum est: l’attacco alla Chiesa avignonese e al suo pa-pa è qui violentissimo, vicino alle più feroci accuse mosse alla infernale, diabolica Ba-bilonia delle Sine nomine (vd. per esempio, con Rvf 136, Sine nom. 5, 4, ove la curiaavignonese per meglio ingannare la «credula cristianorum turba» opera con l’aiuto diBelial, il diavolo di 2 Cor. 6, 15): forse anche troppo nell’equilibrio dell’egloga, beneo male impostata su un dialogo che questo patto infernale dovrebbe rendere del tut-to impossibile. Per quanto riguarda il significato puntuale, credo che esso si fondi e sispieghi attraverso la metafora del denaro quale stercus diaboli, che diventa qui ‘sanguedi porco’, e conseguentemente sull’identificazione del ‘re dell’inferno’ con Plutone,dio della ricchezza (Cicerone, De nat. deorum II, 66; Myth. I, 108, e Myth. II, 10, pp.35 e 77 Bode). Si possono aggiungere due cose: il patto, che ha comportato un esbor-so di denaro, forse allude ai rapporti con il re di Francia, allora esoso tutore del pa-
ENRICO FENZI
364
pato; il patto è gradito alle divinità sotterranee perché è ad esse che in ultima analisicompete ogni ricchezza, che viene dalla terra e alla terra ritorna, come spiega Cice-rone nel passo sopra citato. Circa la forte connotazione infernale di Avignone/Babi-lonia, vale la pena di ricordare un episodio riferito da Matteo Villani, II 48: qualcunoaveva fatto cadere, in concistoro, una lettera diretta a Clemente VI e ai suoi cardinaliscritta a nome del demonio (il ‘principe delle tenebre’), che a quelli raccomandava diinsistere in ruberie e crimini «acciò che pienamente meritassono la grazia del suo re-gno: avilendo e vituperando la vita povera e la dottrina apostolica, la quale come suoifedeli vicari ellino avieno inn-odio e ripugnavano». Tale lettera, databile tra il 1350 eil ’51, nel pieno delle scontro tra il papa e Giovanni Visconti dopo che, nell’ottobredel ’50, costui aveva esteso la sua signoria su Bologna, fu appunto ritenuta «operazio-ne dell’arcivescovo di Milano allora ribello di santa Chiesa, potentissimo tiranno», edera scritta in «alto dittato»: fantasticando, la si potrebbe immaginare opera di Petrar-ca, allora in Italia e da tempo in rappprto con i Visconti, tanto il contenuto corri-sponde ai motivi della sua polemica anti-avignonese. Senza dire che il Villani potreb-be aver raccolto una versione enfatizzata dei fatti, o averla colorata di suo, nel qual ca-so la lettera che allora circolò in curia avrebbe potuto essere una delle Sine nomine…
103. totoque … grando: vd. la grandinis ira sonore nell’egloga VIII, 70.
105. tantum … atris: conferma quel «Servo aurum» del v. 62. Per le scrobes, ‘fosse’ pre-viste da molti lavori agricoli, vd. Virgilio, Georg. II, 235, 260, 288 ecc..
106-107. iubar: normalmente è la corona luminosa del sole (ma a volte anche dellaluna), e nei testi cristiani la luce di Cristo/sole. Qui, secondo l’interpretazione cor-rente, Iubar è Lucifero cioè Venere quale stella del mattino che annuncia il sorgere delsole. Vd. in particolare Varrone, De lingua lat. VI, 2, 6, e Calcidio, Comm. in Tim. I, 71,ed. Waszink, p. 118, che ne fa tutt’uno con la luminosità dell’aurora: «primus splen-dor invehentis solis diem – hunc poetae iubar et interdum auroram cognominant»Ma che cosa rappresenti qui, stabilito che Iupiter è Dio, e Sol è il Cristo/Apollo, nonè chiaro: François e Bachmann suggeriscono, p. 322 nota 40: «Iubar, l’étoile du ma-tin, pourrait désigner la Vierge, la ‘Stella matutina’ des litanies». Ma può anche essereche l’ellittica espressione di Petrarca voglia dire che la luce medesima del giorno, alsuo primo sorgere, ebbe orrore del patto stretto nel buio abisso dell’inferno. ~ acerbarelatu: in clausola, Ovidio, Met. XV, 298: «horrenda relatu».
108-109. qui pastor … perages feliciter: fallirai, cioè, sia come pastore di anime che co-me affarista senza scrupoli.
109-111. Aude linquere … tentare procellas: si riferisce all’abbandono di Roma (le sil-vae) da parte del papato, ora sradicato dalla sua sede naturale e gettato tra le tempestedel mondo, mettendo a rischio la sua stessa sopravvivenza. Topica l’espressione pande-re vela (Properzio, II, 21, 14; Ovidio, Ars III, 500); per le ‘tumide procelle’, vedi Sta-
L’egloga di Petrarca «Pastorum pathos» (Buc. Carm.VI)
365
zio, Achill. I, 658: «in tumidas ibunt haec versa procellas»; Claudiano, In Eutropium II,6: «tumidae subducit vela procellae»; Ennodio, Carm. I, 7, 33: «ad tumidas rapitur meacumba procellas».
112-113. uxor enim … egressa pudicum: la cattività avignonese non è naturalmente co-sa che interessi solo la persona del papa, ma la Chiesa tutt’intera (uxor), trascinata fuo-ri dal ‘talamo’ legittimo a vagare e a prostituirsi per gli ‘ignoti colli’ del sud della Fran-cia. Virgilio, Ecl. VI, 52: «A! virgo infelix, tu nunc in montibus erras» (il patrium limenin App. virg., Ciris 216, e Prudenzio, Contra Symm. II, 736).
114. meretrix famosa: deriva dal famoso passo dell’Apocalisse 17, 1-5, nel quale si tro-vano concentrati gli elementi più importanti che compongono il quadro petrarche-sco di Avignone / Babilonia e, in essa, della corruzione della Chiesa: «Veni ostendamtibi damnationem meretricis magne, quae sedet super aquas multas, cum qua forni-cati sunt reges terrae et inebriati sunt qui inhabitant terram de vino prostitutionis eius[…] Et vidi mulierem sedentem super bestiam coccineam, plena nominibus blasphe-miae, habentem capita septem et cornua decem. Et mulier erat circumdata purpuraet coccino et inaurata auro et lapide pretioso et margaritis, habens poculum aureumin manu sua plenum abominatione et immunditia fornicationis eius; et in fronte eiusnomen scriptum mysterium, Babylon magna, mater fornicationum et abominatio-num terrae» [“Orsù, voglio mostrarti il castigo della grande meretrice che sta assisa su acquecopiose; con essa i re della terra hanno fornicato e col vino della sua prostituzione si sono ine-briati gli abitanti della terra”… vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta, piena di no-mi blasfemi, con sette teste e dieci corna. La donna era vestita di porpora e di scarlatto, tuttaadorna di gioielli d’oro, pietre preziose e perle; teneva in mano una coppa d’oro ricolma di abo-minazioni e impurità della sua prostituzione. Sulla fronte portava scritto un nome simbolico:“la grande Babilonia, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra”: trad. A. Lan-cellotti, Milano, Ed. Paoline, 1987]. Occorre anche ricordare come di qui deriva an-che l’immagine della «puttana sciolta» che rappresenta la Curia, nella complessa rap-presentazione dantesca al sommo del Purgatorio (Purg. XXXII, 148-160). In Petrar-ca, si veda soprattutto come torni la citazione biblica e sia sviluppata, come qui, con-tro Avignone / Babilonia «famosa dicam an infamis meretrix», nella Sine nom. 18, inparticolare 12 e sgg..
114-116. procosque … grata paludis: Benvenuto, in Avena, p. 218: «meretrix famosa du-cet secum procos et amatores, seu cardinales vitiosos et sic yrcos fetentes quia iam pla-cet mansio Avinionis» [la famosa meretrice trascina con sé proci e amanti, cioè quei capronipuzzolenti che sono i cardinali viziosi ai quali piace restare in Avignone]. La ‘palude stranie-ra’ è appunto la detestata Avignone, ‘ripa palustre’ anche nell’egloga VIII, 86, con sco-perta allusione alle paludi formate dalla ‘torbida’ corrente del Rodano e alla pessimaaria che, secondo Petrarca, vi si respira: «Illic enim ventosissimi amnis ad ripam – ubiscilicet et cum vento male vivitur et sine vento pessime viveretur» (Sen. VII, 1, 173:ed. Rizzo, p. 242). Circa gli olentes hircos, si ricordi il vecchio cardinale della Sine nom.
ENRICO FENZI
366
18, 31: «Hircina libido homini inerat vel si quid libidinosius atque olentius hirco est»[Quell’uomo aveva la libidine d’un caprone, e anche di quanto c’è di più libidinoso e puzzo-lente d’un caprone]. Aviano, Fab. 13, 12: «hircus olens».
117. obscuris … imples: Ovidio, Fast. IV, 261: «obscurae sortis patres ambagibus errant».
119. alacres incessere verbis: vd. Ovidio, Met. XIII, 232 : «ausus erat reges incessere dic-tis».
122. Supplicium breve!: Panfilo si corregge. Forse anche perché quanto ha già detto:«post vincla crucem, post verbera ferrum», assomiglia troppo al supplizio di Cristo.
126-129. Vulgata … terga iuberet: già sopra Mizione aveva richiamato l’infedeltà diPanfilo / Pietro che aveva rinnegato Cristo (vv. 35-36). Ora è più esplicito, e ricor-da un episodio ulteriore: Pietro, incarcerato da Nerone, sarebbe infatti fuggito di pri-gione, e uscendo di città avrebbe incontrato Gesù. Il racconto è nella Legenda aurea,LXXXIV, De sancto Petro apostolo (ed. Maggioni, pp. 567-68): «Et cum venisset ad por-tam […] ad locum ubi nunc dicitur sancta Maria ad passus vidit Christum sibi oc-currentem et ait: “Domine, quo vadis?” Qui respondit: “Venio Romam iterum cru-cifigi”. Cui Petrus: “Domine, iterum crucifigeris?”. Cui dominus: “Etiam”. Petrus ve-ro ait: “Ergo, domine, revertar ut tecum crucifigar”. His dictis dominus vidente Petroet lacrimante in celum ascendit. Quod dum de sua passione dictum intelligeret re-diit» [Arrivando alla porta […], nel luogo che ora è detto di santa Maria ai passi, vide Cristoche gli veniva incontro, e disse: ‘Signore, dove vai?’. Il Signore gli rispose: ‘Vengo a Roma peressere crocifisso di nuovo’. E Pietro: ‘Signore, sarai crocifisso un’altra volta?’. ‘Sì, ancora’. Allo-ra Pietro disse: ‘Signore, tornerò indietro per essere crocifisso con te’. Avendo detto ciò, Cristo sa-lì al cielo sotto gli occhi di Pietro che piangeva e che, avendo compreso che quelle parole si rife-rivano alla sua propria passione, tornò]. Merita anche riferire il seguito. Pietro, condan-nato, impose ai suoi carnefici d’essere crocifisso a testa all’ingiù, dicendo: «Quoniamdominus meus de celo ad terram descendit, recta cruce sublimatus est; me autemquem de terra ad celum revocare dignatur, crux mea caput meum in terra debetostendere et pedes ad celum dirigere. Ergo quia non sum dignus ita in cruce esse utdominus meus, crucem meam girate» [Poiché il mio Signore scese dal cielo alla terra fu in-nalzato su una croce diritta. Poiché io, invece, sono stato ritenuto degno di essere richiamato dal-la terra al cielo, la mia croce deve volgere la mia testa verso terra e dirigere i miei piedi al cielo.Dunque, poiché non sono degno di essere crocifisso come il mio Signore, capovolgete la mia cro-ce]. Al v. 128 si noti ancora Apollo, per Gesù (vedi sopra, v. 9, e Buc. I, 66). E vedi Lu-cano, IX, 622: «vulgata per orbem / fabula». A commento delle due opposte men-zioni di Cristo/Apollo, scrive Béatrice Charlet-Mesdjian, Apollon dans le Bucolicumcarmen, «Studi umanistici piceni», XXV, 2005, pp. 138-39, che nella prima è da os-servare «l’adjectif possessif de la première personne du pluriel qui présente la foi enJésus comme profonde et partagée avec tous les Chrétiens», mentre tutt’al contrario«Mitio au lieu de présenter cette rencontre de saint Pierre avec le Christ de manière
L’egloga di Petrarca «Pastorum pathos» (Buc. Carm.VI)
367
positive […] fait de saint Pierre un couard qui rebrousse chemin sous l’ordre et lacontrainte d’un tristis Apollo. Cette interprétation radicalement différente du martyreest mise en évidence par l’identité des places et des constructions utilisées par les deuxinterlocuteurs. Pour Pamphile, le martyre conduit tout droit au ciel; pour Mitio, ilaboutit au contraire à l’impasse d’une mort sinistre».
131. deserte … caule: il gregge dei fedeli, che Pietro avrebbe abbandonato. Le caulaesono i recinti per le pecore, e, per estensione, le pecore stesse (vedi Virgilio, Aen. IX,60, e De remediis II, praef. 5).
132. pastoris iniqui: Nereo / Nerone. Vd. già sopra, v. 47. Il motivo svolto in questiversi (‘io, Pietro, avevo almeno qualche buon motivo nel voler fuggire da Roma, maquale timore ha costretto te, papa, a lasciare Roma per Avignone’) è ripreso con mag-giore ampiezza nella lunghissima Sen. VII, 1 diretta a Urbano V nel 1366, § 330: «Ego[…] iusto metu crudelissimi Neroni fugiens», ecc.
135-136. claustra quieta … quercus […] avitas: la sede romana, come già le selve (v. 110)e il patrium limen (v. 113).
137. claves: le chiavi di Pietro, i repagula del v. 15 (vd).
138-139. per menia … reverti: Benvenuto, in Avena, p. 219: se rinunci alle chiavi «tuncnos habebimus alium papam qui coget populum, vagantem per diversa loca, revertisub tecta» [avremo allora un altro papa che costringerà il suo popolo, che ora vaga in luoghi di-versi, a tornare sotto il suo tetto]. In questo ‘errare’ del popolo dei fedeli François e Bach-mann vedono, credo giustamente, un’allusione alle divisioni che allora tormentavanola cristianità e che avevano portato nel 1328, per esempio, all’elezione dell’antipapaNiccolò V. Vedi Sine nom. 19, 8: «Quis colliget sparsas oves? Quis pastores erroneosarguet? Quis reducet aut retrahet in sedem suam» [Chi raccoglierà le greggi disperse? Chidenuncerà i pastori che hanno perso la via? Chi li riporterà o li trascinerà nella loro casa?].
140. Iam michi magna placent: da questo punto, la soddisfatta sfrontatezza di Mizionefa un ulteriore passo in avanti.
141. cantando: anche il procacciatore di giovani donne per i prelati avignonesi canta-va, come riferisce Petrarca che l’ha visto e conosciuto. Vedi Sine nom. 18, 32-3.
142. solemque perosus: come pure la ‘sposa’, v. 72. È significativo, quest’odio verso il so-le, quando si ricordi l’equazione Cristo / Apollo (vedi già, qui, vv. 9 e 128). Del re-sto, già lo segnalava il Piendibeni: «solemque: Cristi».
143. antra umbrosa: vedi già v. 71: «fusca […] in umbra».
ENRICO FENZI
368
144-145. Speculum … dono dedit: con i commentatori antichi, qui si parla di Costan-tino (Coridon, come il protagonista delle egloghe II e VII di Virgilio) che nel 326, tra-sferendo la sua capitale a Costantinopoli (onde bizantius) avrebbe dato alla Chiesa ein particolare a papa Silvestro il possesso sull’occidente cristiano. In realtà il famosoatto di donazione è un falso dell’VIII° secolo, come dimostrato da Lorenzo Valla nel‘400. Questi versi si chiariscono poco avanti, vv. 157-159, ove i mala dona corrispon-dono appunto allo speculum. Dante, si sa, credeva alla verità della donazione, che con-dannava come la principale causa di corruzione e decadenza della Chiesa e della so-cietà del suo tempo, e sulla stessa linea parrebbe essere anche Petrarca: al proposito, siveda l’oscura chiusa di Rvf 138, 13-14 (con le note relative di Santagata, pp. 675-76).
145-147. omnia novit … dura fero: vuol dire che c’è perfetto accordo tra lui e gli altiprelati di Curia nel tollerare le reciproche malefatte.
148. foveat complexibus: per l’espressione, vedi Virgilio, Aen. IV, 686 e VIII, 388; Luca-no, V, 735. ~ Epy: ancora la Chiesa, materialmente identificata nella Curia (sarà unodegli interlocutori dell’egloga seguente). Benvenuto scrive (in Avena, p. 219): «meaepycuria, seu ecclesia (sicut Epicurus qui posuit voluptatem et felicitatem in gauden-do) gaudeat mecum», aiutandoci a vedere il gioco di Petrarca, che fa di curia il sot-tinteso complemento di Epy(curia).
150. Epycus ille: per Benvenuto e Piendibeni si tratterebbe di papa Bonifacio VIII, ilsecondo con un troppo banale: «Bonifatius papa qui voluptuose vixit», e il primo conun più acuto spunto interpretativo, che si volge al fatto che egli avrebbe ottenuto ilpapato «cum dolo et fraude», e che «ille predicavit per urbes quantum sponsa eccle-sia est nobilis et gloriata est, quantus nobilis sponsa esset sibi» (in Avena, rispettiva-mente pp. 219 e 275). Con tutto ciò, mi pare che abbiano ragione François e Bach-mann nel pensare piuttosto a Clemente V, il papa che per primo, nell’inverno del1309, stabilì la propria sede in Avignone, e che a lui meglio si adatti quanto è subitoappresso detto (ma vedi vv. 154-155).
150-151. profanos lapsus in amplexos: caduto, cioè, nel fatale abbraccio di Filippo il Bel-lo, che nel 1308 aveva imposto al nuovo papa il trasferimento in Francia (onde la scel-ta di Avignone, nel piccolo contado Venassino ch’era formalmente di proprietà dellaChiesa e sotto il dominio dell’Impero, rappresentava una soluzione di compromesso).
152-153. prior ipse … ortos: l’allusione al trasferimento della Curia si fa ancora piùchiara con gli irriguos hortos (vedi Orazio, Sat. II, 4, 16) che verisimilmente s’appaia-no all’erba della straniera palude di cui al v. 116.
154-155. iacentem … sepulcrum: questo postumo oltraggio ignora quanto riferisce Gio-vanni Villani, che giudica Clemente V, morto il 20 aprile 1314, «uomo molto cupido dimoneta e simoniaco, che ogni benificio per danari s’avea in sua corte, e fu lussurioso»,
L’egloga di Petrarca «Pastorum pathos» (Buc. Carm.VI)
369
lo accusa di necromanzia e riferisce che «morto lui, lasciato la notte un una chiesa congrande luminara, s’accese e arse la cassa, e ‘l corpo suo da la cintola in giù» (X, 59, 2).Né so se si possa dire, come fanno François e Bachmann rinviando appunto a Villani,che la versione di Petrarca «est la transposition ‘rustique’ de la réalité historique ou, àtout le moins, de récits à demi légendaires concernant ce pontife».
157-159. speculum Coridonis … mala dona: riprende l’accenno di Mizione alla dona-zione di Costantino (vv. 144-145). Mala dona è in Catullo, LXVI, 85.
160-161. capiti circumdas … pondus avis: proprio perché ignote agli avi, le ghirlande dicui Mizione /Clemente VI si incorona possono essere la traduzione bucolica della tia-ra pontificia, recentemente arricchita della terza corona da Giovanni XXII (vedi so-pra, v. 67).
162. rosis silvestribus: «Peut-être est-ce une allusion à Clément VI fils du seigneur deRosières et qui portait dans son blason un écu chargé de six roses. Il déclarait à sesfamiliers: “J’ai planté dans l’Eglise un rosier qui fleurira longtemps”. D’ailleurs il allajusqu’à faire paraître sur le sceau pontifica les roses de son blason» (François-Bach-mann).
166-169. Succedet michi … in pascua sordes: Clemente VI muore il 6 dicembre 1352, eil 18 il francese Stefano Aubert è eletto papa, con il nome di Innocenzo VI (ma vediper questi versi, quasi certamente inseriti post eventum, il cappello introduttivo). In ve-rità Innocenzo VI ebbe fama di papa ‘duro e giusto’ e se non tornò a Roma lavoròtuttavia, attraverso le missioni dell’Albornoz, affinché tale ritorno diventasse possibi-le. Benvenuto significativamente annota: «loquitur de papa Innocentio qui recte fuitcontrarius ipsius Clementis et fuit optimus», e così Piendibeni: «intelligendum est depapa Innocentio, qui fuit sancte et laudabilis vite et symoniam et scelera fugavit etnunquam beneficia dabat nisi probate vite hominibus et benemeritis» [s’intenda papaInnocenzo, che fu di santa e lodevole vita, eliminò simonia e delitti, e mai concedeva benefici senon a uomini di provata virtù e che avessero ben meritato] (in Avena, pp. 219 e 275: vedianche la nota che segue).
168. mitia … facta: i comportamenti dei cardinali, che Mizione giudica con tanta in-dulgenza. ~ preduris … repulsis: qui Mizione sembra dar voce alle proteste dei cardi-nali dinanzi alle severe reprimende di Innocenzo VI. Piendibeni nota: «repulsis: quiarepellet severitate sua dona et beneficia impetrantes» [perché allontanava con severitàquelli che gli sollecitavano doni e benefici].
169. alvernas … sordes: per Mizione, di nuovo, la severità del nuovo papa, avverso ailussi e alle pompe del predecessore, appare come sordes, e cioè come meschinità, gret-tezza, miseria provinciali (Innocenzo VI non era però alverniate, ma limosino, diBeyssac).
ENRICO FENZI
370
170-174. Quem talem … ad umbram: vedi ancora il cappello introduttivo, per questarisposta di Panfilo che non corrisponde alle parole di Mizione. I commentatori anti-chi recano tracce di questa contraddizione, e tacciono di questi versi.
176. nescio quid … servent: dichiarazione di incredulità. Perfetto il Piendibeni: «somnia:gloria celestis; quia scio quid in hac vita habeo, nescio de tua celesti» [‘somnia’: la bea-titudine celeste; infatti, so che cosa ho in questa vita, ma della tua celeste non so nulla] (Ave-na, p. 275).
177-178. bonus … herus: Cristo, nella veste del ‘buon pastore’ (vedi la parabola dellapecorella smarrita è in Lc 15, 1-7, e vedi anche Joh. 10, 11-15 e 26-29). In questi ver-si e nella ripresa che ne fa poco avanti Mizione, vv. 184 e sgg., Petrarca trae e dispo-ne diversamente alcune tessere da Prudenzio, Cathem. VIII, 33-48 (il vello adfixis ve-pribus, l’inpiger pastor, le lappole...).
180. sublimi … Olimpo: dall’alto dei cieli.
184. Immemor ille sui …: Mizione si lancia in una finale ed efficace parodia della mo-rale evangelica, con un sospetto di divertimento da parte di Petrarca nello stare al gio-co. Nell’espressione latina si intrecciano due interpretazioni: quella a testo, preferitadagli editori francesi, che allude all’onnipotenza divina che Cristo avrebbe dimenti-cato d’avere, e quella, altrettanto ammissibile, che vale ‘non si cura di sé, della sua sor-te terrena’, e allude al suo sacrificio. Dato che qui parla Mizione che poco avanti, v.199, in palese contrapposizione rispetto a Cristo, rivendica con orgoglio di essere ilpastore di un ‘potente signore’, preferisco anch’io la prima, più in linea con la logicadel personaggio. Ma la speciale finezza di Petrarca sta nel far sì che Mizione, del tut-to inconsapevolmente, finisca per dire qualcosa di diverso e perfettamente vero, e cioèche Cristo, ‘immemore’ di se stesso, s’è sacrificato per l’umanità. Una siffatta ironia èancora più evidente avanti, vv. 197-198, là dove gli assurdi conportamenti e insegna-menti di Gesù escludono, agli occhi di Mizione, ch’egli sia davvero un uomo …
185. perdere … multa: s’intenda che Cristo ha paura di perdere il poco, quando in real-tà avrebbe la possibilità di ‘perdere’ molto, e cioè di dispensare con magnificenza sen-za rischiare nulla, se sfruttasse meglio il suo infinito potere, come Mizione implicita-mente suggerisce (ecco perché – diciamo la verità – è avaro …). Questo pensiero sichiarisce con il rimando a quanto ancora Mizione dichiara avanti, v. 200: perdere, ecioè spendere, dissipare a piene mani, è ‘magnifico’! (onde ora si comprende meglio,per contro, l’elogio che Panfilo ha fatto dell’accorta amministrazione, lo studium pe-culi, v. 165). Cristo, insomma, ‘perde’ due volte: perde tutto ciò che sarebbe in gradodi avere e a cui rinuncia, e perde anche il gusto magnifico di dispensarlo che, nellalogica di Mizione, dovrebbe essere naturale in un vero signore.
186. horrisonis … vocibus: in Claudiano, In Rufinum I, 86: «horrisonis […] dictis».
L’egloga di Petrarca «Pastorum pathos» (Buc. Carm.VI)
371
187-188. semperque … oves: in questi versi è uno degli agganci più evidenti con l’e-gloga che segue, Grex infectus.
189. hircos: vedi vv. 1, 75-77 e 114-116.
193. atque intonat ore: così, a fine verso, Virgilio, Aen. VI, 607. Nella tarda Fam. XXIII,19, 14-17, al Boccaccio (28 ottobre 1366) Petrarca racconta che aveva rimproveratoGiovanni Malpaghini di usare troppo spesso calchi virgiliani nei suoi versi, e che co-stui s’era difeso con l’esempio del maestro, al quale aveva recitato proprio questo ver-so. Al che, dice ancora Petrarca: «Obstupui; sensi enim, illo loquente, quod me scri-bente non senserem, finem esse virgiliani versus sexto divini operis» [Ci rimasi male.Mi accorsi infatti mentre egli parlava di ciò di cui non m’ero accorto quando scrivevo: che si trat-tava della fine di un verso di Virgilio nel sesto libro della sua opera divina]. E aggiunge cheavrebbe voluto correggerlo, ma l’opera era ormai conosciuta da troppo tempo perpoterlo fare. Questo episodio è stato attentamente analizzato da Guido Martellotti,Scritti petrarcheschi, a cura di M. Feo e S. Rizzo, Padova, Antenore, 1983, pp. 510-15,che non crede però (giustamente, direi) alla buona fede di Petrarca, e crede inveceche quella citazione virgiliana fosse voluta per arricchire il suo testo di una allusionesignificativa. In Virgilio, infatti, l’espressione è attribuita alla maxima Furiarum che vi-gila affinché i dannati non tocchino i letti dorati e le mense imbandite davanti ai lo-ro occhi, mentre nell’egloga questa stessa funzione è attribuita all’avaro (v. 184) Cri-sto, particolarmente odioso nel voler obbligare il suo gregge alla fame e alla sete.
195. montes … iniquos: Ovidio, Met. X, 172: «per iuga montis iniqui».
196. et pedibus nudis … acutos: anche nel primo dei tre sonetti anti-avignonesi, Rvf136, 12-13, della Chiesa: «Già non fostù nudrita in piume al rezzo, / ma nuda al ven-to, et scalza fra gli stecchi».
197-198. Moribus his … dixerit: per una via tutta sua l’incredulo Mizione arriva para-dossalmente a insinuare la divinità di Cristo, che come uomo gli riesce del tutto in-comprensibile.
199. domino … potenti: l’oro (e dunque, in ultima analisi, il diavolo).
200. multis placuisse decorum: altrettanto sentenziosamente, Orazio, Epist. II, 17, 35:«principibus placuisse viris non ultima laus est».
201-202. Vis ubi … gramina morsu: ripete il concetto già espresso sopra, vv. 102-105,con una piccola concessione al rischio di carestia che la guerra e la violenza in ge-nere potrebbero procurare.
203. lascivos … greges: Orazio, Carm. III, 13, 8: «lascivi suboles gregis».
ENRICO FENZI
372
204. simul ipse iocabor: ripropone l’idea di una reciproca generale complicità, sulla qua-le tutta la politica di Mizione si basa.
208. prevertens gaudia luctu: Claudiano, Depr. Ad Hadrianum (Carm. min. XXII) 32: «li-vor et ingesto turbavit gaudia luctu»; Draconzio, Laud. Dei III, 378: «publica funereoturbantur gaudia luctu».
209-210. Men verbis terrere … terrent: l’ultima parola è di Mizione che nell’egloga chesegue, vv. 11-13, si vanterà con Epy di questo suo atteggiamento coraggioso. Certoegli dà mostra di una coerenza che ha forse suscitato qualche imbarazzo, visto che icommentatori antichi si fermano alla definitiva e conclusiva minaccia di Panfilo, cheoffre un adeguato sigillo morale all’egloga. E in effetti, da questo punto di vista, Mi-zione torna a complicare le cose, sì che l’egloga ha un finale aperto che giustifica ilsuo prolungamento nella successiva. L’espressione verbis terrere è in Corippo, Johann.150: «Romanos potuit verbis terrere superbis».
L’egloga di Petrarca «Pastorum pathos» (Buc. Carm.VI)
373