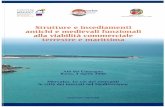Surveys sul monte Castelluccio di Racalmuto (AG). Dati preliminari, in M. Congiu, C. Miccichè, S....
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Surveys sul monte Castelluccio di Racalmuto (AG). Dati preliminari, in M. Congiu, C. Miccichè, S....
V Convegno di Studi EIS AKRA. Insediamenti d’altura in Sicilia dalla Preistoria al III sec. a.C.Caltanissetta, 10 –11 maggio 2008
Organizzato da SiciliAntica, sede di Caltanissetta, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta
Con il patrocinio di: Provincia di Caltanissetta, Assessorato alla Cultura Città di Caltanissetta, Assessorato all'Identità e Futuro
Con il contributo di: Banca di Credito Cooperativo "San Michele" di Caltanissetta e Pietraperzia AXA Assicurazioni e Investimenti, Agenzia di Caltanissetta Zirilli, Caltanissetta
Comitato organizzatore: Simona Modeo, Luigi Santagati, Marina Congiu, Calogero Miccichè, Massimo Arnone, Patrizio Di Benedetto
Redazione atti: Marina Congiu, Calogero Miccichè, Simona Modeo
Segreteria organizzativa: Massimo Arnone, Calogero Miccichè,Simona Modeo, Luigi Santagati
EIS AKRAInsediamenti d’altura in Siciliadalla Preistoria al III sec. a.C.
Atti del V Convegno di studi
a cura diMarina Congiu
Calogero MiccichèSimona Modeo
SALVATORE SCIASCIA EDITORE
SiciliAnticasede di Caltanissetta
PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA©
Copyright 2009 by Salvatore Sciascia Editore s.a.s.Caltanissetta-Roma
ISBN 978-88-8241-310-1
Stampato in Italia / Printed in Italy
In copertina e in quarta:dalla Necropoli Est di Polizzello. Deposizione 7, esterna alla tomba 5Modellini fittili di capanna (VII sec. a.C.)Riproduzione su concessione dell’Assessorato BB.CC.AA. e P.I. della Regione Siciliana. È fattoespresso divieto di ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo senza preventiva formale autoriz-zazione.
SSuurrvveeyyss sul monte Castelluccio di Racalmuto (AG):dati preliminari
di Simona Modeo e Angelo Cutaia*
Il Monte Castelluccio si trova a circa 7 km da Racalmuto e si eleva a 720 ms.l.m. Alle sue pendici meridionali si incontrano le valli dei fiumi Platani, Na-ro ed Akràgas. Il monte è delimitato ad Ovest dal Rio Pantanelle, affluente delPlatani ed a Est dal Fiumicello di Gibellina che confluisce nel Gallo d’Oro1.Originatosi nel periodo Gessoso-Solfifero, esso ricade geologicamente al cen-tro del bacino della Sicilia centro-meridionale, meglio noto come “Fossa diCaltanissetta”, il vasto areale di lago salato che evaporando per centinaia di mi-gliaia di anni ha depositato il sale (salina Pantanelle) e il gesso (masso gipseo diFra Décu e Luggiatu) che ha originato lo zolfo (zolfare Botte, Piano di Corsa,Gibillini e Falcone). Le prospezioni archeologiche hanno interessato non so-lo l’area sommitale del monte, ma anche alcune contrade viciniori e altre sitesia nel versante settentrionale sia in quello meridionale della montagna (fig. 1).Durante i surveys sono state individuate numerose tombe a grotticella artificia-le, la cui distribuzione nel territorio è stata indicata sulla carta IGM (fig. 2).
Sulla sommità del monte sorge un piccolo, ma solido forte rettangolare sal-damente attaccato allo sperone di roccia: il Castelluccio.2 La fortezza agevol-mente raggiungibile, controllava quasi tutte le vie di comunicazione che, attra-verso l’altopiano di Racalmuto, portavano al bacino del Platani e alle zone del-l’interno (fig. 3) e fu probabilmente edificata in età sveva a partire dal 1229. Inun secondo momento il fortino pervenne prima nelle mani della potente fami-glia Chiaramonte signori, fra l’altro, di Agrigento e di Racalmuto e poi venneassegnato, unitamente al feudo di Gibellini, a Guglielmo Raimondo Moncadaconte di Caltanissetta. Successivamente passò da una famiglia all’altra di nobi-li siciliani: De Marinis, Grimaldi, Trigona.
Dopo essere stato lasciato in stato di abbandono per lungo tempo, nel 2001l’edificio è stato acquistato da un privato che ha eseguito alcuni interventi direstauro sia all’interno sia all’esterno del forte.
Durante i lavori, sono venute alla luce tracce di strutture molto più antichea pianta sub-circolare, presumibilmente pertinenti ad un villaggio di capannee individuate nell’area esterna del Castelluccio (fig. 4). Le ricognizioni di super-
227
* Archeologa - Ingegnere1 Cutaia 2000, p.13.2 Cutaia 2000, p. 48.
ficie effettuate dopo tale scoperta, hanno portato al rinvenimento di alcuniframmenti ceramici e di un ciottolo di fiume che presenta segni di martella-mento e tracce di ocra rossa (fig. 5 a). Lungo il costone di roccia che delimital’area del Castelluccio si trovano numerose tombe a grotticella artificiale, chepotrebbero essere state utilizzate dagli abitanti del villaggio capannicolo ubica-to sulla sommità del monte (fig. 6). Tra i frammenti ceramici rinvenuti, l’unicoleggibile è a decorazione dipinta e sembra appartenere alla facies di Serraferlic-chio (eneolitico medio) (fig. 5 b).
Tale facies, caratterizzata da un’apparente uniformità culturale, attestatadalle produzioni ceramiche, in seno alle quali di gran lunga più diffuse sonoquelle a superfici coperte da colore rosso con decorazione geometrica in neroo bruno opaco, è del resto ben documentata in altri insediamenti del territorioagrigentino e lo stesso sito eponimo della facies si trova, in linea d’aria, a pochichilometri da Monte Castelluccio.3
Sul versante meridionale della montagna, in contrada Cienzu – Monumen-ti (fig. 7), sono stati individuati resti di strutture murarie, frammenti di pithoi,di tegole (fig. 8) e la base in pietra calcarea di un palmento, probabilmente per-tinenti ad un insediamento rurale in cui avveniva la trasformazione dei prodot-ti agricoli e per il quale si è trovato un confronto con il centro indigeno di Mon-te Adranone (VI-III secolo a.C.)4 (figg. 9-10 e figg. 11-12). I pochi dati in no-stro possesso non consentono comunque al momento di inquadrare cronolo-gicamente il sito.
Sul versante settentrionale del monte, in contrada Gargiláta, a Nord-Estdell’attuale centro abitato, si trovano la grotta di Fra Décu, prodotta dal carsi-smo del masso gipseo, che prende il nome dall’omonimo frate che vi trovò ri-fugio durante le persecuzioni della Santa Inquisizione, e una necropoli rupe-stre5 (fig. 13). All’interno della grotta si sono potuti raccogliere, in superficie,numerosi frammenti ceramici a decorazione dipinta che sono assegnabili allafacies di Serraferlicchio (eneolitico medio – metà del III millennio a.C.) e di Ca-stelluccio iniziale (fine del III millennio a.C.) e sembrano quindi documentareuna frequentazione della grotta stessa fin dall’eneolitico e ancora nell’antica etàdel bronzo (fig. 14). Interessante è poi il frammento acromo con motivo cor-donato a rilievo con serie di fossette, forse pertinente alla facies del Kronio(neolitico iniziale)6 (fig. 15); l’industria litica è, al momento, attestata soltantodal ritrovamento di un grattatoio in selce (fig. 16). Sulla base dei materiali rin-venuti all’interno, si possono avanzare due ipotesi: 1) la grotta di Fra Décu po-trebbe essere parte integrante della necropoli rupestre; 2) la grotta potrebbe
228
Simona Modeo e Angelo Cutaia
3 Arias 1938.4 Fiorentini 1995.5 Cutaia 2000, pp. 28-29.6 Sulla facies del Kronio cfr. Tiné 1971, pp. 75 e ss.; Maggi 1976-1977, pp. 510 e ss.; Traver-
so 2006.
celare un insediamento attestante vari periodi di frequentazione. A sostegno dientrambe le ipotesi si possono citare alcuni casi analoghi: quello di grotta Tic-chiara7 e di grotta Zubbia8, per rimanere in territorio agrigentino, della grottadella Chiusazza9 nel siracusano o, ancora, di grotta del Vecchiuzzo10 e di grot-ta della Chiusilla11 sulle Madonie. Per quanto riguarda la necropoli rupestre,essa è costituita da tombe a grotticella artificiale con ingresso rettangolare che,in alcuni casi, presenta un riquadro con doppi stipiti chiuso da un portello li-tico. La camera è a pianta circolare o sub-circolare, con volta emisferica; si trat-ta per lo più di tombe polisome e quindi destinate a più inumati, sepolti siacontemporaneamente sia in momenti successivi.
Le sepolture presenti nel costone roccioso di Fra Décu sono state ritrovateprive di corredo poiché violate in antico. Al momento dunque non è possibiledatare le tombe, e anche se la loro tipologia architettonica sembra richiamaresoprattutto quella delle necropoli castellucciane dell’Isola12, alcune di esse po-trebbero essere state utilizzate già in età eneolitica.
Alle sepolture, disposte una accanto all’altra, si giunge attraverso un sentie-ro scavato nella roccia che potrebbe essere interpretato come una sorta di viasacra.
A giudicare dalla conformazione geologica della roccia gipsea, non è daescludere che la concrezione nasconda nuove sepolture ancora integre, mentrele altre, anche se aperte, presentano un notevole interro la cui indagine potreb-be dare interessanti risultati.
La necropoli di Fra Décu rappresenta una vasta area cimiteriale che confer-ma la presenza di un importante insediamento che potrebbe essere proprioquello della grotta oppure un altro da ricercare comunque nelle vicinanze, da-ta la presenza di corsi d’acqua e delle poco distanti miniere di zolfo di Gibilli-ni (fig. 17). L’estrazione di questo minerale e la sua riduzione in pani nella prei-storia sono confermate dagli scavi di Monte Grande presso Palma di Monte-chiaro13.
Mentre la parte più alta del costone roccioso è occupata da tombe di etàpreistorica, alla base della parete si trovano, invece, alcune tombe ad arcosoliodi epoca bizantina.
229
Surveys sul monte Castelluccio di Racalmuto
7 Si vedano al riguardo Tiné 1960-1961, pp.125-126 e Castellana 1997.8 Tiné 1960-1961, pp. 113 e ss.9 Si veda al riguardo Tiné 1965.10 Per la grotta del Vecchiuzzo cfr. Mingazzini 1931 e Bovio Marconi 1979.11 Si vedano al riguardo Bovio Marconi 1944 e G. Mannino in Tusa 1997, p. 312.12 Oltre alla necropoli del sito eponimo della facies (Orsi 1892), sono stati identificati, attra-
verso le ricerche di P. Orsi e di altri studiosi, numerosi complessi tombali assegnabili all’orizzon-te castellucciano, soprattutto nella cuspide sud-orientale della Sicilia e in alcuni siti dell’area cen-tro-meridionale dell’Isola. Per la bibliografia sulla facies castellucciana cfr. Tusa 1983; Castellana2002; per la Sicilia centro-meridionale si veda anche Panvini 1998; Ead. 2000; Ead. 2003.
13 Castellana 1998.
Oltre alla necropoli di Fra Dècu, il territorio è caratterizzato dalla presenzadi altre tombe a grotticella artificiale come quelle in contrada Scifi (fig. 18) e incontrada Zotta di l’Avarieddri (fig. 19), a Nord del Monte Castelluccio, dovenell’area antistante le tombe si sono rinvenuti alcuni frammenti ceramici a de-corazione dipinta assegnabili alla facies di Serraferlicchio e a quella di Castel-luccio (fig. 20) e, ancora, nel versante meridionale della montagna, quelle dicontrada Griddretta (fig. 21).
In conclusione, attraverso le ricognizioni di superficie effettuate sul MonteCastelluccio di Racalmuto e nelle sue contrade, sono state individuate nume-rose e interessanti testimonianze archeologiche. Certamente ulteriori indaginie, possibilmente, una campagna di scavi, consentiranno di portare alla luce im-portanti insediamenti e necropoli e di approfondire ulteriormente la conoscen-za dell’evoluzione storica del territorio, aggiungendo una nuova e significativatessera al grande e complesso mosaico della storia isolana.
230
Simona Modeo e Angelo Cutaia
BIBLIOGRAFIA
Arias 1938 = P. E. Arias, La stazione preistorica di Serraferlicchio presso Agrigento, inMAL XXXVI, 1938.
Bovio Marconi 1944 = J. Bovio Marconi, la cultura tipo Conca d’Oro nella Sicilia occi-dentale, MAL XL, 1944, pp. 1-170.
Bovio Marconi 1979 = J. Bovio Marconi, La grotta del Vecchiuzzo, Roma 1979.Castellana 1997 = G. Castellana, La grotta Ticchiara ed il castellucciano agrigentino, Pa-
lermo 1997.Castellana 1998 = G. Castellana, Il santuario castellucciano di Monte Grande e l’approv-
vigionamento dello zolfo nel mediterraneo nell’età del Bronzo, Palermo 1998.Castellana 2002 = G. Castellana, La Sicilia nel II millennio a.C., Caltanissetta 2002.Cutaia 2000 = A. Cutaia, L’itinerario arabo-normanno Sutera Agrigento nel libro di Al
Idrisi. Il tracciato e gli abitati, Agrigento 2000.Fiorentini 1995 = G. Fiorentini, Monte Adranone, Roma 1995.Maggi 1976 – 1977 = R. Maggi, Gli scavi nelle stufe di San Calogero sul Monte Kronio
(Sciacca) e i rapporti fra la Sicilia e Malta durante il Neolitico, in Kokalos XXII –XXIII, 1976 – 1977, pp. 510 e ss.
Mingazzini 1931 = P. Mingazzini, Gli scavi archeologici nella grotta del Vecchiuzzo a Pe-tralia Sottana, in Giglio di Roccia, III, n. 3-4, Palermo 1931.
Orsi 1892 = P. Orsi, La necropoli sicula di Castelluccio (Siracusa), in BPI XVIII, 1892,pp. 1 e ss.
Panvini 1998 = R. Panvini (a cura di), Gela. Il Museo Archeologico. Catalogo, Caltanis-setta 1998.
Panvini 2000 = R. Panvini (a cura di), Marianopoli. Il Museo Archeologico. Catalogo,Caltanissetta 2000.
Panvini 2003 = R. Panvini (a cura di), Caltanissetta. Il Museo Archeologico. Catalogo,Caltanissetta 2003.
Tiné 1960 – 1961 = S. Tiné, Giacimenti dell’età del rame in Sicilia e la «cultura tipo Con-ca d’Oro», in BPI XIII, 1960 – 1961, pp. 125-126.
Tiné 1965 = S. Tiné, Gli scavi nella grotta della Chiusazza, in BPI XVI, pp. 235-244.Tiné 1971 = S. Tiné, Lo stile del Kronio in Sicilia, lo stile di Ghar Dalam a Malta e la
successione del neolitico nelle due isole, in Atti della XIII Riunione Scientifica IIPP,Firenze 1971, pp. 75 e ss.
Traverso 2006 = A. Traverso, La facies del Kronio. Elementi cronotipologici dagli scavinell’Antro Fazello al Monte Kronio (Sciacca, AG), in AA.VV., Dai Ciclopi agli Ecisti. 231
Surveys sul monte Castelluccio di Racalmuto
Società e territorio nella Sicilia preistorica e protostorica, Atti del Convegno di Studi(San Cipirello, 16-18 novembre 2006), in c.d.s.
Tusa 1983 S. Tusa, La Sicilia nella preistoria, I Ed., Palermo 1983.Tusa 1997 = S. Tusa (a cura di), Prima Sicilia. Alle origini della società siciliana, (Paler-
mo – Albergo dei Poveri, 18 ottobre – 22 dicembre), Palermo 1997.
232
Simona Modeo e Angelo Cutaia
Fig. 1. Stralcio cartografico del comprensorio di Racalmuto con indicazione delle emergenzearcheologiche del Monte Castelluccio e delle sue contrade.
233
Surveys sul monte Castelluccio di Racalmuto
Fig. 2. Stralcio del foglio IGM 267 II SO con indicazione della distribuzione delle tombe agrotticella artificiale.
234
Simona Modeo e Angelo Cutaia
Fig. 3. Monte Castelluccio. Veduta panoramica.
Fig. 4. Monte Castelluccio. Struttura abitativa a pianta sub-circolare.
235
Surveys sul monte Castelluccio di Racalmuto
Fig. 5. Monte Castelluccio. a) Ciottolo di fiume con tracce di ocra rossa; b) frammento di cera-mica a decorazione dipinta (facies di Serraferlicchio ?).
Fig. 6. Monte Castelluccio. Tomba a grotticella artificiale.
236
Simona Modeo e Angelo Cutaia
Fig. 7. Contrada Cienzu - Monumenti. Veduta panoramica.
Fig. 8. Contrada Cienzu - Monumenti. Frammenti fittili.
237
Surveys sul monte Castelluccio di Racalmuto
Fig. 10. Monte Adranone. Palmento.
Fig. 9. Contrada Cienzu - Monumenti. Base di palmento in pietra calcarea.
238
Simona Modeo e Angelo Cutaia
239
Surveys sul monte Castelluccio di Racalmuto
Fig. 11. Contrada Cienzu - Monumenti. Frammenti di pithoi.
Fig. 12. Monte Adranone. Frammenti di pithoi.
Fig. 13. Contrada Gargiláta. Fra Décu. Grotta e necropoli rupestre.
Fig. 14. Contrada Gargiláta. Fra Décu. Frammenti ceramici (facies di Serraferlicchio e diCastelluccio iniziale).
240
Simona Modeo e Angelo Cutaia
241
Surveys sul monte Castelluccio di Racalmuto
Fig. 15. Contrada Gargiláta. Fra Décu. Frammentoceramico (facies del Kronio ?).
Fig. 17. Stralcio del foglio IGM 267 II SO con indicazione delle miniere di zolfo di Gibillini.
Fig. 16. Contrada Gargiláta. FraDécu. Grattatoio in selce.
Fig. 18. Contrada Scifi. Tomba a grotticella artificiale.
Fig. 19. Contrada Zotta di l’Avarieddri. Tombe a grotticella artificiale.
242
Simona Modeo e Angelo Cutaia